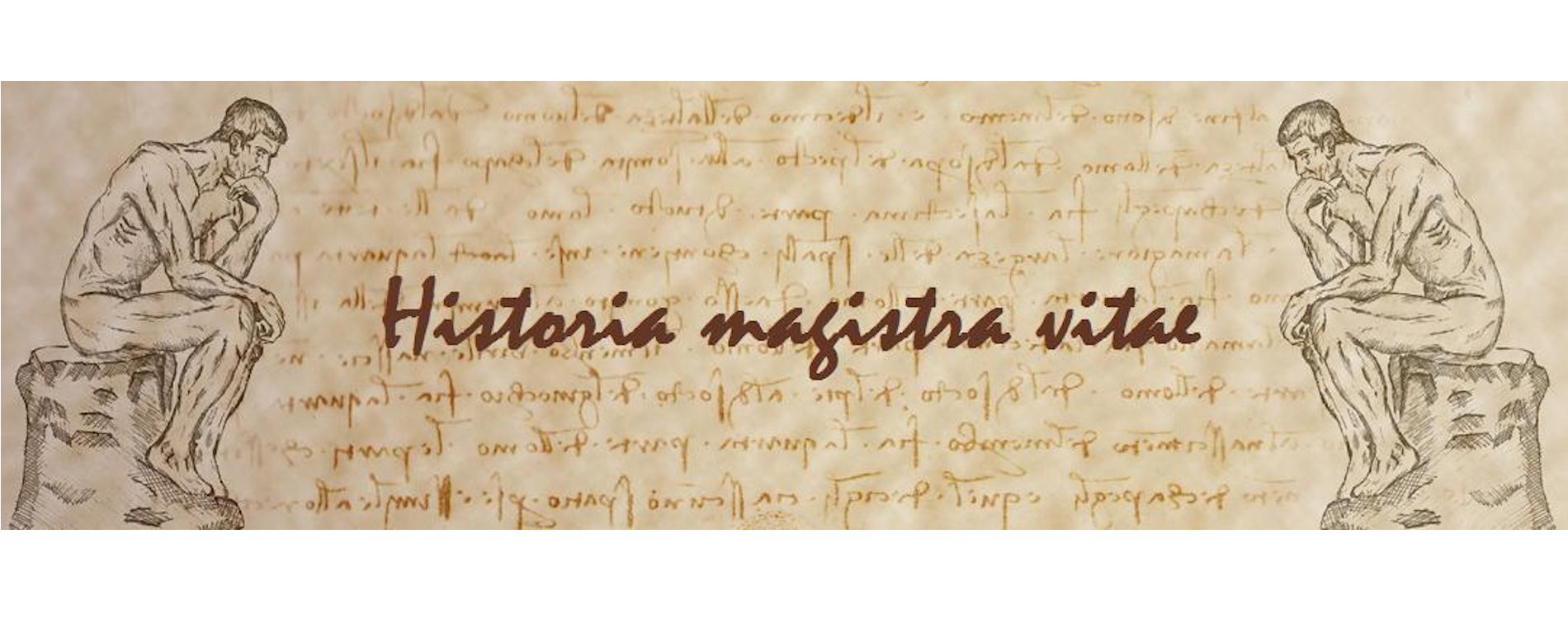Barbari di Alessandro Barbero
- Visite: 99
Introduzione. Frontiere e mobilità umana nell’Impero romano.
Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da disuguaglianze e squilibri al suo interno, ma forte di un’amministrazione stabile e di un’economia integrata; all’esterno popoli costretti a sopravvivere con risorse insufficienti, minacciati dalla fame e dalla guerra, e che sempre più spesso chiedono di entrare; una frontiera militarizzata per filtrare profughi e immigrati; e autorità di governo che debbono decidere volta per volta il comportamento da tener verso queste emergenze, con una gamma di opzioni che va dall’allontanamento forzato all’accoglienza di massa, dalla fissazione di quote d’ingresso all’offerta di aiuti umanitari e posti di lavoro.
Potrebbe sembrare una descrizione del nostro mondo e invece è la situazione in cui si trovò per secoli l’Impero romano di fronte ai barbari, prima che si esaurisse, con conseguenze catastrofiche, la sua capacità di gestire in modo controllato la sfida dell’immigrazione.
Pag. V.
Anche l’idea che la frontiera, comunque intesa, segnasse lo spartiacque fra due mondi radicalmente diversi rispondeva più alla propaganda che alla realtà; grazie agli scavi archeologici, oggi ci appare sempre più chiaro che l’influenza romana si estendeva ben oltre i confini dell’Impero, tanto che in talune aree, ad esempio quella del Reno, si parla correntemente di una civiltà di frontiera, sviluppatasi con caratteristiche omogenee, anche di cultura materiale, al di qua e al di là del limes.
La stessa distinzione fra sudditi dell’Impero e popolazioni esterne ammette l’esistenza di situazioni intermedie, perché l’autorità degli imperatori tendeva dichiaratamente a proiettarsi anche al di là dei confini ufficiali.
Nell’Oriente ellenizzato accadde a lungo che popolazioni più o meno stabili e civilizzate, con i loro re, fossero riconosciute come dipendenti dall’Impero, senza perdere del tutto la loro autonomia.
Col tempo il governo romano preferì abolire gran parte di questi regni clienti, ammettendoli direttamente all’Impero; in compenso, divenne sempre più frequente la stipulazione di accordi con le tribù germaniche stanziate sul Reno e sul Danubio, i clan arabi della Mesopotamia e del deserto arabico e quelli berberi d’Africa, in base ai quali i loro capi riconoscevano l’autorità dell’imperatore, fornivano guerrieri in caso di bisogno e collaboravano alla difesa delle frontiere, anche se i territori su cui erano stanziati o su sui transumavano col loro bestiame non erano formalmente annessi all’Impero.
In più di un caso, come avvenne coi goti sul Danubio e con gli alamanni sul Reno, il governo imperiale sembra aver considerato questi accordi come preparatori a una futura, piena integrazione di quei popoli nell’ecumene romana; il discorso ideologico ufficiale elogiava gli imperatori per la loro capacità di imporre la propria autorità oltre le frontiere, affermandosi come i rettori, almeno potenzialmente, dell’intera umanità.
Pag. VII-VIII
Il lettore che ci abbia seguiti sin qui si potrà chiedere legittimamente che cosa, dunque, sia studiato nelle pagine che seguono.
Tema principale della nostra indagine, in effetti, è l’atteggiamento del governo imperiale, nei confronti non già dell’immigrazione individuale, ma dell’accoglienza in massa di intere tribù, o comunque di aliquote significative di popolazione barbarica: un problema cui le autorità romane, come vedremo, dedicano sufficiente attenzione da consentirci di parlare, non anacronisticamente, di una vera e propria politica di immigrazione.
Quale consapevolezza abbiano avuto i vertici dell’Impero dell’opportunità di reclutare manodopera libera al di fuori dei confini, sia per venire incontro alla necessità di un esercito affamato di coscritti, sia per alimentare la popolazione contadina insediata sui latifondi demaniali e privati, in un’economia dove il lavoro dei coloni, per diversi motivi, stava cominciando a rimpiazzare quello degli schiavi; come, concretamente, le autorità centrali e locali si siano mosse per soddisfare questa esigenza, quali misure amministrative e quali accorgimenti giuridici si siano messi in opera per gestire il fenomeno, e come si sia risolto il problema cruciale dell’accesso alla cittadinanza per gli immigrati: questi sono gli interrogativi principali cui cercheremo di rispondere nelle pagine che seguono.
Nel corso dell’indagine avremo modi di constatare come per lo più le necessità di manodopera dell’Impero si siano incontrate con movimenti di profughi e richieste di accoglienza provenienti dall’esterno.
Gli abitanti del barbaricum erano in genere contadini, che sopravvivevano in un’economia di pura sussistenza, senza ammortizzatori in grado di assorbire gli effetti della carestia o della guerra; capitava dunque che intere popolazioni fossero spinte dalla fame ad affollarsi alle frontiere dell’Impero, chiedendo un permesso di entrata che implicava automaticamente anche l’assegnazione di case e lavoro.
In questi casi, tenuto conto della congiuntura demografica, delle esigenze dei grandi proprietari terrieri e di quelle dell’esercito, l’orientamento delle autorità fu spesso quello di favorire l’insediamento in territorio romano; e in qualche caso anche di promuoverlo forzatamente, deportando gli avanzi di tribù sconfitte e rimaste alla mercé dell’esercito.
La differenza principale fra l’immigrazione antica e quella odierna consiste dunque in questo, che in epoca romana l fenomeno si attuava normalmente in forma collettiva e assistita anziché attraverso una somma di percorsi individuali e si concludeva con l’insediamento nelle campagne, piuttosto che nelle città.
Per molto tempo l’Impero riuscì a gestire l’afflusso, favorendo l’assimilazione degli immigrati e integrandoli con successo tanto per rivitalizzare la produzione agricola, quanto per infoltire i ranghi dell’esercito; a un certo punto, invece, qualcosa cominciò ad andare storto e la presenza di nuovi arrivati manifestò effetti destabilizzanti.
La catastrofe d Adrianopoli, nel 378, è solo la conseguenza più vistosa di una nuova incapacità di gestire e controllare i flussi di immigrazione: quella che era cominciata coma una brutta storia di profughi prima respinti e poi accettati, di abusi e malversazioni nella gestione dei campi di accoglienza, finì per costare la vita a un imperatore e per segnare la svolta epocale nella storia di Roma, aprendo la via ai grandi stanziamenti mal controllati di barbari che fra Quarto e Quinto Secolo liquidano la nozione stessa di territorio romano opposto al barbaricum, e prefigurano la dissoluzione dell’Impero in Occidente.
Lo studio dell’immigrazione si rivela, così, anche un modo per affrontare da un’angolatura nuova, e sul lungo periodo, il problema sempre aperto della trasformazione del mondo romano fra Antichità e Medioevo.
Pag. XVII-XVIII
Cap. 1. Deportazioni e immigrazione sotto il Principato.
La necessità di affrontare in termini politici il problema dell’immigrazione comincia a porsi per le autorità romane all’indomani della conquista della Gallia.
L’onerosa protezione imposta alle riluttanti popolazioni celtiche implicava infatti che le truppe di occupazione fossero almeno in grado di impedire l’afflusso violento di nuovi gruppi tribali ai danni di quelli pacificati e sottomessi.
Era un compito tutt’altro che ovvio, perché fino a quel momento il popolamento della Gallia si era compiuto proprio attraverso ripetute ondate migratorie, che nessuna forza organizzata era stata in grado di impedire prima dell’arrivo delle legioni.
E’ solo con la dominazione romana che il Reno comincia ad assumere la funzione di una frontiera fortificata e non transitabile, ciò che non era mai stato in precedenza; ed è nella percezione delle autorità romane che si irrigidisce la distinzione tra popolazioni celtiche, sottomesse, e popolazioni germaniche indipendenti, una distinzione che non appare affatto così netta in base ai dati archeologici e linguistici.
E’ necessario, insomma, rinunciare alla comoda idea del Reno come frontiera naturale fra un mondo celtico, dalla civiltà più complessa e in via di romanizzazione, e un mondo germanico irrimediabilmente selvaggio e arretrato.
La maggior parte delle tribù che vedremo coinvolte in trattative con le autorità romane allo scopo di passare il Reno e insediarsi in Gallia, anche se classificate come germaniche dagli scrittori antichi, sono viste oggi come parte d’una civiltà comune, di stampo celtico, che dominava entrambe le sponde del Reno e si distingueva nettamente da quella dell’interno della Germania.
Il modo di vita di questi ubii, sugambri, usipeti, tencteri richiama molto più da vicino quello stanziale, agricolo e in certa misura urbanizzato dei galli, che non al civiltà primitiva, seminomade e guerriera attribuita dagli autori romani ai germani; sono solo le popolazioni dell’interno, svevi, catti e cheruschi a corrispondere allo stereotipo del germano primitivo messo in circolazione da Giulio Cesare.
Pag. 3-4
Più di cento anni dopo, quando ormai a loro città era stata elevata da un pezzo al rango di colonia romana, Tacito scrive che essi ricordavano ancora la propria origine barbarica e non se ne vergognavano, perché erano stati insediati sul Reno non come un popolo sconfitto e deportato, ma come alleati di fiducia incaricati di sorvegliare la frontiera dell’Impero.
Pag. 5
La vicenda degli ubii mostra come una profonda romanizzazione potesse coesistere con la precisa memoria di un’origine etnica diversa; una memoria che sembra essere stata fonte d’orgoglio per gli ubii e di risentimento per le tribù germaniche rimaste al di là del Reno.
tacito osserva che quando queste tribù si ribellavano, aggredivano volentieri gli ubii, “perché quel popolo di origine germanica, rinnegata la patria, si faceva chiamare col nome romano di agrippinesi”.
I privilegi riconosciuti alla loro città suscitavano la gelosia degli altri, il quali chiedevano “o che fosse sede comune a tutti i germani, o che fosse distrutta e gli ubii dispersi”.
In questo caso, insomma, il permesso accordato selettivamente a una singola tribù di stanziarsi sulla riva romana del Reno era chiaramente percepito dalle popolazioni locali come una misura politica e discriminatoria, , che tuttavia dal punto di vista delle autorità romane, aveva pienamente sortito il suo effetto.
Pag. 6
In conclusione, accoglienza di profughi o reinsediamento forzato di popoli sconfitti sono strumenti di cui le autorità romane dell’età giulio-claudia si avvalgono con una certa libertà, rispondendo innanzitutto a esigenza di sicurezza, e solo secondariamente a opportunità economiche e demografiche, nel quadro di una politica di espansione in cui il consolidamento dei confini via via raggiunti si accompagna alla sistemazione pacifica delle province conquistate.
Le esigenze del momento determinano di volta in volta le decisioni, prese al più alto livello nel lontano palazzo imperiale oppure, con apparente libertà di azione, dai comandanti sul campo: profughi che si presentano offrendo sottomissione possono essere accolti oppure spietatamente respinti, tribù sconfitte possono essere ricacciate più lontano o deportate all’interno dell’Impero.
Emergono certo alcune preoccupazioni costanti, peraltro in contrasto fra loro: tenere tranquilla l’opinione pubblica nelle province pacificate, ma anche garantirne il popolamento e la produzione; trasformare il confine in una barriera invalicabile, ma anche mantenere i rapporti con i capi fedeli fra le tribù indipendenti.
Ma quello che conta è che nessuna di queste preoccupazioni appare tale da dettare alle autorità romane comportamenti obbligati, in un contesto in cui la sola regola, come dichiarò brutalmente il proconsole Avito agli Ampsivari, era “il dominio dei più forti”.
Pag. 16
Cap. 2. L’arruolamento di stranieri nell’esercito fino agli Antonini.
Cap. 3. Una svolta: l’epoca di Marco Aurelio
Fino al regno di Marco Aurelio i rapporti con i barbari stanziati al di là delle frontiere non costituiscono per Roma un problema prioritario.
Durante gran parte del Secondo Secolo la romanizzazione delle province procede spedita, l’esercito regolare assume un volto più omogeneo e l territorio dell’Impero sembra al sicuro da aggressioni esterne.
Il problema dell’immigrazione non è all’ordine del giorno, né come sfida né come risorsa.
Il frequente impiego di reparti militari reclutati fra le popolazioni barbariche, a mala pena sottomesse, non basta di per sé a modificare questo quadro d’insieme: il trasferimento di mauri in Dacia o di britanno in Germania, a gruppi di poche centinaia, inquadrati da ufficiali e sottufficiali romani, non poteva avere alcun effetto sulla composizione etnica della popolazione locale, anche nel caso, tutt’altro che accertato, che quegli uomini avessero la possibilità di condurre con sé le proprie famiglie.
Pag. 29
Senza voler entrare, in questa sede, in una discussione storiografica vivacissima come quella sull’origine e la natura del colonato barbarico, conviene sottolineare come gli scenari appena evocati si inseriscano in modo convincente nel quadro della più ampia trasformazione allora in corso nella società rurale e nei rapporti di lavoro.
Sintetizzando le acquisizioni di un recente convegno, Andrea Giardina osservava come l’impiego di manodopera tecnicamente libera sui latifondi e il parallelo sforzo di introdurre vincoli alla mobilità dei coltivatori si siano certamente diffusi “in coincidenza con al crisi demografica verificatesi tra la fine del secondo e gli inizi del Terzo Secolo”; e come all’avanguardia in questa nuova tendenza fossero proprio le grandi proprietà imperiali.
In questo contesto, il fatto che la manodopera impiegata secondo queste modalità e sottoposta a questi vincoli cominciasse ad essere, in misura non irrilevante, manodopera immigrata o deportata non può essere trascurato, e dovrà forse avere uno spazio più ampio di quello che ha avuto di recente nel dibattito storiografico.
Pag. 35-36
Cap. 4. Esercito e cittadinanza nell’età dei Severi.
Sull’entità di deportazioni e immigrazioni durante l’età dei Severi sappiamo ben poco, molto meno che non per l’età di Marco Aurelio.
E’ probabile che fenomeni di questo genere continuassero a verificarsi; non tanto su vasta scala, quanto attraverso l’immigrazione di piccoli gruppi, accolti e sistemati dalle autorità locali senza che la cosa richiedesse l’approvazione dell’imperatore e giungesse alle orecchie dei cronisti.
La fame di braccia nelle campagne, una generazione dopo la fine dell’epidemia, doveva essere comunque meno acuta e bisogna cercare molto attentamente nelle fonti per trovare traccia di insediamenti di barbari finalizzati all’agricoltura.
Severo Alessandro, al momento di rompere guerra all’Impero sassanide, fece arrestare l’intero seguito degli ambasciatori persiani che erano venuti a sfidarlo, ben quattrocento persone fra militari e domestici; e dopo averli spogliati di tutto li fece deportare in Frigia, “concedendo loro di abitare nei villaggi e coltivare la terra.”
L’assenza di stupore con cui Erodiano riferisce questo episodio lascia pensare che simili casi di deportazione e insediamento di barbari come coltivatori su suolo romano non fossero per lui insoliti; ma certamente gli imperatori di quest’epoca non li considerarono una priorità.
Al contrario, la loro agenda politica e la gestione del reclutamento fanno pensare che l’emergenza determinatasi sul confine danubiano negli anni di Marco Aurelio fosse ormai rientrata e che l’Impero si stesse avviando verso una sostanziale omogeneità e autosufficienza etnica.
Pag. 42-43
La sanatoria del 212.
Nel 212, con la Constitutio Antoniniana, l’imperatore Caracalla concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’Impero.
Si concludeva così il processo secolare per cui il privilegio della cittadinanza era stato progressivamente esteso, in forma collettiva, alle comunità che via via risultavano sufficientemente romanizzate.
Alcuni storici sono inclini a svalutare il significato di questa concessione, anche perché l’unico autore contemporaneo che ci abbia lasciato la sua versione dei fatti, Cassio Dione, nutre in generale una pessima opinione di Caracalla, e gli attribuisce motivazioni sordide: l’imperatore si sarebbe proposto semplicemente di estendere a tutti i sudditi determinate imposizioni fiscali che gravavano soltanto sui cittadini romani.
In un impero in cui la distinzione fra l’élite dei potenti, gli honestiores, e la massa della povera gente, gli humiliores, stava diventando più importante di qualsiasi distinzione giuridica, e anzi assumeva essa stessa una rilevanza decisiva davanti alla legge, è facile concludere che l’editto estese a tutti gli abitanti dell’Impero un privilegio formale ormai in pratica svuotato di significato.
Pag. 43
La storiografia recente tende a prendere posizione in favore della prima ipotesi, sicché l’esclusione dei dediticii dalla concessione della cittadinanza è spesso data per scontata.
In realtà c’è almeno un fattore importante che spinge a propendere piuttosto per la seconda: è ormai accertato, infatti, che le leggi locali e le consuetudini giuridiche dele innumerevoli civitates in cui si articolava l’Impero rimasero a lungo in vigore anche dopo il 212, indipendentemente dal fatto che i loro abitanti fossero tutti divenuti, formalmente, cittadini romani.
Che la cittadinanza romana, quando veniva concessa a un provinciale, non implicasse l’esenzione dalle consuetudini, e dagli obblighi, della città di residenza era spesso stato ribadito in precedenza, e non ci sarebbe nulla di strano se Caracalla avesse specificamente sottolineato che le norme delle singole città non s’intendevano abolite con la nuova costituzione; ad abbandonare completamente la propria condizione preesistente, allora, secondo la formulazione del papiro Giessen, sarebbero stati per forza i soli dediticii.
Pag. 45
A colmare questo abisso provvederanno quasi certamente, come vedremo meglio più avanti, meccanismi di assimilazione tacita dal momento che con l’Editto di Caracalla e “con l’assunzione di un criterio ‘spaziale’, a integrazione di quello ‘personale’… si era capovolto il rapporto tra ‘cittadinanza’ e ‘non cittadinanza’, facendo della prima lo status per dir così ‘normale’ e della seconda quello ‘eccezionale’”; sicché in epoca più tarda l’editto verrà inteso come un’estensione della cittadinanza a chiunque venga a vivere nell’Impero e si sottometta all’autorità imperiale.
Tutto lascia pensare, però, che questa interpretazione si sia imposta col tempo, e non fosse prevista nel 212.
Pag. 47
Se proviamo ad immaginare la situazione dal punto di vista di Caracalla e dei suoi successori, l’immagine che ne emerge è quella di un impero ormai abitato quasi esclusivamente da cittadini romani.
Questa popolazione sempre più omogenea dal punto di vista giuridico costituisce il bacino di reclutamento di gran lunga maggioritario per tutte le forze armate, e anzi, di fatto, esclusivo per i reparti regolari dell’esercito terrestre.
L’esistenza, all’interno dell’Impero, di persone che non godono della cittadinanza e che dunque tecnicamente possono essere definite come peregrini, appare come un fenomeno marginale, alimentato essenzialmente da quegli interventi governativi che in singoli casi hanno concesso a gruppi di profughi di attraversare il confine, nonché, forse, da un’immigrazione individuale, la cui entità però ci sfugge del tutto.
L’afflusso di questi dediticii si è certo intensificato durante le guerre di Marco Aurelio, ma quella crisi appare ora superata; anzi, il fatto che i diplomi di cittadinanza abbiano continuato ad essere rilasciati ai veterani dei reparti ausiliari fino ai primi anni del nuovo secolo offrirebbe proprio il lasso di tempo necessario perché tutti i germani e i sarmati arruolati prima del 180 concludessero il loro servizio e ricevessero la cittadinanza al congedo.
Pag. 49-50
In conclusione, l’età dei Severi appare caratterizzata da un’evoluzione coerente.
Sul piano del reclutamento, la presenza di bande etniche accanto ai reparti regolari dell’esercito in occasione delle maggiori campagne militari è così largamente documentata da apparire ormai scontata; ma rispetto all’età di Marco Aurelio essa non si accompagna più allo stanziamento consensuale di intere tribù sul suolo romano.
Sul piano del popolamento, la prospettiva del governo è quella di promuovere l’omogeneità giuridica della popolazione, etnicamente così variegata, abitante all’interno dei confini; quale prospettiva si sia adottata, da questo punto di vista, nei confronti degli immigrati recenti è impossibile stabilire con certezza in assenza di un’interpretazione univoca del papiro di Giessen, ma in un caso come nell’altro sembra di poter concludere, dall’esistenza stessa dell’editto come dall’interpretazione che ne diedero i contemporanei, che a quegli immigrati si pensava come a una frangia minoritaria, destinata ad essere assorbita senza difficoltà sotto i paterno governo di un imperatore che a partire da Caracalla si definiva con sempre maggiore insistenza come orbis pacator, “pacificatore del mondo intero”.
Pag. 53
Cap. 5. La crisi del Terzo Secolo
Con l’assassinio di Severo Alessandro e l’avvento di Massimino il Trace si aprì una lunga stagione di torbidi, che vide alternarsi sul trono imperiale non meno di 22 imperatori nell’arco di mezzo secolo.
In quest’epoca di frenetiche guerre civili e devastanti invasioni barbariche, il ricorso al reclutamento e all’insediamento forzato di barbari esterni su territorio romano è documentato in misura crescente: l’Impero che aveva ufficialmente supposto l’universalità della cittadinanza si ritrova invece pieno di immigrati.
E’ in quest’epoca che l’amministrazione imperiale, dopo i precedenti isolati riscontrati sotto Marco Aurelio e i Severi, collauda e trasforma in routine le procedure che d’or ain poi saranno regolarmente impiegate per gestire il fenomeno dell’immigrazione: ovvero l’insediamento di coloni per rimettere a coltura zone spopolate, e l’incorporazione di reclute barbariche negli organici dell’esercito regolare.
Nel secolo seguente, lo storico Aurelio Vittore andrà a colpo sicuro nel denunciare che proprio in questo periodo, per la prima volta, i governanti “hanno lasciato entrare nell’Impero promiscuamente i buoni e i cattivi, i nobili e gli ignobili e molti provenienti dalla barbarie”, e senza rendersene conto “hanno spianato la via ai militari, e in pratica ai barbari, per comandare a loro e ai posteri”.
Pag. 54
La notizia sarà interpretata nel senso che “un gruppo di marcomanni […] venne insediato da Gallieno nella Pannonia Superiore. Essi avevano certamente ottenuto un foedus che riconosceva loro l’autonomia”.
In questi termini, l’affermazione è indicativa soprattutto della facilità con cui la storiografia tende a trarre conclusioni circostanziate da fonti la cui attendibilità è per lo meno dubbia.
Data la pluralità di rapporti che potevano instaurarsi in quegli anni critici fra imperatori e capi barbari nelle zone si frontiera non sembra prudente spingersi così lontano, ed hanno forse ragione quegli studiosi secondo cui la notizia “suona priva di credibilità”.
In alternativa, tuttavia, si può pensare ad uno stanziamento simile a quelli così spesso attestati nell’area danubiana al tempo di Marco Aurelio, che non implicavano alcun arretramento del potere imperiale o concessione di autonomia; al vicenda non investirebbe più, in tal caso, alcun carattere eccezionale, se non in quanto indicherebbe già sotto Gallieno l’inizio di una politica di intervento a favore delle aree che avevano maggiormente sofferto negli anni precedenti.
Pag. 58-59
Ma ancora più interessante è la notizia secondo cui una parte dei prigionieri vennero insediati come agricoltori all’interno dell’Impero.
Sul modo in cui il governo organizzò questo insediamento disponiamo di un resoconto entusiastico, in cui si afferma che dopo le vittorie di Claudio “le province romane si riempirono di schiavi barbari e di coloni sciti; il goto fu tramutato in colono nelle province confinanti con la barbarie. E non ci fu nessuna ragione che non avesse qualche schiavo goto, asservito dopo la sconfitta”.
Dovremmo concluderne che i prigionieri non vennero soltanto insediati nelle zone spopolate della frontiera, acquisite dal fisco, ma anche venduti come schiavi ai latifondisti; di per sé, non ci sarebbe niente di improbabile, se non fosse che questo resoconto proviene dalla solita, fantasiosa Historia Augusta, e riflette le esperienze di un’epoca, quella di Valente e di Teodosio, in cui la presenza gotica nell’Impero era ben più capillare rispetto al tempo di Claudio Secondo.
E c’è allora da chiedersi se anziché una deportazione verso le province interne, quegli insediamenti agricoli di cui riferisce Zosimo non fossero semplicemente il frutto di un compromesso fra l’imperatore e singoli capi gotici, cui venne permesso di continuare a risiedere nei distretti che già avevano occupato, distribuendo ai loro uomini i campi senza padrone; una novità che dà comunque la misura dello spopolamento delle zone rurali, soprattutto in quelle province balcaniche dove per anni i goti avevano condotto impunemente le loro scorrerie.
Pag. 60
Sul piano giuridico, un nucleo di barbari trapiantato all’interno dell’Impero poteva continuare indefinitamente a viverci senza ottenere la cittadinanza e senza organizzarsi in modo autonomo, restando a completa disposizione dell’imperatore; la qualifica di dediticii si applicava a costoro sia che si trattasse di prigionieri deportati sia che la loro immigrazione fosse in realtà il risultato di un negoziato.
Bisognerà però evitare di immaginare che queste condizioni giuridiche rimanessero per sempre congelate, in mancanza di specifici interventi di concessione della cittadinanza, dei quali peraltro non c’è alcuna traccia.
In un Impero la cui popolazione, in base all’editto di Caracalla, godeva in blocco della cittadinanza, è verosimile che almeno i nuclei insediati pacificamente, con diritto di proprietà o d’usufrutto sulla terra distribuita loro dal governo, venissero prima o poi tacitamente assimilati.
Quando Zosimo scrive che i bastarni accolti da Probo in tracia “continuarono a vivere obbedendo alle leggi romane”, è evidente che pensa a una progressiva assimilazione e integrazione nella politeia imperiale, e non a uno stato di perdurante minorità giuridica che sarebbe molto difficile dimostrare.
Pag. 67
Il fatto che i predecessori di Diocleziano abbiamo fatto ricorso sempre più spesso all’arruolamento di barbari non implica dunque una barbarizzazione dell’esercito, se non in senso molto limitato.
Nulla indica che l’organico delle legioni sia stato seriamente interessato da questa nuova politica di reclutamento, se escludiamo il passo dell’Historia Augusta relativo alle reclute di Probo, di cui si è già segnalato l’anacronismo almeno sul piano metodologico.
Un numero crescente di reggimenti ausiliari sarà invece tornato a presentare una riconoscibile connotazione barbarica; ma questa, dopo tutto, era stata la situazione normale all’epoca di Augusto o di Traiano.
L’assunzione di bande di mercenari sotto capi propri rimase un fenomeno occasionale, limitato alle guerre civili e alle campagne contro i persiani sul fronte orientale.
Quanto ai casi in cui il governo imperiale organizzò l’insediamento di interi gruppi di prigionieri o di profughi all’interno dell’Impero, gli indizi che da queste comunità s siano poi reclutati dei reparti etnici continuano a essere rari; a quello dei sarmati trasferiti in Britannia da Marco Aurelio si può forse aggiungere quello dei vandali e burgundi deportati, egualmente in Britanni, da Probo.
E’ abbastanza per creare un precedente interessante; ma nel contesto complessivo dell’organizzazione militare romana, che manteneva sotto le insegne migliaia di soldati regolari, si tratta di fenomeni percentualmente irrilevanti.
Non è invece privo di interesse, soprattutto considerando la generale lacunosità delle nostre conoscenze del Terzo Secolo, aver potuto stabilire con una certa sicurezza che l’epoca dei primi grandi imperatori militari e della restaurazione da loro avviata dopo la catastrofe del 260 è senza dubbio quella in cui il governo imperiale cominciò a praticare con una certa regolarità, e non soltanto sporadicamente come già all’epoca di Marco Aurelio, due misure destinate a conoscere sempre maggiore fortuna per tutta l’epoca successiva: ovvero la costituzione di interi reparti ausiliari dell’esercito regolare con materiale umano reclutato o catturato fuori dai confini, e lo stanziamento di prigionieri di guerra come coloni per risanare zone spopolate.
E’ in quest’epoca che l’amministrazione civile e militare dell’impero dovette cominciare ad attrezzarsi per gestire questa duplice prassi non più come occasionale emergenza, ma sempre più come un aspetto della normalità; in modi che per il momento possiamo a mala pena immaginare, ma che diverranno via via conoscibili dall’età della tetrarchia
Pag. 71-72
Cap. 6. Ripopolamento e reclutamento sotto la tetrarchia.
Negli anni di governo di Diocleziano, Massimiano, Costanzo e Galerio, che vanno complessivamente dal 284 al 311, la deportazione forzata di popolazioni barbare verso l’impero diventa un aspetto centrale della politica romana.
Sotto la tetrarchia, l’obiettivo primario di queste misure parrebbe soprattutto il ripopolamento delle province desertificate, mentre il reclutamento per l’esercito appare nelle fonti come un obiettivo ben presente, ma secondario.
Un buon punto di partenza per analizzare l’azione dei tetrarchi è il panegirico anonimo di Costanzo Cesare, pronunciato all’inizio del 297, in cui è affermata la continuità dei loro interventi in questa direzione: “così come prima per tuo comando, Diocleziano Augusto, l’Asia col trasferimento dei suoi abitanti ha riempito i deserti della Tracia, come poi per tuo ordine, Massimiano Augusto, il prigioniero restituito alla patria e il franco accolto nella nostra legge hanno coltivato i campi abbandonati dei nervii e del treviri, così ora grazie alle tue vittorie, Costanzo Cesare invitto, tutto ciò che era ancora spopolato nel territorio di Amiens e di Beauvais, di Troyes e di Langres torna a verdeggiare coltivato dai barbari.
Pag. 73
Negli anni della tetrarchia compare dunque per la prima volta con certezza, anche se soltanto come sistemazione provvisoria, una distribuzione dei deportati fra i latifondisti privati.
Che ciò avvenisse gratuitamente o dietro pagamento, non siamo in grado di accertarlo e può ben darsi che a seconda delle circostanze si siano verificate entrambe le eventualità; lo Stato vi trovava comunque il suo tornaconto, dal momento che si allargava il bacino della popolazione soggetta all’imposta e alla coscrizione.
Per comprendere le modalità con cui avvenivano queste assegnazioni di manodopera, è utile anticipare qui l’analisi di un testo più tardo, l’unico esempio di editto imperiale che regolamenta specificamente una situazione di questo genere.
Nel 409, l’imperatore Onorio informa di aver sottomesso la “barbara nazione” degli sciri, “e perciò diamo a tutti una gran quantità di questa gente perché coltivino le terre private, purché si sappia che saranno assegnati soltanto con la condizione giuridica di coloni, e che nessuno potrà sottrarre con l’inganno coloni di questo genere al padrone cui sono stati assegnati una volta per tutte, né accoglierli se fuggiaschi”.
L’imperatore continuava precisando che a causa della carestia in corso i padroni avevano un certo margine di tempo prima di sistemarli nella loro sede definitiva, ma che comunque dovevano farli proseguire immediatamente per le province d’oltremare, mentre era vietato trattenerli nelle province della Tracia e dell’Illirico.
Per attirare maggiormente i proprietari interessati, l’editto garantiva che i coloni sarebbero stati esenti per vent’anni dalla coscrizione, e invitava chiunque desiderasse partecipare all’assegnazione a presentare regolare domanda presso gli uffici del prefetto al pretorio.
Pag. 76-77
Il riferimento che si è appena fatto a un villaggio di Carpi, tratto da Ammiano Marcellino, è tanto più prezioso in quanto conferma che gli immigrati venivano per lo più installati in comunità compatte: una conclusione che gli archeologi hanno spesso raggiunto indipendentemente, ma che in vista delle tendenze revisioniste oggi dominanti in campo archeologico, assai prudenti circa la possibilità di attribuire un’identità etnica agli insediamenti, è confortante veder confermata da fonti letterarie.
E accade allora di osservare che in epoca molto più vicina a noi, in quell’Impero russo che per certi versi era l’erede dell’Impero romano d’Oriente, e che era ben familiare con insediamenti di coloni e deportazioni organizzate, il popolamento di certe province di frontiera, come il Caucaso o la Crimea, era bensì multietnico, ma si organizzava generalmente proprio a villaggi etnicamente riconoscibili e pressoché aggregati: un sistema che sembra plausibile attribuire anche alle province romane interessate dall’insediamento organizzato di immigrati e deportati.
Pag. 80
Ad accomunare le due categorie c’era del resto anche un altro aspetto, la cui rilevanza giuridica oltre che psicologica era certamente considerevole: lo sradicamento.
Se i barbari immigrati o deportati non potevano vantare, per definizione, un’origo, anche i rustici assoggettati al patronato, come appare chiaramente dalla documentazione papirologica, erano per lo più dei sradicati, che lasciavano i villaggi natii per trasferirsi sui possedimenti dei magnati.
Significativa da questo punto di vista è anche la diffusione del termine inquilini, che come s’è visto compare nel linguaggio giuridico al tempo di Marco Aurelio forse proprio per designare i coloni importati a forza sui latifondi imperiali, ma che finisce per assumere un valore più generale, di coltivatore dipendente non originario del luogo, magari perché fuggiasco rispetto ai propri obblighi fiscali.
In una campagna dove andavano diffondendosi al tempo stesso lavoro dipendente e bracciantato rurale, rapporti di patronato e limitazioni alla mobilità dei rustici, la diffusione indiscriminata della terminologia della deditio e della inquilinatus sembra insomma implicare che contadini senza terra e immigrati d’oltreconfine erano due categorie che tendevano a sovrapporsi nella percezione collettiva, alimentando la formazione di quell’ampio proletariato rurale che i giuristi cercavano di solidificare attraverso la legislazione del colonato.
Pag. 84
Gli anni della Tetrarchia sono dunque caratterizzati da una poderosa politica di ripopolamento e deportazione, orientata essenzialmente alla rivitalizzazione delle province e alla sicurezza dei confini.
Non sembra invece che queste operazioni abbiano avuto una ricaduta importante sul reclutamento dell’esercito: il sistema di coscrizione introdotto o generalizzato da Diocleziano, e fondato sull’obbligo per i proprietari terrieri di fornire reclute tratte dai loro coloni, indica piuttosto una volontà di completare gli organici senza fare troppo affidamento sull’arruolamento collettivo di barbari esterni.
Certamente, come ricordano i panegirici, quando si insediavano immigrati o deportati su terra demaniale si prevedeva di assoggettarli alla leva come tutti gli altri coloni, ma si trattava comunque di gente destinata, in prospettiva, a venire assimilata, le cui reclute erano mescolate con quelle provenienti da tutti i capi dell’immenso impero.
Il caso di Massimino Daia, imperatore dal 310 al 31, che costituì la sua guardia personale reclutando esclusivamente fra i profughi d’oltre Danubio accolti pochi anni prima da Massimiano, è stigmatizzato da Lattanzio in termini tali che dobbiamo senz’altro considerarlo come una pratica isolata e impopolare.
Pag. 84-85
Non c’è dunque nessun elemento per sostenere che in quest’epoca la costituzione di nuovi reggimenti si sia indirizzata in modo professionale verso reparti di tipo nuovo e dalle stabili connotazioni barbariche.
Certo, quando Costanzo Cloro morì in Britannia nel 306, le truppe che acclamarono imperatore suo figlio Costantino pare comprendessero un contingente di alamanni comandato da un proprio capo, Crocus o Erocus; ed è plausibile che cuesta unità, non meglio indentificata, sia stata costituita con guerrieri passati dalla parte di Costanzo durante le sue grandi campagne sul Reno.
Ma per quello che ne sappiamo, quegli alamanni possono aver costituito una regolare coorte ausiliaria, come ce n’erano sempre state; il fatto che reparti da poco reclutati fra popolazioni appena o per nulla romanizzate fossero spediti su quella sperdutissima frontiera dell’Impero che era la Britannia rappresentava una prassi consolidata da secoli; e che il comandante di un reparto ausiliario appena formato, dalla connotazione etnica ancora ben riconoscibile, appartenesse anch’egli alla medesima nazionalità, ha dei precedenti fin dall’epoca di Augusto.
Pag. 87-88
Cap. 7. L’età di Costantino
Rispetto all’epoca della Tetrarchia il flusso dell’immigrazione, volontaria o forzata, sembra essersi ridimensionato durante gran parte del regno di Costantino.
Solo negli ultimi anni, dopo che la liquidazione del collega Licinio nel 323 ebbe portato sotto il suo controllo anche l’Impero d’Oriente, sono documentati interventi di deportazione e accoglienza nell’area danubiana e siriana, e un complessivo riassetto dei rapporti con le popolazioni seminomadi d’oltreconfine, le cui conseguenze dovevano farsi sentire ancora per molto tempo.
Prima di allora, gran parte delle energie di Costantino vennero assorbite dalla durissime guerre civili; le campagne contro i barbari furono limitate al fronte del Reno e non sembrano aver avuto come conseguenza trasferimenti in massa di popolazione, ma piuttosto l’assorbimento forzato di reclute nell’esercito, lo strumento fondamentale di cui Costantino si avvalse per affermare e consolidare la sua autorità a scapito dei molti rivali.
Per un po’, insomma, la politica militare ha la precedenza sulla gestione dell’immigrazione; non a caso è proprio nel rapporto con l’esercito che la storiografia individua tradizionalmente uno fra i maggiori elementi di novità dell’età costantiniana.
Pag. 89
In conclusione, Costantino non sembra discostarsi dalla politica dei suoi predecessori, per cui l’omogeneità etnica della truppa ausiliaria non era mai stata una priorità, come non lo era l’omogeneità etnica della popolazione nel suo complesso.
Nulla ci autorizza a supporre che proprio sotto il suo regno l’occasionale afflusso di reclute poco o per nulla romanizzate, e le frequenti promozioni di notabili barbari romanizzati, si siano tradotti in una sistematica costituzione di reggimenti dalle connotazioni volutamente barbariche, e che queste connotazioni siano poi state mantenute con cura dagli uffici di reclutamento.
Tutto quello che sappiamo sulle consuetudini dell’amministrazione militare romana suggerisce al contrario la dispersione dei coscritti in una moltitudine di reparti, vecchi e nuovi, etnicamente compositi e rapidamente romanizzati, com’era sempre avvenuto in passato; reparti che solo in pochissimi casi, troppo enfatizzati dagli studiosi, mantenevano almeno nel nome una connotazione barbarica.
Pag. 93
Ma la campagna di gran lunga più importante, anche per i risultati che ne seguirono, fu quella del 332 contro i goti.
In quest’occasione, Costantino impose agli sconfitti un accordo che secondo gli storici della tarda antichità, per non parlare di quello moderni, rappresentò una svolta decisiva nei rapporti tra goti e l’Impero.
Nel valutare l’episodio, su cui in realtà sappiamo pochissimo, bisogna però evitare di cadere nell’anacronismo, come invece da lo storico gotico del Sesto Secolo, Iordanes: secondo lui, nel 332 i goti erano divenuti alleati dell’Impero con un regolare trattato (foedus), impegnandosi a fornire la fantastica cifra di 40.000 uomini in caso di guerra e le unità di foederati che all’epoca di Giustiniano servivano nell’esercito imperiale risalivano direttamente a quell’accordo.
Sui reali contenuti del trattato, di cui possediamo il testo, è difficile pervenire a conclusioni sicure.
Pag. 95
Al di là delle motivazioni umanitarie, che non erano di solito la prima preoccupazione, l’accoglienza offerta ai rifugiati appare in linea con la politica seguita già in precedenza dai tetrarchi sul confine del Danubio: una frontiera ancor più difficile da gestire rispetto a quella del Reno, giacché dall’altra parte non c’erano popolazioni sedentarie, seppur bellicose, ma clan seminomadi in continua effervescenza.
Sorvegliare a distanza gli scontri fra i barbari e intervenire deportando nell’Impero, in condizioni di massima sicurezza, le tribù che rischiavano di soccombere e dunque di trasformarsi in un’orda di profughi, è la linea che era già stata seguita da Diocleziano nei confronti dei carpi e non è sorprendente che Costantino abbia deciso di seguirla nei confronti dei sarmati; in ogni caso come nell’altro, il presupposto è che il governo imperiale si arrogava la facoltà di decidere chi dovesse occupare prioritariamente i territori transdanubiani e, quando riconosceva un interesse a farlo, provvedeva a risistemare i nuclei di popolazione che ne venivano di conseguenza espulsi.
Pag. 97
Ovviamente non possiamo essere certi che tutte queste prefetture di immigrati siano state costituite proprio all’epoca di Costantino.
La Notitia Dignitatum ne elenca sei anche in Gallia, una regione che non è menzionata dalle fonti fra quelle in cui vennero distribuiti i profughi del 334; è prudente, dunque, non considerare questo organigramma come lo specchio esatto degli uffici aperti da Costantino per gestire l’immigrazione sarmatica.
Resta il fatto che l’ondata di profughi accolta sotto di lui è la prima, e probabilmente la più consistente, e che a questa vicenda va fatta risalire la presenza in certe aree dell’Impero e della stessa Italia, do comunità di immigrati sarmati stabilmente integrate nel tessuto amministrativo - anche se la loro origine barbarica implicava, almeno per la prima generazione, l’esclusione dalla cittadinanza, come dimostra appunto l’appellativo di gentiles.
L’ampiezza di questi insediamenti è tale da suggerire che, se nei suoi primi anni di regno Costantino si era preoccupato prevalentemente del reclutamento dell’esercito, in epoca più tarda il problema del ripopolamento sia tornato a farsi urgente come era stato sotto i suoi predecessori; non a caso il poeta Optaziano Porfirio lo elogerà per aver imposto ai barbari accordi di pace grazie ai quali “li rendi tuoi e fai loro coltivare i campi dei tuoi sudditi”.
Pag. 99
Cap. 8. Immigrazione e reclutamento sotto la dinastia di Costantino.
Nel quarto secolo che segue la morte di Costantino nel 337, la gestione dell’immigrazione diventa un problema sempre più incalzante per il governo imperiale.
Può darsi che questa impressione sia accentuata dal fatto che ora disponiamo di fonti più espressive e dirette rispetto a quelle, assai scarne, disponibili per l’età dei tetrarchi e di Costantino, sicché le preoccupazioni degli uomini di governo e le discussioni che precedono le decisioni importanti possono finalmente essere colte con maggiore vivezza.
Ma è un fatto che ora l’accoglienza o la deportazione di immigrati appaiono più raramente il frutto di decisioni unilaterali assunte dagli imperatori, e di campagne offensive deliberatamente pianificate allo scopo, e più spesso come espedienti di una politica di compromesso volta a contenere i barbari che premono sulle frontiere.
Non è sempre facile distinguere fra bande di razziatori che passano il confine per saccheggiare, immigrati clandestini che si insediano abusivamente in zone spopolate, e profughi che chiedono apertamente di negoziare con le autorità romane le condizion di accoglienza; anzi, talvolta si ha l’impressione che sia proprio la linea di condotta attuata dal governo a spingere i barbari verso l’una o l’altra di queste opzioni.
Una faticosa alternanza di concessioni negoziate e di brutale repressione permise comunque all’Impero di contenere la minaccia: se in certe regioni di frontiera, e soprattutto in Gallia, l’insicurezza rimane patologica nel corso del Quarto Secolo, nella stragrande maggioranza delle province la generazione successiva a quella di Costantino è testimone di un’epoca di sostanziale pace e prosperità, soprattutto se confrontata con i rivolgimenti del Terzo Secolo.
Pag. 102-3
L’immigrazione dei franchi. La Gallia, insomma, era un’area in cui più che altrove si sperimentavano, con continuità e su vasta scala, la deportazione e l’accoglienza, al duplice scopo di depotenziare la minaccia barbarica e d rivitalizzare le province; uno sfondo di cui è necessario tener conto per l’altro grande flusso di immigrazione, quello delle tribù franche stanziate lungo i confini più settentrionali della Gallia.
Inizialmente, la loro penetrazione investì una zona che doveva apparire estremamente periferica agli occhi dei romani, il che spiega l’apparente assenza di reazioni.
Fin dal 341-342, svanito ormai il ricordo della disfatta impartita loro da Costantino una generazione prima, i franchi tornano a occupare la zona, evidentemente indifendibile e ormai parzialmente spopolata, del delta del reno, l’antico paese dei batavi.
Gli scavi archeologici confermano che le guarnigioni di frontiera nelle fortezze lungo il fiume erano state in gran parte disciolte; gli abitanti rimasti sembrano essersi concentrati in un piccolo numero di siti fortificati e meglio difendibili, mentre molti profughi erano stati risistemati nell’interno della Gallia sotto l’amministrazione di ben tre praefecti laetorum batavorum.
E’ difficile dire se l’immigrazione dei franchi in quest’area sia avvenuta fin dall’inizio coll’assenso delle autorità romane o se le abbia invece prese alla sprovvista; tuttavia l’imperatore Costante decise di sanzionarla, nominando un prefetto per sovrintendere all’afflusso degli immigrati in quell’estremo settore del confine, dove da tempo la foresta e le acque stavano riprendendo il sopravvento sull’insediamento umano.
Pag. 107
Si è spesso sostenuto che questi franchi, insediati in un paese dov’erano gli unici abitanti, siano il primo esempio di immigrati stanziati su suolo romano con uno statuto di foederati semiautonomi, anche se con obblighi militari.
In questo caso, la novità e le conseguenze potenzialmente disgregatrici dell’accordo stabilito con loro apparirebbero, com’è evidente, considerevoli.
Ma in realtà non c’è motivo di pensare che l’insediamento autorizzato da Giuliano abbia rappresentato una novità rispetto ai precedenti già stabiliti in Gallia fin dall’età dei tetrarchi e celebrati dagli autori dei panegirici, o a quegli insediamenti di alamanni che lui stesso aveva organizzato lungo il medio corso del Reno.
Il paese in cui si insediarono gli immigrati franchi era in gran parte spopolato e bisognoso di manodopera da impegnare nella ricostruzione, e i metodi sbrigativi con cui il comandante romano liquidò ogni velleità di resistenza obbligarono verosimilmente i salii ad accettare quella stessa condizione di dediticii che era stata imposta agli alamanni; insediati su terra abbandonata e quindi acquisita dal demanio, anch’essi si trovarono soggetti, in questo caso, al pagamento delle imposte e alla coscrizione obbligatoria, al pari di tutti gli altri coloni del fisco.
Pag. 111-12
Va invece menzionata qui l’ipotesi, emersa recentemente fra gli studiosi del diritto medievale e trasformata fors’anche troppo rapidamente in certezza, che proprio per regolare i rapporti fra la popolazione indigena e gli ausiliari reclutati fra i salii sia stato emanato già nel Quarto Secolo, ad opera di alti ufficiali romani anch’essi di origine franca, forse identificabili con i praefecti laetorum responsabili di quella comunità, un regolamento militare che costituì poi il nucleo della più tarda Lex Salica.
Anche se la prudenza impone di frenare gli entusiasmi rispetto a questa ipotesi brillante e in definitiva non compiutamente dimostrata, è comunque evidente il suo interesse per il nostro assunto; se dovesse rivelarsi corretta, essa significherebbe che nel testo della legge, pur successivamente rimaneggiato, possediamo una testimonianza assolutamente unica del modo di vita di questi mercenari, e della faticosa convivenza che s’instaurava fra le loro bande e le popolazioni provinciali.
Pag. 112-13
Il fronte barbaro. Mentre il Cesare Giuliano conduceva la sua truppa malpagata e malnutrita a massacrare i franchi e alamanni sul Reno, il suo imperatore era impegnato a sorvegliare quel che accadeva fra i barbari stanziati al di là del Danubio.
Rispetto alla frontiera politica, quella balcanica aveva sempre dato meno preoccupazioni a Costanzo Secondo, grazie soprattutto alle energiche misure di pacificazione adottate da suo padre Costantino.
In particolare, l’accordo stipulato dai goti nel 332 aveva neutralizzato per un lungo periodo questo popolo, e anzi avviato in qualche misura la sua integrazione nel mondo romano.
Nel suo elogio di Costanzo Secondo e Costante, composto fra il 344 e il 349, Libanio constata con soddisfazione che quei barbari si tengono tranquilli, non minacciano più la frontiera danubiana “e trattano il nostro imperatore come se fosse dei loro”.
Eutropio, che scrive più tardi, ma comunque prima della catastrofe di Adrianopoli, conferma che Costantino, concedendo la pace ai goti sconfitti, aveva “lasciato un grato ricordo fra i barbari; e non è un caso che nella successiva tradizione gotica proprio Costantino sia stato ricordato come l’iniziatore di una duratura amicizia fr ai due popoli.
Pag. 115-16
Sul contesto ideologico e l’impatto propagandistico di queste misure di deportazione offre una testimonianza importante l’Itinearium Alexandri, operetta anonima dedicata a Costanzo Secondo, che rievoca i trionfi di Alessandro Magno contro i persiani nel momento in cui l’imperatore romano sta intraprendendo a sua volta un’impegnativa campagna contro lo stesso nemico.
Fra gli scopi della guerra l’autore colloca senz’altro al posto d’onore quello di reinsediare sul suolo romano, e avviare a un futuro di libertà e di integrazione, quelle moltitudini che gemono sotto l’oppressione dell’Impero persiano: “accolti infine per opera tua nel nome di nostri e ricevuta in dono la cittadinanza romana entro le vostre province, imparino ad essere liberi per beneficio di chi governa, essi che là per la superbia dei re sono considerati tutti soldati in tempo di guerra e servi in tempo di pace”.
Questo testo straordinario dà la misura di quanto l’ideologia dell’assorbimento e dell’integrazione fosse diventata centrale nell’orizzonte politico dell’Impero e offre una delle rare risposte inequivocabili a un interrogativo cruciale: in che misura, cioè, fosse presupposta la concessione della cittadinanza romana alle popolazioni accolte o deportate all’interno dell’Impero.
Se proviamo a trarre un bilancio delle vicende fin qui analizzate, è difficile negare che per l’epoca di Costanzo Secondo e Giuliano esso appare complessivamente in attivo.
Anche se le province di frontiera hanno avuto ben poco respiro, nell’insieme la difesa dell’Impero ha tenuto e anzi ha spesso lasciato il posto a iniziative aggressive, più o meno fortunate.
L’amministrazione ha elaborato procedure efficienti per gestire accoglienza di profughi e trasferimenti forzati di deportati, ha messo in piedi una rete di uffici specializzati nello stanziamento e nella sorveglianza degli immigrati ed è in grado di far fronte con minimo preavviso ogni volta che una convenienza politica o un’emergenza umanitaria persuadono il governo ad autorizzare l’apertura delle frontiere.
L’esercito si è ormi abituato a contare largamente su reclute nate all’estero, senza che questa trasformazione del materiale umano sia percepita come un rischio per la disciplina della truppa.
L’Impero, in sostanza, si è attrezzato per gestire al meglio l’emergenza, ogni volta che per un motivo o per l’altro si decide di introdurre in territorio romano nuclei di popolazione barbarica, senza che questo inibisca in alcun modo il ricorso a una linea dura in caso di bisogno.
e se la terminologia amministrativa sottolinea spesso, concretamente, che al loro arrivo nell’Impero questi immigrati sono gentiles, e dunque estranei ala cittadinanza romana, tutto lascia pensare che in una prospettiva di più lungo periodo la loro trasformazione in sudditi a pieno titolo, e dunque in cittadini, fosse data tranquillamente per scontata.
Pag. 123-24
Cap. 9. Ideali umanitari e sfruttamento degli immigrati sotto Valentiniano e Valente.
Non è un caso che proprio all’epoca di Valentiniano, e in circoli vicinissimi al trono, si manifesta con insistenza un’ideologia, non sapremmo dire se umanitaria o utilitaristica, per cui i barbari non sono più dei subumani da sterminare come animali nocivi, ma una risorsa che conviene risparmiare a impiegare con oculatezza.
Nelle orazioni pronunciate al cospetto degli imperatori, la gloria di Roma non si identifica più con la moltitudine dei nemici uccisi, ma con l’umanità del vincitore benevolo che sa fermare il suo braccio, risparmiare gli sconfitti e trarre profitto dal loro lavoro.
Intorno al 370 Simmaco assicura Valentiniano vincitore degli alamanni, che ha guadagnato molto di più dimostrandosi clemente anziché spopolando il loro paese: “ora l’abitante dell’Alamannia vive per te; quelli che sottrai al ferro, li aggiungi all’Impero.”
Segue un quadro idillico dello zelo con cui i barbari, sotto la sorveglianza delle guarnigioni romane impiantate nel loro paese, lavorano alla manutenzione dei posti fortificati che preannunciano l’arrivo dell’autorità imperiale e della civiltà.
Spostandoci dall’Occidente all’Oriente, verificheremo ora un impressionante parallelo fra l’argomentazione dell’oratore latino e quella, del tutto identica, rivolta negli stessi anni dall’oratore greco Temistio al fratello di Valentiniano, Valente: cambia il popolo di cui si parla, che là sono i goti e non più gli alamanni, ma identico è l’approccio di un’élite burocratica e intellettuale che con ogni evidenza, di fronte al bisogno di manodopera e di reclute di cui soffre l’Impero, ha sposato la linea di un progressivo allargamento ai barbari dei benefici del governo e della civiltà romana.
Pag. 128
Nella reazione del mondo romano a questo afflusso inaspettato di manodopera a basso costo si intravvede una contraddizione di fondo, che avrà ben presto conseguenze catastrofiche.
Tutto ciò che sappiamo del trattamento riservato ai goti quando venivano a contatto con la società romana contrasta drasticamente con la prospettiva filantropica enunciata da Temistio e di cui si compiaceva la corte imperiale.
Lo stato d’animo generalizzato dei funzionari e dei latifondisti, per non parlare dei militari, nei confronti dei barbari sembra essere stato spavaldamente predatorio, come davanti a un materiale umano abbondante e a buon mercato, che poteva essere sfruttato senza scrupoli.
Sul piano puramente militare, al familiarità acquisita con i goti e l’abitudine a considerarli come schiavi o poco più, anche quando si trattava di manodopera libera, provocò quel pericoloso senso d falsa sicurezza denunciato più tardi da Eunapio, per cui di gente del genere non si poteva davvero aver paura.
Ma più in generale, l’inadeguatezza di un approccio di puro sfruttamento, che smentiva lo spirito umanitario dei discorsi ufficiali, si manifestò clamorosamente con l’emergenza del 378: quando non fu l’afflusso inatteso di immigrati ma la sua disastrosa gestione a produrre la catastrofe di Adrianopoli.
Pag. 132
Certamente l’afflusso dei profughi si rivelò maggiore di quello che Valente, nella lontana Antiochia, aveva potuto prevedere; e altri continuavano ad arrivarne, sospinti dalla notizia che il confine era aperto e che i romani stessi traghettavano gli immigrati sulla loro sponda.
A un certo punto le autorità si allarmarono e quando nuovi capi, alla testa di convogli ben organizzati, si presentarono alla frontiera facendo esplicitamente appello all’aiuto umanitario che speravano di ricevere, si sentirono dire che non c’era più posto.
Sulla riva settentrionale del fiume crebbe dunque la moltitudine accampata, e sempre più apertamente ostile all’incomprensibile Impero che tutt’a un tratto le rifiutava l’accesso, mentre le imbarcazioni romane, interrotte le operazioni di trasbordo, ora pattugliavano il fiume per impedire sbarchi clandestini.
Pag. 136
Cap. 10. Teodosio e il tentativo di assimilare i goti.
La gravità della rottura consumata tra il 378 e il 378 non si misura tanto col fatto che una moltitudine di barbari ostili fosse entrata, più o meno a forza, sul territorio dell’Impero e stesse devastando la Tracia.
Una catastrofe del tutto analoga si era già verificata nel Terzo Secolo e solo l’estrema scarsità delle fonti può dare l’impressione, scuramente erronea, che si fosse trattato di vicende meno drammatiche e sensazionali.
Ciò che conferisce alla battaglia di Adrianopoli una portata epocale è il comportamento successivo del governo imperiale, che dopo la distruzione dell’esercito di Valente non giudicò possibile affrontare l’emergenza esclusivamente con la forze e nell’arco di alcuni anni negoziò con gran parte dei capi gotici una serie di concessioni destinate a provocare, in breve tempo, conseguenze destabilizzanti.
Ma se gli accorsi stipulati con gli invasori fra il 379 e il 382 segnano ai nostri occhi l’apertura di una fase nuova e dirompente nella storia delle relazioni fra l’Impero romano e i barbari, non è meno importante rilevare che essi rappresentavano, per altro verso, una naturale prosecuzione della politica dell’immigrazione praticata nei due secoli precedenti; e che i loro effetti risultarono imprevedibili più per i mutati rapporti di forza che per un’effettiva novità delle misure adottate.
Pag. 140
All’indomani della sconfitta di Valente il nuovo imperatore d’Oriente, Teodosio, e il suo collega Graziano dovettero tamponare la falla in condizioni di emergenza.
Nella maggior parte dei casi questo significò venire a patti con la moltitudine di goti che erano entrati in armi, con le loro famiglie e il loro bestiame, sul territorio dell’Impero.
Sulla carta, gli accomodamenti stipulati con questa pericolosa controparte si presentavano ancor sempre come regolamentazioni autoritarie dell’immigrazione da parte di un governo imperiale pienamente in controllo della situazione, per quanto in pratica la situazione sia poi sfuggita di mano.
In questo capitolo, più che soffermarci sugli esiti imprevisti degli accordi stipulati coi goti, ci proponiamo di analizzare l’atteggiamento con cui i governanti romani intrapresero il negoziato con gli immigrati ribelli, cercando di valutare le loro proposte e le loro aspettative alla luce dell’esperienza pregressa, piuttosto che d’un futuro di cui essi non sapevano nulla.
Pag. 141
Gli accordi del 382 sono entrati nella tradizione storiografica come una svolta epocale, che introdusse le basi giuridiche per l’integrazione del popoli germanici nel mondo romano-cristiano, ma che al tempo stesso aprì la strada verso la dissoluzione della sovranità territoriale dell’Impero.
Questa prospettiva, tuttavia, comincia ad emergere dal groviglio degli avvenimenti soltanto se le decisioni prese dal governo imperiale sono analizzate insieme alle loro conseguenze di medio e lungo periodo, come infatti avviene in quasi tutti gli studi.
Se invece proviamo a valutare la situazione utilizzando soltanto gli elementi di cui potevano disporre all’epoca Teodosio e i suoi consiglieri, l’impressione è che gli accordi presi con i goti apparissero loro come la prosecuzione di una politica seguita già da tempo immemorabile nei confronti dei potenziali immigrati e che le conseguenze epocali non fossero state minimamente previste.
Di per sé, rilevare che le decisioni prese dai politici sono spesso foriere di conseguenze inattese non sarebbe certo una scoperta; ma il punto da rilevare qui è che i negoziatori del 382 non stavano affatto introducendo novità sostanziali sul piano giuridico, e neppure culturale, e che fu soltanto l’impossibilità pratica di gestire gli accordi nei termini in cui erano stati originariamente concepiti a provocare un effetto destabilizzante di cui ci si rese conto troppo tardi.
Pag. 149
Se dai soldati incorporati nell’esercito allarghiamo lo sguardo sino a considerare l’insieme della popolazione gotica accolta sul suolo romano, sembra indiscutibile che nella prospettiva del governo imperiale quegli immigrati fossero destinati all’assimilazione, impiegando una categoria che è antropologica più che giuridica, perché com’è noto a partire dall’età di Costantino non sono più documentate procedure formali di concessione della cittadinanza romana; e in questa evoluzione molti studiosi scorgono il sintomo di una generale perdita di importanza del concetto stesso di cittadinanza, vanificato dal potere assoluto che l’autocrate esercitava ormai sui suoi sudditi.
“All’interno dell’Impero, la nozione stessa di cittadinanza romana si era largamente dissolta dopo il Terzo Secolo”, è stato scritto di recente.
E in un certo senso è davvero così, se s’intende che nella percezione comune, ma anche nella pratica giuridica, tutti gli abitanti dell’Impero godevano ormai degli stessi diritti in conseguenza dell’Editto di Caracalla, il cui ricordo era ancora vivo e celebrato; mentre i barbari, un termine che non a caso si era specializzato a indicare le popolazioni esterne all’Impero, ne erano ovviamente esclusi.
Pag. 155
Certamente la cittadinanza romana non era più intesa, se non nella retorica più tradizionalista, come una condizione giuridica speciale e privilegiata, ma era semplicemente la condizione comune di coloro che erano sudditi dell’Impero e vivevano secondo le leggi romane; dal nostro punto di vista, però, ciò che è rilevante è proprio il fatto che questo tipo di assimilazione fosse proposto come ovvio agli immigrati – esattamente come avverrà in età giustinianea, quando è ben documentata la piena confluenza del concetto giuridico di cittadinanza in quello di appartenenza alla Romaion politeia e sudditanza all’imperatore.
Pag. 157
Negli stessi anni in cui Prudenzio scriveva il Contro Simmaco, a Costantinopoli Giovanni Crisostomo predicava ai goti sforzandosi di convertirli dall’arianesimo all’ortodossia.
In un sermone pronunciato nel 399, durante una messa concelebrata insieme a un prete goto e con una liturgia letta almeno in parte in lingua gotica, il patriarca spiegò che era motivo di orgoglio avere nel suo gregge tanti barbari avvicinatisi a Cristo; e aggiunse che non c’era niente di strano al vedere dei barbari che partecipavano alla messa e addirittura si alzavano a parlare davanti alla congregazione, perché dopo tutto anche Abramo e Mosè, agli occhi dei contemporanei, sarebbero apparsi dei barbari.
Nonostante tutti gli avvenimenti traumatici che avevano scosso l’Impero, l’integrazione dei barbari in una prospettiva filantropica o religiosa continuava a rappresentare il motivo dominante dei discorsi ufficiali; agli occhi di Sinesio tanta coerenza sarebbe forse sembrata incoscienza, ma è evidente che ai vertici del potere imperiale, come in quello ecclesiastico, la linea ufficiale era e non poteva essere altro che quella.
Pag. 159
Cap. 11. Truppe limitanee e impiego dei barbari a difesa delle frontiere.
Quando descrivono le condizioni offerte da Teodosio ai goti le fonti coeve utilizzano, come si è visto, un linguaggio estremamente generico: i barbari ricevettero terra e prestarono servizio militare.
Se ci sforziamo di riempire queste indicazioni di contenuti più precisi, dal punto di vista giuridico e amministrativo, siamo costretti ad accontentarci di ipotesi, rafforzate, nel migliore dei casi, dal confronto con i precedenti cui l’amministrazione romana può aver fatto riferimento.
In un contesto così incerto, è opportuno esplorare tutti gli ambiti che in qualche modo possono aver interferito con gli accordi degli anni successivi al 378, suggerendo a Teodosio e ai suoi consiglieri le misure da adottare nell’emergenza.
Per prima cosa faremo il punto di quel che sappiamo sull’organizzazione delle truppe limitanee, a cui, in condizioni normali, era demandata la difesa delle frontiere, e che in taluni aree dell’Impero, come vedremo, erano già a questa data integrate da gruppi barbarici.
Pag. 160
Assegnazioni di terra e reclutamento di barbari. C’è tuttavia una zona dell’Impero, l’Africa, in cui sono precocemente documentate sia l’assegnazione di terre pubbliche ai reparti limitanei, sia la loro parziale sostituzione con bande autonome di barbari, precariamente inquadrate negli organici amministrativo e anch’esse ricompensate per mezzo di concessioni fondiarie.
Il quadro che ne esce è così diverso da quello sin qui ricostruito, da suggerire che si sia trattato di uno sviluppo proprio dell’area africana e finché non emergeranno concreti riscontri non è prudente supporne l’estensione ad altre aree di frontiera, come quella renana o danubiana.
Esso è tuttavia fortemente suggestivo di come, quando la situazione lo richiedeva, l’amministrazione imperiale fosse capace di gestire con estrema flessibilità le risorse offerte dalla presenza dei barbari, per assicurare in un modo o nell’altro la difesa delle frontiere.
Pag. 169
Tutto suggerisce, insomma, che l’assunzione di una milizia indigena per la difesa contro i predoni, inquadrata da ufficiali locali più o meno romanizzati, abbia rappresentato una soluzione innanzitutto africana; e che l’abitudine, precocemente documentata in questa zona, di assegnare terre ai militari dislocati lungo la frontiera, rispondesse proprio alla necessità di ricompensare, e magari in prospettiva di fissare a una residenza stabile, questo personale indigeno, che a differenza dei reparti regolari non era trasferibile d’ufficio in qualsiasi altra provincia dell’Impero.
Entrato in uso già da tempo, tanto che Onorio nel 409 può parlarne come di un ordinamento antico, questo arrangiamento rimane comunque assai suggestivo della flessibilità con cui le autorità romane sapevano utilizzare in corrispondenza alle condizioni locali le risorse umane rappresentate dalle popolazioni barbariche.
Pag. 176
Cap. 12. Una leggenda storiografica: i “laeti”.
Benché smentito dalla storiografia più recente, il presupposto che fosse consueta nell’Impero l’assegnazione di terre pubbliche ai reparti militari, e in particolare ai limitanei stanziati nelle province di frontiera, condiziona ancor oggi l’interpretazione di un’istituzione, quella del laeti, che ebbe un ruolo centrale nella gestione dell’immigrazione, specialmente nell’area del Reno.
Secondo una teoria largamente diffusa nella storiografia e nell’archeologia del Novecento, in Gallia l’afflusso di barbari verso l’Impero sarebbe stato alimentato dalla disponibilità del governo a creare nelle zone di confine, e lungo i principali assi viari, una sorta di milizia barbarica, composta da immigrati stanziati in armi con le loro famiglie.
A ciascuno di questi insediamenti sarebbero state assegnate in perpetuo delle terre che i guerrieri barbari avrebbero potuto coltivare, garantendo al tempo stesso la difesa locale.
Sarebbe questa la logica sottostante a quegli stanziamenti di laeti da cui si incontrano le prime menzioni all’epoca della tetrarchia, e che vennero poi affidati alla gestione di apposite prefetture, elencate nella Notitia Dignitatum.
La constatazione che dopo tutto il governo, a quell’epoca, non assegnava affatto terre alla truppa non è stata sufficiente per distruggere uno stereotipo ormai troppo profondamente radicato: anche in opere recenti, le comunità dei laeti continuano continuamente ad evocare l’immagine di gruppi armati, insediati sul territorio, in base a un disegno strategico.
Essi avrebbero costituito “una gendarmeria barbara”, insediata in guarnigioni fortificate dalle connotazioni pesantemente etniche; le autorità imperiali avrebbero fatto sempre più volentieri ricorso all’”installazione di guarnigioni di frontiera, composte essenzialmente di immigrati”; la difesa della Gallia sarebbe stata affidata in misura crescente (qui però il linguaggio si fa meno preciso)a queste “unità di limitanei composte da immigrati, fino a lasciare “il fronte del Reno quasi interamente nelle mani di unità etniche”.
Pag. 177-78
Anche se le nostre fonti insistono che ogni rimpatriato fu restituito alla sua provincia, è improbabile che si sia ricollocato ciascuno esattamente nel villaggio d’origine e sui campi che gli erano appartenuti, in una situazione in cui molti villaggi erano stati bruciati e i campi erano tornati boscaglia.
L’esperienza del Novecento lascia pensare che in condizioni del genere, dovendo ricollocare una folla di migliaia e forse decine di migliaia di profughi, le sottigliezze giuridiche siano passate in secondo piano, e la gente sia stata reinsediata collettivamente, in base a un programma complessivo di ripopolamento.
Proprio questo, d’altronde, è il quadro tratteggiato dall’autore del panegirico di Costanzo, quando accomuna l’ex-prigioniero rimpatriato e il barbaro sconfitto, impegnati fianco a fianco a rimettere a coltura i campi abbandonati.
Si giustifica allora l’ipotesi che fin dall’epoca della tetrarchia il reinsediamento di profughi sia avvenuto, al pari dell’installazione di immigrati o deportati, essenzialmente su terre demaniali o che tali erano diventate dopo la desertificazione.
Pag. 182-83
Rimane da spiegare perché i rimpatriati siano definiti laeti.
Il termine ha suscitato la perplessità degli studiosi, che lo ritengono inspiegabile, pur subodorando un’origine germanica.
In realtà, basta osservare che il termine è lo stesso che nella Lex salica designa i liberti, cioè gli schiavi liberati, per capire che il senso di fondo è quello della liberazione, lo stesso che si ritrova nel tedesco moderno (Frei)lassen.
Evidentemente, l’abitudine a negoziare con i capi germanici il rilascio dei prigionieri romani da loro detenuti introdusse anche nel latino dell’epoca il termine impiegato a questo proposito dai germani stessi.
E non si può escludere che la burocrazia imperiale abbia apprezzato l’umorismo d’un termine che in latino, per una falsa analogia, sembrava implicare un’idea di allegrezza, anch’essa ben compatibile con la condizione dei rilasciati e con la saeculi felicitas celebrata dal medaglione di Lione.
Pag. 184
Non c’è dubbio che oltre alle braccia per lavorare la terra, il governo vedesse negli immigrati innanzitutto un bacino di reclutamento per l’esercito.
L’analisi fin qui condotta appare però poco e nulla compatibile con il postulato, di cui si è già segnalata l’inconsistenza, per cui ciascun insediamento avrebbe costituito una colonia militare, armata e semiautonoma.
Rimane da verificare se, come ritengono diversi studiosi, gli insediamenti di laeti abbiano comunque costituito un settore a sé stante nell’organigramma dell’esercito, alimentando col loro reclutamento unità di tipo particolare.
Secondo questa ipotesi, ad ogni insediamento di una certa ampiezza avrebbe corrisposto un’unità militare, che lì avrebbe reclutato i suoi uomini; per cui si sarebbe verificata una corrispondenza fra insediamenti di laeti sotto il controllo dei prefetti regionali e “i numeri barbarici che, appoggiandosi a tali ‘prepositure’, venivano via via allestiti”.
In questa prospettiva, i praefecti dei laeti sarebbero da intendersi non, o non solamente, come funzionari militari incaricati di stanziare e sorvegliare gli immigrati, ma anche come i comandanti si specifiche unità militari.
Pag. 189-90
L’ipotesi che ogni prefettura costituisse, oltre a un’impalcatura amministrativa, anche un’unità militare stanziata nella stessa zona al comando de praefectus si rivela dunque, a un esame più ravvicinato, priva di puntuali conferme nelle fonti.
Per contro, diverse testimonianze suggeriscono che le comunità di immigrati insediate su terra pubblica e sottoposte al controllo dei praefecti laetorum fossero soggette al reclutamento nelle forme abituali, le stesse che vincolavano parecchie altre categorie della popolazione e che consentivano alle autorità di prelevare i giovani e inquadrarli liberamente in qualsiasi reparto.
Vanno in questo senso il passo già citato di Ammiano Marcellino, per cui Giuliano si proponeva di arruolare i giovani laeti nei reggimenti destinati a partire per l’Oriente, e ancor più chiaramente un rescritto di Arcadio e Onorio, indirizzato nel 400 a Stilicone per reprimere le frodi di quei militari che abbandonavano i reparti prima di aver completato il servizio, con la complicità dei superiori che non esitavano a rilasciare falsi certificati di congedo.
Pag. 191
Sui confini di un impero multiculturale, con una popolazione rurale continuamente rimodellata attraverso l’immigrazione e le deportazioni, difeso da un esercito che da sempre assumeva e assimilava barbari, governato da un’amministrazione civile essa stessa in via di militarizzazione, e dove per ogni grande burocrate o latifondista bisogna dare per scontata la presenza di un gran numero di guardie del corpo e concubine, per lo più di origine barbara come la Bissula di Ausonio, avere troppa fiducia nell’etnicità dei ritrovamenti archeologici rischia insomma di essere fuorviante.
Ma soprattutto, appare improponibile pretendere di ricavare dai ritrovamenti di fibule e orecchini una carta dettagliata dei luoghi in cui si sarebbero insediati nuclei compatti di barbari, o di dedurne la percentuale rispettiva di indigeni e immigrati nella popolazione complessiva.
La teoria per cui lungo i confini e gli assi stradali della Gallia sarebbero state capillarmente insediate, nel corso del Quarto Secolo, comunità semiautonome di guerrieri germanici, al servizio del governo imperiale e rimunerate con concessioni di terra pubblica, si rivela, alla fine, altrettanto fragile sul piano archeologico quanto su quello delle fonti scritte.
Pag. 197-98
L’archeologia e gli stanziamenti dei coloni. Si deve dunque concludere che l’archeologia non è in grado di aiutarci concretamente nello studio dell’immigrazione verso l’Impero?
In realtà non è così.
Altri tipi di ritrovamento, che ci informano ad esempio sulle tecniche di costruzione, possono mostrare connotazioni etniche più solide rispetto alla fattura d’una fibbia o alla presenza di un cinturone.
Da poco, gli archeologi hanno cominciato ad offrirci qualche informazione su insediamenti mol verosimilmente germanici, che però non corrispondono affatto alle fantasie sulle guarnigioni armate di laeti, e permettono invece di gettare uno sguardo sui modi concreti di insediamento degli immigrati e dei deportati accolti come manodopera agricola.
Scavi recenti hanno portato alla luce a St. Ouen-du-Breuil, in Normandia, e dunque decisamente all’interno della Gallia, un insediamento dalle caratteristiche edilizie inconfondibilmente mutuate da quelle in uso in Germania, composto da una ventina di abitazioni in legno, impiantato, a giudicare dai ritrovamenti monetari, intorno alla metà del Quarto Secolo, e rimasto in uso per due o tre generazioni.
L’assenza di armi esclude che si trattasse di un insediamento di natura militare, è più probabile che ci troviamo di fronte a un insediamento di coloni, provenienti dagli attuali Paesi Bassi o dalla Germania nord-occidentale, che costruirono le proprie case secondo le tecniche cui erano abituati.
E’ da sistemare e sorvegliare gente del genere che si occupavano, con ogni probabilità, quei praefecti laetorum in cui si è voluto vedere in passato, senza alcuna prova, dei comandanti di unità militari.
Pag. 198-99
Analoghe condizioni sono state individuate nella zona d’insediamento concessa da Giuliano ai franchi salii nel 358, quella che le fonti antiche chiamano Toxandria.
Qui, come si ricorderà, non è venuta alla luce alcuna sepoltura con armi; in compenso, sul sito d’una importante villa romana poco a nord di Maastricht, distrutta o abbandonata prima della fine del Terzo Secolo, sono emerse le tracce inequivocabili di una rioccupazione del suolo, cominciata a giudicare dalle numerosissime monete proprio intorno al 360, ad opera di contadini che costruivano le loro capanne infossate nel suolo, secondo un modello di insediamento del tutto estraneo alla tradizione rurale galloromana, e utilizzavano indifferentemente ceramiche di fattura romana o germanica.
Qui, come in altri siti analoghi, siamo di fronte a tracce concrete dell’insediamento di immigrati, che tuttavia non hanno nessuna delle connotazioni militari abitualmente associate ai foederati.
Essi sembrano invece aver costituito piccole comunità di contadini e pastori, integrate nel tessuto economico e sociale della Gallia romana, se è vero che in qualche caso i siti erano occupati contemporaneamente da autoctoni e immigrati, mentre in altri i nuovi venuto si installavano, o erano installati, in prossimità dei forti, sotto la protezione e la sorveglianza dell’esercito regolare.
Un modello di stanziamento, quasi ultimo, di cui abbiamo già incontrato diversi esempi, anche su altre frontiere dell’Impero, e che può aver rappresentato, esso sì, una procedura abituale da parte delle prefetture incaricate di sovrintendere all’immigrazione.
Pag. 199
Cap. 13. L’esercito come “melting-pot”.
L’analisi condotta negli ultimi due capitoli sull’organizzazione delle truppe limitanee e sull’impalcatura amministrativa delle praefecturae laetorum non hanno messo in evidenza alcun elemento che possa smentire le conclusioni raggiunte analizzando la politica di Teodosio negli anni immediatamente seguenti al 378: per cui l’imperatore cercò di normalizzare i rapporti con i goti soprattutto stanziando le loro famiglie su terre pubbliche e arruolando gli uomini abili alle armi nei reggimenti dell’esercito regolare.
Il fatto che non ci sia alcuna traccia di praefecturae gothorum istituite per gestire stanziamenti e arruolamenti suggerisce che quelle misure vennero adottate, sotto la pressione dell’urgenza, in modo più sommario e urgente del solito: in particolare, è possibile che si sia fatto ricorso più del consueto alla creazione di reggimenti nuovi, destinati a essere stanziati nella stessa area in cui erano state accolte le popolazioni da ci provenivano le loro reclute; ma rimane comunque l’impressione che il governo imperiale si illudesse di aver avviato la soluzione dell’emergenza gotica senza allontanarsi troppo da modalità già collaudate e di esito generalmente felice.
Questa interpretazione comporta, ovviamente, un assunto: che cioè la cosiddetta barbarizzazione dell’esercito, ovvero l’inclusione nei ranghi di una crescente percentuale di coscritti e volontari nati al di fuori dell’Impero, non abbia comportato nel corso del Quarto Secolo quel peggioramento nella qualità dei reparti combattenti e della loro fedeltà che è stato spesso supposto dalla storiografia.
Importanti studi dedicati all’esercito tardoimperiale hanno già ampiamente segnalato che nei confronti di questo luogo comune è opportuna una revisione; in questo capitolo vedremo come nel complesso la barbarizzazione degli effettivi non abbia affatto determinato, almeno fino ai primi anno di Teodosio, un deterioramento dell’immagine dell’esercito, né un venir meno del suo duplice ruolo, quello ufficiale di pilastro del potere imperiale, e quello ufficioso di melting-pot in cui si compiva la romanizzazione degli immigrati.
Ancora una volta, la maggior familiarità della nostra epoca con il funzionamento delle società multietniche ci permette, forse, di valutare questi aspetti, evitando i pregiudizi inconsci che influenzano il giudizio degli storici nell’età degli stati nazionali.
Pag. 200-1
Questo fenomeno ha molto colpito la storiografia fra Ottocento e Novecento, così dominata dalla prospettiva nazionale e non è un caso che sia stato studiato soprattutto da storici tedeschi.
Oggi, tuttavia, accade di guardarlo con occhio diverso; e se un riferimento di attualità si impone, è piuttosto l’esercito americano, quello cioè di un paese multietnico, largamente aperto all’immigrazione, e tuttavia dotato di una indiscutibile coesione nazionale.
Il fatto che al tempo della guerra del 2003 contro l’Iraq il segretario di Stato ed ex ministro della Difesa, Colin Powell, fosse un immigrato dalla Giamaica, che il capo di Stato maggiore dell’esercito fosse un figlio di giapponesi di nome Shinseki e il comandante sul campo si chiamasse Ricardo Sanchez non inficiava in alcun modo la loro natura di generali americani.
Ed è certamente in questa prospettiva che dobbiamo guardare a quei militari di origine barbara che salirono ai massimi gradi dell’esercito e della corte imperiale.
Pag. 205
Cap. 14. Il fallimento dell’integrazione gotica.
Il percorso sin qui seguito ci permette di comprendere meglio l’ottimismo che regnava fr ai gruppi dirigenti dopo che i negoziati di Teodosio con i barbari ebbero permesso di raddrizzare una situazione già paurosamente compromessa, consentendo come per miracolo di trasformare in una risorsa vitale per l’Impero quei nemici che avevano minacciato di disgregarlo.
La capacità di integrare i barbari e utilizzare la loro forza lavoro per ripopolare le campagne e riempire i ranghi dell’esercito era sempre stata uno dei segreti del successo dell’Impero; e perciò abbiamo motivo di pensare che almeno all’inizio l’ottimismo ufficiale si astato davvero condiviso da molti.
L’entusiastico sostegno espresso dalla pubblicistica greca e latina alla politica di accoglienza e assimilazione condotta dall’imperatore nei confronti delle moltitudini gotiche e dell resto la prosecuzione diretta d’una linea che s’era già affermata all’epoca di Costanzo Secondo, Valentiniano e Valente; in essa si ritrovano accomunati, pur nella diversità delle occasioni e dei toni, influentissimi politici della capitale come Temistio e portavoce degli interessi provinciali, sia orientali come l’antiocheno Libanio, sia occidentali come il galloromano Pacato.
Pag. 219
A questo punto, tuttavia, il peggio era già accaduto, anche se a farne le spese in quegli anni era sempre più chiaramente soltanto l’Impero d’Occidente.
Se il fallimento dell’esercito di Teodosio nel gestire l’integrazione dell’enorme quantità di reclute gotiche e il pauroso declino della disciplina nei reparti sopravvissuti alla catastrofe di Adrianopoli possono anche apparire fenomeni contingenti, per contro l’incapacità delle autorità militari d’Oriente di costituire un’ordinata struttura di praefecti gothorum per gestire lo stanziamento degli immigrati, come si era fatto con i laeti e con i sarmati in Gallia e in Italia, e il sempre più frequente ricorso ai goti non come coscritti per i reggimenti ma come mercenari autonomi sotto capi propri rappresentano un fattore cruciale per comprendere il disastro che l’Impero sfiorò in Oriente e in cui finì per sprofondare in Occidente nei decenni successivi al 378.
Pag. 225
Di questo moltiplicarsi delle assunzioni di mercenari le fonti coeve offrono una chiara testimonianza.
Benché sappiamo benissimo che anche la truppa regolare è composta soprattutto da reclute di origine barbarica, gli autori di quest’epoca individuano un drastico spartiacque fra i soldato dell’esercito, che avevano prestato giuramento di fedeltà all’imperatore e vivevano tutta la loro vita nell’orizzonte del servizio, del reggimento e della carriera, e le bande di mercenari accolte nell’Impero sotto capi propri.
Così, sant’Ambrogio discutendo nel 388 proprio con l’usurpatore Magno Massimo traccia una distinzione puntigliosa fra il “soldato romano” e i mercenari barbari reclutati oltre i confini dell’Impero (turbas translimitanas); così Sozomeno, raccontando la campagna di Teodosio nel 394 contro l’altro usurpatore Eugenio, ricorda “che il suo esercito consisteva non soltanto di soldati romani, ma di bande di barbari provenienti dalle rive del Dnestr”, ovvero di mercenari goti.
Pag. 226
Dal punto di vista militare, può ben darsi che i mercenari sapessero fare il loro mestiere come e meglio dei soldati.
Proprio Sinesio, ricordiamolo, era entusiasta dell’efficienza con cui i mercenari unni proteggevano i latifondi dai razziatori berberi, mentre non nascondeva il suo disprezzo per la corruzione e la vigliaccheria dei militari.
Non c’è niente di strano, dunque, nel fatto che la società abbia continuato a funzionare più o meno bene anche là dove i goti assumevano il controllo; ma se al centro dell’attenzione, anziché la società, c’è lo Stato, la conclusione deve essere diversa.
Le scorrerie Alarico e dei suoi mercenari insoddisfatti della paga, cominciate proprio all’indomani della grande battaglia contro l’usurpatore Eugenio e conclusesi, più di vent’anni dopo, con il loro stanziamento semi-indipendente nella Gallia meridionale, nucleo del primo regno romano-barbarico, sono soltanto l’esempio più noto degli effetti disgreganti prodotti dalla presenza nel suolo romano di bande mercenarie che di fatto sostituivano i soldati imperiali.
Tutto quello che sappiamo del funzionamento dell’Impero romano ci spinge a concludere che dove non c’erano più i soldati, dove il meccanismo faticoso degli acquartieramenti e delle requisizioni, la sorveglianza delle strade e il mantenimento dell’ordine pubblico, non erano più gestiti dall’esercito regolare, ma da capi mercenari giunti sul posto con un mandato poco chiaro e con bande di guerrieri né inquadrati né disciplinato, l’Impero in pratica aveva cessato di esistere.
Pag. 230-31
Conclusione.
A partire al più tardi dalla crisi del Terzo Secolo, l’immigrazione rappresentò per l’Impero romano una risorsa indispensabile.
Tanto il ripopolamento delle campagne spopolate dalla guerra e dalle epidemie, quanto il reclutamento di un esercito ossessionato dalla fame di uomini, finirono per dipender in larga misura dalla capacità del governo di accogliere immigrati o, in caso di bisogno, di organizzare deportazioni forzate verso l’interno dell’Impero.
Nonostante l’estrema brutalità con qui queste operazioni venivano normalmente condotte, e la paurosa corruzione degli apparati incaricati di gestirle, esisteva comunque un consenso di fondo sulla necessità di questa manodopera, e sull’opportunità di favorirne l’assimilazione.
Questa priorità politica si rispecchia nell’enfasi posta dalla cultura ufficiale sull’universalismo dell’Impero, sui doveri dell’imperatore come padre e protettore dell’intero genere umano e sull’obbligo morale di estendere la Romana felicitas a tutti i popoli che vi aspiravano.
In confronto all’ampiezza assunta da questa retorica ufficiale, appare decisamente minoritaria la corrente allarmistica che nel tardo Quarto Secolo prese ad additare con acredine i pericoli dell’immigrazione, fino a dar vita a quella che viene tradizionalmente definita la reazione anti barbarica.
Questa linea assimilazionista era, naturalmente, espressione di un’autocrazia che riteneva l emani completamente libere per attuare qualsiasi politica apparisse di giovamento allo Stato.
Se nell’epoca del principato si era ancora levata qualche voce di protesta a difendere la purezza della stirpe minacciata da troppe concessioni di cittadinanza, più tardi questo genere di lamentele viene completamente soffocato.
Il governo imperiale non ha il minimo interesse a difendere l’omogeneità etnica della popolazione e del resto è indifferente anche a quella della truppa; semplicemente, preoccupazioni di questo genere non vengono prese in considerazione.
Se l’improvviso trapianto di migliaia di sarmati o di alamanni in mezzo ai contadini gallici o italici provocò resistenze e insicurezze, manifestazioni di razzismo e magari incidenti, come ci parrebbe verosimile paragonando la situazione dell’Europa attuale, a tutto ciò non venne dato rilievo né sbocco.
Le campagne, le grandi dimenticate di tutta la storia romana, erano per il governo una tabula rasa in cui era possibile compiere qualsiasi esperimento di ingegneria sociale, purché alla fine la terra fosse coltivata e gli uomini iscritti sui registri degli uffici di leva.
L’amministrazione maggiormente impegnata nella gestione dell’immigrazione fu indiscutibilmente quella militare e del resto l’esercito non era soltanto il veicolo principale dell’assimilazione per una moltitudine di iscritti, ma anche la principale occasione di carriera che poteva consentire ai figli degli immigrati di integrarsi ai vertici della società romana.
Al più tardi dall’epoca di Diocleziano, il nesso stabilito per legge fra colonato e coscrizione assicurò che le due facce della politica dell’immigrazione, l’insediamento dei coloni e il reclutamento dei coscritti, fossero per sempre connesse.
A sua volta, il nesso fra coscrizione e fiscalità garantì che l’esercito non rappresentasse l’unico gruppo di interesse che conveniva favorire l’immigrazione, giacché nella stessa direzione andavano gli interessi di chi gestiva il prelievo fiscale.
A determinare il collasso del sistema fu un accumulo di disfunzioni, che tuttavia non avrebbero avuto un impatto così devastante senza un’improvvisa accelerazione delle congiuntura.
La corruzione delle amministrazioni che gestivano l’ingresso e lo stanziamento degli immigrati trasformò l’emergenza del 376, già difficile da gestire in condizioni normali, in un incubo senza soluzioni.
A sua volta, la gravità della situazione che si era venuta a crearsi rese pressoché impraticabili le soluzioni consuete, che avevano sempre funzionato in precedenza e che all’inizio anche Teodosio si sforzò di applicare correttamente, affidando all’esercito il compito di impiegare e assimilare la moltitudine degli immigrati.
L’esperienza traumatica degli anni successivi al 382, quando parve che l’esercito dovesse disgregarsi sotto la pressione di quell’impegno eccessivo, indusse il governo a sperimentare, nel panico, nuove soluzioni, che tuttavia si avvicinavano pericolosamente a una rinuncia a gestire con mano ferma l’accoglienza degli immigrati e la loro integrazione.
La situazione precipitò definitivamente quando l’Impero si vide costretto a lasciar entrare moltitudini di gente che in realtà non sapeva come sistemare e proporre loro sistemazioni troppo precarie per essere soddisfacenti; quando, cioè, sotto la spinta delle circostanze non si poté più parlare di una politica dell’immigrazione, come quella che bene o male, in modi brutali e corrotti, aveva comunque permesso di accogliere una moltitudine di profughi e immigrati, e di rinnovare profondamente la composizione etnica degli stessi gruppi dirigenti.
A partire da allora, gli stanziamenti delle bande barbariche e dei loro capi sul suolo delle province d’Occidente, e gli obblighi di mantenimento imposti alle popolazioni provinciali, comportarono sempre più spesso una perdita dell’effettivo controllo governativo di quei territori, e la nascita, col tempo, di regni dapprima autonomi e poi a tutti gli effetti indipendenti; ovvero, quella che, con il nostro abituale etnocentrismo, siamo soliti definire caduta dell’Impero romano, dimenticandoci di aggiungere “d’Occidente”.
Bibliografia
Confrontarsi con l’altro: i romani e la Germania / F. Borca. – 2004
Alle radici della cavalleria medievale / F. Cardini. – 1981
Società romana e impero tardoantico / a c. di A. Giardina. – Laterza, 1986
Storia di Roma, vol. 3. – Einaudi, 1993
Terre, proprietari e contadini dell’Impero romano: dall’affitto agrario al colonato tardoantico / a c. di E. Lo Cascio. – 1997
Impero tardoantico e barbari: la crisi militare di Adrianopoli / M. Cesa. – 1994
Storia di Roma, vol. 2. – Einaudi, 1999
Il reclutamento delle legioni / G. Forni. – 1953
Il confine nel mondo classico / a c. di M. Sordi. – 1988
I vandali: lingua e storia / N. Francovich Onesti. – 2002
Per la storia dell’esercito romano in età imperiale / E. Gabba. – 1974
Storia di Roma, vol. 4. – Einaudi, 1989
Prima delle nazioni: popoli, etnie e regni fra Antichità e Medioevo / S. Gasparri. – 1997
L’esercito rimano: le armi imperiali da Augusto alla fine del Terzo Secolo / Y. Le Bohec. – 1992
Storia d’Europa. Vol. 3. / a cura di G. Ortalli. – Einaudi,, 1994
Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico / B. Luiselli. – 1992
La grande strategia dell’Impero romano / E. N. Luttwak. – 1981
La corruzione e il declino di Roma / R. MacMullen. – 1991
La politica di Teodosio nella pubblicistica del suo tempo / M. Pavan. – 1964
Le origini etniche dell’Europa: barbari e romani tra Antichità e Medioevo / W. Pohl. – 2000
Migrazioni e comunicazione / W. Pohl. – In: Comunicare e significare nell’Alto Medioevo, 2005
Romani e barbari: incontro e scontro di culture / a cura di S. Giorcelli Bersani. – 2004
Una cultura barbarica: i germani / E. A. Thompson. – Laterza, 1976
I germani: dalla tarda repubblica all’età carolingia / M. Todd. – 1996
Le frontiere imperiali. – In: Storia di Roma, vol. 3.. – Einaudi, 1993
Storia dei goti / H. Wolfram. – 1985
I germani / H. Wolfram. – 2005
La civiltà bizantina di Cyril Mango
- Visite: 151
Introduzione
Stando alle definizioni della maggioranza degli storici, l’Impero bizantino sarebbe nato con la fondazione della città di Costantinopoli o Nuova Roma nel 324 d. C. e sarebbe finito con la resa della medesima città ai turchi ottomani nel 1453.
Nel corso di questi undici secoli l’Impero bizantino conobbe profonde trasformazioni; di qui l’uso di dividere la storia bizantina in almeno tre unità principali – il primo periodo bizantino cui succedono il medio e il tardo periodo.
Può rientrare nella prima unità l’epoca che giunge sino alla metà del settimo secolo e cioè sino all’insorgenza dell’islam e alla definitiva installazione degli arabi lungo le coste orientali e meridionali del Mediterraneo; il medio periodo può giungere sino all’occupazione turca dell’Asia Minore (intorno al 1070) oppure – con minor fondamento – sino alla presa di Costantinopoli da parte dei crociati (1204); il tardo periodo, da una qualunque di queste date, sino al 1453.
Per quanto arbitraria possa apparire, ci sono buone ragioni per mantenere tale definizione.
Quando poi all’aggettivo ‘bizantino’, potrebbero sollevarsi serie obiezioni, come spesso è accaduto, in merito alla questione se sia parola adeguata o meno.
Comunque sia, alla lunga questo termine si è imposto e sarebbe pedante rifiutarlo fin tanto che comprendiamo che si tratta semplicemente di una comoda etichetta.
Nel mondo reale non è certamente mai esistita alcuna entità detta ‘Impero bizantino’.
Ciò che esisteva era uno Stato romano che aveva il suo centro a Costantinopoli.
I suoi abitanti si definivano Rhomaioi o semplicemente cristiani; e chiamavano Rhomania il loro paese.
Ci si poteva definire un Byzantios solo se si era nati a Costantinopoli e non se si proveniva da qualsiasi altra regione dell’Impero.
Per gli europei d’Occidente la parola ‘romano’ aveva una connotazione completamente diversa; pertanto identificavano i ‘bizantini’ come Graeci.
Affine il termine impiegato dagli slavi (Greki), laddove per arabi e turchi essi erano Rum, vale a dire ‘romani’.
L’impiego del termine Byzantinus quale designazione dell’Impero e dei suoi abitanti non si impose sino al Rinascimento.
Nessun tentativo di sostituirlo con goffi equivalenti del tipo ‘romano-orientale’ o ‘cristiano-orientale’ ha incontrato il consenso generale.
Guardando la storia bizantina in modo cursorio e da lungi – qui non possiamo fare altrimenti – dobbiamo dire che il primo periodo bizantino è senz’altro il più importante dei tre che abbiamo indicato.
Quel periodo appartiene ancora all’antichità, di cui forma l’ultima propaggine in ambito mediterraneo.
Certo, l’Impero romano aveva progressivamente perduto le sue province settentrionali, ma continuava ad estendersi da Gibilterra sino alle acque dell’Eufrate, oltre le quali lo fronteggiava il suo nemico tradizionale: la Persia dei Sassanidi.
La base politiche che sottostava al periodo in questione era costituita dal confronto/equilibrio tra queste due grandi potenze.
AL di fuori di Roma e della Persia, con pochi Stati minori alle loro rispettive periferie, non c’erano che fluttuazioni di un oceano di popolazioni barbariche.
Non fu solo in termini di estensione geografica e di potere politico che lo Stato bizantino del primo periodo si mostrò incomparabilmente maggiore che nel medio o nel tardo periodo.
Il discorso vale anche per i suoi esiti culturali.
Seppe integrare il cristianesimo all’interno della tradizione greco-romana; definì il dogma cristiano e stabilì le strutture della vita cristiana; creò una letteratura e un’arte cristiana.
In tutta la panoplia bizantina non c’è quasi istituzione o idea che non abbia le sue origini nel primo periodo.
Non è facile sovrastimare la catastrofica struttura avvenuta nel Settimo Secolo.
Chi leggesse la narrazione di come gli eventi si succedettero non mancherebbe di essere colpito dalle calamità che afflissero l’Impero: dall’invasione persiana subito a inizio secolo sino all’espansione araba una trentina di anni dopo, fu una serie di rovesci che privarono l’Impero di alcune delle sue province più prospere (Siria, Palestina, Egitto, poi il Nord Africa) riducendolo a meno di metà di ciò che era prima, sia per estensione sia per numero di abitanti.
Ma la lettura delle fonti di narrazione storica non dà che una pallida idea della profonda trasformazione che si accompagnò a questi eventi.
Per comprendere le dimensioni del crollo bisogna considerare l’evidenza archeologica proveniente da numerosi siti.
Per l’area bizantina quel crollo segnò la fine di un modo di vita – la civiltà urbana del mondo antico – e l’inizio di un mondo assai diverso, decisamente medievale.
In un certo senso la catastrofe del Settimo Secolo è dunque l’episodio centrale della storia bizantina.
Come nell’Europa d’Occidente tutti il Medioevo fu dominato dall’ombra della Roma imperiale, così il miraggio dell’Impero cristiano di Costantino, Teodosio e Giustiniano rimase per Bisanzio un ideale da perseguire ma giammai realizzato.
Sono questi fatti a spiegare in massima parte la natura retrospettiva della civiltà bizantina.
Se il primo periodo bizantino può interpretarsi quale equilibrio tra due grandi potenze, il medio periodo può apparentarsi a un triangolo con un lato maggiore (l’islam) e due lati minori (rispettivamente Bisanzio e l’Europa occidentale).
Il mondo islamico assorbì l’eredità sia di Roma sia della Persia e unendo in un solo grande ‘mercato comune’ l’area che si estendeva dalla Spagna ai confini dell’India seppe produrre una civiltà urbana d’inconsueta vitalità.
Quanto allo Stato bizantino, ancorché escluso dalle principali vie del commercio internazionale e costantemente vessato dai suoi nemici, seppe mostrare grande iniziativa e recuperare parte del terreno perduto.
Ma ora doveva guardare altrove – non più verso le regioni ‘classiche’ ma verso i barbari del Nord e dell’Ovest: i Balcani, ora sede di slavi e altri nuovi inquilini; lo Stato cazaro, lungo la costa settentrionale del Mar Nero; infine, ciò che nel corso del Nono Secolo divenne lo Stato russo.
Si dischiudevano nuovi scenari; l’influsso bizantino, che nell’attività missionaria aveva la sua punta di diamante, poté irradiarsi fino alla Moravia e al Baltico.
In una più ampia prospettiva storica può ben dirsi che quest’ultimo sia stato il maggior contributo del periodo medio bizantino.
Anche il periodo tardo può essere considerato come un triangolo – ma un triangolo dalla diversa configurazione.
Sia il mondo bizantino sia il mondo arabo sono ora in disarmo, laddove l’Europa occidentale è in ascesa.
I principali sviluppi che diedero inizio a questa fase furono la perdita della maggior parte dell’Asia minore, passata ai turchi Selgiuchidi, simultaneamente alla cessione dei traffici marittimi alle repubbliche marinare italiane.
Per i cento anni successivi Bisanzio riuscì ancora a mantenere la sua unità e almeno parte del suo prestigio, ma a partire dal 1180 l’edificio cominciò a creparsi dappertutto.
La frammentazione che ne risultò – la presa di Costantinopoli da parte dei cavalieri della Quarta Crociate, lo stabilirsi dei principati latini del Levante, la formazione di frammenti di Stati greci a Trebisonda, a Nicea, in Epiro, il ricostituirsi di una pallida somiglianza dell’Impero di Costantinopoli nel 1261 – dà vita a una storia fin troppo complessa e curiosa.
Tuttavia, non può dirsi che questo periodo della storia bizantina abbia un significato universale; i centri principali del potere e della civiltà si erano spostati altrove.
Tali, con quanta più sintesi è possibile, le fasi principali della storia bizantina.
Il soggetto della nostra indagine ha pertanto una lunga estensione cronologica e un contesto geografico sempre mutevole.
Nel primo periodo abbiamo a che fare con pressoché tutto il bacino mediterraneo; nel periodo medio l’Occidente scompare dalla nostra prospettiva, eccezion fatta per l’Italia meridionale e la Sicilia, laddove il principale nucleo d’interesse è in Asia Minore e nei Balcani; alla fine non ci resta che Costantinopoli e un continuo sparpagliarsi di terre sia in Asia Minore sia in Grecia.
Diversità di sito implica anche diversità di popolazione.
Bisogna sottolineare con vigore che non è mai esistita una ‘nazione’ bizantina.
Questo tema sarà più distesamente trattato nel primo capitolo, ma occorre segnalare sin dal principio che qualunque tentativo di imporre le attuali categorie di nazione al mondo bizantino non può che condurre a un fraintendimento dei fatti.
Un’ulteriore restrizione è da avanzarsi a questo punto.
La nostra conoscenza di ogni civiltà del passato si basa su documenti, si tratti di documenti scritti o di monumenti.
Dove la documentazione scritta è copiosa, i monumenti vengono relegati a una posizione di rincalzo; e dunque possiamo studiare l’età vittoriana senza mai posare lo sguardo sull’Albert Memorial (e tuttavia, contentandoci così, possiamo perderne aspetti importanti).
La documentazione monumentale o archeologica si fa tanto più importante quanto più i documenti scritti risultano inadeguati.
Da questo punto di vista la posizione dell’Impero bizantino è piuttosto speciale.
A prima vista, la quantità di materiale scritto che ci ha trasmesso risulta assai considerevole.
Ma qual è la natura di questo materiale?
Il primo fatto che colpisce l’osservatore è la penuria di materiale documentario o d’archivio.
La sola parte dell’Impero ove si è serbato una certa quantità di tale materiale è l’Egitto fino alla conquista araba – ma ci viene detto sovente che l’Egitto none ra affatto una provincia rappresentativa, che non valgono per altre aree dell’Impero le informazioni sulla vita quotidiana che deduciamo dai papiri scoperti in Egitto.
Possediamo altresì uan modesta quantità di papiri connessi a Ravenna, che era parte dell’Impero ancor più marginale.
Per il resto non abbiamo che qualche archivio monastico, per lo più attinente al Monte Athos o all’Italia meridionale, più due o tre ascrivibili all’Asia Minore.
Gli archivi in questione si limitano a questioni di godimento dei suoli e non contengono materiali datati prima del Decimo Secolo.
E questo è tutto.
I documenti del governo centrale (e va ricordato che l’Impero bizantino era lo Stato burocratico per antonomasia), quelli dell’amministrazione provinciale, della Chiesa, dei padroni delle terre, dei loro affittuari, dei mercanti, dei negozianti – sono spariti, tutti.
Il risultato è che siamo senza cifre attendibili in merito all’entità della popolazione, senza registri di nascite, matrimoni e decessi, senza cifre sui commerci e sulle tasse – in pratica senza tutto ciò che può essere oggetto di calcolo e valido ai fini statistici.
Questo significa che non può scriversi storia economica dell’Impero bizantino provvista di un minimo di senso.
Per il vero, vi sono stati storici che hanno ceduto all’odierna passione per l’economia e la statistica, cercando di applicare all’Impero bizantino i medesimi metodi impiegati con tanto successo per altri periodi – solo per cadere sul medesimo ostacolo: la mancanza di documentazione.
Il materiale scritto a nostra disposizione può essere genericamente chiamato materiale letterario, nel senso che si è conservato in libri manoscritti.
A contare solo i manoscritti in greco, nelle varie biblioteche ne sopravvivono circa cinquantamila; la metà circa sono di epoca medievale.
Un’ampia parte di questo materiale è liturgica, teologica, devozionale e via dicendo, ma certo lo storico dell’Impero bizantino non può lamentarsi di non avere abbastanza testi da leggere; al contrario, ne ha fin troppi.
Tuttavia questi testi non hanno una qualità stranamente opaca; e quanto maggiore l’eleganza stilistica, tanto più opachi diventano.
Ciò non significa che le loro informazioni siano scorrette; al contrario, storici e cronisti bizantini si rivelano essere piuttosto veritieri.
Ma essi ci rendono soltanto l’involucro esteriore degli avvenimenti pubblici, ed è senza frutto che cerchiamo la soggiacente realtà della vita.
Se ci volgiamo all’epistolografia, genere assiduamente coltivato lungo tutta l’esistenza dell’Impero, restiamo ancor più delusi: sono clichés eruditi quelli che ci vengono offerti, non osservazioni personali.
Solo raramente viene levato il sipario – e questo accade con autori di cultura relativamente grezza.
Ricadono in questa categoria alcune Vite dei santi sfuggite alla ‘cura della bellezza’ stilistica operata nel Decimo Secolo da Simeone Metafraste; alcuni paterica, ovvero raccolte di aneddoti su monaci; qualche testo eterogeneo come il cosiddetto Strategicon di Cecaumeno (Undicesimo Secolo).
Per qualche istante ci troviamo dinanzi alla vita qual era, in qualche villaggio della Galizia, nel deserto egiziano, nelle terre di un gentiluomo della Grecia centrale.
Ma dal grande corpus della letteratura bizantina la realtà rimane estraniata.
Mi diffonderò maggiormente al proposito nel capitolo tredicesimo.
Per lo storico della civiltà bizantina i limiti imposti dalla natura del materiale scritto comportano notevoli implicazioni.
Il solo modo di superare tali limiti consiste a mio avviso nello studio dei resti materiali: in altre parole nell’archeologia.
Purtroppo ben poco è stato fatto finora in questo campo.
Certo, si è scavato in un buon numero di città classiche delle province orientali; di esse, molte mostrano di essere state abitate senza soluzione di continuità sino all’inizio del Settimo Secolo.
Pertanto, sebbene vi sia ancora molto da apprendere, siamo piuttosto bene informati in merito all’aspetto materiale della vita urbana nel corso del primo periodo bizantino.
Ma i siti in questione di solito evidenziano una frattura drammatica nel Settimo Secolo: talvolta essa assume forma di drastica riduzione, talvolta di quasi abbandono.
Ma che cosa accadde dopo?
Per il periodo medio bizantino e per il periodo tardo le nostre conoscenze rimangono assai frammentarie.
Il solo tipo di monumento che sia sopravvissuto in quantità considerevoli e sta stato oggetto di studio sistematico è la chiesa.
Comunque, la chiesa è stata studiata da storici dell’arte il cui approccio – ancorché indubbiamente importante per altri storici dell’arte – risulta di rado rilevante per lo storico della civiltà.
Possiamo trarre talune deduzioni interessanti anche dalle chiese, ma ciò che ci serve – e che difficilmente potremo avere nel prossimo futuro – è l’investigazione sistematica di città e villaggi, castelli e fattorie, opere idrauliche e varie nonché installazioni industriali nelle differenti province dell’Impero bizantino.
Solo dopo aver fatto ciò potremo parlare con qualche sicurezza del livello della civiltà bizantina e della sua portata.
Questa grave lacuna non sempre è stata percepita; certamente non ha impedito a un buon numero di specialisti di scrivere libri sulla civiltà di Bisanzio.
C’è almeno una dozzina di libri di tal genere che merita di essere ricordata con onore (vedi Bibliografia).
Come era inevitabile, anche io ho dovuto in gran parte muovermi su terreni già occupati dai miei predecessori, ma ho adottato una disposizione della materia in qualche modo diversa dalla tradizionale.
Il mio libro è stato concepito come un trittico.
Nella prima ‘tavola’ ho delineato taluni aspetti della vita dei bizantini – certamente non tutti i suoi aspetti significativi ma soltanto quelli che a mio avviso hanno esercitato un influsso notevole sul ‘prodotto’ culturale bizantino.
Data l’enorme estensione della materia ho dovuto tralasciare molto d’importante.
Per esempio ho parlato poco della vita militare, nonostante che tutto il corso della storia bizantina sia stato dominato dalle guerre.
Né ho potuto dire molto dell’economia bizantina e delle comunicazioni per via di terra e di mare: due aspetti interconnessi che per ora rimangono conosciuti in modo assai imperfetto.
In termini cronologici, ho privilegiato il primo periodo e il periodo medio bizantino, spesso a scapito del periodo tardo.
I lettori dotati di acume critico troveranno senz’altro ulteriori lacune.
La seconda tavola del trittico è dedicata a ciò che Norman Baynes ebbe a chiamare ‘mondo concettuale della Roma d’Oriente’.
Ho qui cercato di descrivere nella sua compattezza e relativa stabilità quel corpus di credenze che può specificamente chiamarsi bizantino.
Così facendo mi sono imposto di scegliere il livello concettuale del bizantino ‘medio’: come egli intendeva la sua posizione in rapporto alle potenze soprannaturali del bene e del male, il suo posto nella natura, il suo posto nella storia (passata e futura), il suo atteggiamento nei confronti degli altri popoli, che cosa infine riteneva essere ‘vita buona’ e ‘uomo ideale’.
Non si tratta necessariamente di posizioni condivise da tutti gli intellettuali bizantini, ma, come avremo a spiegare dettagliatamente in seguito, gli intellettuali – almeno dopo il Settimo Secolo – costituivano una cerchia ridottissima e non esercitavano apprezzabile influsso sul più vasto pubblico.
Nell’ultima tavola del trittico mi sono provato a descrivere ciò che Bisanzio ci ha trasmesso.
Data la loro natura così altamente tecnica, ho tralasciato la legge e la teologia bizantine per limitarmi a letteratura e arte.
Qualunque cosa possa essere stata ai suoi tempi la civiltà bizantina, in ultima analisi è dalla sua espressione letteraria e artistica che il nostro apprezzamento deve dipendere.
Parte prima. Aspetti di vita bizantina.
Cap. 1. Popoli e lingue.
Costantinopoli, come ogni grande capitale, era un crogiuolo di elementi eterogenei; stando a una fonte contemporanea, erano in essa rappresentate tutte le settantadue lingue note all’uomo.
Genti di ogni provincia vi si erano stabilite o comunque la visitavano per ragioni di carattere commerciale o ufficiale.
Tra gli schiavi molti erano i barbari.
Un altro elemento straniero veniva dalle unità militari che nel Sesto Secolo erano costituite o da barbari (germani, unni, altri ancora) o dai provinciali di maggior nerbo: isaurici, illirici, traci.
Si legge che settantamila soldati gravassero sugli abitanti di Costantinopoli durante il regno di Giustiniano.
Dalla Siria, dalla Mesopotamia, dall’Egitto si riversavano nella capitale monaci che parlavano poco o punto greco: avrebbero così goduto della protezione dell’imperatrice Teodora e destato stupore tra gli abitanti della capitale con le loro bizzarre imprese ascetiche.
Onnipresente, l’ebrei si guadagnava da vivere in qualità di artigiano o mercante.
Costantinopoli era stata fondata quale centro di latinità in Oriente e continuava ad annoverare tra i residenti non pochi illirici, italiani [direi italofoni, ma esistevano?], africano di madrelingua latina come lo stesso imperatore, Giustiniano.
Inoltre, numerose opere di letteratura latina vennero composte a Costantinopoli: la celebre grammatica di Prisciano, la cronaca di Marcellino, il panegirico di Giustino Secondo dovuto all’africano Corippo.
Il latino continuava a essere necessario per il ruolo legale e per talune branche dell’amministrazione, ma la bilancia stava pendendo inesorabilmente a favore del greco.
Alla fine del Sesto Secolo, come asserisce papa Gregorio Magno, nella capitale dell’Impero non era facile trovare un buon traduttore dal latino al greco.
Pag. 21
Non è probabile che l’uso del greco sia stato più diffuso in Palestina che nella Siria settentrionale, fatta eccezione per un fenomeno artificiale: lo sviluppo dei ‘luoghi santi’.
A partire dal regno di Costantino il Grande quasi non vi fu sito di rinomanza biblica che non divenne – come diremmo oggi – attrazione turistica.
Ci si riversava in Palestina da ogni angolo del mondo cristiano, chi quale pellegrino di passaggio, chi per soggiorni più lunghi.
Monasteri di ogni nazionalità spuntavano come funghi nel deserto prossimo al Mar Morto.
Così la Palestina era una babele linguistica, ma la popolazione del posto – e dobbiamo ricordare che essa comprendeva due gruppi etnici distinti, i giudei e i samaritani – parlava aramaico come sempre.
La pellegrina Egeria, testimone alle funzioni di Pasqua in Gerusalemme intorno al 400, ha questo da dire:
Visto che in quel paese parte della popolazione conosce sia il greco sia il siriaco, parte solo il greco, altra parte solo il siriaco, e dato inoltre che il vescovo, quantunque edotto in siriaco, parla sempre greco e mai siriaco, c’è sempre accosto a lui un prete sì che quando il vescovo parla greco possa tradurre le sue osservazioni in siriaco e ognuno possa capirle.
Il medesimo avviene per le letture che si svolgono in chiesa; poiché devono essere lette in greco, c’è sempre qualcuno a tradurle in siriaco col beneficio del popolo, che possa riceverne istruzione.
Quanto ai latini che ivi si trovano – quelli cioè che non conoscono né greco né siriaco – c’è un’interpretazione anche per loro, per non dispiacergli; vi sono infatti fratelli e sorelle esperti sia in greco sia in latino che danno spiegazioni in latino.
Pag. 24-25
Tutto il paese era allora in uno stato pietoso.
Il continuo stato di guerra tra Bisanzio e gli ostrogoti – durò dal 535 al 562 – portò alla distruzione di Milano con una perdita di vite umane stimata in trecentomila maschi abili alle armi, al virtuale spopolamento di Roma che ebbe a patire tre assedi, a diffuse carestie nelle campagne.
“In ogni suo sito l’Italia è divenuta ancor più spopolata della Libia”, scrisse Procopio: forse non esagerava troppo.
Quanto alla composizione della popolazione ci sono pochi dubbi che gli Italiotai, come li chiamava Procopio, fossero sostanzialmente latini; anche nella capitale imperiale di Ravenna, che aveva stretti legami con l’Est e numerosi abitanti di origine orientale, il latino era il normale mezzo di comunicazione.
Qualche modesta isola linguistica greca poteva forse sopravvivere nella parte meridionale della penisola e certo si continuava a parlare greco lungo la costa orientale della Sicilia.
C’erano altre minoranze, come quella ebraica, o gli ostrogoti, di più recente arrivo: questi ultimi raggiungevano a stento le centomila unità.
Molte altre ondate di invasori e di nuovi abitanti sarebbero giunte in seguito, senza però alterare il carattere fondamentalmente latino della popolazione.
Pag. 28
Tali, in sintesi, popoli e lingue dell’Impero di Giustiniano, e se ho particolarmente sottolineato gli elementi nativi è stato per correggere le distorsioni delle nostre fonti letterarie e narrative.
Limitiamoci a un esempio, quello di Libanio, retore del Quarto Secolo nato ad Antiochia, dove passò la maggior parte della sua vita.
Il suoi scritti occupano undici volumi a stampa e sono una miniera di informazioni utili.
Ora, Libanio si limita a menzionare l’esistenza della lingua siriaca.
Tuttavia è un fatto incontestabile che Antiochia, dove si parlava greco, era un’isola in un mare di siriaco.
Gli autori colti, semplicemente, non badavano a fenomeni così uncivilized.
Neppure le iscrizioni risultano particolarmente illuminanti.
Chiunque componesse un’iscrizione – quand’anche fosse non più che una lapide tombale – usava naturalmente la lingua più prestigiosa della sua area.
Inoltre, molti vernacoli locali non erano scritti.
E’ principalmente in ambiente monastico che può capitare di trovarsi dinanzi alla gente comune, priva di istruzione, e di cogliere qualche barlume di quel che parlavano.
Com’è da aspettarsi, si tratta del dialetto nativo.
Di qui l’abitudine di fondare monasteri ‘nazionali’.
Altri, comunque, erano multinazionali: quello degli Insonni (Akoimetoi) era suddiviso per lingue in quattro gruppi (latino, greco, siriaco, copto).
Il monastero fondato in Palestina da San Teodosio Cenobiarca offriva scelta tra greco, besso, armeno.
Sul Monte Sinai, nel Sesto Secolo, si poteva udire latino, greco, siriaco, copto, besso.
Nel 518 il superiore di un monastero costantinopolitano non poté apporre la propria firma a una petizione perché ignaro di greco.
E’ agevole moltiplicare esempi analoghi.
Pag. 29-30
Venne in tal modo a crearsi un enorme gap demografico.
Ben presto l’Impero si trovò ad avere bisogno di contadini così come aveva necessità di soldati. [Guarda caso].
A tal fine dové ricorrere a ingenti trasferimenti di popolazione.
Fu in particolare l’imperatore Giustiniano Secondo ad applicare questa politica su ampia scala.
Buona parte della popolazione di Cipro fu da lui spostata nella regione di Cizico, sulla costa meridionale del Mar di Marmara.
Fu un chiaro fallimento: molti immigranti perirono nel corso del viaggio e quanti arrivarono a destinazione chiesero in seguito di venire rimpatriati.
Giustiniano Secondo spostò altresì “una grande moltitudine” di slavi in Bitinia.
Ancora una volta, non fu molto fortunato, giacché i trentamila soldato che poté arruolare entro questo gruppo per combattere gli arabi passarono al nemico.
Per tale ragione l’imperatore inflisse crudeli rappresaglie alle loro famiglie.
Come che fosse, leggiamo che nel settimo decennio dell’Ottavo Secolo ben 208.000 slavi andarono a vivere in Bitinia di loro spontanea volontà.
Nell’Ottavo Secolo si parla più volte di un insediamento organizzato di siriaci in Tracia.
Pag. 33-34
Non possono esserci molti dubbi sul fatto che l’evangelizzazione dei popoli non cristiani stanziati nell’Impero venisse svolta in greco.
Ciò può destare sorpresa nel caso degli slavi, dacché l’alfabeto slavo fu invenzione di un bizantino, san Cirillo, presumibilmente nel settimo decennio del Nono Secolo.
Tale invenzione, comunque, non meno che la successiva traduzione dei testi cristiani più importanti, era destinata a un remoto paese slavo, la Moravia; e fu un frutto del caso se la missione di Cirillo e Metodio, dopo un fallimento iniziale, trovò terreno fertile in un paese cui non era inizialmente rivolta, vale a dire il regno di Bulgaria.
Per quanto sappiamo, non vi furono mai tentativi di evangelizzare in lingua slava gli slavi insediati in Grecia; analogamente l’uso liturgico del greco venne imposto alla Bulgaria dopo la conquista a partire dal 1018.
Tutto ciò avrà certamente contribuito alla diffusione del greco: ma si doveva a una scelta politica?
Non è più probabile che la mancanza di un clero con competenze linguistiche, la relativa inaccessibilità delle scritture in slavo, la natura composita della popolazione – tutto ciò abbia congiuntamente contribuito a rendere l’uso del greco la scelta più agevole?
Pag. 37
Da questi e da molti altri casi va tratta una conclusione ovvia, e cioè che l’Impero medio bizantino non fu in nessun modo uno Stato pienamente greco.
Oltre agli armeni e agli slavi, c’erano molti altri elementi stranieri come i georgiani e i valacchi balcanici.
Il forte influsso dei siriaci e di altri cristiani d’Oriente seguì l’espansione a Est dell’Impero, alla fine del Decimo Secolo; quando poi, nel 1018, la frontiera dell’Impero venen nuovamente riportata al Danubio, giunse a comprendere vaste aree dove mai era stato parlato greco – o dove si era estinto da molto tempo.
Se gli ellenofoni costituissero all’epoca maggioranza o minoranza degli abitanti dell’Impero è solo una supposizione che non vorrei azzardare.
Pag. 38
Per quanto possiamo giudicare, i principali legami di solidarietà erano due: regionali e religiosi.
La gente si identificava con il villaggio molto più che con l’Impero.
Quando qualcuno si allontanava da casa era uno straniero, spesso trattato con sospetto.
Un monaco proveniente dalla parte occidentale dell’Asia Minore entrò in un monastero del Ponto e fu “denigrato e maltrattato come uno straniero”.
Corollario della solidarietà regionale era l’ostilità tra regioni.
Incontriamo molte affermazioni dispregiative sul “siriaco astuto” dalla voce roca, sul rozzo paflagone, sul cretese bugiardo.
Gli abitanti di Alessandria detestavano il riso in quel di Costantinopoli.
Gli armeni erano quasi sempre descritti in termini offensivi.
Anche i demoni, come vedremo nel capitolo settimo, provavano intensi sentimenti di affiliazione locale e non volevano associarsi ai loro pari della provincia vicina.
Pag. 39
Cap. 2. Società ed economia.
La società che aveva l’imperatore a suo capo doveva essere governata dal concetto di ordine.
Le sue parti costitutive sono variamente descritte nelle nostre fonti.
A volte troviamo una triplice divisione: l’esercito, il clero, i contadini.
Altrove ci viene detto che l’esercito costituiva il capo del corpo politico oppure che le occupazioni essenziali erano la coltivazione della terra e l’attività militare, giacché i contadini nutrivano i soldati mentre i soldati proteggevano i contadini.
Il Sesto Secolo ci ha lasciato una classificazione del componente civile della società molto più elaborata, con una suddivisione in dieci gruppi e cioè:
1. Il clero
2. il ruolo giudiziario
3. I consiglieri (senatori?)
4. Addetti alla finanza
5. Professionisti e tecnici
6. Commercianti
7. Addetti all’approvvigionamento di materie prime
8. Subordinati e servi
9. Inutili (in altre parole: anziani, infermi, malati di mente)
Pag. 44-45
Il vuoto che si creò a livello di provincia venen colmato in parte dai governatori locali, in parte – e sempre più – dai vescovi.
E’ stato giustamente evidenziato che la Chiesa bizantina non costituiva un’organizzazione sui iuris; in termini moderni potremmo descriverla come un dicastero di salute pubblica.
Il compito di provvedere agli indigenti, ai forestieri, alle vedove, agli orfani era un impegno evangelico assunto dalla Chiesa nel Quarto Secolo.
Con il declino dei consigli municipali i vescovi assunsero una sempre maggiore varietà di funzioni extra religiose.
Li troviamo intenti ad amministrare la giustizia, a sorvegliare sui mercati, a regolare pesi e misure, a riparare ponti e costruire granai.
Là dove c’era un governatore provinciale insediato, il vescovo era suo pari; nelle altre città il vescovo divenne la figura più eminente, l’equivalente di un governatore.
Il vescovo era in tal modo un amministratore, designato all’interno della piccola nobiltà locale sia per le sue funzioni di rappresentanza sia perché doveva possedere esperienza manageriale.
Era perfettamente normale che un laico – magari non particolarmente religioso – venisse direttamente ordinato vescovo.
Abbondano gli esempi in tal senso: uno sarà sufficiente.
All’inizio del Sesto Secolo un certo Harfat veniva da una famiglia di ricchi proprietari terrieri.
Quando i suoi genitori morirono Harfat e un parente ereditarono la proprietà e in più circa cinquemila pezzi d’oro.
Allora venne offerta ad Harfat la sede vescovile di Arsamosata in Armenia, ma declinò l’offerta, che venne però ripetuta al suo parente “con l’allettamento delle ricchezze e del rango” – e quegli, che viene descritto come persona dal carattere disonesto, accettò.
Ci sono anche molti esempi di laici che si dimostrarono eccellenti vescovi: Sinesio di Cirene nel Quarto Secolo oppure San Giovanni l’Elemosiniere, patriarca di Alessandria all’inizio del Settimo Secolo.
Pag. 49
La documentazione archeologica offre una stupefacente conferma della ricchezza della Chiesa nel periodo che va dal Quarto al Sesto Secolo.
Lungo tutto il Mediterraneo sono state trovate basiliche a ogni piè sospinto.
Ancorché standardizzate dal punto di vista architettonico, erano edifici di grandi dimensioni: lunghi trenta, quaranta metri o anche più, sontuosamente decorati con colonne di marmo d’importazione, sculture e mosaici.
Non ci fu città dove non si costruisse chiesa su chiesa, fino a circa la metà del Sesto Secolo, quando l’attività edilizia cominciò a segnare il passo per poi arrestarsi del tutto.
C’era veramente bisogno di tanti luoghi di culto?
Dal punto di vista pastorale la risposta non può che essere negativa.
Dato però che erigere chiese era considerato un atto degno di lode, che dava soddisfazione alla vanità dei donatori, che nel contempo creava posti in più per il clero, probabilmente per un certo tempo si continuò a costruire anche senza servire più ad alcuna necessità reale.
Pag. 52
Ciò che possiamo vedere con maggiore chiarezza è che l’intero meccanismo del governo imperiale era stato posto su basi diverse.
I grandi dicasteri dello Stato come le prefetture del pretorio e i grandi comandi militari dei magistri militum erano stati aboliti.
Al loro posto troviamo un assai accresciuto numero di cariche, tutte direttamente responsabili nei confronti dell’imperatore e non disposte in piramide gerarchica.
La natura del cambiamento, secondo la definizione di J. B. Bury, fu “sostituire il principio di coordinamento a quello di subordinazione e moltiplicare le cariche supreme anziché riporre immensi poteri nelle mani di pochi”.
La cosa più stupefacente fu la ristrutturazione dell’amministrazione provinciale avviata, a quanto sembra, dall’imperatore Eraclio.
Le vecchie province raggruppate in diocesi furono rimpiazzate da un certo numero di grandi unità chiamate thémata, ‘temi’, ciascuna governata da uno strategos (generale) le cui competenze comprendevano affari sia militari sia civili.
Questa riforma venne dapprima applicata in Asia Minore e successivamente estesa alle province europee man mano che queste ultime venivano gradualmente liberate dai barbari; nel contempo i temi più grandi perdevano le loro dimensioni originarie, venendo suddivisi in temi di minore estensione.
Il termine ‘tema’, di cui non è a tutt’oggi chiaro donde derivi, denotava in primo luogo un corpo d’armata militare e per estensione il distretto in cui era di guarnigione.
Stabiliti una prima volta i militari, di cui spesso i ‘temi’ prendevano il nome, il reclutamento sembrerebbe essersi in seguito svolto su base locale, sicché venne a costituirsi un esercito permanente indigeno.
Ovvia è la somiglianza con il vecchio sistema dei limitanei, solo che ora è tutto il territorio dell’impero a essere divenuto zona per così dire di frontiera.
Taluni studiosi ritengono che fu questa riforma radicale a consentire all’Impero di salvarsi nel corso della sua lunga lotta contro gli arabi.
Tali studiosi ritengono inoltre che sin dall’inizio i soldati (stratiotai) dei temi ricevettero elargizioni di terre vincolate alla prestazione di servizio militare su base ereditaria, per cui coltivavano i campi quando non servivano lo Stato in guerra.
Questo quadro di strenui soldati-contadini intenti alla difesa dei loro focolari contro l’invasore viene infine contrapposto alla società ‘debosciata’ dell’epoca precedente, che passava giornate intere a teatro e pagava mercenari barbari perché fossero loro a combattere.
Pag. 65-66
La nostra difficoltà a descrivere la crescita del ‘feudalesimo’ bizantino deriva dal fatto che non venne mai formalizzato in legge e non acquisì un vocabolario tecnico.
I bizantini erano certamente consapevoli delle istituzioni del feudalesimo occidentale; trattando con cavalieri e principi franchi l’imperatore otteneva sovente da loro un giuramento di fedeltà.
Il termine lizios (uomo ligio, vassallo) poté così farsi strada nella lingua greca, ma rimase riservato agli stranieri.
Leggiamo che il suo equivalente bizantino era “servo e soggetto” (oiketes kai hypocherios) e può ben essere che queste ed affini parole greche assai spesso presenti nelle nostre fonti si riferiscano talvolta al vassallaggio, ma solo di rado il contesto è abbastanza chiaro per stabilire la distinzione.
Mentre possiamo garantire, pertanto, che mai ebbe a svilupparsi in Bisanzio una struttura coerente di relazioni feudali, dobbiamo ammettere che vi si sviluppò un sistema per la massima parte non formulato che assomigliava da molti punti di vista al feudalesimo.
Uan dispersione dell’autorità centrale ne era sia la causa sia l’effetto.
Pag. 77
Una delle più grandi tragedie della storia bizantina è che la crescita economica e sociale del Secolo Undecimo sia stata amputata prima di poter raggiungere qualsiasi risultato duraturo, eccettuato forse il campo artistico e letterario.
La causa immediata fu certamente politica e militare: l’invasione pecenega dei Balcani, la perdita improvvisa di tanta parte dell’Asia Minore a vantaggio dei turchi selgiuchidi, la guerra con i normanni, l’effetto negativo delle crociate.
Questi rovesci sarebbero stati evitati se l’Impero avesse mantenuto la sua precedente struttura ‘sana’, quella basata sui ‘temi’ e su un esercito indigeno?
Facile è criticare gli imperatori ‘civili’ del Secolo Undecimo per la loro scarsa preveggenza, come ha fatto la maggior parte degli storici; più difficile è discernere le cause profonde del crollo seguito agli anni a cavallo del 1070.
Una causa può essere stata la smilitarizzazione; un’altra fu senz’altro l’espansione precedentemente conseguita dall’Impero – non entro i suoi ‘confini nazionali’, come si sono espressi taluni studiosi, ma ben oltre ogni ragionevole confine, su paesi e popolazioni che mai ebbero affinità o simpatia di sorta con il governo di Costantinopoli.
Pag. 82
Dividere l’Impero stava diventando uan possibilità assai chiara.
Venne suggerita ad Alessio dal cognato Niceforo Melisseno prima della sua ascesa al trono; venne considerata da Giovanni Secondo con riferimento alle sole province sudorientali; divenne una realtà effettiva a partire dal penultimo decennio del Dodicesimo Secolo, con la secessione di Cipro, di alcune parti dell’Asia Minore occidentale e infine di Trebisonda.
Forse è un miracolo che lo Stato dei Comneni sia riuscito a sopravvivere per un secolo e persino a nutrire sogni di gloria pur essendo divenuto in gran parte un affare di famiglia.
Alessio Primo e i suoi successori epurarono le file della vecchia aristocrazia e si circondarono dei loro parenti, fossero intrinseci per nascita o acquisiti per vincolo matrimoniale.
I loro titoli pomposi, di fresca invenzione, riflettevano il loro livello di parentela con l’imperatore regnante; tutti ricevevano ampie assegnazioni di terre ed esenzione dalle tasse.
La riforma comnena contraddistingue l’ultima trasformazione significativa della società bizantina; ciò che i comneni fecero i paleologhi continuarono a fare, ma su scala ridotta.
Pag. 83-84
Cap. 3. Scomparsa e rinascita delle città
Nel Sesto Secolo l’Impero concepiva se stesso quale aggregato di città.
Il manuale di Ierocle enumera – o meglio: enumerava, quando era completo – 935 città.
Tuttavia, non includendo Ierocle l’Italia né le province riconquistate del Nord Africa, in totale vi saranno state più di 1500 città durante il regno di Giustiniano.
Dobbiamo ricordare che in età antica il termine “città” (polis o civitas) non designava in senso stretto ciò che noi chiamiamo città; valeva semmai per un’unità dotata di propria amministrazione e c’era una differenza enorme tra ‘città’ come Alessandria o Efeso da un lato e in oscuro buco come Zeldepa in Scizia dall’altro.
Tuttavia con ‘città’ si intendeva di norma un vero centro abitato provvisto di un territorio rurale e così anche noi intenderemo il termine nella discussione che cui si presenta.
Pag. 87
Il passaggio dal paganesimo al cristianesimo fu ovunque lento.
Se molti templi pagani vennero chiusi alla fine del Quarto e all’inizio del Quinto Secolo, resta che in altri luoghi continuarono a funzionare.
La loro trasformazione in chiese, quando si realizzò, non fu affatto repentina, tanto più che i cristiani li consideravano infestati da demoni maligni.
Per esempio ad Atene (che per comune consenso era città dalle forti propensioni al paganesimo) i templi risultano essere stati sconsacrati solo verso la fine del Quinto Secolo e fu solo nel Settimo che il Partenone, l’Eretteo, il Tempio di Efesto divennero chiese.
La chiesa cristiana più importante veniva di solito costruita in un sito lasciato intatto dalle vecchie religioni, spesso un poco lontano dal centro della città e veniva circondata da un complesso di edifici residenziali e amministrativi usati dai vescovi.
Via via che il cristianesimo metteva sempre più profonde radici, un sempre maggior numero di chiese veniva costruito: per rendere onore a questo o quel martire o semplicemente quale atto di pietà.
Consideriamo nuovamente il caso di Atene: sono documentate quattordici chiese del Quinto e del Sesto Secolo e ve ne erano senz’altro molte di più.
All’epoca di Giustiniano c’era ovunque una tale abbuffata di chiese che la loro manutenzione, come abbiamo visto, stava diventando un serio onere.
Un monastero urbano era ancora una rarità, ma già cominciavano le prime infiltrazioni dalla campagne circostanti.
Altre tendenze dell’urbanesimo tardo antico – per esempio l’abbandono dei ginnasi – non erano connesse con l’avvento del cristianesimo.
Al di fuori delle mura si estendevano ampi cimiteri (era severamente proibito seppellire i morti intra muros), orti, ville e talvolta il sobborgo ebraico con la sinagoga.
Pag. 89-90
Un altro fatto dovrebbe essere menzionato in questo contesto, giacché fu esso a offrire ad alcuni storici il primo indizio del drammatico declino delle città bizantine.
Si tratta della brusca riduzione nel numero delle monete bronzee circolanti.
Nei siti che sono stati scavati sistematicamente – Atene, Corinto, Sardi e altri ancora – si è accertato che di emissioni bronzee (delle monetine usate per le transazioni d ogni giorno) c’era stata grande abbondanza sino all’ultima parte del Decimo Secolo.
A Sardi, per esempio, il secolo e un quarto che va dal 491 al 616 è rappresentato da 1.011 monete in bronzo; il resto del Settimo Secolo da circa 90 monete; l’Ottavo e il Nono Secolo insieme non superano le nove monete.
Mutatis mutandis, risultati analoghi sono stati ottenuti d quasi tutte le città delle province bizantine.
Sembra che nella sola Costantinopoli il declino della quantità del bronzo circolante non sia stato così catastrofico.
Si sa anche che nelle zone rimaste sotto il controllo bizantino cessò l’attività delle zecche locali: a Nicomedia dopo il 627, a Cizico e Tessalonica dopo il 629.
Non risulta che a Cherson sia stata battuta moneta tra l’inizio del Settimo e la seconda metà del Nono Secolo.
Pag. 107-8
Nei decenni che seguirono la sua inaugurazione (330) Costantinopoli conobbe una notevole espansione.
Continuo era l’afflusso di nuovi abitanti, attratti dalle elargizioni di pane gratis nonché dalle prospettive di impiego che venivano dalla vicinanza alla corte dell’Impero.
Nel 359 la città era abbastanza sviluppata da avere diritto a un prefetto urbano, come Roma.
I rifornimenti di acqua potabile dovettero essere accresciuti.
Dalla sua nuova cattedrale della Santa Sapienza (completata nel 360) il vescovo di Costantinopoli cominciava a superare sia per influsso sia per ricchezza i responsabili delle più antiche sedi apostoliche.
Teodosio Primo e i suoi successori intrapresero un ulteriore programma di costruzione urbana: un grande nuovo porto, che dovette notevolmente potenziare le capacità commerciali della città, nuovi depositi, il Foro di Teodosio e quello d’Arcadio, altri fastosi monumenti,
Le dame della dinastia regnante erano in reciproca competizione nell’acquisto dei terreni più invitanti e nella costruzione di dimore cittadine.
Nel 413 il circuito fortificato venne nuovamente ingrandito con la costruzione di una doppia cinta muraria che rese Costantinopoli un bastione inespugnabile come nessun altro.
Lo spazio urbano potenziale era aumentato raggiungendo circa 1.400 ettari e la popolazione era probabilmente salita alle 300.000-400.000 unità.
Ora Costantinopoli era più grande di Roma, ormai in declino – più grande anche di Alessandria e di Antiochia.
Pag. 111
Non è questa la sede indicata a discutere i molti problemi posti da queste cifre, ma è importante segnalare la complessità e la potenziale precarietà del sistema.
Il raccolto egiziano dipendeva anzitutto dall’annuale inondazione del Nilo.
Il prodotto doveva poi essere raccolto, misurato dagli ispettori governativi e trasferito nei granai di Alessandria entro il 10 settembre di ogni anno.
Da Alessandria ciò che era chiamato il “felice trasporto” prendeva il largo per Costantinopoli.
Andavano presi in considerazione i rischi del viaggio via mare, in particolare il passaggio dei Dardanelli se soffiava il vento contrario.
Per proteggersi da questa eventualità vennero costruiti ampi granai nell’isola di Tenedo: il grano vi veniva scaricato e si costituivano le riserve, come accadeva ad Ostia per le necessità di approvvigionamento di Roma.
Se il raccolto egiziano non era sufficiente o se qualche altra parte del meccanismo non funzionava a dovere la popolazione di Costantinopoli rischiava la fame e andavano attivate misure d’emergenza.
Sappiamo che nel 409 una carestia portò a una sollevazione con spargimenti di sangue nonché a una riorganizzazione delle spedizioni.
In un’altra occasione si dovette procedere in Tracia, Bitinia e Frigia a una requisizione forzosa a prezzi artificialmente bassi; dato poi che da quelle regioni a Costantinopoli non c’era un sistema di trasporto già allestito, furono i produttori stessi a essere gravati dell’onere aggiuntivo di trasportare il loro grano nella capitale.
Considerando quante erano le cose che potevano andare male, nel complesso l’approvvigionamento di Costantinopoli funzionò con apprezzabile efficienza stante l’alta priorità riservata al compito del governo.
Comunque è chiaro che l’esistenza stessa di Costantinopoli quale grande città dipendeva da un sistema di rifornimento marittimo perfettamente registrato.
Pag. 113-14
Nonostante i cupi pronostici, Costantinopoli avviò nel 755 un processo di graduale recupero che sarebbe continuato sino all’epoca delle crociate.
Nell’Ottavo Secolo non vi fu attività edificatoria, eccettuate opere di fortificazione e di riparo dei danno causati dai terremoti.
Nel Nono Secolo vi furono nuove intraprese edilizie, di carattere però diverso da quelle del primo periodo bizantino: non c’era più richiesta di piacevolezze urbane, sicché le nuove costruzioni si concentrarono soprattutto all’interno del palazzo imperiale che acquisì un’aria da mille e una notte.
I propagandisti delle corti di Michele Terzo e di Basilio Primo coltivarono uno spirito di ‘rinnovamento’ che significava riparazione di ciò che era andato in rovina più che creazione di qualcosa di nuovo.
Particolarmente istruttivo è l’elenco degli edifici voluti da Basilio Primo.
Esso mostra che praticamente tutte le più importanti chiese della capitale erano decadute, alcune giungendo prossime all’estinzione.
Così Basilio procedette al rinnovamento di più di venticinque chiese in città e di altre sei nei sobborghi.
Tutte le sue costruzioni nuove erano nel palazzo imperiale.
Pag. 118-19
Siamo così avvezzi a considerare i greci uan nazione di commercianti che ci riesce difficile immaginare che i bizantini erano tutto il contrario – terragni, diffidenti, privi di iniziativa.
Così non furono bizantini ma stranieri a trarre profitto dallo sviluppo urbano.
Abbiamo già ricordato la presenza di mercanti russi e italiani a Costantinopoli nel Decimo Secolo e la decisiva importanza dei privilegi commerciali garantiti a Venezia dall’imperatore Alessio Primo.
In un breve arco di tempo il basileus scoprì di non essere più il padrone di casa propria.
Nel 1126 Giovanni Secondo Comneno si provò a sospenderei privilegi dei veneziani: fu costretto dalla forza delle armi a desistere dal suo tentativo.
Nel 1148 venne ingrandito il quartiere veneziano (si trovava tra i due ponti moderni che racchiudono il Corno d’Oro).
Il numero dei veneziani residenti a Costantinopoli sembra essere giunto a ben 20.000 persone; le loro ricchezze erano immense.
In linea teorica erano soggetti all’Impero e pertanto sulle prime vennero posti sotto la giurisdizione di ufficiali imperiali; a poco a poco, però, si resero virtualmente autonomi.
Non è questa la sede adatta a raccontare la tortuosa storia dei rapporti tra l’Impero e Venezia, le rivalità tra gli italiani dei diversi gruppi, i vani tentativi attuati dagli imperatori perché si escludessero a vicenda.
Basta notare che le varie concessioni ‘latine’ occuparono i migliori terreni a uso commerciale della città, lungo la costa del Corno d’Oro; e che il numero degli occidentali residenti poté ammontare sino a un quinto circa del totale degli abitanti, che giunsero a 200.000-250.000.
Nelle strade di Costantinopoli risuonava una babele di lingue straniere.
Pag. 122-23
Da vero levantino Tzetze sapeva dire qualche parola in più lingue e anche se un purista avrebbe avuto da ridire sul suo latino era probabilmente quello l’idioma straniero che Tzetze conosceva meglio.
In breve: Costantinopoli sotto i Comneni non era dissimile da Istanbul antecedentemente alla Prima Guerra Mondiale, quando la maggior parte della vita economica della città era nelle mani degli stranieri del posto (greci, armeni, ebrei) e la maggioranza ottomana si sentiva ridotta allo stato di cittadini di seconda classe.
Stretta anche la corrispondenza tra i privilegi concessi alle colonie italiane dall’Impero bizantino e il regime delle ‘capitolazioni’ che prevalse in quello ottomano.
Nell’uno come nell’altro caso la situazione portò a tensioni esplosive.
Ma mentre la Turchia moderna è stata in grado di espellere o almeno di neutralizzare gli elementi estranei di Istanbul, Bisanzio si mostrò inerme dinanzi ai suoi sfruttatori italiani.
L’arresto di tutti i veneziani residenti nell’Impero con la confisca delle loro proprietà nel 1171, il massacro di altri latini (per lo più pisani e genovesi) a Costantinopoli nel 1182 non servirono che ad accelerare la tremenda punizione richiesta dall’Occidente.
Quando gli armati della Quarta Crociata si arrestarono dinanzi a Costantinopoli nel giugno del 1203, riuscivano a stento a prestare fede ai loro occhi: mai avevano veduto una città così grande e potente, così ricca, così piena di palazzi e di chiese.
Altresì ignoravano che il loro arrivo avrebbe significato la rovina della grande capitale.
Il terribile incendio che scoppiò nell’agosto dello stesso anno e che devastò almeno mezza città dopo avere infuriato per otto giorni non era che un presagio delle imprese avvenire.
Presa dai crociati, sistematicamente saccheggiata per quasi un sessantennio, svuotata dei suoi abitanti, Costantinopoli non divenne che l’ombra di ciò che era.
Non ci proveremo qui a tracciarne la malinconica storia nel corso dei sue secoli successivi, ripetendo essa la situazione coloniale già prevalente sotto i Comneni.
L’ambasciatore spagnolo Clavijo, che vide Costantinopoli nel 1403, diche che lo spazio entro le mura consisteva in un certo numero di piccoli agglomerati, separati da campi di grano e orti.
Soltanto le zone costiere avevano una certa densità di popolazione, in particolare l’area commerciale del Corno d’Oro.
Per contrasto la colonia genovese di Galata, ancorché piccola per superficie, era assai popolosa e fitta di dimore di pregio.
Quando, nel 1454, cedette ai turchi, il numero degli abitanti di Costantinopoli era ben sotto i 50.000.
Pag. 123-24
Cap. 4. I dissenzienti.
Pressoché tutto il dissenso bizantino prese forma di eresia religiosa.
Gli storici hanno cercato ovunque cause di tipo nazionale e sociale – cause ‘reali’, di cui l’eresia non sarebbe stata che la maschera – ma nel complesso i loro sforzi non sono stati ricompensati.
Tra gli esempi che abbiamo passato in rassegna ben pochi possono essere associati a tendenze di separatismo nazionalistico: possono forse ricadere nella categoria i samaritani del Quinto e del Sesto Secolo e gli armeni monofisiti.
Se poi i pauliciani ebbero uno Stato indipendente per una ventina d’anni, questo non fu che il risultato di circostanze tutte particolari, che non avevano niente a che fare con il dualismo in quanto tale.
Come abbiamo visto, i bogomili erano affatto pacifici di comportamento e per quanto sappiamo non avevano aspirazioni politiche.
La loro maggioranza era senz’altro slava, ma seppero farsi un seguito tra molte altre nazioni.
Pag. 150
Cap. 5. Il monachesimo.
Su nessun altro aspetto della vita bizantina siamo ampiamente documentati come sul monachesimo.
Possediamo centinaia di biografie di santi monaci, un’infinità di riflessioni, epistole, sermoni, esortazioni e giustificazioni attinenti alla condizione monastica.
Abbiamo inoltre un buon numero di regolamenti, canoni disciplinari, editti imperiali, persino un considerevole corpus di materiale d’archivio.
E tuttavia, nonostante questa sovrabbondante documentazione scritta, non è cosa facile rendere conto del monachesimo bizantino in termini che ci riescano oggi comprensibili.
Pag. 155
Sia nella sua forma eremitica sia in quella cenobitica il monachesimo costituiva una minaccia per la Chiesa istituzionale.
Il monaco, va ripetuto, era un cristiano laico che seguiva alla lettera l’ingiunzione di Cristo “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi ciò che possiedi e avrai un tesoro nei cieli” (Matteo, 19,21).
Cercava di essere il cristiano perfetto, di tornare alla semplicità dei tempi apostolici quando “tutti i credenti erano insieme e tutto ciò che avevano era in comune; e vendevano i loro possessi e i loro beni e ne distribuivano il prezzo a tutti” (Atti, 2, 44 sg.).
Il monaco riteneva che vi fosse una sola morale, una sola askesis, quella del Vangelo, e che in termini ideali ogni cristiano dovesse farsi monaco.
Significativo, tuttavia, che il monaco cercasse la perfezione non entro la Chiesa ma al di fuori di essa.
Anche sant’Antonio giunse alla santità senza alcun ricorso al clero e nei suoi vent’anni di reclusione non sentì alcun bisogno di comunicarsi.
Tutto il suo modo di vivere era un’implicita condanna della Chiesa ‘nel mondo’.
Laddove Origene aveva raccomandato una segregazione morale più che fisica da tutto ciò che era profano, il monaco proclamava la virtuale impossibilità di conseguire la salvezza senza ritirarsene fisicamente.
Il ministero della Chiesa, la sua liturgia, ciò che essa predicava risultavano pressoché irrilevanti.
Pag. 159
Il Quinto e il Sesto Secolo segnano l’apice del movimento monastico in Oriente.
Corteggiati da aristocratici e imperatori, incoraggiati dai vescovi, i nuovi ‘filosofi’ cristiani si beavano di quella notorietà che avrebbero dovuto evitare.
Per l’Egitto abbiamo la Historia monachorum (400 circa) e la Storia Lausiaca di Palladio (419-20), per la Siria la Historia religiosa di Teodoreto (444 circa).
Oltre a queste famose opere e alle singole Vite dei santi monaci più importanti, in tutte le lingue del Vicino Oriente circolavano infinite storie – spesso stereotipate e intercambiabili – che infine entrarono a far parte delle raccolte dette paterica (libri dei padri).
Comunque la più eloquente testimonianza del prestigio del monachesimo è sicuramente l’enorme complesso di Qal’at Sim’an, costruito per iniziativa imperiale quale centro di pellegrinaggio a Simeone Stilita.
Pag. 166
Per afferrare la complessità della situazione dobbiamo tenere presenti alcuni fatti.
Primo: il monastero bizantino era di norma uan azienda agricola che, debitamente amministrata, produceva un profitto che andava ad aggiungersi alle contribuzioni presentate dai nuovi entrati e alle altre donazioni.
Secondo: le proprietà di un monastero erano inalienabili per diritto sia civile sia canonico: ciò significa che o rimanevano quelle che erano o aumentavano.
Terzo: chi era proprietario di monasteri poteva appartenere a diversi corpi sociali: alcuni monasteri erano imperiali, altri patriarcali o episcopali; alcuni erano proprietà di privati per linea di discendenza ereditaria dal fondatore o per altre ragioni; altri monasteri erano affatto indipendenti.
Possiamo ritenere che in ogni caso il proprietario trattenesse tutto il surplus prodotto dal monastero e fosse in posizione tale da esercitare un influsso considerevole sugli affari interni dell’istituto.
Il gioco degli interessi era pertanto assai complesso.
Se il monastero non era indipendente (autodespoton o autoxousion) i monaci non ne erano i beneficiari principali.
Certo, il loro modo di vita poteva arrivare a essere piuttosto confortevole ma in sostanza essi restavano sorveglianti a metà strada tra il proprietario e i lavoratori agricoli.
Pag. 172
Con la loro lunga tradizione di testardaggine unita alla capacità finanziaria i monasteri bizantini erano ben preparati a sopravvivere sotto dominazione straniera.
Quelli del Monte Athos ottennero benefici considerevoli passando sotto il re di Serbia Stefano Dusan.
Quando, pochi decenni dopo, i turchi ottomani apparvero per la prima volta in Europa, i monasteri dell’Athos neppure aspettarono l’inizio del dominio turco.
Andarono direttamente dal sultano, offrirono la loro sottomissione e ottennero la conferma dei loro di ritti di proprietà terriera (1372 circa).
Negli anni di confusione che seguirono essi riuscirono addirittura ad ampliare i loro possedimenti e a impegnarsi in altre vantaggiose attività.
Certo, non possiamo dire lo stesso di tutti i monasteri, ma quelli che sopravvissero alla conquista non se la passarono affatto male durante i cinque secoli di dominazione turca.
Così il monachesimo bizantino sopravvisse all’Impero bizantino.
Pag. 181
Cap. 6. L’istruzione.
Alla fine del Quinto Secolo la vita universitaria stava cominciando ad assomigliare a quella della Germania nazista, ma il peggio doveva ancora venire.
Giustiniano, in particolare, era deciso a imporre uniformità di credo a tutti i suoi sudditi.
Si ricorda sovente, a prova della sua intolleranza, l’editto del 529 che ordinava la chiusura dell’Accademia di Atene – ma va segnalato che l’Accademia continuò a funzionare dopo quella data e che ad Alessandria la filosofia continuò a essere insegnata dal pagano Olimpiodoro sino a dopo il 565(anno della morte di Giustiniano).
Si trattava comunque di eccezioni.
Per quanto la legge del 529, che vietava l’insegnamento a pagani, eretici ed ebrei, forse non venne applicata su larga scala, non ci sono dubbi sulla sistematica persecuzione dei pagani nello stesso anno; e ancora nel 546, allorché “una moltitudine di grammatici, sofisti, avvocati e medici” venne trascinata dinanzi all’inquisitore Giovanni d’Efeso (eretico a sua volta) e punita con la flagellazione e incarceramenti; e nel 562, con il rogo dei libri pagani.
Ci si può agevolmente immaginare l’effetto di tali misure sul morale del mondo accademico – morale ulteriormente abbassato dal fatto che i sussidi statali non vennero più concessi agli insegnanti.
Non ci sorprende molto constatare che alla fine del Sesto Secolo la tradizione degli studi superiori era sopravvissuta solo a Costantinopoli, Alessandria e Beirut.
Pag. 197
Psello non era una figura di grande originalità quale pensatore e invero è difficile chiamarlo filosofo nel vero senso della parola.
Era però un uomo di curiosità senza limiti, che cercava di abbracciare tutti i campi della conoscenza.
Anche il suo insegnamento ricopriva un’area assai vasta, che andava dai rudimenti della grammatica e della retorica alle scienze naturali, alla filosofia, persino alla legge.
Non c’è ragione di pensare che qualcuno di questi insegnamenti risultasse sovversivo nei confronti dell’ordine costituito, anche se è vero che le sue ricerche lo condussero in qualche zona oscura.
Era certamente attratto dall’occulto, dalle cosiddette dottrine caldee – astrologia e demonologia – e in campo filosofico le sue preferenze andavano a Platone e ai Neoplatonici.
Pag. 208
Nel campo dell’istruzione il Dodicesimo Secolo rappresenta il culmine di un conflitto le cui origini, come abbiamo visto, risalgono all’inizio dell’Impero cristiano.
Si può trovare sorprendente che la Chiesa non abbia affermato la sua autorità in precedenza.
La ragione st forse nella natura intermittente e generalmente innocua dell’insegnamento filosofico.
Solo nell’Undicesimo Secolo, con l’insorgenza di uno spirito secolare, il pericolo si fece acuto e la speculazione filosofica nelle scuole – la ‘nuova ricerca’ (nea zetesis) condannata dal Synodicon – dové essere repressa.
Non seguiremo qui la storia posteriore dell’istruzione bizantina a Nicea, a Costantinopoli, a Trebisonda: una storia certo non priva di dignità, eppure confinata nei modelli tradizionali.
Ci proveremo invece a formulare qualche osservazione di carattere generale.
Sarà risultato evidente al lettore che a partire dal Settimo Secolo la distinzione tra studi secondati e studi superiori cominciò a sparire.
Abbiamo osservato qualche isolato tentativo del governo per istituire una sorta di università, con il cesare Barda, con Costantino Porfirogenito, con Costantino Monomaco: ogni volta questi progetti, con tutte le loro buone intenzioni, portarono a ben pochi risultati.
Così non vi fu una tradizione continua di studi superiori.
Il motivo ricorrente della ‘riscoperta della cultura’, di solito grazie all’illuminato patrocinio di un dato imperatore, va preso con un grano di sale; tuttavia non è senza rapporti con la realtà.
Se Leone il Matematico era almeno in parte giustificato nel ritenere di aver recuperato la cultura dall’oblio più profondo, pari ragione più tardi aveva anche Psello.
Le sole tradizioni continue furono l’insegnamento di legge nell’ambito delle corporazione dei notai e quello di grammatica con retorica da parte del grammatikos.
Entrambi gli insegnamenti erano reperibili solo a Costantinopoli.
Quel che è più evidente nell’insegnamento del grammatico è il suo carattere estremamente conservatore.
Quando scopriamo che Niceforo Basilace, insegnante della Scuola Patriarcale, nel Dodicesimo Secolo componeva ‘schizzi di carattere’ su argomenti come “Che cosa avrebbe potuto dire il navigante che avesse veduto Icaro volar nell’aere e Dedalo sfiorar la superficie marina con le punte dell’ali sue” o come “Che cosa avrebbe potuto dir Pasifae colta d’amore per un toro”, non possiamo sfuggire all’impressione che il tempo si sia fermato per un millennio.
Né possiamo fare a meno di domandarci che utilità avessero Icaro e Pasifae per il futuro funzionario statale, che non avrebbe condotto alcuno dei suoi affari in greco antico.
Il massimo che si possa dire è che una certa dimestichezza con la grammatica e la retorica definiva una certa classe professionale.
Ora, è stato calcolato che nel Decimo Secolo il totale dei ragazzi e dei giovani che fruirono dell’insegnamento grammaticale a Costantinopoli (e pertanto in tutto l’Impero) non superò i due o trecento.
Conseguenza: quale che sia il periodo che si vuol prendere in esame, il totale delle persone provviste di questa esperienza superava a stento il centinaio.
Per quanto approssimative siano, queste cifre ci danno una prospettiva senza la quale non c’è discorso sull’istruzione bizantina che abbia senso.
Immaginiamoci dunque un gruppo di un migliaio di persone di buona famiglia, spesso nipoti di vescovi o figli di pubblici funzionari: in breve, uomini impegnati in carriere che richiedevano dimestichezza con la parola scritta.
Essere in grado, secondo necessità, di stilare un’elegante epistola, o di pronunciare un’allocuzione dopo il pranzo al cospetto dell’imperatore, era cosa che non poteva non destare favorevole attenzione.
Di qui Icaro e Pasifae.
E dato che lo scopo di tutto l’esercizio stava nell’essere apprezzati dai propri pari, che ragione c’era per cambiare un sistema educativo che designava il tale o il talaltro come uomini di cultura?
Sono evidenti gli effetti di questo sistema di cose sulla letteratura bizantina e li esploreremo in un capitolo successivo.
Un’osservazione finale.
Non è mai esistita a Bisanzio un’istruzione monastica che sia andata oltre il livello più elementare.
Sin dal tempo di Pacomio alcuni dei monasteri più grandi cominciarono a provvedere all’istruzione dei novizi analfabeti che sovente erano ragazzi.
Veniva loro insegnato il servizio divino, il Salterio e il Nuovo Testamento (passi scelti), preferibilmente da parte di un monaco anziano cui era richiesto di usare a tal uopo una carriera separata, sì da proteggere i confratelli da tentazioni sessuali.
Il Salterio e gli altri più importanti libri della Bibbia venivano normalmente imparati a memoria, sì da ridurre il bisogno della familiarità con la scrittura.
L’istruzione dei ‘fanciulli laici’ nei monasteri era considerata inopportuna già da San Basilio e venne scoraggiata per tutta l’era bizantina.
Pag. 213-14
Parte Seconda. Il mondo concettuale di Bisanzio.
Il mondo invisibile del bene e del male.
Sarebbe superfluo diffondersi qui sul primato della Vergine Maria nel pantheon cristiano; per i bizantini ella poi aveva un ruolo particolarmente importante in quanto patrona e protettrice di Costantinopoli.
Assunse questo compito in virtù di due reliquie assai venerate che riuscirono ad arrivare nella capitale – il Cinto e il Velo.
Il Cinto era conservato alla basilica di Santa Maria al Mercato del Rame, che era ritenuta essere una fondazione dell’imperatrice Pulcheria(450); le rovine dell’abside sono tuttora conservate poco lontano da Santa Sofia, verso Ovest.
Stando a una tradizione fu Giustiniano a portare la reliquia a Costantinopoli da Zela, località posta a Sud di Amasia, nell’Asia Minore orientale; per una diversa tradizione fu l’imperatore Arcadio a portarla a Gerusalemme.
Pag. 225
Questa storie, così ingenuamente narrate, ci forniscono l’opportunità di avanzare un certo numero di osservazioni.
In primo luogo possiamo notare il forte sentimento ‘locale’ dimostrato dai demoni: quelli della Gordiene si ritenevano più forti di quelli della Galazia; i demoni originari della Cappadocia rifiutavano di essere confinato a Germia, e la loro supplica era considerata ragionevole da san Teodoro.
In secondo luogo i demoni erano legati alle reminiscenze del paganesimo antico.
L’identificazione ‘dèi pagani = demoni’ è un luogo comune del pensiero cristiano antico e infatti negli esempi che abbiamo citato Artemide appare con un séguito di demoni.
Ma le divinità antiche erano già morte, non avevano lasciato che una vaga memoria o un’aura di maleficio.
Come che fosse, le campagne continuavano a essere coperte di resti dell’antichità greco-romana.
I grandi sarcofagi marmorei con le rappresentazioni di banchetti funerari e di altre strane figure erano troppo preziosi per non essere all’occorrenza utilizzati quali abbeveratoi o fontane, e tuttavia anch’essi sembravano avere un che di funesto.
Anziché lasciar liberi i demoni che li sorvegliavano era spesso ritenuto più saggio non toccarli – e per questo gli archeologi possono essere grati.
Pag. 236
Il ruolo dei demoni nell’esistenza di ciascun uomo veniva a concludersi con l’esame postumo dell’anima.
Come in terra così nella sfera soprasensibile il fato dell’uomo veniva deciso dalla burocrazia degli angeli e dei demoni.
Divise in classi, le anime dei dipartiti ora attendevano il Giudizio Universale che non era affatto un giudizio ma semmai una sorta di grande corteo imperiale nel corso del quale le sentenze già in essere diventavano permanenti.
Pag. 240
Cap. 8. L’universo fisico.
Non dobbiamo farci sviare dall’asserzione – che pure è almeno parzialmente vera – che i bizantini ereditarono la speculazione scientifica degli antichi greci.
Certo, in alcuni periodi piuttosto che in altri vi fu qualche membro dell’élite intellettuale di Bisanzio che si dedicò allo studio della cosmologia e della geografia antica.
Vennero copiati e commentati testi di Aristotele, Tolomeo, Strabone e altri autori; e se dobbiamo essere grati in eterno agli eruditi bizantini che hanno salvaguardato per noi questa eredità, sbaglieremmo a supporre che le loro fatiche avessero un apprezzabile impatto sul più vasto pubblico.
Al bizantino medio non faceva certamente difetto l’interesse per il mondo che lo circondava, ma ai suoi occhi i problemi di scienza naturale rientravano nell’esegesi biblica e potevano essere risolti dalle autorevoli discussioni incentrate sui Sei Giorni della Creazione.
Il testo chiave era il primo capitolo dalla Genesi che, nonostante la sua brevità, contiene un buon numero di incongruenze.
C’era qualche altro passo della Bibbia (soprattutto dal libro dei Salmi e da Isaia) da prendere in considerazione, ma l’attività principale era l’interpretazione del Genesi che poneva molte difficoltà sia per le sue enunciazioni sia per le sue omissioni.
Pag. 243
La posizione di San Basilio può così definirsi:
1. Rifiuto di tutte le teorie pagane sull’universo date le contraddizioni reciproche.
Non c’è pertanto necessità di confutarle; si eliminano da sole.
Qual è lo scopo di tutta questa aritmetica e geometria, dello studio dei solidi, persino della rinomata astronomia?
Tutto è “faticosa vanità”.
Come dice San Paolo (testo di importanza centrale per questo problema) “Si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente insensata si è ottenebrata. Affermando di essere sapienti son divenuti stolti” (Lettera ai romani 1, 21 sg.).
2. La certezza, di cui sono così dolorosamente privi i pagani, viene fornita da Mosè (ritenuto autore del Genesi) el cui qualifiche accademiche erano eccellenti siccome allievo di sapienti egiziani che passò quarant’anni in contemplazione.
Così munito egli vide Iddio vis-à-vis e gli venne direttamente detta la verità.
Che bisogno c’è dunque di porgere l’orecchio agli argomenti degli uomini?
3. La Bibbia deve essere intesa letteralmente e non allegoricamente.
Se essa tace su qualche argomento è perché esso non deve riguardarci.
4. L’universo ha uno scopo morale: è una scuola dove le anime dotate di ragione vengono istruite e guidate verso l’alto, fino alla contemplazione dell’invisibile.
Pertanto lo studio del mondo deve essere condotto da uno spirito affatto purificato dalle passioni carnali, libero dalle cure quotidiane e sempre in cerca di un’adeguata nozione di Dio.
Pag. 247
Bastano questi esempi per illustrare l’approccio di Basilio.
Nonostante la sua ricerca di certezza, di certezza che solo la Bibbia poteva fornire, Basilio si accontentava di sorvolare su alcuni dei grandi problemi della cosmologia.
Era molto più a suo agio quando descriveva le lezioni morali desumibili dall’osservazione degli animali.
Forse era un uomo troppo colto per adottare le ingenue conclusioni che erano l’ineluttabile conseguenza di un’interpretazione letterale del testo biblico; si rifugiò così in una sorta di indifferentismo.
San Giovanni Crisostomo perseguì un approccio di tipo allegorico su questi problemi ma neppure lui riuscì a soddisfare interamente un pubblico che voleva risposte semplici a questioni fondamentali.
Questo pubblico si rivolse pertanto a una diversa scuola esegetica, solitamente chiamata Scuola d’Antiochia, che ebbe il coraggio di costruire un sistema interamente biblico.
I suoi maestri, dopo Teofilo d’Antiochia, furono Diodoro di Tarso, Teodoro di Mopsuestia, Severiano di Gabala e infine Cosma Indicopleuste.
Pag. 249-50
Cap. 9. Gli abitanti della terra.
La diversità dei popoli veniva spiegata dalla divisione delle terre tra i figli di Noè e la successiva moltiplicazione delle lingue durante la costruzione della Torre di Babele; infatti prima di allora l’umanità non conosceva distinzioni interne e parlava uan sola lingua: l’ebraico.
Il capitolo 10 del Genesi forniva l’elenco base dei popoli.
Nella versione dei Settanta questo elenco contiene un certo numero di nomi che possono essere interpretati in senso etnico e altri che sono chiaramente etnici.
Così tra gli otto figli di Jafet troviamo Iouan (che fa pensare agli Ioni) e Thiras o Tharsis che assomiglia sia ai Traci sia ai Keti (si pensi a Cizio, città cipriota) e ai Rodi.
Tra i quattro figli di Cam, Misraim si riferisce chiaramente all’Egitto (Misr), laddove Canaan generò Sidone, i Gebusei, gli Amorei, gli Arvadei (da Arado in Siria), i Samarei e gli Amatei (dalla città cipriota di Amathos) e così via.
Pag. 264
Il principale problema che i popoli della terra ponevano alla mentalità bizantina era il loro posto nel progetto della divina provvidenza.
Il Vangelo proclama l’eguaglianza tra gli uomini, poiché Dio “da un solo sangue ha fatto uscire tutto il genere umano, per popolare tutta la faccia della Terra, avendo determinato la durata dei tempi e i confini della loro dimora; Egli ha voluto che gli uomini cercassero il Signore e si sforzassero di trovarlo, come a tastoni, quantunque non sia lontano da ciascuno di noi” (Atti degli apostoli 18, 26 sg.).
E tuttavia sembrava che questi vari popoli non fossero stati oggetto di pari sollecitudine da parte del Signore.
Non c’erano problemi in merito al periodo iniziale, i circa 2.900 anni che andavano dalla Creazione alla divisione delle lingue.
Ma che dire dei successivi 2.600 anni, fino all’Incarnazione?
I profeti erano stati inviati agli Israeliti soltanto, laddove gli altri popoli erano rimasti nell’ignoranza di Dio.
E il periodo successivo all’Incarnazione?
Per quanto si fosse diffusa la predicazione del Vangelo, non si era estesa a tutta la terra.
E infine qual era il ruolo delle nazioni pagane nello schema della Provvidenza divina?
Pag. 266-67
Cap. 10. Il passato dell’umanità.
Con Abramo giungiamo a uno dei punti nodali che hanno caratterizzato il corso della storia universale, perché fu lui a introdurre la vera conoscenza di Dio, distruggendo gli idoli del padre.
Caldeo per nascita, diede inizio alla storia del popolo ebraico.
Fu anche una figura importante per la storia della scienza: esperto d’astronomia per la sua origine caldea, insegnò questa disciplina agli egizi.
Fu dai caldei, inoltre, che apprese l’uso delle lettere e lo trasmise ai fenici dai quali in seguito i greci mutuarono il loro alfabeto.
Fu inoltre contemporaneo di Melchisedec, il sacerdote-re di stirpe ‘gentile’ che fondò Gerusalemme e fu il prototipo di Cristo.
Il regno di Sicione – il più antico della Grecia – venne fondato nella stessa epoca.
Lo stadio successivo del processo della storia si lega a Mosè, il più grande di tutti i profeti anteriori a Giovanni Battista nonché, incidentalmente, primo tra tutti gli storici.
L’importanza di Mosè non sta tanto nel fatto che liberò il suo popolo dalla cattività in Egitto ma nella superiore rivelazione che gli fu concessa e nei ‘segni’ che accompagnarono tutta la sua carriera.
Analogamente a Cristo, Mosè scampò da infante all’omicidio che venne invece perpetrato su tutti i maschi appena nati della sua stirpe; come Cristo anche Mosè si ritirò nel deserto - non per quaranta giorni ma per quaranta anni.
Quando separò le acque del Mar Rosso, lo colpì con un movimento a forma di croce e anche quando gettò un albero nelle acque amare di Mara, anche allora quel gesto fu un’allusione alla vivifica Croce.
Le dodici fonti d’acqua e le settanta palme di Elim stavano per i dodici apostoli maggiori e i settanta apostoli minori.
La manna raccolta nei sei giorni della settimana e rimasta buona per il sabato prefigurava il corpo di Cristo.
Infine, nonostante che Mosè morì e fu sepolto, nessuno vide la sua tomba.
Il codice religioso stabilito da Mosè era certamente provvisorio, adeguato al fatto che il suo popolo non aveva perfetta intelligenza e le sue abitudini erano idolatriche – era un’ombra della realtà avvenire.
A confronto, comunque, con i popoli ‘gentili’ del suo tempo (Mosè era generalmente ritenuto contemporaneo di Inaco, primo re argivo), Mosè era figura di dottrina insuperata: un’osservazione che serviva a dimostrare una volta di più che tutta la conoscenza pagana, e particolarmente quella greca, non era che uno sviluppo posteriore e derivato.
Pag. 284-85
L’incarnazione di Cristo, evento centrale di tutto il processo storico, corrisponde al regno di Augusto, primo sovrano che si trovò a dominare il mondo intero e quindi apportatore di pace universale.
Inoltre, dato che l’Impero romano è il quarto regno delle profezie di Daniele, esso ben si presta ad accogliere l’avvento del Creatore dei quattro elementi.
La fine delle sette ‘settimane’ di Daniele viene inoltre a connettersi con la soppressione dei grandi sacerdoti degli ebrei – gli ‘unti’.
Gli imperatori romani successivi ad Augusto vengono soprattutto considerati dal punto di vista del cristianesimo.
La crocifissione di Cristo avviene sotto Tiberio.
Esso cade di venerdì perché l’uomo è stato creato il sesto giorno e Adamo mangiò il frutto dell’albero proibito alla sesta ora del giorno.
La resurrezione ripete la creazione.
Pilato riferisce a Tiberio i miracoli di Cristo e l’imperatore concede libertà completa alla predicazione cristiana, tanto che tutta la terra ne viene riempita.
Il regno del malvagio Caligola è testimone della conversione di San Paolo e del martirio di Stefano, quello di Claudio della fondazione del monachesimo a opera di San Marco.
Sotto Nerone, primo persecutore dei cristiani, vengono messi a morte Pietro, Paolo, Giacomo e Luca.
Nel contempo gli ebrei avevano ricevuto quaranta anno di tempo a partire dall’Ascensione per pentirsi.
Il risultato del loro mancato pentimento è il sacco di Gerusalemme e la distruzione del tempio.
Questa è la quarta cattività degli ebrei e non avrà fine, né gli ebrei avranno altri profeti.
I loro successivi tentativi di ricostruzione del tempio verranno soprannaturalmente vanificati.
Pag. 286
Cap. 11. Il futuro dell’umanità.
Per un certo periodo la speranza che nel Settimo Secolo l’Impero arabo crollasse sembrò prossima a realizzarsi.
A conferma di ciò potevano considerarsi la guerra civile araba (661-65), il fallimento dell’attacco a Costantinopoli (674-78), le devastanti incursioni dei mardaiti in Siria e in Palestina.
Gli arabi dovettero accettare la pace alla sfavorevoli condizioni imposte dall’imperatore Costantino Quarto e allora, stando alle parole di un cronista, “vi fu grande tranquillità sia in Oriente che in Occidente”.
Ben presto, tuttavia, gli arabi tornarono all’offensiva.
Non sappiamo nei dettagli coem questa nuova situazione potesse esser fatta rientrare nella visione apocalittica: sappiamo solo che la durata prevista dell’Impero arabo venne gradualmente estesa: alla fine del Secolo Ottavo il periodo della sua prosperità e potenza aveva assegnato un arco di 152 anni.
Intorno all’820 un profeta siciliano si limitò a rielaborare lo Pseudo-Metodio ma introdusse un tocco di novità e cioè che l’ultimo imperatore si sarebbe rivelato a Siracusa.
Avrebbe inviato i suoi emissari “nelle regioni interne di Roma e avrebbe domato le stirpi bionde e insieme avrebbero dato la caccia a Ismaele”.
A Roma l’imperatore avrebbe trovato tesori nascosti, sufficienti per pagare le sue truppe, e poi avrebbe marciato via terra sino a Costantinopoli.
Poi sarebbe apparso l’anticristo, eccetera.
Un lato interessante di questa profezia è che assegna un posto ai popoli germanici entro lo schema escatologico.
Le “stirpi bionde” erano destinate a ricoprire un ruolo importante nelle successive profezie bizantine, dove sarebbero state identificate ora con gli occidentali, ora con i russi.
Pag. 300-1
Il profilo qui fornito circa le idee bizantine sul futuro dell’umanità e sul Secondo Avvento dimostra che nonostante tutte le graduali trasformazioni subite esse rimasero notevolmente vicine alle loro origini bibliche.
Sarebbe un errore confinare queste idee nel campo della fantasia e dei racconti delle vecchie zie; infatti, eccettuata la sola Scrittura, non c’era altra categoria letteraria cui le persone comuni si dedicassero più avidamente dei testi oracolari.
Essi forniscono una chiave di comprensione della mentalità bizantina e come tali sono degni dell’attenzione dello storico.
Insegnano anzitutto a non attendersi in terra alcuna durevole felicità o soddisfazione.
L’intento degli ‘ultimi giorni’ era di sottoporre i cristiani a una serie di crudeli prove, sì da separare gli eletti dai peccatori.
E poiché il Messia già era venuto, non ci poteva essere alcuna età messianica nel futuro.
L’Apocalisse di San Giovanni, l’unico libro biblico che prevedesse un millennio di felicità prima della fine del mondo, non era considerato testo canonico a Bisanzio e pertanto non era preso in considerazione per questi fini.
C’è un altro elemento che colpisce nelle profezie bizantine e riguarda l’assenza di qualsiasi senso nazionale.
Certo, la portata geografica degli oracoli tendeva a ridursi finché non venne praticamente a limitarsi ai destini di Costantinopoli, ma era soltanto un segno di miopia.
Preoccupati per i loro problemi, gli abitanti di quello Stato bizantino ridotto non guardarono abbastanza lontano da abbracciare tutta l’umanità.
L’adempimento dei loro desideri consisteva nella distruzione simultanea degli occidentali e degli ismaeliti (ora identificati con i turchi).
Ma anche così il ‘re liberatore’ non avrebbe introdotto un periodo di reviviscenza nazionale; vendicando le sofferenze patite dai bizantini avrebbe dato inizio alla fine del mondo.
Fu solo dopo la caduta di Costantinopoli, davvero molto tempo dopo, che il liberatore, l’imperatore ‘che si era addormentato’ o ‘trasformato in marmo’, assunse il ruolo dell’eroe nazionale che avrebbe scacciato da Costantinopoli i turchi, avrebbe posto nuovamente la croce sulla cupola di Santa Sofia e fondato uno Stato greco.
Pag. 311-12
Cap. 12. La vita ideale.
Non può mettersi in dubbio che il cristianesimo abbia introdotto almeno un poco di mitezza nei rapporti sociali, soprattutto per quanto riguardava la schiavitù.
Le Vite dei santi ripetutamente sottolineano il fatto che tutti gli uomini erano fatti della stessa argilla e biasimano i padroni crudeli.
A volte si levano suppliche per la ridistribuzione delle ricchezze.
Così nel Sesto Secolo Agapeto osserva che ricchi e poveri “patiscono simile danno da dissimili circostanze; questi scoppiano d’abbondanza, quelli sono distrutti dalla fame”.
Pertanto esorta l’imperatore a prendere una parte del surplus dei ricchi per darlo ai poveri e in tal modo addivenire a maggiore uguaglianza.
Con la sua continua insistenza sull’obbligo del cristiano all’elemosina la Chiesa ottenne identico risultato più efficacemente e su più ampia scala di quanto sarebbe stato possibile a qualsiasi intervento del potere centrale.
Nel contempo va osservato che non si invocava alcuna riforma fondamentale della società: tanto più che il merito stava solo nell’azione volontaria.
Se la ricchezza in sé fosse un male allora perché noi tutti desidereremmo trovare requie nel seno d’Abramo, che era stato ricco, padrone di trecentodiciotto servi?
Certo, all’origine della disuguaglianza nella distribuzione stava l’ingiustizia: Dio dava a tutti il pubblico demanio imperiale.
Non c’erano dispute o contese in merito all’uso dei bagni, strade o piazze mentre costanti erano i conflitti dovuti alla proprietà privata.
Ma dato che la ricchezza si tramandava di padre in figlio e che era impossibile rintracciare l’atto di ingiustizia originario da cui essa veniva, tutto quel che importava era che chi si trovava a possederla la usasse saggiamente e ne facesse partecipare i bisognosi.
Pag. 320-21
Tante e tante volte ci hanno spiegato che il cristianesimo si compenetrò d’ellenismo che tendiamo a trascurare un fatto molto basilare: lo schema della vita cristiana, quale lo esposero i padri del Quarto Secolo e quale poi si mantenne nel corso di tutta l’età bizantina, ere proprio l’antitesi dell’ideale ellenico della polis.
Profondamente radicato nella Bibbia qual era, lo schema cristiano era anche un riflesso dell’ordine autoritario e irreggimentato del tardo Impero.
Si fondava sulla monarchia, sull’impermeabilità tra le classi sociali, sulla schiavitù.
Il suo atteggiamento nei confronti del mondo materiale – il mondo della carne – era di orrore quasi manicheo.
Rispecchiava inoltre l’instabilità dei tempi con la similitudine tra l’uomo virtuoso e la cittadella fortificata.
Ora, non dobbiamo immaginarci che il bizantino medio vivesse in assoluta conformità alla propaganda della Chiesa, ma non possono esserci dubbi sugli effetti di un messaggio ripetuto da secolo a secolo.
Un esame della letteratura bizantina ne rivelerà le tracce sotto più di un aspetto.
Pag. 329-30
Parte terza. L’eredità.
Cap. 13. La letteratura.
Come abbiamo indicato nel primo capitolo, l’Impero multinazionale della Nuova Roma non si espresso solo in greco.
Molti suoi abitanti parlavano e scrivevano altre lingue.
Se pertanto noi definissimo la letteratura bizantina come letteratura di un dato impero e di una data civiltà, dovremmo far rientrare sotto questa etichetta non solo il componente greco, che è il principale, ma anche un considerevole corpus di testi in latino, siriaco, copto, slavo ecclesiastico e anche armeno e georgiano.
Qui non faremo così, ma è utile ricordare che limitandoci al greco trascureremo un intricato modello di influssi reciproci che si manifestò non solo nella migrazione di testi ma anche in convenzioni linguistiche e mentali.
La letteratura greca bizantina, in altri termini tutto ciò che è stato scritto in greco tra il Quarto e il Quindicesimo Secolo, ci colpisce anzitutto e semplicemente per la sua mole.
Sembra che nessuno abbia mai calcolato quali siano esattamente le sue dimensioni.
Proviamo a dire che ad una valutazione assai approssimativa essa dovrebbe riempire dai duemila ai tremila volumi di dimensioni normali.
Una sua parte – ma si tratta ormai di una parte non molto grande né molto interessante – rimane ancora inedita, il che significa che è disponibile solo nei manoscritti; uan notevole sua porzione è andata perduta: parecchio del primo periodo medio, decisamente poco dell’ultimo periodo.
Pag. 335
Non sarebbe corretto giudicare la letteratura bizantina con il criterio del piacere estetico che essa concede al lettore moderno.
Se essa non ci cattura o non ci commuove è perché il nostro gusto letterario è diametralmente opposto a quello dei bizantini colti.
Noi apprezziamo l’originalità e quelli apprezzavano il cliché; noi non sopportiamo la retorica e quelli ne erano appassionati; ci piace la concisione, laddove quelli avevano naturale inclinazione a quanto fosse elaborato e verboso.
Per il momento sospendiamo il giudizio e cerchiamo di giungere a una prima comprensione della letteratura bizantina nel suo contesto storico.
Per farlo ci sono molti fattori da tenere in considerazione.
Il primo fattore riguarda lo sviluppo della lingua greca.
Al normale filologo classico il greco appare congelato in due stadi, l’epica (Omero, Esiodo) e l’attico letterario del Quinto e del Quarto Secolo a. C.
La sua evoluzione successiva, incluso ciò che è solitamente definito greco neotestamentario, è considerata fase di decadenza.
Ma come ogni lingua viva il greco subì uno sviluppo continuo nella fonologia, nella morfologia, nella sintassi e nel vocabolario; il passo decisivo fu in età ellenistica, quando divenne un mezzo di comunicazione internazionale.
Non è questa la sede per descrivere dettagliatamente tali cambiamenti, ma dobbiamo notare un fattore che avrebbe avuto conseguenze durature: la scomparsa della quantità delle vocali (lunghe o brevi per natura o per posizione), cui si sostituì l’accento tonico.
Il risultato fu che gli schemi prosodici sui quali si era basata l’antica poesia greca erano divenuti inintelligibili.
Nel contempo, o poco dopo, molti altri cambiamenti erano avvenuti: i dittonghi non venivano più pronunciati; il duale, il medio, l’ottativo, il dativo non erano più d’uso comune, eccetera.
Per quanto sappiamo, il normale greco parlato d’età bizantina era molto più vicino al greco moderno che al greco antico.
Pag. 336-37
Qual era dunque lo scopo del comporre opere letterarie?
Nessun autore bizantino ebbe certo la pretesa o l’ambizione di eguagliare i classici, e qui intendo non tanto i classici dell’antichità pagana quanto i classici cristiani: san Giovanni Crisostomo, i due Gregori, Basilio, Sinesio.
Essi stavano su un podio speciale e a giudicare dal numero dei manoscritti conservati erano letti più degli altri autori.
Il compito degli epigoni era di esporre gli avvenimenti più recenti, sì da evitare che cadessero nell’oblio (preoccupazione, questa, sovente espressa); di riferire le vite dei santi contemporanei; di assimilare la dottrina e l’insegnamento morale dei Padri; di produrre ogni sorta di manuali utili.
Non deve quindi sorprendere che i bizantini provassero poco interesse per la loro letteratura e nessuno per le biografie dei loro scrittori – ecco perché sappiamo tanto poco sul loro conto.
Si riteneva sufficiente dire nel titolo che tizio e caio era stato diacono di Santa Sofia, o vescovo di Sinada, o protospathaeios, in altri termini dargli un posto nella gerarchia.
Il ruolo della letteratura ‘bella’ si limitava all’esibizione retorica, e il nostro capitolo sull’istruzione dovebbe averlo già suggerito.
Sembra che gran parte di questa elaborata produzione fosse destinata alla recitazione orale; non solo i discorsi e i sermoni ma anche le lettere, le Vite dei santi scritte in stile ‘alto’, forse addirittura qualche capitolo di storiografia.
Terminata la recitazione, l’autore veniva applaudito dai suoi amici e il testo era pronto a essere dimenticato a meno che l’autore in persona o qualche membro della sua cerchia si assumesse il compito di copiarlo qualche esemplare degno di essere imitato.
Ma anche se veniva copiato, non aveva ampia circolazione.
La maggior parte di questi testi sono circolati in un unico manoscritto.
Ciò rende conto della ‘atemporalità’ della letteratura bizantina, nel senso che ogni generazione di scrittori non costruiva sull’esperienza e sulle idee della generazione precedente ma piuttosto si poneva costantemente in rapporto con i suoi lontani modelli.
La prova, come sa ogni studioso di filologia bizantina, è che ogni testo che non sia saldamente attribuito a un autore identificabile o che sia privo di chiari riferimenti storici risulta pressoché impossibile da datare.
Gli esempi sono numerosi e spesso imbarazzanti; non parlo qui soltanto di pastiches come i dialoghi pseudolucianei o quelle orazioni contri Leptine che per lungo tempo vennero considerate di Elio Aristide (Secondo Secolo d. C.) e che ora sappiamo essere opera di Tommaso Magistro (Quattordicesimo Secolo).
Lettere di Isidoro di Pelusio (Quinto Secolo) sono state attribuite da uno studioso insigne a Fozio (Nono Secolo), ed è tuttora controverso se la versione greca del Barlaam e Ioasaf sia di San Giovanni Damasceno (Ottavo Secolo) o se, come sembra più probabile, risalga all’Undicesimo Secolo.
Si è persino asserito che un testo storico quale La presa di Tessalonica di Giovanni Caminiate sia stato composto non già poco dopo il 904 come tutti pensavano, ma all’inizio del Secolo Quindicesimo.
Tali incertezze non sarebbero state possibili se lo stile della letteratura bizantina avesse evidenziato sviluppi apprezzabili.
Pag. 345-46
I pochi esempi da noi qui forniti non costituiscono certamente una base sufficiente per avanzare un giudizio sulla letteratura bizantina nel suo complesso, anche se possiamo sperare di averne reso in parte il sapore.
A un osservatore moderno questa letteratura sembra carente sotto più aspetti.
C’è un’enorme quantità di versi, ma quasi non c’è poesia e non c’è niente per il teatro.
C’è ironia, spesso goffa, ma non c’è praticamente umorismo.
Tranne pochissime eccezioni, non c’è interesse per l’amore, se non per quello sacro o familiare.
Non c’è niente di sboccato e non c’è joie de vivre.
La letteratura bizantina ha un tono solenne e persino cupo; probabilmente è al suo meglio quando deve descrivere morte, disastri, l’instabilità dell’esistenza umana.
Si è soliti asserire che il più grande risultato conseguito dai letterati bizantini non stava nella creazione di opere originali ma nella conservazione dell’eredità classica.
Che la maggior parte della letteratura greca ancor oggi conservata sia giunta a noi via Bisanzio è un fatto innegabile.
Vero è anche dire che ‘conservazione’ non era un processo passivo: presupponeva attività di raccolta di libri, di copia, di redazione.
Rendeva necessario scrivere commenti, compilare glossari ed enciclopedie.
La Biblioteca di Fozio, l’Antologia Greca, gli Excerpta di Costantino Porfirogenito, la Souda, i commenti omerici di Eustazio rappresentano grandi realtà erudite, analogamente alle intraprese di filologi di età paleologa quali Massimo Planude e Demetrio Triclinio.
Perché dunque i bizantini, che tanta attenzione dedicarono agli autori classici, mai ne intesero lo spirito?
Si è data la colpa alla Chiesa, al monachesimo, all’autocrazia.
Quanto a me, non credo che alcuno di questi fattori basti a spiegare la peculiare impenetrabilità della mente medievale a una serie di idee e valori che essa considerava alieni, malvagi, caduti in disuso.
Sarà pertanto più fruttuoso cercare una risposta in alcune considerazioni che abbiamo presentato all’inizio di questo capitolo.
Di rado sopravvengono mutamenti basilari negli atteggiamenti intellettuali senza corrispondenti cambiamenti nelle strutture sociali.
La società bizantina avrebbe potuto essere trasformata, e la generazione di Psello ci dà qualche motivo di supporre che le sue abitudini intellettuali – ivi compreso il rapporto con i classici – avrebbero potuto evolversi in una nuova direzione.
Purtroppo gli eventi decisero in altro modo.
Pag. 364-65
Cap. 14. L’arte e l’architettura.
Bisogna ammettere che l’arte è la sola porzione dell’eredità bizantina che esercita su di noi un richiamo immediato.
Un’asserzione di questo genere non sarebbe stata vera cento anni fa e se è vera oggi la ragione è che il nostro gusto estetico si è allontanato dal naturalismo privilegiando in parte o del tutto l’astrazione.
Come ebbe a scrivere Robert Byron nel 1930, “Tra le numerose culture europee i cui monumenti sono considerati grandi dal nostro gusto, l’arte figurativa bizantina è stata la prima a scoprire quel principio di interpretazione – anziché di riproduzione – dei fenomeni da noi percepiti, che nel nostro tempo è venuto a soggiacere a ogni forma di espressione artistica”.
La produzione bizantina era apprezzatissima anche nel Medioevo, , ma per ragioni completamente diverse.
L’erudito arabo al-Djahiz (Nono Secolo), pur osservando che i bizantini erano privi di scienza e di letteratura, elogia assai i risultati da loro conseguiti nella lavorazione del legno, nella scultura, nei tessuti.
Conclude che “gli antichi greci erano uomini colti, i bizantini sono artigiani”.
Pag. 367
Parlando di arte proto bizantina o di arte paleocristiana (è quasi la stessa cosa) dobbiamo ricordarci che intendiamo l’arte del tardo impero romano adattata alle necessità della Chiesa.
Può essere che, tratteggiando l’opposizione dei primi cristiani alla rappresentazione artistica, gli storici abbiano indebitamente esagerato; comunque, non si può dire che essi avessero un programma artistico.
Diversamente da quella di Mani, la dottrina di Gesù non si trasmetteva facendo ricorso ad immagini.
Il problema di un’arte cristiana si pose dapprima all’epoca della conversione di Costantino, quando l’imperatore, i suoi parenti e i membri delle più alte sfere del clero (che, come abbiamo visto, improvvisamente si ritrovarono ricchissimi) cominciarono a erigere splendide chiese.
Per la loro forma architettonica si trovò ben presto una formula (invero, poteva essere preesistente): la basilica, un salone rettangolare delimitato da un giro di colonne, con un palco (bema) a un’estremità.
Derivata da un tipo di edificio ampiamente usato nel mondo romano per vari scopi giudiziari, commerciali, militari e cerimoniali, la basilica cristiana era concepita per soddisfare le esigenze della synaxis; la spaziosa navata ospitava la congregazione dei fedeli, mentre l’elevato bema era per il clero, con la cattedra vescovile posta al centro.
Un altare era adibito al sacrificio eucaristico, l’altro era destinato alle offerte dei fedeli.
Mentre il nucleo architettonico della chiesa non creava alcune intrinseca difficoltà, valeva il contrario per le decorazioni.
Pag. 370
Al suo volgere l’Impero bizantino del primo periodo lasciava pertanto una eredità complessa e non assimilata, costituita in parte da un classicismo parzialmente degradato e in parte da uno stile più astratto e decorativo.
Quel che è importante è capire che non corrispondevano rispettivamente alla sfera profana e a quella religiosa.
Al contrario: una certa misura di classicismo rimase permanentemente insediata nel corpus di illustrazione biblica e agiografica che come abbiamo visto raggiunse forma canonica all’inizio del Sesto Secolo.
Questo spiega il fatto – piuttosto sconcertante a prima vista – che nel periodo bizantino tardo il più alto livello di classicismo si associa a contenuti religiosi tradizionali.
Pag. 381
L’impatto dell’iconoclasmo sull’arte deve essere valutato sulla base dell’evidenza testuale più che su quella dei monumenti sopravvissuti.
Certamente vi furono ampie distruzioni delle precedenti opere con rappresentazioni religiose; vennero date alle fiamme icone portatili, pitture murali e mosaici vennero graffiati via o imbiancati, piatti liturgici furono fusi e subirono mutilazioni i manoscritti miniati.
Certo, non dobbiamo immaginarci che si procedette alla distruzione con la spietata sistematicità che caratterizza i regimi totalitari moderni.
Per esempio ci sorprende venire a sapere che alcuni mosaici e alcune pitture del palazzo patriarcale di Costantinopoli – il vero ganglio dell’iconoclasmo – furono asportati solo nel 768: una quarantina d’anni dopo la promulgazione del divieto.
A Tessalonica i mosaici di San Demetrio non sembrano aver subito danni, mentre il mosaico absidale della Mone Latomou (Hosios David), nella medesima città, venne occultato sotto una copertura protettiva.
In linea generale si direbbe che le distruzioni più gravi furono a Costantinopoli e in Asia Minore (in altre parole, nelle aree poste sotto l’effettivo controllo del governo); non così nelle province più fuori mano.
Gli iconoclasti non riuscirono a sradicare tutte le tracce dell’arte religiosa paleocristiana in Oriente, ma certamente ne diminuirono il volume.
Pag. 382
Il contributo più significativo dato dal periodo iconoclastico allo sviluppo dell’arte bizantina stava comunque nella formulazione di una precisa teoria e giustificazione della pittura religiosa.
Per tutto un secolo i migliori intelletti di Bisanzio si dedicarono a questo problema e se gli scritti dei teorici pro-iconoclasmo sono andati distrutti, quelli dei loro oppositori ortodossi – dei patriarchi Germano e Niceforo, di San Giovanni Damasceno, di San Teodoro Studita – occupano molti volumi.
Il dibattito venne condotto sul piano teologico e su quello filosofico e si incentrò su questioni quali l’autorità della Scrittura e quella dei Padri, il rapporto tra l’immagine e l’archetipo (la persona che dall’immagine è rappresentata), e soprattutto l’ammissibilità della rappresentazione del Cristo, che era nel contempo Dio e uomo.
La conclusione infine raggiunta fu che si era autorizzati a rappresentare quei sacri personaggi che erano effettivamente apparsi sulla terra in forma visibile: Cristo, poiché era stato vero uomo, i santi, persino gli angeli che in varie occasioni si erano manifestati in forma umana; ma non Dio Padre o la Santa Trinità.
Si stabilì anche che l’immagine era diversa dal suo archetipo per quanto ne riguardava la ‘essenza’ o ‘sostanza’ (ousia), ma era identica quale ‘persona’ (hypostatis).
Era come l’impressione di un anello con sigillo o il riflesso in uno specchio; in altre parole, l’icona era considerata essere un ritratto vero e proprio.
Pag. 384
Stando alle opinioni di molti recenti studiosi, la storia dell’arte bizantina è stata scandita da una serie di movimenti di rinascenza.
Due sono riconosciuti essere i più importanti tra loro: la cosiddetta rinascenza macedone e la cosiddetta rinascenza paleologa.
La prima prende il nome dalla dinastia macedone; nonostante le scarse testimonianze in merito, si ritiene che sia giunta al suo apice durante il regno di Costantino Settimo Porfirogenito.
Va detto sin d’ora che la rinascenza macedone non si riflette in alcune restante opera di pittura parietale o di mosaico; la sua impronta è avvertita solo nel campo delle arti minori, soprattutto nei manoscritti miniati e negli avori.
Pag. 391
Ciò che può essere definita fase matura dell’arte bizantina cade approssimativamente tra il 1100 e il 1150, nel periodo della rinascita urbana.
Quest’arte si irradiò ben al di là dei confini dell’Impero e le manovalanze bizantine vennero chiamate a Kiev e a Novgorod, a Montecassino, a Palermo, a Cefalù.
L’influsso bizantino penetrò in Italia via Venezia, via Sicilia e via i territori dell’Impero situati nel Sud della penisola.
Più a nord, particolarmente in Germania, lo stile bizantino si diffuse in data un po’ più tarda (a partire dalla fine del Dodicesimo Secolo circa) e soprattutto grazie a opere che potevano essere trasportate – per esempio i manoscritti miniati.
Pag. 394
Per concludere questa rapida rassegna dell’arte bizantina possiamo concederci qualche riflessione di carattere generale.
Senza alcun dubbio la nostra comprensione di questa arte è assai sbilanciata e frammentaria.
Se fosse rimasta conservata parte maggiore dei suo corpus profano, sicuramente avremmo trovato maggiore varietà e apertura agli influssi esterni.
Leggiamo per esempio che l’imperatore Teofilo rimase così incantato da quel che gli era stato riferito in merito ai palazzi di Bagdad che cercò di imitarli e che a metà del Dodicesimo Secolo venne costruito nel palazzo imperiale un salone in stile selgiuchida, con tanto di stalattiti e piastrelle smaltate.
Parlando poi di piastrelle smaltate, è solo negli ultimi 40-50 anni che si è giunti a riconoscerne l’ampio utilizzo nella decorazione parietale bizantina, sebbene ci possa mettere a disagio provare a visualizzarne l’effetto.
Ampio era anche il traffico di oggetti d’importazione: per quanto attiene all’islam, pensiamo ai lavori in metallo, alle sete, ai cristalli di rocca: tutto questo non mancò di esercitare il suo influsso sul gusto dei bizantini.
Invero per alcune arti minori – tessuti e ceramiche inclusi – è spesso molto difficile distinguere la produzione bizantina da quella di altre aree del Vicino Oriente.
Dovendo in massima parte limitarci alla sfera conservatrice dell’arte religiosa bizantina, e portando il pregiudizio dell’ammirazione per l’antichità classica, possiamo forse porre troppo spesso l’accento sulla tradizione classica.
Abbiamo tentato di suggerire che, come gli scrittori bizantini non capivano veramente l’antica letteratura greca, così gli artisti bizantini non provavano interesse per l’arte classica dell’età pagana-greca o romana che fosse.
Ciò che essi conoscevano dell’antichità era filtrato sino a loro attraverso i canoni dell’illustrazione biblica e agiografica, ai cui più antichi esemplari gli artisti bizantini fecero ripetuto ricorso.
Ma così operando gli artisti bizantini del Medioevo non poterono evitare di parafrasare i modelli che imitavano, ed è in questa parafrasi selettiva che risiede gran parte della bellezza dell’arte bizantina.
Laddove la prima arte cristiana tendeva all’ostentazione e si mostrava – almeno in base a standard classici – incompetente, l’arte bizantina infuse nelle forme antiche la spiritualità e l’eleganza che le sono caratteristiche.
Abbandonò il naturalismo senza peraltro cadere in un’astrazione totale e sempre mantenne una certa comprensione della figura umana e del drappeggio.
Erede di una tradizione di luminosa policromia, la volse in una tavolozza di superba ricchezza e armonia che venne poi ereditata dai veneziani.
Certo, era un’arte di clichés, ma la sua funzione primaria stava nell’esprimere un messaggio invariabile: la perenne ripetizione del dramma cristiano, al presenza del Regno dei Cieli, l’intercessione dei santi.
Entro questi limiti, la sua riuscita è stata ammirevole.
Pag. 402-3
Bibliografia.
Storia dell’Impero bizantino / G. Ostrogorsky. – Einaudi, 1968
Storia del mondo medievale: l’Impero bizantino. – Garzanti, 1978
Costantino Porfirogenito e il suo mondo / A. Toynbee. – 1987
Bisanzio e la sua civiltà / A. P. Kazdan. – Laterza, 1986
Scavi linguistici nella Magna Grecia / G. Rohfs. – 1933
Nuovi scavi linguistici nella Magna Grecia / G. Rohfs. – 1972
Il tardo Romano Impero / A. H. M. Jones. – Il saggiatore, 1973-74
Povertà ed emarginazione a Bisanzio, Quarto -Settimo Secolo) / E. Patlagean. – Laterza, 1986
Storia economica Cambridge. La società rurale nel Medioevo. – 1976
Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo ne Secolo Quarto. – Einaudi, 1968
L’arte paleocristiana, 200-395 / A. Grabar. – Rizzoli, 1967
L’età d’oro di Giustiniano / A. Grabar. – Rizzoli, 1967
Architettura paleocristiana e bizantina / R. Krautheimer. – Einaudi, 1986
Storia della pittura bizantina / V. lazarev. – Einaudi, 1967
Introduzione alla storia bizantina di Giorgio Ravegnani
- Visite: 161
Introduzione alla storia bizantina di Giorgio Ravegnani
Cap. 1 La storia di Bisanzio
La nozione di storia bizantina
La storia bizantina riguarda gli avvenimenti della parte orientale dell’Impero romano che sopravvisse per un millennio alla caduta dell’Occidente e di cui fu capitale la città di Bisanzio.
Bisanzio è la denominazione originaria dell’attuale Istanbul, chiamata nel Quarto Secolo Costantinopoli (“la città di Costantino”) in onore dell’imperatore Costantino Primo.
Bisanzio e Costantinopoli sono i toponimi greci della città, usati indifferentemente dalle fonti medievali, mentre Istanbul è il nome turco, derivante dalla deformazione delle parole greche is tin polin che significano “nella città”.
I sudditi di questo impero sono comunemente definiti bizantini, ma nella storiografia più recentesi incontrano anche le definizioni di romani o di romei: al prima si usa in genere per il periodo più antico di storia bizantina (dal Quarto al Settimo Secolo); la seconda deriva dalla fonetica della parola greca rhomaioi (secondo la pronuncia della lingua attuale).
L’uso di bizantini in riferimento agli abitanti dell’Impero d’Oriente è di origine moderna e non trova riscontro nelle fonti se non per indicare i cittadini della capitale.
I bizantini, infatti, si ritenevano romani e così si definirono nel corso di tutta la loro storia, adattando lo stesso termine al mondo in cui vivevano: la Rhomania, “la terra dei romani”, in contrapposizione a quella dei barbari che non ne facevano parte.
Il termine compare nel Quarto Secolo e pare essere di origine popolare: a partire dal successivo entra nell’uso corrente e fino al Quindicesimo Secolo ai parla di Rhomania con riferimento all’Impero di Costantinopoli.
Era utilizzato non solo dai bizantini, ma anche dagli stranieri che così indicavano i territori governati dall’Impero: si pensi ad esempio alla Romagna e alla Lombardia in Italia, che derivano i loro nomi dall’antico dominio dei romani intorno a Ravenna e da quello contrapposto dei longobardi, al toponimo Romania con il quale i crociati chiamarono l’Impero, al termine ar-Rum usato dagli arabi e dagli altri popoli musulmani per indicare i sudditi di Bisanzio, o ancora al sultanato di Rum che i turchi costituirono in Asia Minore occupando i territori già appartenenti all’Impero.
La definizione di greci o di elleni era ritenuta dispregiativa a Bisanzio: ellenismo veniva considerato sinonimo di paganesimo e, di conseguenza, elleno corrispondeva a idolatra, implicando un legame con i culti pagani che erano stati messi al bando nella Costantinopoli cristiana.
Questi due termini furono rivalutati nel Tredicesimo Secolo, a opera degli umanisti greci che volevano così richiamarsi al passato classico, ma si trattò di un’operazione puramente culturale, senza alcun legame con la realtà e l’uso corrente: i sudditi dell’Impero continuarono a definirsi “romani” e anche dopo la caduta di Bisanzio il patriarca di Costantinopoli fu il patriarca dei romani.
“Greci” è un epiteto spesso usato nel Medioevo con intenti diffamatori all’indirizzo dei bizantini.
La definizione ricorre nei frequenti conflitti protocollari con l’Occidente, quando i sovrani germanici rivendicavano la qualifica di imperatori romani chiamando in segno di spregio i colleghi orientali semplicemente “imperatori dei greci” o anche “re dei greci”.
A Bisanzio la cosa era però considerata un affronto, perché il sovrano di Costantinopoli si riteneva l’unico depositario del titolo imperiale e rifiutava di riconoscere gli emuli dell’Occidente.
L’idea di romanità fu infatti alla base del sistema politico dei bizantini.
Per tutto il millennio l’Impero venne considerato la continuazione di Roma con diritto alla sovranità su tutti i territori a questa appartenuti; l’eventuale dominazione straniera all’interno dei confini del mondo romano era ritenuta illegale e frutto di un’usurpazione.
A questa concezione, propriamente politica, si aggiunse fin dalla prima epoca un aspetto religioso, che la completava formando un tutto omogeneo: l’Impero era un disegno di Dio, che aveva eletto il popolo cristiano come depositario della sua volontà.
Ne conseguiva che era eterno, in quanto voluto da Dio, e universale, in quanto romano.
Non poteva esistere inoltre un altro imperatore dopo quello di Costantinopoli, che da Dio riceveva il potere perpetuando l’autorità delegata a Costantino Primo, il primo monarca cristiano.
Questa idea sopravvisse tenacemente nel mondo bizantino, anche quando la realtà dei fatti la rese improponibile, e fu sempre l’ispiratrice di uan diffusa pretesa alla diversità.
Pag. 7-8
Cap. 2. Da Roma a Bisanzio, 324-610
Il Senato di Costantinopoli costituiva a quest’epoca la più alta aristocrazia dell’Impero d’Oriente e, assieme al Concistoro, formava il Consiglio di Stato del sovrano.
Svolgeva inoltre alcune funzioni specifiche, coem la facoltà di proporre disegni di legge o l’esercizio di compiti giudiziari.
L’importanza maggiore dell’assemblea si aveva però sul piano istituzionale in caso di vacanza del trono.
Se l’imperatore in carica provvedeva a nominare un successore, al Senato non spettava altro compito che ratificare formalmente l’avvenuta elezione; ma se il sovrano moriva senza designare un erede, aveva il diritto di sceglierlo e tale diritto venne effettivamente esercitato fino al Settimo Secolo, quando l’assemblea perse ogni importanza politica, anche se spesso fu più un’apparenza che una realtà per l’azione di gruppi di potere capaci di condizionare la designazione.
Il Concistori (Sacrum Consistorium) era il consiglio più ristretto composto da alcuni membri permanenti (comites consistoriani) scelti nelle file dell’alta burocrazia; alcuni lo erano di diritto, altri venivano nominati dall’imperatore.
Tra i primi si trovavano i più alti ufficiali civili e militari come il quaestor sacri Palatii, responsabile delle questioni legali, il magister officiorum addetto a vari servizi di corte, il comes sacrarum largitionum e il comes rei privatae, direttori di dipartimenti finanziari, e il prefetto del pretorio dell’Oriente.
I membri militari dovevano poi comprendere i comandanti della guardia imperiale (il comes domesticorum e dal Quinto Secolo il comes excubitorum) nonché i due magistri militum praesentales da cui dipendevano gli eserciti mobili di stanza nella capitale.
Il prefetto cittadino (praefectus Urbi o in greco eparco) rappresentava infine il Senato, di cui era il capo ed era nello stesso tempo un funzionario dello Stato.
L’eparco avrebbe assunto un’importanza crescente fino al Decimo Secolo: presiedeva alla vita giudiziaria di Costantinopoli, garantiva l’ordine pubblico, provvedeva al rifornimento della città e ne controllava la vita economica.
L’aristocrazia bizantina ebbe fin dall’inizio il carattere prevalente di nobiltà dei funzionari, mantenutosi poi per tutto il millennio, in conseguenza della forte impronta burocratica data al mondo romano.
A Bisanzio non si ebbe mai uan nobiltà ereditaria sul genere occidentale: i titolari di funzioni pubbliche elevate entravano automaticamente a far parte di uan classe aristocratica, la cui importanza variava in funzione del peso dell’ufficio ricoperto, ma l’appartenenza a tale classe e il relativo titolo non erano ereditari, estinguendosi con la morte del titolare.
I funzionari civili e militari ottenevano titoli di nobiltà fissi in rapporto al posto occupato nella gerarchia, sia che si trattasse di funzionari in servizio attivo o a disposizione, sia che fossero incarichi puramente onorifici.
A partire da un certo grado, infatti, ogni funzione era compresa in una classe di nobiltà e queste classi nel Quinto Secolo si stabilizzarono in ordine ascendente in clarissimi, spectabiles e illustres.
Facevano parte dell’ultima i più alti dignitari dello Stato, cui era conferito di regola il titolo di comes, aggiunto come distinzione alle designazioni delle maggiori cariche.
Più in alto ancora si trovavano la dignità di patricius, non legata all’esercizio di alcuna magistratura, e nobilissimo, di curopalate e di cesare riservate ai componenti della famiglia imperiale.
A metà strada fra una semplice dignità e una carica effettiva infine si collocava il consolato, sopravvivenza dell’antica magistratura romana, che continuò a essere conferito ai privati cittadini fino al Sesto Secolo sia in Oriente sia in Occidente.
I consoli si distinguevano in ordinari e onorari, di cui soltanto i primi entravano effettivamente in carica mentre gli altri la rivestivano unicamente in modo fittizio; a questi si aggiungevano poi i consoli imperiali allorché i sovrani assumevano a loro volta l’ufficio in una o nell’altra parte dell’Impero e, in questo modo, potevano diventare eventuali colleghi di privati cittadini.
Il console assumeva la carica il Primo Gennaio per deporla il 31 dicembre e conservava l’antico privilegio di dare il proprio nome all’anno; gli spettava però il compito oneroso di organizzare diversi spettacoli per il popolo della capitale.
I bizantini attribuirono sempre una grande importanza al rango: fin dal tardo antico elaborarono un complesso sistema di precedenze, che regolava nei minimi dettagli l’etichetta di corte.
Nella loro concezione mistico-politica, infatti, la corte di Costantinopoli era il luogo in cui si manifestava visivamente una sorta di religione imperiale legata alla straordinarietà che si riteneva connessa alla figura del sovrano voluto da Dio.
Le cerimonie palatine, considerate la più tangibile espressione di questo culto, dovevano perciò svolgersi con ordine e regolarità a imitazione della perfezione dell’universo, di cui la monarchia terrestre riteneva di essere espressione.
Pag. 19-20
I monaci a quest’epoca rappresentavano l’ala più radicale del cristianesimo, ma godevano di grande seguito nella comunità dei fedeli e di una diffusa considerazione per la loro scelta di vita, ritenuta l’applicazione più perfetta del precetto evangelico.
Nato come movimento spontaneo nel Terzo Secolo, il monachesimo si era distinto fin dall’inizio in una corrente ascetica e un’altra conventuale.
La prima, inaugurata da sant’Antonio, ritiratosi in meditazione nel deserto egiziano verso il 70, trovò nel mondo bizantino un seguito costante e diede anche origine a forme estreme coem lo stilismo, ovvero la pratica di condurre vita contemplativa in cima a una colonna.
Fondatore della pratica conventuale (o, ala greca, cenobitica) fu Pacomio, un ex soldato che fondò uan comunità nell’alto Egitto; il ruolo di teorico dell’ideale di vita fu però ricoperto nel Quarto Secolo da San Basilio, che lo espose dettagliatamente in due opere.
Il monachesimo orientale, comunemente definito “basiliano”, anche se gli ordini monastici a Bisanzio non sono mai esistiti, incontrò all’inizio una diffusa avversione da parte della chiesa ufficiale, ma divenne uan componente determinante della società bizantina e tale si mantenne nel corso dei secoli.
Attraverso lasciti e donazioni, le singole fondazioni acquisirono ampie proprietà terriere e i monaci costituirono un fenomeno sociale non sempre controllabile ponendosi spesso in una posizione antagonista all’autorità costituita, anche in virtù del forte prestigio di cui godevano.
I monasteri furono inoltre depositari di una propria cultura, che trovò espressione soprattutto nella conservazione libraria, nell’istruzione elementare, nella particolare produzione letteraria espressa nelle cronache e dall’ampia letteratura agiografica destinata per lo più a celebrare i fondatori delle singole comunità.
Pag. 31-32
Giustiniano Primo (527-565) rinnovò profondamente il vecchio Impero portandolo a una considerevole potenza dopo la crisi del Quinto Secolo.
Dotato di un’energia instancabile, volle trasformare e, contemporaneamente, rafforzare lo Stato con una serie di riforme che datano per lo più ai primi anni di regno e riguardarono i temi più svariati del diritto privato e pubblico.
Si impegnò inoltre in un ambizioso programma di riconquista dei territori appartenuti all’Occidente, recuperandone circa un terzo con lunghi anni di guerre e portando così Bisanzio a un’estensione in seguito mai più raggiunta.
Fu spinto a tale determinazione dalla necessità di ricostruire l’unità del bacino mediterraneo, in parte sfuggito al controllo imperiale, ma anche da forti convinzioni ideologiche: si sentiva profondamente romano e considerava un suo diritto far rientrare le regioni perdute sotto il dominio imperiale in quanto, secondo le concezioni mistico-politiche legate alla sovranità bizantina, era convinto che tale compito gli fosse stato affidato da Dio, dal quale aveva ricevuto il potere.
L’età di Giustiniano può essere considerato il periodo più splendido della prima fase della storia bizantina, anche perché caratterizzato da una notevole fioritura delle arti e della cultura.
Fu però nello stesso tempo un’epoca di grandi contraddizioni: le vittore militari ebbero costi enormi, le riforme amministrative andarono spesso incontro a clamorosi fallimenti e, per lo più, si susseguirono devastanti calamità naturali, fra cui in primo luogo l’epidemia di peste che a partire dal 542 imperversò nell’Impero.
Pag. 38-39
I provvedimenti imperiali riuscirono soltanto in minima parte ad arrestare i processi di decadenza innescato dal lungo conflitto e la società italica cambiò profondamente a seguito delle devastazioni subite.
La guerra gotica portò infatti ad un grosso regresso demografico, dovuto sia alle vicende belliche sia all’infuriare di carestie ed epidemie, e a distruzioni più o meno ampie in numerose città, tra cui Milano, rasa al suolo dai goti e burgundi nel 539, con l’uccisione o la deportazione degli abitanti, o anche Roma, le cui mura furono in parte abbattute da Totila nel 546 e che, per alcune settimane, si trovò ad essere completamente spopolata.
Particolarmente significativa in termini di cambiamenti epocali fu poi la forte riduzione dell’aristocrazia senatoria, simbolo in un certo senso della continuità del mondo antico, che fu in buona parte sterminata dai goti in quanto naturale alleata di Bisanzio o costretta a fuggire dall’Italia senza riuscire in seguito a ricostruire le proprie fortune.
Tutti questi avvenimenti contribuirono a determinare una cesura con la qualità della vita che si era mantenuta abbastanza elevata fino all’inizio della guerra e a dare inizio a una lunga fase di generale declino, in seguito accentuato dall’invasione longobarda.
Pag. 40
I longobardi erano un popolo già noto nell’antichità, entrato nell’orbita del mondo romano a partire dal primo secolo dell’era cristiana come abitanti della Germania settentrionale.
Nel 489 si stanziarono a nord del Danubio e alcuni anni più tardi si spostarono a oriente insediandosi nell’antica Pannonia romana, cioè nei territori dell’attuale Ungheria.
Erano una gente guerriera, che si distingueva per la natura selvaggia dalle altre stirpi barbariche, tanto che già i romani li avevano definiti “più feroci della ferocia germanica”.
Durante la guerra gotica 2500 guerrieri longobardi, con il loro seguito, avevano militato in Italia agli ordini di Narsete, ma erano stati rimandati in patria a causa degli eccessi ai quali si abbandonavano nei confronti dei civili.
L’invasione longobarda seguì di poco tempo il richiamo a Costantinopoli di Narsete, che nel 568 per ordine di Giustino Secondo fu sostituito nel governo italiano dal prefetto Longino.
Non è del tutto chiaro quale motivazione sia alla base dello spostamento dei longobardi, ma verosimilmente è da connettere alla pericolosa vicinanza creatasi nella loro sede in Pannonia con il popolo bellicoso degli avari, dopo l’eliminazione nel 567 del regno dei gepidi attuata dagli stessi longobardi, e dal rischio rappresentato dall’atteggiamento di Giustino Secondo che aveva favorito i gepidi in opposizione ai longobardi.
Gli storici medievali, a partire dal Settimo Secolo, hanno proposto come spiegazione la cosiddetta leggenda di Narsete, secondo la quale l’eunuco si sarebbe vendicato della deposizione e delle minacce del partito di corte a lui avverso chiamandoli a invadere la penisola italiana, una versione che però è più tarda rispetto agli avvenimenti e non trova credito nella moderna storiografia.
L’intero popolo longobardo, rafforzato da altri contingenti barbarici, entrò in Italia dai valichi della Alpi Giulie nel maggio del 568, addentrandosi nella pianura veneta senza incontrare forte reazione da parte bizantina.
L’inerzia dei bizantini, che rinunciarono ad affrontare sul campo gli invasori limitandosi a difendere alcuni punti fortificati, doveva essere motivata da una serie di cause concomitanti, fra cui le principali si ritiene siano state lo spopolamento dovuto a una pestilenza diffusa in alta Italia poco prima dell’invasione, l’impegno delle truppe mobili di Bisanzio su altri teatri di guerra o l’assenza di un comando militare centralizzato dopo la rimozione di Narsete che potrebbe aver paralizzato la risposta degli imperiali.
In aggiunta a queste si è poi pensato anche a un possibile accordo iniziale con le autorità bizantine per utilizzare i longobardi contro i franchi, accorso poi reso nullo dall’aggressività longobarda, o ancora dalla tradizionale strategia difensiva dell’impero per cui, data la scarsità di soldati normalmente disponibili, si preferiva evitare lo scontro campale con gli invasoti, attendendo che si ritirassero spontaneamente o che si potesse risolvere il conflitto per via diplomatica.
Pag. 51-52
L’istituzione del nuovo magistrato, l’esarca d’Italia (o di Ravenna) ebbe luogo probabilmente nel 584: alla sua figura furono attribuiti poteri eccezionali, che esercitava attraverso magistri militum, duces e tribuni, posti rispettivamente alla guida di reparti operativi, di governatorati militari e di città.
L’autorità dell’esarca ravennate si estendeva su quanto a Bisanzio restava dell’Italia, cioè più o meno un terzo della penisola, con l’esclusione di Sicilia e Sardegna rimaste sotto altre giurisdizioni.
Gli esarchi venivano scelti direttamente dai sovrani fra i più alti dignitari palatini e al titolo di funzione univano la dignità di patrizio, che li collocava ai vertici della gerarchia nobiliare.
Spesso furono eunuchi e non a caso perché, secondo la mentalità del tempo, dagli eunuchi non ci si poteva aspettare un tentativo di usurpazione, resa assai probabile dalle suggestioni evocate dall’antica Roma.
Si riteneva infatti a Bisanzio che un uomo mutilato non potesse esercitare la suprema carica pubblica e, per questo motivo, la scelta di un eunuco limitava notevolmente i pericoli per il potere centrale.
Le nostre informazioni sui governatori dell’Italia imperiale sono assai scarse: allo stato attuale della ricerca non è possibile stabilirne una lista sicura né fissarne con esattezza la cronologia.
Non abbiamo neppure la certezza del numero: potrebbero essere stati ventiquattro, compresi coloro che reiterarono l’ufficio, distribuiti cronologicamente tra il 585 e il 751.
Pag. 53
La conquista slava diede origine a un fenomeno storico del tutto particolare, che presenta due aspetti caratteristici: l’insediamento stabile di popolazioni nemiche in territorio imperiale, come avveniva nello stesso tempo in Italia con i longobardi, e la slavizzazione della penisola balcanica, dove le popolazioni autoctone scomparvero o si ritirarono fra le montagne più inaccessibili, nelle coste e nelle isole.
Molti territori vennero sottratti al dominio imperiale, formando zone di dominazione slava (le cosiddette “slavinie”) che Bisanzio avrebbe faticosamente recuperato con un’azione secolare di riconquista.
La situazione creatasi a seguito di queste invasioni non è del tutto chiara, data la scarsità di testimonianze, e può essere ricostruita soltanto nelle linee generali.
Le regioni settentrionali e centrali dei Balcani furono occupate pressoché integralmente dagli slavi, mentre restarono sotto l’autorità bizantina le città costiere dell’Adriatico e del mar Nero nonché Tessalonica e la stessa Costantinopoli, sebbene la prima fosse interamente circondata da territori slavi e la seconda esercitasse soltanto un dominio precario sulle zone circostanti della Tracia fino almeno alla fine del Settimo Secolo.
Nelle parti meridionali della penisola balcanica, la Tessaglia, l’Epiro e le regioni occidentali del Peloponneso furono profondamente slavizzate e l’Impero continuò a controllare soltanto le città che potevano essere raggiunte via mare.
Pag. 57-58
Cap. 3. Da Eraclio agli iconoclasti, 610-717
L’autorità imperiale in Italia, verso la fine del Settimo Secolo, si era notevolmente indebolita, come mostra con chiarezza l’episodio del protospatario Zaccaria, la debolezza del potere di Costantinopoli aveva portato a maturazione i fattori di crisi interna determinanti per la successiva caduta dell’esarcato sotto la pressione longobarda.
Questi fattori di crisi sono riconducibili a tre cause: in primo luogo lo sviluppo di un’aristocrazia di grandi proprietari terrieri, che tendeva a rendersi autonoma da Bisanzio, poi la rivoluzione intervenuta nella società cittadina, in cui emersero come componenti di primo piano le milizie reclutate localmente, più legate ai loro capi che al governo centrale e, di conseguenza, alle vicende puramente locali.
Come terzo elemento, infine, si deve tenere presente l’influsso sempre più forte esercitato sulle popolazioni dalla chiesa romana tendenzialmente ostile a Costantinopoli.
Ciò malgrado, finché fu possibile, i papi cercarono di evitare la rottura definitiva con l’Impero, pressati come erano dal timore dell’espansionismo longobardo contro il quale rappresentava una garanzia; a parte gli occasionali contrasti, perciò, non vollero rinunciare a una sostanziale alleanza, un atteggiamento venuto meno soltanto nell’Ottavo Secolo, subito dopo la caduta dell’esarcato, quando al legame tradizionale in funzione anti longobarda si sostituì la ricerca di appoggio da parte dei franchi.
Pag. 75
Cap. 4. L’iconoclastia, 717-843
L’iconoclastia, come fenomeno storico, presenta ancora molti lati oscuri, a motivo della perdita pressoché totale della letteratura a essa favorevole, le cui opere vennero distrutte dagli avversari.
Per ricostruirne la genesi dobbiamo ricorrere a scrittori di parte contraria e legati in genere agli ambienti monastici, quindi ai più tenaci nemici degli iconoclasti.
Essi spiegano il fenomeno in termini riduttivi e dissacranti, mettendolo il relazione all’influsso di ebrei e arabi, cioè dei peggiori nemici della fede cristiana; alle origini dell’iconoclastia la storiografia monastica connette infatti una leggenda che ha per protagonista un ebreo.
Secondo il monaco e cronista Teofane, autore di un’opera storica che giunge fino all’813, un mago ebreo si sarebbe presentato al califfo Yazid, promettendogli un regno di quarant’anni se avesse fatto rimuovere le immagini venerate nelle chiese dei cristiani.
Yazid gli avrebbe dato ascolto emanando un editto iconoclasta, ma sarebbe morto di lì a poco, senza che molti fossero venuti a conoscenza dell’editto.
Leone Terzo, informato di quanto era avvenuto nel califfato, avrebbe a sua volta introdotto l’iconoclastia a Bisanzio con la complicità dei suoi più stretti collaboratori.
Come ogni leggenda, anche quella dell’ebreo dovrebbe presentare un fondo di verità, ma è difficile dire di cosa esattamente si tratta.
Leone Terzo, pur avendo costretto gli ebrei al battesimo, potrebbe essere stato influenzato dal divieto delle immagini della religione mosaica; allo stesso modo, benché nemico degli arabi, non è da escludere che abbia subito il loro influsso culturale.
L’iconoclastia araba, d’altronde, è un fatto storicamente accertato, risalente agli anni fra il 723 e 724, ma in parte diversa perché comportò la distruzione di tutte le rappresentazioni di esseri viventi.
E’ tuttavia probabile che a questi modelli culturali si affianchino anche altre motivazioni, di ordine religioso e politico.
I moderni hanno dato in proposito diverse spiegazioni, oscillando sostanzialmente fra due interpretazioni opposte.
L’iconoclastia sarebbe stata cioè un fatto puramente religioso, volto a purificare la chiesa da un culto con aspetti idolatrici o, al contrario, di prevalente natura politica, adombrando sotto le apparenze altre motivazioni di ordine pratico; per esempio il tentativo di accattivarsi le simpatie delle popolazioni orientali dell’Impero da parte di sovrani essenzialmente militari come furono gli Isaurici.
Nell’Oriente bizantino si reclutavano i migliori soldati e un esercito forte e disciplinato era indispensabile per sostenere l’urto dei nemici esterni.
La fedeltà dell’Oriente era però condizionata dall’accettazione di teorie religiose non ortodosse, a motivo della grande diffusione in queste regioni di sette nemiche di ogni culto delle immagini e, in particolare, del monofisismo che godeva di un seguito considerevole in Asia Minore.
Gli iconoclasti rimproveravano il carattere di idolatria al culto delle immagini di Cristo, della Vergine e dei santi; i loro avversari, gli iconoduli (cioè i “veneratori delle immagini”), lo ritenevano lecito sostenendo che non si venerava l’oggetto in sé, ma ciò che esso rappresentava.
Il paragone più immediato, a tale proposito, veniva fatto con le immagini imperiali, alle quali si rendeva omaggio come simboli dell’autorità sovrana.
La disputa pro o contro le icone non era un fatto trascurabile a Bisanzio, dato che esse erano un aspetto caratteristico della religiosità orientale, venendo usate come ornamenti delle chiese, associate alla liturgia, e come oggetti privati di devozione.
Alcune “non fatte da mano umana” erano considerate miracolose e, in quanto tali, andavano soggette a una venerazione particolare: rientravano fra queste l’immagine della Vergine Hodigitria, conservata a Costantinopoli, che si ritenevano eseguita da San Luca, i ritratti del Cristo portati a Bisanzio dalla Cappadocia al tempo di Giustiniano o il mandylion di Edessa, una tela sulla quale si sarebbe miracolosamente impressa l’immagine di Cristo.
Le icone, eseguite dagli artisti secondo modelli fissi, erano oggetto di forme esteriori di ossequio, come la prosternazione, ma anche di pratiche che ricordavano il paganesimo.
Si prestava giuramento sulle immagini, si bruciava incenso di fronte ad esse, ci si serviva di alcune icone come padrini per i propri figli o, anche, se ne faceva cadere la polvere nel calice usato per comunicare i fedeli.
Pag. 79-80
Nicéforo, patriarca di Costantinopoli dall’806 all’815, fu anche uomo di cultura.
Nato verso il 758 da una nobile famiglia della capitale, divenne segretario della cancelleria imperiale e, in seguito, si fece monaco.
Dopo la deposizione si ritirò nel monastero di San Teodoro a Scutari e vi morì nell’829.
La sua produzione letteraria consta di opere teologiche, di polemica anticonoclasta, e storiche.
Della prima fanno parte tra le altre i tre libri di Antirretici scritti contro Costantino Quinto (Costantino “Copronimo”, come era stato definito dai detrattori per aver sporcato la fonte al momento del battesimo), che consentono anche di ricostruire storicamente l’azione di questo sovrano, sia pure nell’ottica deformata della polemica.
Al versante storico appartengono la Sintesi cronografica, un breve panorama storico da Adamo all’’829, e il più importante Breviario o Storia abbreviata con il racconto degli avvenimenti dal 602 al 769, un’opera di notevole importanza per la ricostruzione della storia di Bisanzio nella generale carenza di fonti dei secoli Settimo e Ottavo.
Pag. 88
Cap. 5 L’apogeo dell’Impero, 843-1025
Il periodo che va dall’843 al 1025, per lo più segnato dalla presenza sul trono della dinastia macedone, può essere considerato l’età di maggiore fioritura dell’Impero.
La fine delle grandi lotte religiose coincise con una forte ripresa della potenza bizantina, destinata a manifestarsi soprattutto nel Decimo Secolo, grazie appunto all’assenza di contrasti interni e delle conseguenti lotte fra schieramenti contrapposti.
A questo elemento positivo si aggiunsero la solidità economica e politica, soltanto in parte minata dallo sviluppo del ceto dei grandi proprietari terrieri, l’affermazione di una rinnovata potenza militare contrassegnata in particolare dalle guerre fortunate con gli arabi in Oriente e dalla sottomissione nella rinascita dell’istruzione superiore e nella produzione letteraria del Nono-Decimo Secolo.
Pag. 91
L’Impero musulmano al momento della controffensiva bizantina aveva già da tempo perduto la coesione iniziale e, malgrado alcuni isolati successi espansionistici, si avviava a un processo di decadenza, che sarebbe stato più evidente nel secolo seguente.
Alla morte di Maometto, nel 632, il potere supremo era passato ai califfi, che avevano condotto a termine la fase eroica dell’espansione, culminata nel 711 nella penetrazione in Spagna, con la conseguente sottomissione del regno visigoto, e nell’assedio di Costantinopoli nel 717.
Il fallimento dell’assedio e la battaglia di Poitiers nel 732 avevano tuttavia segnato uan consistente battuta di arresto, seguita nel 750 dalla fine del califfato omayyade (istituito a Damasco nel 661) a opera della famiglia degli Abbasidi, che condusse a una prima divisione fra il califfato abbaside, insediatosi a Baghdad, e un emirato rivale degli omayyadi in Spagna costituito nel 756.
Nel Nono Secolo l’azione delle forze centrifughe si fece più pressante e l’Impero islamico si frantumò in una serie di governi regionali retti da emiri, il cui vincolo di subordinazione a Baghdad finì talvolta per divenire puramente formale.
Alcuni di questi emirati, come gli Aglabiti di Tunisia, nel Nono Secolo realizzarono ancora conquiste autonome (come l’invasione della Sicilia bizantina a opera dell’Emirato indipendente di Qairavan), ma nella prima metà del successivo il processo di frantumazione di quello che era stato l’Impero islamico si accentuò con la creazione di altri due califfati antagonisti a Baghdad: in Egitto sotto la stirpe dei Fatimidi nel 910 e in Spagna a opera dell’Emirato omayyade di Cordova nel 929.
La perdita dell’unità arrestò di conseguenza l’originaria spinta espansionistica dell’Islam e, anche se alcuni governi locali continuarono a essere potenze rilevanti, finì per facilitare la controffensiva di Bisanzio.
Pag. 92
Fozio (810 ca.), nipote del patriarca Tarasio, prima dell’elezione alla carica ecclesiastica aveva ricoperto l’ufficio di protoasecrétis, l’alto funzionario che dirigeva la cancelleria imperiale.
La sua promozione al trono imperiale fu voluta da Barda, avversario del patriarca Ignazio (figlio dell’ex imperatore Michele Primo), un monaco intransigente vicino alle posizioni degli zeloti e ostile alla politica di Barda con il quale era entrato in aperto conflitto.
La fama letteraria di Fozio è legata soprattutto alla cosiddetta Biblioteca, costituita da una lunga serie di capitoli che contengono notizie ed estratti di opere lette dall’autore.
Si tratta di 279 “codici” (come sono comunemente definiti) che riguardano opere religiose e profane dall’epoca classica a quella bizantina, utili in molti casi per ricostruire il contenuto di scritti andati perduti.
Pag. 93
In prime nozze, costretto dal padre, Leone Sesto aveva sposato all’età di sedici anni la pia Teofano, appartenente a una famiglia dell’aristocrazia della capitale, ma il matrimonio fallì per una profonda incomprensione reciproca e Teofano finì per ritirarsi nel monastero di Blacherne, dove morì nell’897.
Leone Sesto richiamò a Costantinopoli l’amante Zoe Zautzina, figlia del suo principale consigliere politico Stiliano Zautze, che Basilio Primo aveva allontanato dalla città e nell’898 la sposò subito dopo la morte del marito di questa.
Zoe, da cui ebbe una figlia, morì nell’899 e poco più tardi Leone Sesto si sposò nuovamente con Eudocia Bainé, morta di parto nel 901 assieme all’erede che le sopravvisse soltanto per qualche giorno.
Per il terzo matrimonio, contrario alla tradizione della chiesa greca, l’imperatore aveva ottenuto la complicità dell’allora patriarca di Costantinopoli, Antonio Cauleas, ma in seguito il suo progetto di convolare a quarte nozze con l’amante Zoe Carbonopsina fu violentemente ostacolato dal nuovo patriarca Nicola Mistico.
Da lei nel 905 aveva avuto un figlio maschio (il futuro imperatore Costantino Settimo) e, sebbene avesse accettato inizialmente il compromesso proposto dal patriarca, offertosi di battezzarlo a condizione che il sovrano allontanasse l’amante, in seguito si era risolto a far celebrare le nozze da un prete di palazzo per legittimare l’erede al trono.
Nonostante fosse dettata dalla ragion di Stato, al pretesa di sposarsi per una quarta volta poneva il sovrano in una situazione fortemente anomala e, nello stesso tempo, contravveniva a un principio di buon governo comunemente accettato a Bisanzio, secondo cui l’imperatore era tenuto a rispettare le leggi al pari dei sudditi, tanto più che lo stesso Leone Sesto, con una sua Novella, aveva vietato il terzo matrimonio disapprovando anche il secondo.
Pag. 98
Il nuovo sovrano (così chiamato da Lakape in Armenia di cui era originari0), nato verso l’870, proveniva da una famiglia contadina e aveva fatto carriera nell’esercito divenendo stratego di Samo, per assumere quindi come drungarios il comando della marina imperiale.
Il 25 marzo del 919 sbarcò a Costantinopoli, sventando il piano di Zoe per sposare lo stratego Leone Foca e portarlo così sul trono, e prese possesso del palazzo imperiale dopo essersi impegnato a difendere i diritti del sovrano legittimo.
A seguito delle nozze tra la figlia e Costantino Settimo, fu elevato al rango di basileopator (“padre dell’imperatore”) e, poco più tardi, divenne cesare e quindi imperatore associato.
Pag. 102
A Edessa (oggi Urfa, nella Turchia meridionale), durante l’assedio persiano del 544, fu trovato nelle mura cittadine un pezzo di tessuto (in greco medievale un mandylion) su cui figurava un’immagine che fu ritenuta del Cristo e miracolosa.
L’immagine di Edessa rappresenta la più importante fra le varie figurazioni del Cristo che iniziarono ad apparire nel Sesto Secolo e vennero ritenute acheiropoiete cioè “non fatte da mano umana”.
Secondo la leggenda più accreditata questa immagine si era formata allorché Gesù aveva appoggiato al volto una tela e, in seguito, era stata portata da Abgar, re di Edessa, il cui inviato si era recato presso il Cristo su incarico del re.
L’immagine restò a Edessa, sotto la dominazione araba e sfuggì di conseguenza alla persecuzione degli iconoclasti.
Durante l’assedio della città i generali di Romano Primo promisero di risparmiarla a condizione che fosse consegnata l’icona, che presa la via di Costantinopoli dove fu collocata in una cappella del palazzo imperiale.
Scomparve però nel 1204, quando i crociati si impossessarono di Bisanzio, probabilmente per prendere la via dell’Occidente.
Secondo una teoria abbastanza accreditata, il mandylion di Edessa potrebbe essere identificato con la Sindone, che compare in Occidente nel secolo successivo alla presa di Bisanzio da parte dei crociati.
Pag. 103
La letteratura cerimonialistica del tempo trova espressione anche in opere minori, relative al sistema delle precedenze palatine, la più importante delle quali è il Kletorologhion di Filoteo, composta nell’899 e successivamente inserita nel Libro delle cerimonie.
L’autore era un atriklines (una delle numerose parole della burocrazia derivate dal latino, in questo caso da a triclinio), addetto all’organizzazione dei banchetti di corte, che erano uno dei principali momenti del cerimoniale palatino.
I banchetti si svolgevano a cadenze fisse o variabili, in occasione delle principali festività, e venivano regolati da una minuziosa etichetta basata essenzialmente sull’ordine delle precedenze con cui si doveva prendere posto vicino al sovrano.
Il Kletorologhion, oltre che sul tema specifico, nella sua parte più teorica fornisce precise indicazioni sulla gerarchia del tempo, tali da consentirne una dettagliata ricostruzione.
L’apparato burocratico si era profondamente modificato dall’epoca tardo antica seguendo un naturale processo di svalutazione e di aggiornamento dei titoli che fu caratteristico di tutta l’epoca bizantina.
I cortigiani si dividevano ora in due categorie distinte: i semplici dignitari di corte senza compiti amministrativi, i cui gradi di nobiltà vitalizi e teoricamente irrevocabili implicavano come unico compito la partecipazione onorifica alle cerimonie palatine, e quelli incaricati di assolvere una funzione, sia militare sia civile, a tempo determinato.
I primi ricevevano “dignità per insegne”, cioè contraddistinte da un brevetto o insegna della carica, mentre i secondi ottenevano dignità a “voce” o “per editto”, cioè conferite con una semplice nomina verbale, che investivano delle funzioni effettive di comando nei vari servizi dello Stato.
Come in età più antica, inoltre, a un titolo di funzione si accompagnava una dignità palatina fissa, che collocava il detentore in una classe nobiliare attribuendogli i relativi privilegi, primo fra tutti l’inserimento in una complicata gerarchia delle precedenze che ne definiva lo status sociale.
Caratteristica peculiare dell’epoca è invece l’esistenza di due distinte gerarchie, sia per le dignità per insegna sia per le altre, di cui una veniva riservata ai “barbuti”, l’altra agli eunuchi, la cui importanza a corte, già notevole fin dai primi tempi, era notevolmente cresciuta nel corso dei secoli fino a costituire uan classe particolare di dignitari e funzionari.
I titoli per barbuti erano diciotto, in parte derivati da innovazioni e in altra parte provenienti dalla tarda antichità, sia tali quali erano sia come trasformazioni di cariche scomparse di cui era sopravvissuto il nome.
Al gradino più alto si trovavano in ordine decrescente di cesare, nobilissimo e curopalate, conferite di norma ai membri della famiglia imperiale.
Seguivano poi la zosté patrikia, la “patrizia con cintura”, l’unica dignità femminile, e quelle di magistro (residuo dell’antico magister officiorum), antipato, patrizio, protospatario, disipato (cioè due volte console), spatarocandidato, spatario, ipato (ricordo dell’antica carica di console, in greco chiamata hypatos), strator, candidato, mandator, vestitor, silenziario, stratelates epi thematon o apo eparchon.
I gradi di nobiltà degli eunuchi erano otto: nipsistiario, cubiculario, spatarocubiculario, ostiario, primicerio, protospatario, preposito e patrizio.
Le dignità a voce per i barbuti erano sessanta, corrispondenti ai più elevati posti di comando, e da ognuno di questi capi servizio dipendeva un ufficio più o meno ampio con vari funzionari amministrativi.
Al vertice delle sessanta cariche pubbliche si trovavano il basileopator, il rettore e il sincello: la prima carica, istituito da Leone Sesto, era una sorta di tutore del sovrano con pieni poteri amministrativi, il rettore uan funzione piuttosto imprecisa, mentre il sincello era l’ecclesiastico che fungeva da assistente del patriarca nominato dal sovrano.
Venivano quindi i grandi comandi militari cominciando dallo stratego del tema degli anatolici, immediatamente seguito in ordine gerarchico dal domestico delle scholai, entrambi con il rango di antipato e patrizio, e la serie proseguiva con incarichi militari e civili fino al sessantesimo posto.
La gerarchia degli eunuchi doveva comprendere a sua volta nove dignità a voce, quante ne indica Filoteo sebbene poi ne enumeri dieci, forse per una interpolazione nel testo: il parakoimomenos dell’imperatore (addetto alla camera del sovrano), il protovestiario dell’imperatore, preposto alla tavola dell’imperatore, il preposto alla tavola dell’imperatrice, il papias (portiere) del Gran palazzo, il deuteros (il sostituto del portiere) del Gran palazzo, il pinkernes (coppiere) dell’imperatore e dell’imperatrice, il papias del palazzo della Magnura e quello del palazzo di Dafne.
A differenza di quanto avveniva per i barbuti, le dignità a voce degli eunuchi comportavano servizi effettivi a corte; gli eunuchi potevano inoltre esercitare quasi tutte le funzioni pubbliche dei barbuti, a eccezione di quelle di eparco, questore e domestico, cioè di governatore di Costantinopoli, di capo dei dipartimenti giudiziari (derivato dall’antico quaestor sacri Palatii) e di comandante militare.
Pag. 107-8
Questa donna volitiva e straordinaria [Teofano], la cui bellezza stupiva i contemporanei, fu, assieme alla famosa Teodora, una delle figura più caratteristiche di Bisanzio.
Aveva sposato nel 956 Romano Terzo, già vedovo per la morte precoce della prima moglie, Berta, uan figlia naturale di Ugo di Provenza, che il giovane principe aveva dovuto sposare per volontà di Romano Primo, malgrado una simile unione fosse considerata degradante alla corte di Bisanzio.
Divenuta imperatrice all’età di diciotto anni, confinò in monastero le cinque cognate e costrinse la suocera Elena a vivere appartata a palazzo.
Quando fu a sua volta estromessa dal palazzo, si oppose con tutte le forze all’esilio e, in seguito, riuscì a fuggire dal monastero in cui era stata relegata.
Raggiunse Costantinopoli e si rifugiò come supplice in Santa Sofia.
Il gesto non ottenne però l’effetto sperato: venne di nuovo arrestata e l’esilio fu reso più duro confinandola nella lontana Armenia.
Tornò a corte soltanto sei anni più tardi, quando vi fu richiamata dai figli, ma verosimilmente distrutta nello spirito, dato che visse nell’ombra senza più fare parlare di sé.
Pag. 110-11
Il carattere di Basilio Secondo si modificò profondamente negli anni delle guerre civili.
La sua unica preoccupazione fu il governo dell’Impero, che resse con mano inflessibile senza dividere con altri le responsabilità.
Rinunciò a ogni piacere e condusse un’esistenza da asceta.
Mostrandosi assai poco bizantino nelle abitudini e nei modi, rifuggiva dalla eleganza, dal culto delle forme e dagli splendori della corte.
Amava esprimersi in modo chiaro, con poche parole, non aveva interessi culturali e non teneva in alcuna considerazione la retorica, tanto amata dai suoi contemporanei.
Dopo la conclusione delle guerre intestine, iniziò a combattere i nemici esterni e sostenne contemporaneamente quattro fronti: i Balcani, la Siria, il Caucaso e l’Italia.
Fra questi tuttavia fu di gran lunga più importante il fronte balcanico, dove l’imperatore si impegnò a combattere la potenza bulgara.
Contro i bulgari fu ingaggiata una lotta mortale, che si trascinò per parecchi anni e venne condotta con ferocia e determinazione, tanto da far attribuire a Basilio Secondo il soprannome di bulgaroctono, “uccisore di bulgari”.
Basilio Secondo comandava di persona gli eserciti nei teatri di guerra, che riteneva più importanti, e si mostrò un comandante di qualità eccezionali, trasformando le armate imperiali in una formidabile macchina bellica.
Pag. 114
Cap. 6. La crisi dell’Undicesimo Secolo, 1025-1081
Nel cinquantesimo che seguì il regno di Basilio Secondo l’Impero di Bisanzio andò incontro a una rapida decadenza, dovuta all’azione coincidente di cause interne ed esterne.
Sul piano interno ebbe particolare rilievo il notevole indebolimento dell’autorità centrale con il conseguente affermarsi del dominio incontrastato dei latifondisti.
I sovrani che si susseguirono dal 1028 al 1081 furono per lo più esponenti dell’aristocrazia civile di Costantinopoli, formata da grandi proprietari terrieri e assai lontana per ideali e metodi di governo dagli imperatori macedoni e, in particolare, da Basilio Secondo.
Come tali, non si opposero più ai potenti, assumendo un atteggiamento all’apparenza neutrale, ma che di fatto assicurò la vittoria ai latifondisti.
Il partito civile al potere, inoltre, trascurò l’esercito nazionale causandone una rapida disgregazione e la progressiva sostituzione del sistema dei temi con il reclutamento di mercenari.
La crisi del tradizionale apparato militare incise notevolmente sulle possibilità di contenere i nemici che premevano sulle frontiere (in particolare i turchi selgiuchidi e i normanni) conducendo a catastrofiche disfatte, a seguito delle quali l’estensione territoriale dell’Impero si ridusse notevolmente.
La frattura religiosa fra Costantinopoli e Roma, infine, divenne irreversibile a seguito dello scisma del 1054.
Pag. 117
L’aristocrazia terriera, ormai saldamente al potere, si rafforzò ulteriormente ottenendo privilegi sempre più ampi dal governo centrale.
Fra questi l’esenzione dalle imposte, largamente concessa, e l’immunità giudiziaria, per cui proprietari giudicavano direttamente i loro coloni.
Si costituirono così grandi domini che si andavano separando dal corpo dello Stato; il governo centrale, anziché intervenire come avevano fatto i macedoni, favorì lo sviluppo del fenomeno.
L’espansione del latifondo e la conseguente crisi del potere centrale vennero accentuate dal sistema della “pronoia”, destinato ad avere grande fortuna in seguito.
Quale ricompensa dei servizi prestati, il sovrano dava terre in concessione (che è il significato letterale del termine greco pronoia) ai “potenti” affinché le amministrassero trattenendone le rendite.
L’assegnazione della pronoia era temporanea e durava in genere quando la vita del beneficiato.
Si andava così sempre più configurando un feudalesimo bizantino, un fenomeno che fino a quel momento non aveva trovato posto in uno Stato fortemente centralizzato e che finì per modificare profondamente il volto dell’Impero trasferendo il potere, e le lotte per conquistarlo, alle famiglie rivali provenienti dal nuovo ceto di magnati.
Pag. 122
In Italia meridionale iniziò infatti la conquista normanna, nella penisola balcanica irruppero invasori provenienti da nord e in Oriente iniziarono a muoversi i turchi selgiuchidi.
………….
I normanni arrivarono come mercenari al servizio di un nobile barese, Melo, che nel 1009 si era ribellato ai normanni.
Pag. 125
Cap. 7. Dai Comneni agli Angeli, 1081-1204
Il periodo che va dal 1081 al 1204 vede la stabile permanenza sul trono di esponenti dell’aristocrazia militare che con Alessio Comneno riuscì ad imporsi a seguito del conflitto con il partito civile.
La società bizantina finì per perdere quella sia pur relativa mobilità sociale che l’aveva caratterizzata, e al suo vertice si impose un ristretto numero di potenti e ricche famiglia, detentrici di ampi latifondi e di sontuose dimore a Costantinopoli, che fecero venir meno i precedenti contrasti fra civili e militari trasferendoli a una semplice rivalità interna fra il ceto dominante.
I Comneni, con un’incisiva attività di governo, diedero vita a una rinascita della potenza imperiale, ma questa fu resa possibile da uno sfruttamento talvolta spietato di tutte le risorse disponibili e da un continuo aumento della tassazione, che colpì in maniera sempre più pesante la popolazione delle province.
I risultati ottenuti furono brillanti, soprattutto perché consentirono uan parziale riconquista del territorio perduto, ma la ricostruzione ebbe basi assai fragili e finì per crollare drammaticamente dopo la fine della dinastia Comnena sino a portare, nel 1024, alla capitolazione dell’Impero di fronte all’espansionismo occidentale.
Pag. 129
Nell’Undicesimo Secolo Venezia aveva da tempo raggiunto la completa indipendenza, anche se la diplomazia bizantina continuava a indicarla formalmente come se fosse in posizione di sudditanza.
L’autonomia da Bisanzio non aveva tuttavia portato alla rottura politica e, a parte occasionali contrasti, vi era stato un tradizionale rapporto di alleanza e, probabilmente col consenso di Bisanzio, all’inizio dell’Undicesimo Secolo al città lagunare aveva affermato la propria supremazia su parte della Dalmazia eliminando la secolare minaccia della pirateria slava.
Pag. 131
La crociata ebbe inizio nel 1095, quando papa Urbano Secondo al Concilio di Clermont-Ferrand lasciò un appello in difesa della cristianità orientale minacciata dagli infedeli.
L’appello del papa suscitò un grande entusiasmo e l’adesione all’impresa andò probabilmente anche al di là delle sue aspettative.
Il grande movimento di persone che ne fu conseguenza, però, venne visto con stupore e preoccupazione dall’Oriente bizantino.
L’idea di crociata, così come fu concepita in Occidente, era quanto mai lontana dalla mentalità di Bisanzio, dove per secoli era stato combattuto l’Islam e gli imperatori ritenevano che la lotta conto gli infedeli fosse uno dei loro esclusivi doveri.
In termini materiali, inoltre, lo spostamento di una grande quantità di armati dall’Occidente destava un comprensibile allarme, dato che non si poteva prevedere quale atteggiamento avrebbero assunto.
A Bisanzio gli occidentali erano da sempre guardati con sospetto, a causa di quelle che venivano ritenute le loro principali caratteristiche: l’arroganza, la sete di denaro, l’incapacità di rispettare i trattati e la considerevole potenza militare, tale da renderli concorrenti pericolosi e imprevedibili.
L’indicazione di Costantinopoli fatta dal papa come luogo di raduno dei partecipanti, nella convinzione che il sovrano sarebbe stato lieto di associarsi alla spedizione, ottenne soltanto lo scopo di acuire i sospetti di Alessio Primo, che peraltro si trovava nell’impossibilità materiale di opporsi.
Le sue aspirazioni di collaborazione con l’Occidente si erano infatti limitate alla richiesta di invio di mercenari e a promuovere trattative con Roma per la riunificazione religiosa, in cui comprendere verosimilmente anche un progetto di cooperazione nella lotta contro i turchi.
Pag. 134
I serbi – la cui potenza inizia ad affermarsi in questa epoca – erano come i croati una popolazione originaria dei territori a nord dei Carpazi insediata da Eraclio nel Balcani per contenere l’espansionismo avaro.
E’ incerta la loro origine etnica, ma dopo lo stanziamento finirono come i croati per assimilarsi alla locale popolazione slava.
A differenza di questi, per lo più sotto l’influenza occidentale attraverso l’assoggettamento all’Impero franco e la subordinazione alla Chiesa romana, i serbi mantennero a lungo stretti rapporti culturali e politici con Bisanzio.
I serbi vivevano in comunità chiamate zupanije o zupe sotto un principe detto zupan e l’Impero di Bisanzio pare aver conservato su di loro una sovranità almeno nominale fino alla prima metà del Nono Secolo, quando divennero indipendenti.
I rapporti tuttavia si fecero di nuovo stretti al tempo di Basilio Primo con l’accettazione del cristianesimo ortodosso e di un vassallaggio politico mantenuto fino alla prima metà dell’Undicesimo Secolo, allorché il più importante principato serbo (conosciuto come Dioclea o Zeta) riuscì ad assicurarsi l’indipendenza, confermata poi nel 1077 con l’invio da parte di papa Gregorio Settimo di una corona regale allo zupan Michele, entrato così formalmente nell’orbita politica romana.
All’inizio del dodicesimo secolo, con la decadenza della Zeta, il ruolo preminente sul popolo serbo fu assunto dai governatori di Rascia, così chiamata dalla fortezza di Ras, che era la residenza del principe.
L’indipendenza del popolo serbo non fu in ogni modo duratura e, alla fine dell’Undicesimo Secolo, il paese tornò sotto la supremazia imperiale, mantenuta sia pure con frequenti ribellioni fino alla seconda metà del secolo successivo.
Pag. 137-38
Gli ungheresi (o magiari) ebbero probabilmente rapporti con Bisanzio già nel Sesto Secolo, quando vivevano tra il Don e il Caucaso, ma entrarono decisamente nella scena politica dell’Impero nel Nono Secolo, allorché migrarono verso Ovest raggiungendo in parte le pianure a nord dell’estuario del Danubio.
Alla fine del secolo, pressati dai Peceneghi, si spostarono nella pianura pannonica distruggendo il Regno moravo (nel 906) e, di qui, fecero periodiche incursioni sia in Occidente sia nei territori balcanici soggetti a Bisanzio, spingendosi in due occasioni fin sotto le mura di Costantinopoli.
Per quanto devastanti, tuttavia, queste incursioni ebbero carattere temporaneo e non intaccarono le città fortificate, contro le quali la loro organizzazione militare, basata sulle veloci incursioni di cavalleria, era del tutto impotente.
La pesante sconfitta subita a Lechfeld da Ottone Primo (nel 955) mise fine al nomadismo di questo popolo e, poco più tardi, si costituì una stabile nazione a opera del principe Géza e, soprattutto, del successore Stefano Primo (1000-1038), che fu il primo re di Ungheria.
La cristianizzazione, avvenuta verso il 970, portò gli ungheresi nell’orbita della Chiesa romana, ma non vennero meno i rapporti politici e culturali con l’Impero, con cui per oltre due secoli ebbero una frontiera comune lungo il medio Danubio e la Sava.
Il legame con Bisanzio si fece particolarmente intenso nell’Undicesimo Secolo, come attestano indirettamente anche la presenza alla corte ungherese di corone inviate in dono da Costantinopoli con un atto politico-simbolico che, secondo la mentalità del tempo, voleva significare la dipendenza gerarchica del sovrano ungherese dall’imperatore.
La prima di queste, la corona di Costantino Nono Monomaco (di cui sono state trovate nell’Ottocento alcuen placche smaltate), fu verosimilmente donata al re Andrea Primo (1046-1060), mentre la seconda (che costituisce la parte inferiore della “santa corona di Ungheria”) venne probabilmente inviata in dono di Michele Settimo al re Géza verso il 1074.
Lo stesso re sposò poi la nipote di Niceforo Botaniate e, più tardi (nel 1104), Piroska, figlia del re Ladislao Primo, andò in sposa a Giovanni Comneno diventando così imperatrice di Bisanzio.
Pag. 137-40
I rapporti con Venezia, che erano stati il cardine della politica paterna, subirono una crisi destinata a suscitare un conflitto con la tradizionale alleata.
Per tutto il regno di Alessio Primo Venezia era stata in netto vantaggio sia rispetto ai commercianti bizantini che alle altre città marinare italiane.
La sua posizione di forza non venne scossa dal trattato del 1111 con Pisa, alla quale Alessio Primo concesse privilegi commerciali inferiori a quelli ottenuti dai veneziani; al momento, i genovesi restavano ancora esclusi da benefici del genere.
Le cose però cambiarono bruscamente subito dopo l’avvento al potere di Giovanni Comneno.
Un’ambasceria veneziana giunse a Costantinopoli nel 1119 per ottenere il rinnovo del precedente trattato, ma si vide opporre un rifiuto dall’imperatore.
Non è del tutto chiaro perché Giovanni Secondo abbia adottato tale decisione, ma è probabile che su di essa abbiano pesato fattori di ordine politico, come la diminuita importanza dell’aiuto navale degli alleati, o anche il comportamento arrogante dei veneziani che li rendeva particolarmente sgraditi ai suoi sudditi.
L’iniziativa del Comneno fu rovinosa per Venezia, ma inizialmente non si ebbe alcuna reazione e soltanto nel 1122 la Repubblica iniziò a fare rappresaglie navali in territorio orientale.
La flotta bizantina non era in grado di far fronte agli attacchi e, nel corso di quattro anni, i veneziani agirono indisturbati ottenendo una serie di successi, sufficienti a spingere alla capitolazione l'imperatore.
Giovanni Comneno fece sapere al doge che era pronto a rinnovare il trattato e nell’agosto 1126 gli ambasciatori della città lagunare conclusero a Costantinopoli un nuovo accordo che rinnovò ed estese i privilegi concessi da Alessio Primo.
Pag. 140-1
Manuele Primo Comneno (1143-1180), figlio di Giovanni, fu designato espressamente dal padre a succedergli in violazione dei principio di anzianità (prima di lui infatti sarebbe dovuto venire il fratello Isacco) per le non comuni capacità politiche e militari di cui aveva dato prova.
Manuele Comneno fu un sovrano del tutto nuovo per Bisanzio: egli amava infatti le usanze occidentali e le introdusse a corte, modificando profondamente la mentalità e le tradizioni della sua gente.
Si trattava, d’altronde, anche di un’inevitabile conseguenza delle crociate, in seguito alle quali Bisanzio era uscita dalla chiusura all’Occidente, per secoli caratteristica della sua civiltà.
Manuele Comneno ebbe assai vivo il senso dell’universalità dell’Impero e cercò di riportarlo all’antico splendore sia con le armi sia con un’abile e instancabile attività diplomatica, che lo condusse a inserirsi nelle vicende politiche delle più importanti potenze del tempo.
Questi progetti finirono per tradursi in un’ultima fase espansionistica, ma vennero drammaticamente resi vani verso la fine del regno dal repentino crollo dell’intera costruzione politica degli anni precedenti, seguito da una nuova e questa volta irreversibile fase di decadenza.
Pag. 141
Guglielmo Primo procedette quindi alla riconquista del territorio italiano e, nella primavera del 1158, venne concluso un trattato, con la mediazione del papa, in forza del quale i bizantini abbandonarono la penisola.
L’impresa non fu soltanto un insuccesso militare, ma ebbe anche pesanti conseguenze politiche: creò infatti un contrasto insanabile fra l’imperatore di Bisanzio e il collega germanico e condusse a una frattura nelle relazioni con Venezia.
Il timore di una riaffermata presenza bizantina in Italia aveva spinto infatti la repubblica a concludere un trattato con Guglielmo Primo nel 1154 e, al momenti delle ostilità, Venezia restò neutrale.
Per aggirare l’ostacolo, Manuele Comneno si rivolse a Genova nel 1155, gettando le basi di un accordo, ma la diplomazia normanna vanificò la sua opera l’anno successivo ottenendo che anche questa città restasse al di fuori del conflitto.
Pag. 144
La precarietà del rapporto con Venezia, i cui accordi con Bisanzio erano soltanto compromessi provvisori, e il cambiamento della situazione politica in Occidente segnarono l’inizio della fine per Alessio Terzo Angelo.
Dopo la morte di Enrico Sesto l’Impero occidentale si era di fatto disgregato nella lotta civile che contrapponeva Filippo di Svevia a Ottone di Brunswick, senza quindi poter più condurre una propria politica in Italia, dove si impose la forte personalità di papa Innocenzo Terzo, salito al trono di Pietro nel 1198.
Innocenzo Terzo riprese con decisione il progetto di crociata, abbandonato dopo la fine ingloriosa della terza spedizione e le sue aspirazioni spirituali vennero a coincidere con quelle puramente politiche di un’altra forte personalità, il doge veneziano Enrico Dandolo, intenzionato a riaffermare con altrettanta determinazione la supremazia veneziana nell’Impero di Bisanzio.
La conseguenza di questa situazione fu la quarta crociata, al cui conclusione anomala finì per portare a una rapida dissoluzione dell’Impero di Bisanzio, che nel 1204 fu conquistato senza sforzo dagli occidentali.
Pag. 152
Cap. 8. La quarta crociata e l’Impero latino, 1204-1261
La quarta crociata, o “crociata dei veneziani”, venne bandita nel 1198 da papa Innocenzo Terzo; il suo invito fu raccolto dapprima dalla feudalità francese e fiamminga, alla quale si unirono in seguito i signor i tedeschi e dell’Italia settentrionale.
Questa volta non presero parte alla spedizione re o imperatori, ma soltanto feudatari di diversa importanza; capo riconosciuto ne fu il conte Tibaldo di Champagne, che però morì nel 1201 e venne sostituito dal marchese Bonifacio di Monferrato.
I partecipanti si accordarono per raggiungere l’Egitto via mare e, per procurarsi una flotta adeguata, si rivolsero a Venezia.
Furono avviate trattative con la Repubblica e, nell’aprile del 1201, venne concluso un trattato in forza del quale Venezia avrebbe preso parte all’impresa offrendo le navi e i viveri necessari per un anno contro il pagamento di una forte somma di denaro.
In più i veneziani avrebbero fornito una scorta di cinquanta galere, a condizione di ricevere in cambio metà delle conquiste future.
Come data del raduno a Venezia fu stabilito il giorno di San Giovanni, cioè il 29 giugno 1202.
Pag. 153
In questo modo era caduta la capitale dell’Impero romano di Oriente, dopo essere inviolata per secoli.
I vincitori dilagarono indisturbati e, per tre giorni, Costantinopoli fu abbandonata a un saccheggio indiscriminato che aggiunse altre devastazioni a quelle causate dagli incendi sviluppatisi nel costo dell’assedio.
Vennero profanate le chiese, per asportarne i tesori e le reliquie, violati i palazzi e le dimore private e la furia dei conquistatori ai abbatté indiscriminatamente sulle persone e le cose, distruggendo fra l’altro una grande quantità di opere d’arte.
Non si risparmiarono neppure le tombe imperiali, che furono aperte per prelevare gli ornamenti dei cadaveri.
I crociati distrussero per lo più senza alcun criterio, per impossessarsi delle ricchezze, mentre da parte veneziana si ebbe maggiore discernimento e le principali opere d’arte furono salvate per essere trasferite a Venezia, dove ancora sono in gran parte visibili.
Qualche tempo dopo, passata la furia del saccheggio, si provvide a creare un imperatore latino e alla spartizione dell’Impero seguendo i criteri fissati dal trattato di marzo.
Terminava così, sulle ceneri di Costantinopoli, l’età aurea delle crociate, dando vita a un Impero latino in Oriente che sarebbe sopravvissuto fino al 1261, quando la città venne ripresa dai bizantini.
Pag. 156
Il trattato del marzo 1204 costituì una sorta di carta costituzionale dell’Impero latino e, quando Costantinopoli fu presa, servì per la formazione del nuovo organismo statale istituito dai vincitori.
Venne costituito uno Stato di carattere eminentemente feudale e in primo luogo fu eletto un imperatore latino: a questo scopo, si riunì una commissione formata da sei veneziani e sei crociati, che scelse il conte Baldovino di Fiandra, sul quale fecero convergere i voti i veneziani verosimilmente per evitare che si imponesse la forte personalità di Bonifacio di Monferrato.
Subito dopo venne istituito un patriarca latino di Costantinopoli, nella persona del veneziano Tommaso Morosino.
Il trattato di marzo prevedeva infatti di affidare il patriarcato alla parte dalla quale non fosse stato scelto l’imperatore.
Si mise mano infine alla spartizione dell’Impero: il sovrano latino ne ottenne un quarto (costituito dalla sua porzione di Costantinopoli, dalla Tracia, da parte dell’Asia Minore e da alcune isole egee) e il resto andò diviso in parti uguali fra veneziani e cavalieri crociati.
La spartizione aveva tuttavia un valore in gran parte teorico dato che, quando fu completata (nel settembre dello stesso 1204), la provincia bizantina doveva ancora essere sottomessa, a eccezione dei territori di Macedonia e di Tracia, conquistati da Baldovino di Fiandra con uan breve campagna estiva.
Anche quando, in seguito, la sottomissione ebbe luogo, non sempre le assegnazioni fatte sulla carta coincisero con le acquisizioni effettive sia per gli accordi occasionalmente intervenuti fra i vincitori, che modificarono in alcuni casi le zone di influenza, sia anche a motivo della resistenza dell’elemento greco che spesso impedì ai latini di sottomettere alcune regioni.
Pag. 157
Giovanni Vatatze raddoppiò l’estensione del suo Stato e lo condusse a una notevole fioritura economica, mentre l’Impero latino continuava a sopravvivere, sia pure privo di ogni energia, in pratica, soltanto perché sostenuto dalla flotta veneziana, con la quale le forze nicene non erano in grado di confrontarsi a motivo della superiorità tecnica di quest’ultima.
Lo stato di cronica debolezza dell’Impero latino fu aggravato da una pesante crisi finanziaria.
Baldovino Secondo, sul trono dal 1228, trascorse lunghi anni in Occidente, vendendo i possedimenti aviti a Costantinopoli.
Una dopo l’altra vennero anche cedute le reliquie più preziose e giunsero così a Parigi la corona di spine e altre reliquie della Passione, per accogliere le quali re Luigi il Santo fece costruire la Sainte-Chapelle.
A causa del continuo bisogno di denaro, infine, il sovrano finì per dare in pegno ai mercanti veneziani il figlio Filippo e a vendere il piombo che ricopriva i tetti dei suoi palazzi.
Ogni sforzo fu però inutile e l’Occidente abbandonò Costantinopoli latina al suo destino, con la sola eccezione dei veneziani che fino all’ultimo cercarono di preservarla.
Pag. 162-63
Cap. 9. L’età dei Paleologi, 1261-1453
L’epoca dei Paleologi rappresenta l’ultima fase della storia di Bisanzio.
L’Impero ricostruito nel 1261 riuscì a sopravvivere per circa due secoli, anche se riducendosi progressivamente nell’estensione, in preda a un continuo processo di disfacimento dopo il tentativo fatto da Michele Ottavo per riportarlo alle dimensioni di potenza internazionale.
L’opera di erosione del territorio residuo venne attuata dai tradizionali nemici balcanici e orientali, che approfittarono della debolezza di Bisanzio per espandersi, nonché dalle Repubbliche marinare di Genova e di Venezia, la cui ipoteca sul secondo impero si fece sempre più pesante.
Il colpo definitivo fu tuttavia assestato dai turchi ottomani, la stirpe guerriera che iniziò a imporsi nel Quattordicesimo secolo, al cui incontenibile potenza finì per travolgere ciò che restava di Bisanzio e di gran parte dei possedimenti occidentali costituitisi dopo la quarta crociata, espandendosi poi anche ai danni degli Stati balcanici tradizionalmente nemici dell’Impero.
La crisi politica dell’epoca paleologa ebbe anche pesanti ripercussioni sul punto interno, che si fecero drammaticamente avvertire nel corso del Trecento, con un generale impoverimento della popolazione, eccezion fatta per una classe ristretta di grandi proprietari terrieri, passato in gran parte in mano alle repubbliche marinare italiane.
In stridente contrasto con la decadenza di Bisanzio, tuttavia, la cultura letteraria e la produzione artistica ebbero un periodo di rigogliosa fioritura.
Pag. 165
I cambiamenti intervenuti nella situazione italiana misero un pesante ipoteca sui progetti di Michele Ottavo.
L’eliminazione del dominio svevo in Italia meridionale (nel 1266) e l’avvento al trono di Sicilia di Carlo d’Angiò, fratello del re di Francia, diedero infatti nuovo impulso ai piani espansionistici dell’Occidente ai danni di Bisanzio.
Intenzionato a conquistare l’Impero, Carlo d’Angiò si assicurò l’appoggio papale e, in forza di accordi diplomatici che ne facevano l’alleato del deposto sovrano latino, rivendicò il diritto alla sovranità su Costantinopoli, iniziando nello stesso tempo i preparativi per una grande spedizione militare.
Privo delle forze necessarie per contrastarlo, Michele Ottavo cercò di ritardare l’impresa e, parallelamente, di giocare la carte diplomatica nell’unione religiosa con Roma, che avrebbe tolto la spinta propagandistica per l’attacco alla scismatica Bisanzio.
La sua diplomazia convinse il re di Francia, Luigi Nono, a portare con sé il fratello nella crociata di Tunisi nel 1270 e l’anno successivo vennero avviati i contatti con Roma, resi possibili dall’elezione del papa italiano Gregorio Decimo, ben disposto nei confronti di Costantinopoli e nello stesso tempo avverso alla politica angioina.
Le trattative andarono a buon fine: nel 1274 fu convocato un Concilio a Lione dove il dissidio fra le due chiese venne formalmente ricomposto con la proclamazione dell’unione religiosa e i delegati bizantini giurarono di accettare la fede romana nonché il primato di Roma.
I vantaggi politici furono immediati: Carlo d’Angiò dovette rinunciare ai piani di conquista e Michele Ottavo poté avviare una controffensiva su vari fronti.
L’unione ebbe però gravi contraccolpi interni a Bisanzio per l’opposizione pressoché compatta del clero, del monachesimo e di buona parte della popolazione, che spinsero Michele Ottavo a mettere in atto pesanti persecuzioni dei dissidenti.
La fazione ecclesiastica contraria all’unione trovò espressione nel movimento degli arseniti (così detto dal patriarca di Costantinopoli Arsenio, deposto nel 1266 da Michele Ottavo), che si oppose con vigore alla politica imperiale.
L’unione non fu duratura neppure in Occidente e con l’avvento al seggio papale nel 1281 del francese Martino Quarto, strumento di Carlo d’Angiò, si torno alla rottura piena: il papa condannò Michele Ottavo come scismatico e l’Angiò (che già nel 1280 aveva attaccato senza successo l’Albania imperiale) poté riprendere i suoi piani di conquista, promuovendo una coalizione antibizantina formata dall’erede al trono latino Filippo di Courtenay, Venezia, Tessaglia (che nel 1271 si era staccata dall’Epiro), Serbia e Bulgaria.
I serbi e il despota di Tessaglia irruppero in Macedonia nel 1282 e l’Angiò, con l’aiuto navale di Venezia, si apprestò a dare il colpo definitivo al nemico, ma la situazione fu salvata all’ultimo momento dalla rivolta dei Vespri siciliani, scoppiata a Palermo nel marzo del 1282, alla quale non fu estranea la diplomazia di Costantinopoli.
A seguito di questa rivolta, infatti, al Sicilia si liberò dal dominio francese e il tentativo dell’Angiò di rientrarne in possesso fu ostacolato dalla potenza rivale degli aragonesi, con cui si accese un violento conflitto (destinato a trascinarsi fino al 1302 oltrepassando la vita stessa dei primi protagonisti) a seguito del quale naufragò ogni progetto di spedizione in Oriente.
Pag. 167-68
La rinuncia al mantenimento di una forza militare e la linea politica adottata da Andronico Secondo ebbero un pesante contraccolpo sull’Impero.
La potenza ancora esistente sotto il predecessore subì un rapido processo di contrazione, avviando Bisanzio a divenire un piccolo Stato incapace di esprimere una propria politica estera e preda di una sempre più accentuata disgregazione interna.
La moneta andò soggetta a una forte svalutazione e nello stesso tempo si diffuse in modo sempre più massiccio la grande proprietà fondiaria, inutilmente contrastata da un tentativo imperiale di aumentare l’imposizione fiscale ai ricchi.
Sui mercati prevalsero le monete d’oro delle repubbliche italiane, portando come conseguenza un forte rincaro dei prezzi e un generale impoverimento, mentre la pronoia si consolidò con l’affermazione all’interno di questo sistema di uan classe privilegiate di feudatari, così da accentuare il divario con il resto della popolazione impoverita.
Analogamente disastrose furono le ripercussioni interne della politica seguita nei confronti delle repubbliche marinare, la cui alleanza o neutralità gravò ulteriormente sull’erario imperiale con una serie di concessioni o privilegi per mantenerne l’amicizia.
Pag. 169
L’Asia Minore turca aveva subito un processo di ridefinizione territoriale tra il Tredicesimo e il Quattordicesimo Secolo.
Il sultanato selgiuchide di Rum, giunto all’apogeo nei primi anni del Duecento, era stato travolto dall’invasione mongola subendo uan disastrosa sconfitta campale nel 1243, a seguito della quale si era frazionato in una serie di piccoli emirati più o meno indipendenti e soggetti al controllo dei mongoli.
Con il declino della potenza mongola, verso l’inizio del Quattordicesimo secolo, acquistò un’importanza sempre crescente l’emirato costituito dagli ottomani (o osmanili) nel territorio dell’antica Bitinia.
Si trattava di uan tribù turca arrivata fra le ultime in Asia Minore, che aveva avuto come suo primo capo Ertogul, cui era poi succeduto il figlio Osman (1281-1326), il vero fondatore della dinastia ottomana.
A lui è legato il nome stesso del suo popolo, che fu chiamato Osmanli e venne poi conosciuto in Occidente come “Ottomani”.
Gli Ottomani si mostrarono subito una stirpe guerriera e, fra Tre e Quattrocento, misero in atto una inarrestabile espansione territoriale destinata a riunificare le genti turche e a assestare un colpo mortale all’Impero di Bisanzio.
Pag. 170-1
L’Impero uscì stremato dal nuovo conflitto civile e subì ulteriori perdite territoriali.
I genovesi ripresero Chio, Stefano Dusan conquistò la Macedonia, eccezion fatta per Tessalonica, , e subito dopo l’Epiro e la Tessaglia.
Il territorio in mano a Costantinopoli si ridusse alla Tracia, le isole dell’Egeo settentrionale, Tessalonica isolata all’interno delle conquiste arabe e una parte del Peloponneso.
Bisanzio subì inoltre un tracollo economico e finanziario a seguito delle devastazioni apportate dal passaggio degli eserciti di Cantacuzeno e dei suoi rivali, e a questo, come ulteriormente negativo, si accompagnò nel 1347 la diffusione della grande epidemia di peste che poi avrebbe raggiunto l’intera Europa.
La situazione era disastrosa, d’altronde, già all’inizio del conflitto quando Anna di Savoia aveva impegnato a Venezia i gioielli della corona per ottenere un prestito con cui far fronte alle spese di guerra.
L’idea del degrado è data pienamente dal fatto che alla corte, un tempo splendida, si usava ora soltanto vasellame di piombo e di terracotta.
Il grande Impero di Bisanzio si era ridotto all’ombra dell’antica potenza, ma sarebbe tenacemente sopravvissuto ancora per un secolo.
Pag. 174
La Crociata di Nicopoli rappresentò uno sforzo serio compiuto dalle potenze occidentali per arrestare l’avanzata turca e venne promossa essenzialmente per la difesa dell’Ungheria cattolica.
L’iniziativa du presa da Sigismondo re di Ungheria, l’unico Stato balcanico che ancora disponeva delle risorse necessarie per poter condurre operazioni militari di ampio respiro, che fece appello a tutti i sovrani d’Europa per un’impresa destinata a salvare la cristianità.
Il suo invito fu raccolto: si mossero due papi (Bonifacio Nono e Benedetto Tredicesimo ad Avignone) e venne costituita una grande armata di circa centomila uomini il cui grosso era formato dagli ungheresi, ma che comprendeva anche migliaia di uomini variamente affluiti da Francia, Germania, Valacchia, Italia, Spagna, Inghilterra, Polonia e Boemia.
I genovesi di Lesbo e di Chio e i cavalieri di Rodi si assunsero il compito di presidiare la foce del Danubio e le coste del mar Nero, mentre Venezia finì per superare le esitazioni iniziali (determinate dal proposito di avviare una trattativa bizantino-turca) inviando una piccola flotta nei Dardanelli da cui fu infranto il blocco navale dei turchi.
L’esercito crociato si concentrò a Buda per ricongiungersi ai veneziani nella capitale e, nell’estate del 1396, superò il Danubio proseguendo verso Nicopoli, che fu posta sotto assedio.
Il 25 settembre però le forze cristiane furono disastrosamente sconfitte da Bayazid.
Il re Sigismondo riuscì a mettersi in salvo con la fuga, ma molti combattenti occidentali perirono sul campo o furono fatti prigionieri.
Pag. 181
La crisi dell’Impero ottomano conseguente alla disfatta del 1402 portò ad alcuni anni di calma, segnati anche dalla fioritura culturale di Mistrà a opera del despota Teodoro Secondo Paleologo e dell’umanista Giorgio Gemisto Pletone, uno dei più fecondi pensatori del tempo.
Si ebbe a Mistrà una paradossale rifioritura dell’ellenismo, in aperto contrasto con lo sfascio generale del mondo bizantino.
La Morea, nella prima metà del Quattrocento, divenne il vivaio della grecità e mostrò anche una considerevole vitalità politica, riuscendo a sottomettere tutto il Peloponneso, a eccezione delle colonie veneziane di Corone, Modone, Argo e Nauplia.
Nel 1432, infatti, venne assoggettato il principato latino di Acaia e terminò così la contesa franco-bizantina per il possesso del Peloponneso, che era iniziata al tempo di Michele Ottavo.
Per meglio proteggere la Morea, Manuele Paleologo fece poi costruire l’Hexamilion, un forte bastione difensivo lungo tutto l’istmo di Corinto.
Pag. 182
La crociata svoltasi fra il 1443 e 1444, comunemente nota come crociata di Varna, fu inizialmente coronata da un promettente successo.
L’appello del papa per la spedizione trovò un’accoglienza favorevole e nella parte meridionale dell’Ungheria si raccolse un esercito guidato dal re Ladislao Terzo, dal voivoda di Transilvania Giovanni Corvino Hunyadi, dal despota serbo Giorgio Brankovic, che era stato cacciato dal suo paese dai turchi; a questo si aggiunsero poi altri rinforzi guidati dal legato papale, il cardinale Giuliano Cesarini.
L’esercito crociato, composto da circa 25000 uomini cui si unirono lungo il percorso più di 6000 serbi, superò il Danubio all’inizio dell’ottobre 1443 e si addentrò fino in Bulgaria e, di qui, in Tracia ottenendo una serie di brillanti vittorie sui nemici.
Le operazioni militari vennero sospese nell’inverno ma la situazione continuava a essere favorevole ai crociati: Murad Secondo, impegnato a domare una rivolta in Asia Minore, si trovò in difficoltà, anche perché contemporaneamente l’Albania era insorta e le truppe del despota bizantino di Morea, Costantino Paleologo, erano passate all’offensiva nella Grecia centrale.
Il sultano fece perciò proposte di tregua e nel giugno 1444 si accordò per un armistizio di dieci anni che alla fine venne respinto dai cristiani, con l’eccezione del despota di Serbia, ritiratosi dall’impresa.
Le forze crociate ripresero la marcia in direzione del mar Nero, dove prevedevano di imbarcarsi sulla flotta veneziana a Varna e raggiungere Costantinopoli.
Le operazioni navali e terrestri, però, furono male coordinate: i veneziani ritardarono il loro arrivo e, nello stesso tempo, non riuscirono a impedire a Murad Secondo di traghettare al di là del Bosforo un forte contingente di truppe asiatiche.
Il 10 novembre 1444 le forze turche, pari a circa il triplo di quelle nemiche, affrontarono i crociati in prossimità di Varna, sulla costa del mar Nero.
I cristiani combatterono con eroica determinazione, ma alla fine furono sbaragliati lasciando fr ai morti il re Ladislao e il cardinal Cesarini; i superstiti si sbandarono e soltanto pochi riuscirono a salvarsi.
Pag. 183-84
La disfatta di Varna determinò la fine di Bisanzio.
Nel 1448 morì Giovanni Ottavo Paleologo e, in assenza di eredi diretti, il suo posto fu preso dal fratello e despota di Morea Costantino Undicesimo Paleologo (1448-1453) che fu incoronato a Mistrà e qualche tempo più tardi ragiunse Costantinopoli su una nave veneziana.
Le operazioni militari condotte in Grecia da Costantino Paleologo erano proseguite anche dopo la sconfitta dei crociati, ma nel 1446 Murad Secondo troncò ogni velleità di rivincita irrompendo nella regione, superò le difese dell’istmo ricostruite dal despota e si addentrò in Morea devastandola completamente per poi ritirarsi con sessantamila prigionieri dopo aver imposto il riconoscimento della sua sovranità.
La potenza ottomana era ormai incoronabile e, dopo la sconfitta di Hunyadi, era rimasto in armi nei Balcani soltanto l’albanese Giorgio Castriota, detto Scanderbeg, che si era ritirato sulle montagne dell’Albania per proseguire la lotta.
La sorte di ciò che restava dell’Impero era ormai segnata, ma l’epilogo si sarebbe avuto soltanto con l’avvento al potere nel 1451 del giovane ed energico sultano Maometto Secondo, che diede un forte impulso all’espansionismo turco portando il suo Stato a una potenza non ancora raggiunta dai predecessori.
Maometto Secondo il Conquistatore (come fu chiamato dai contemporanei) decise in primo luogo di farla finita con quanto restava dell’Impero.
Le residue sopravvivenze bizantine rappresentavano un ostacolo per i suoi piani di dominio e Costantinopoli, in particolare, era un assurdo ricordo di una potenza ormai scomparsa, pericolosamente incuneata però nell’Impero ottomano.
Maometto Secondo preparò con cura l’accerchiamento della città imperiale, che con le sue forti mura rappresentava ancora un ostacolo formidabile.
Prese dapprima una serie di iniziative volte a intercettare l’arrivo di qualsiasi aiuto esterno, poi fece costruire nel punto più stretto del Bosforo il castello di Rumir-Hisar, che si aggiunse alla fortezza di Anadolu Hisar fatta edificare da Bayazid sulla sponda asiatica e dotata di un imponente spiegamento di artiglieria in grado di impedire a chiunque la navigazione.
Quando l’accerchiamento fu completato, ebbe inizio l’assedio vero e proprio nei primi giorni di aprile del 1453.
Maometto Secondo schierò di fronte a Costantinopoli un’armata imponente, forte a quanto pare di circa centocinquantamila uomini, ma soprattutto ricorse in modo massiccio all’artiglieria, che si sarebbe rivelata determinante per la caduta della città.
Per suo conto, un fonditore ungherese di nome Urban realizzò ad Adrianopoli un cannone di proporzioni gigantesche, che venne trasportato in due mesi con un tiro di sessanta buoi fin sotto le mura della capitale assediata.
Alla grande quantità di combattenti turchi e ai mezzi tecnologicamente all’avanguardia si contrapponevano un’artiglieria antiquata e un nucleo di difensori formato da circa settemila uomini, composto da bizantini e settecento mercenari genovesi guidati da Giovanni Giustiniani Longo, cui venne affidato dal sovrano il comando delle operazioni difensive.
Pag. 184-85
Gli ottomani iniziarono l’assedio della città il 12 aprile con un bombardamento diurno e notturno delle mura terrestri che durò per una settimana.
Il 18 aprile Maometto Secondo tentò un attacco notturno andato a vuoto e, subito dopo, lo scontro si spostò sul mare nel tentativo di forzare l’ingresso al Corno d’Oro che era stato chiuso con uan grossa catena.
Anche questa operazione non ebbe l’esito sperato, per la resistenza dei cristiani, e il sultano decise di trasportare via terra le navi facendole trainare fin sulla cima di una collina antistante per poi farle scendere nel porto e, qui, prendere alle spalle la flottiglia che difendeva la catena.
L’operazione fu eseguita con successo il 22 aprile e alcuen decine di navi turche entrarono così nel porto di Costantinopoli; tuttavia non condusse ai risultati sperati, dato che le imbarcazioni turche alla fine si trovarono intrappolate ed esposte agli attacchi nemici.
Maometto Secondo intensificò di conseguenza l’assedio, con due tentativi di penetrare in città attraverso brecce aperte nelle mura, il 7 e il 12 maggio, che vennero ugualmente respinti dagli assediati.
Fu inoltre aumentato il bombardamento, aprendo grossi squarci nelle mura e vennero fatti altri inutili assalti diretti alle difese cittadine.
Il 26 maggio Maometto Secondo si risolse a tentare l’attacco finale eseguendo i necessari preparativi.
Il 28, nella città ormai presaga della fine, si svolsero grandi processioni e una cerimonia religiosa in Santa Sofia, alla quale presero parte l’imperatore con i suoi dignitari e i comandanti del presidio.
L’assalto iniziò dopo le tre del mattino del 29 maggio e si concentrò in prossimità della porta di San Romano, che era il punto più debole della difesa.
La prima ondata, composta da reparti irregolari, fu respinta dopo due ore di combattimenti e lo stesso avvenne per un secondo assalto di truppe anatoliche.
Verso l’alba il sultano fece scendere in campo le truppe scelte (i giannizzeri) e queste alla fine riuscirono a penetrare dentro le mura.
Il Longo, ferito, abbandonò la posizione gettando il panico fra i difensori, che si sbandarono, e Costantino Undicesimo morì combattendo nella disperata difesa della sua capitale ormai invasa dai nemici.
Alcuni superstiti riuscirono a fuggire facendo salpare fortunosamente dal porto un certo numero di navi veneziane, cretesi e genovesi, che raggiunsero il Bosforo e di qui proseguirono verso la salvezza mentre Costantinopoli venne brutalmente messa a sacco dai vincitori per tre giorni.
Pag. 185-86
Ancora una volta le potenze occidentali non accorsero in difesa di Costantinopoli, malgrado gli appelli disperati di Costantino Undicesimo e i pericoli connessi alla perdita della città, che avrebbe offerto ai turchi una posizione strategica di prim’ordine per proseguire il loro attacco al mondo cristiano.
La flotta veneziana inviata in soccorso degli assediati partì con incredibile ritardo e non arrivò mai sul teatro operativo, perché fu preceduta dalla notizia della caduta di Costantinopoli in mano turca.
Nell’inutile tentativo di ottenere l’aiuto dell’Occidente, l’imperatore bizantino aveva fatto proclamare di nuovo l’unione religiosa in Santa Sofia (12 dicembre 1452), suscitando l’indignata reazione dei suoi sudditi, in grande maggioranza determinati a sopportare il dominio turco piuttosto che la soggezione a Roma.
Poco più tardi caddero in mano ottomana anche i residui frammenti dell’Impero: la Morea ne 1460 e Trebisonda l’anno successivo.
Molti bizantini fuggirono riparando soprattutto in Italia e, fra questi, un buon numero di eruditi che contribuirono alla diffusione in Occidente della cultura greca.
Il Ducato di Atene, residuo della conquista latina, fu ugualmente nel 1456, mentre alcune delle colonie genovesi e veneziane costituite nel corpo dell’Impero avrebbero resistito più o meno a lungo alla marea turca.
Con la conquista di Costantinopoli, a ogni modo, finiva la storia di Bisanzio, ma la sua tradizione fu continuata attraverso la cultura greca, che nel corso del Quattrocento si affermò decisamente in Occidente, e la Chiesa ortodossa che ne raccolse l’eredità.
Pag. 186
Bibliografia
Opere generali sulla storia e la civiltà di Bisanzio
I grandi problemi della storia bizantina / C. Diehl. – Laterza, 1957
Storia di Bisanzio /P. Lemerle. – Lecce, 2004
L’Impero bizantino / N. H. Baynes. – Firenze, 1971
Vita e morte di un impero / L. Brehier. – Genova, 1995
L’eredità di Bisanzio / N. H. Baynes e L. B. Moss (a cura di). – Milano, 1961
La civiltà bizantina / S. Runciman. – Firenze, 1960
I bizantini / D. Talbot Rice. – Milano, 1963
Storia dell’Impero bizantino / G. Ostrogorsky. – Einaudi, 1968
Storia e cultura di Bisanzio / H. W. Haussig. – Milano, 1964
Storia del mondo medievale. Vol. 3.: L’Impero bizantino. – Garzanti, 1968
Bisanzio e la sua civiltà / A. P. Jordan. – Laterza, 1983
Il dramma di Bisanzio: ideali e fallimento d’una società cristiana / A. Ducellier. – Napoli, 1980
La teocrazia bizantina / S. Runciman. – Milano, 2003
Il millennio bizantino / H.-G. Beck. – Roma, 1981
La civiltà bizantina /C. Mango. – Laterza, 2003
Il pensiero politico bizantino / A. Pertusi. – Il Mulino, 1990
L’uomo bizantino / a cura di G. Cavallo. – Laterza, 1992
Materiali di storia bizantina / A. Carile. – Il Mulino, 1994
Guida allo studio della storia bizantina / E. Pinto. – Messina, 1994
La chiesa ortodossa: storia, disciplina, culto / E. Morini. – Il Mulino, 1996
Bisanzio: splendore e decadenza di un impero, 330-1453 / J. J. Norwich. – Milano, 2000
La civiltà bizantina: donne, uomini, cultura e società / a cura di G. Passarelli. – Milano, 2000
La civiltà bizantina / C. Capizzi. – Milano, 2001
Storia di Bisanzio / W. Treadgold. – Il Mulino, 2005
Gli ortodossi / E. Morini. – Il Mulino, 2002
Lo Stato bizantino / S. Ronchey. – Einaudi, 2002
Bisanzio: la seconda Roma / R.-Lilie. – Roma, 2005
La storia di Bisanzio / G. Ravegnani. – Roma, 2004
Il mondo bizantino, 1.: L’Impero romano d’Oriente, 330-641 / C. Morrisson. – Einaudi, 2007
Bisanzio: storia di un impero, secoli Quarto-Tredicesimo / M. Gallina. – Roma, 2008
Studi su singoli aspetti
Costantino tra cristianesimo e paganesimo / A. Alfoldi. – Laterza, 1976
Lo scisma di Fozio: storia e leggenda / F. Dvornik. – Roma, 1953
Storia delle crociate / S. Runciman. – Einaudi, 1966
Comneni e Staufer: ricerche sui rapporti fra Bisanzio e l’Occidente nel Secolo Dodicesimo / P. Lamma. – Roma, 1955-1957
L’imperatore Michele Paleologo e l’Occidente, 1258-1282 / D. J. Geanakoplos. – Palermo, 1985
Il Concilio di Firenze / J. Gill. – Firenze, 1967
Bisanzio e il Rinascimento: umanisti greci a Venezia e la diffusione del greco in Occidente, 1440-1535 / D. J. Geanakoplos. – Roma, 1967
Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel Secolo Quarto / A Momigliano. – Einaudi, 1968
Il tardo Impero romano / A. H. M. Jones. – Milano, 1973-81
La caduta di Costantinopoli, 1453 / S. Runciman. – 2001
Studi sulle colonie veneziane in Romania nel Tredicesimo Secolo / S. Borsari. – Napoli, 1966
Il tramonto del mondo antico / A. H. M. Jones. – Laterza, 1972
Maometto il Conquistatore e il suo tempo / F. Babinger. – Einaudi, 1967
La dominazione bizantina nell’Italia meridionale dal Nono all’Undicesimo Secolo / V. von Falkenhausen. – Laterza, 1978
L’imperatore Anastasio, 391-518: studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità / C. Capizzi. – Roma, 1969
Il mondo tardoantico: da Marco Aurelio a Maometto /P. Brown. – Einaudi, 1974
Giustiniano e Teodora / R. Browning. – Milano, 1974
Il Commonwealth bizantino: l’Europa orientale dal 500 al 1453 / D. Obonlensky. – Laterza, 1974
Costantino Porfirogenito e il suo mondo / A. Toynbee. – Firenze, 1987
Costantinopoli: nascita di una capitale, 350-451 / G. Dragon. – Einaudi, 1991
L’imperatore Giustiniano: storia e mito / a cura di G. G. Archi. – Milano, 1978
Per una storia dell’Impero latino di Costantinopoli, 1204-1261 / A. Carile. – Il Mulino, 1978
L’amministrazione bizantina in Dalmazia / J. Ferluga. – Venezia, 1978
L’Impero bizantino e l’islamismo / A. Guillou, F. Bulgarella e F. Bausani. – Einaudi, 1981
I Bizantini in Italia / G. Cavallo et al. – Milano, 1982
Cirillo e Metodio apostoli degli slavi / M. Lacko. – Milano, 1982
La spedizione italiana di Costante Secondo / P. Corsi. – Il Mulino, 1983
L’Impero bizantino, 1025-1204: uan storia politica / M. Angold. – Napoli, 1992
Costantino il Grande / E. Horst. – Milano, 1987
Introduzione allo studio dell’età giustinianea / R. Bonini. – Il Mulino, 1985
Lo storico e la sua vittima: Teodora e Procopio / H.-G. Beck. – Laterza, 1988
L’Impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204-1461: rapporti politici, diplomatici e commerciali / S. P. Karpov. – Roma, 1986
L’Italia bizantina: dall’Esarcato di Ravenna al tema di Sicilia / A. Guillou e F. Bulgarella. – Einaudi, 1988
Venezia e Bisanzio / D. M. Nicol. – Milano, 1990
Il crepuscolo di Bisanzio, 1392-1448 / I. Djuric. – Roma, 1989
Il tardo romano impero / A. Cameron. – Il Mulino, 1995
Un impero, due destini: Roma e Costantinopoli fra il 395 e il 600 d. C. / A. Cameron. – Genova, 1996
Teodosio: l’ultima sfida / S. Williams e F. Friell. – Genova, 1999
Potere e società a Bisanzio dalla fondazione di Costantinopoli al 1204 / M. Gallina. – Einaudi, 1995
La Sardegna bizantina tra Sesto e Settimo Secolo / P. Spanu. – Oristano, 1998
Giovanna di Savoia alias Anna Paleologina, latina a Bisanzio, c. 1306-c. 1365) / S. Origone. – Milano, 1999
Teofano: una bizantina sul trono del Sacro Romano Impero, 958-991 / R. Gregoire. – Milano, 2000
Costantino il Grande / A. Marcone. – Laterza, 2000
L’Impero perduto: vita di Anna di Bisanzio, una sovrana tra Oriente e Occidente / P. Cesaretti. – Milano, 2006
Quarta Crociata: Venezia-Bisanzio-Impero Latino / a cura di G. Ortalli et al. – Venezia, 2006
I bizantini in Italia / G. Ravegnani. – Il Mulino, 2004
Bisanzio e Venezia / G. Ravegnani. – Il Mulino, 2006
Figure bizantine / Ch. Diehl. – Einaudi, 2007
Costantino Quinto imperatore di Bisanzio / N. Bergamo. – Rimini, 2007
Imperatori di Bisanzio / G. Ravegnani. – Il Mulino, 2008
I Normanni in Italia di Donald Matthew
- Visite: 154
Parte prima. I normanni e la monarchia
Cap. 1. L’Italia meridionale e i Normanni prima della creazione della monarchia
Il regno normanno fondato in Italia da Ruggero Secondo nel 1130 comprendeva le terre di Sicilia e Calabria che questi aveva ereditato dal padre, il conte Ruggero Primo, i territori continentali retti fino alla sua morte (1127) dal duca di Puglia Guglielmo Primo, suo cugino, e le terre dei signori dell’Italia meridionale che erano o diventarono vassalli dello stesso Ruggero.
Queste terre non erano mai state unite in precedenza sotto un’autorità politica propria e non avevano più avuto una storia comune dal tempo della riconquista d’Italia da parte di Giustiniano sei secoli prima.
La creazione del regno nel 1130 fu resa possibile dalla instaurazione di signorie normanne in gran parte di quelle terre nel corso dei cento anni precedenti; ma è errato vedere nei successi normanni di quegli anni le fasi di un piano a lunga scadenza concepito per integrare i vari possedimenti in uno Stato unitario.
I capi militari normanni avevano assunto in momenti diversi il governo delle regioni che controllavano e non tutte queste autorità politiche erano sopravvissute nel 1130.
Le varie parti del regno erano quanto mai differenziate e avevano ben poco in comune, tranne che il capo e i suoi vassalli, spesso anch’essi di origine normanna.
Inoltre, più erano vaste e più le loro strutture erano complesse.
Le terre di Ruggero Secondo riunivano la Calabria, tolta ai bizantini, e la Sicilia, tolta ai musulmani.
Guglielmo, duca di Puglia, ultimo di una stirpe normanna che, dopo la vittoria sui bizantini (1042), aveva assunto un primato nominale sui conti normanni stabilitisi in Puglia, era anche, in modo più effettivo, erede dei principi longobardi di Salerno, che era diventata la città principale della famiglia di Guglielmo quando suo nonno Roberto il Guiscardo l’aveva conquistata nel 1076.
E’ del tutto evidente che governare territori messi insieme solo per fatto di conquista non era impresa facile.
In questo senso anziché semplificare le cose, la riunione di tutte le parti in un unico regno poteva sembrare un modo per accrescere le difficoltà.
Finché Ruggero si fosse accontentato di una deferenza puramente formale, i nuovi vassalli erano disposti a riconoscerlo re; con ciò essi non prevedevano però di perdere potere nelle proprie terre.
Non si può dire cioè che essi, in quanto normanni, che costruivano i propri domini secondo la tradizione politica normanna, avessero preparato la via alla monarchia.
L’instaurazione di signorie normanne nell’Italia meridionale e in Sicilia durante l’Undicesimo Secolo aveva comportato, entro certi limiti, accordo e collaborazione trai normanni per favorire i comuni interessi.
Ma il potere dei vari capi militari non aveva semplificato, con questo, la situazione politica della regione.
L’aveva invece complicata, disgregando le maggiori entità politiche precedenti.
Aveva distrutto l’amministrazione imperiale bizantina e sfruttato spietatamente la debolezza dei principati longobardi, Benevento, Salerno e Capua.
Di questi, soltanto quello di Capua andò pressoché per intero a un principe normanno; gli altri furono spezzettati.
Il solo normanno che nell’Undicesimo Secolo riuscì davvero a dominare un territorio comprendente normanni e longobardi insieme fu Roberto il Guiscardo duca di Puglia (1057-85), ma al prezzo di lotte continue per tenere in soggezione i suoi vassalli normanni.
Il suo “Stato” non gli sopravvisse: i figli se ne disputarono l’eredità e lo divisero.
Le contese di famiglia non avevano del resto nulla di eccezionale.
Dopo il 1042, tre fratellastri del Guiscardo, Guglielmo, Dragone e Umfredo, erano diventati in successione conti dei normanni di Puglia, ma quando il giovane Guiscardo venne nel Sud (tra il 1046 e il 1047) essi non lo accolsero a braccia aperte.
Roberto dovette farsi strada per conto suo, dapprima più o meno come brigante e ladro di cavalli, con pochi seguaci in Calabria.
Quando nel 1057 il conte Umfredo morì, Roberto volle succedergli nel ruolo di capo normanno in Puglia, provocando naturalmente il risentimento dei figli di lui.
Oltre alle rivalità interne della famiglia del Guiscardo c’erano inoltre altre tensioni, come quelle tra i normanni stanziati in Puglia e quelli insediatisi nel 1030 ad Aversa, prima base normanna nell’Italia meridionale.
Nel 1058 Riccardo conte di Aversa si impadronì del principato longobardo di Capua, rilanciando la pretesa di Aversa di essere considerata il centro normanno più importante; ma insieme con il principato Riccardo ereditò anche l’antica rivalità tra Capua e Salerno.
I normanni di Puglia avevano goduto, nei primi tempi del loro insediamento, della protezione del principe di Salerno, e continuavano a interessarsi agli affari di questo principato.
Lungi dall’aiutare i loro compagni di Capua e battere la longobarda Salerno, i normanni di Puglia presero Salerno sotto la loro protezione, finché il Guiscardo decise di impadronirsi lui della città.
All’originario spirito di emulazione dei normanni delle varie bande si sommarono dunque, a un certo punto, gli effetti della rivalità secolare dei longobardi.
Insomma, i normanni non agivano nel Sud come una forza compatta: ogni signore aveva interessi propri a cui badare.
Pag. 9-11
Quando nel 751 il re longobardo dell’Italia settentrionale si impadronì finalmente della bizantina Ravenna, il signore longobardo del Sud, il duca di Benevento, poté sperare di completare la sua conquista del Mezzogiorno.
Senonché il timore dei successi del re longobardo indusse il papa a invocare l’intervento in Italia dei franchi,
Sconfitto il re Desiderio da Carlo Magno (774), anche i duchi di Benevento, ultimi rappresentanti dell’autorità longobarda in Italia, si videro minacciati dal dominio franco, e mantenere la propria indipendenza divenne per loro più importante che ricacciare i bizantini in mare.
A volte, anzi, si giovarono dell’aiuto greco.
Sebbene i duchi cominciassero a chiamarsi grandiosamente principi, il loro territorio fu indebolito da una divisione in tre parti e quando nel Nono Secolo il timore dei franchi si attenuò, le rivalità tra i vari principi prevalsero su tutto il resto.
Ogni speranza di espellere completamente i greci fu dimenticata.
…………..
Insomma, circa la propria presenza in Italia non si fecero scrupoli: i bizantini ritenevano di avere nel territorio diritti inoppugnabili.
Pag. 12-13
Gli annali in questione parlano poco delle cose siciliane, anche se spesso si presume che il conte di Sicilia ostentasse nelle proprie terre maggiore autorità di quella che i duchi di Puglia potevano esibire nella loro.
Il fratello del Guiscardo, Ruggero Primo, aveva goduto nei suoi domini calabresi e siciliani di un prestigio e di un’autorità derivatigli dall’aver guidato la riconquista della Sicilia.
Dopo la sua morte, però, ci fu un certo disordine e non si sa se la vedova e i due figli, Simone e Ruggero, succeduti a turno nel titolo, godessero di un rispetto paragonabile; prima, almeno, che Ruggero Secondo diventasse maggiorenne (1112).
Le donazioni fatte dal conte Tancredi di Siracusa a quella chiesa nel 1104 non accennano all’autorità del conte Simone; sono datate senza riferimento a nessun genere di alta signoria formale.
Analogamente, ancora nel 1120 le donazioni del conte di Ragusa alla chiesa di Catania non fanno riferimento a Ruggero Secondo come conte di Sicilia; il documento è datato secondo gli anni del pontificato di Callisto Secondo, signore diretto della diocesi.
Sembra arbitrario interpretare comportamenti analoghi sul continente come indizio di un’autorità intrinsecamente più debole del duca di Puglia a paragone di quella di Sicilia.
Pag. 22-23
D’altro canto, la frequenza con cui i normanni, rispetto ai precedenti governanti longobardi, effettuano concessioni alle chiese, ha suscitato il sospetto che i normanni incoraggiassero la “feudalizzazione” dell’autorità “sovrana”.
Contrariamente a questo, tuttavia, va rilevato che l’insistenza a ricorrere ad atti formali di concessione di tali prerogative dimostra l’importanza che essi annettevano a una preliminare autorizzazione scritta per l’esercizio delle medesime.
I diplomi di concessioni alle chiese, che rendevano possibile l’esatta definizione di ciò che veniva accordato, permettevano anche ampie variazioni nel contenuto delle concessioni stesse.
Quando il duca Ruggero di Puglia concesse al vescovo di Troia certi diritti di pascolo, non passò molto che il vescovo tornò a chiedere anche una concessione ducale dell’herbaticum, il tributo normalmente corrisposto per la pastura.
I funzionari del duca sembra interpretassero meticolosamente le concessioni ducali e non erano disposti a dare ai destinatari il beneficio del dubbio.
In questo contesto, non si può dire che i normanni siano stati noncuranti o prodighi nel fare concessioni di redditi potenzialmente preziosi.
Pag. 28
Uno dei tratti più singolari di alcune categorie del Sud in questo periodo è che esse continuarono a usare per la datazione gli anni di regno dell’imperatore bizantino, come se questi fosse ancora considerato il sovrano supremo.
In certi casi, è probabile che i conti normanni si mostrassero ligi all’imperatore per evitare pressioni dagli Altavilla; ma Alessio Comneno, dal canto suo, non dovette trarre grande profitto da questi gesti di deferenza alla sua autorità.
All’epoca la sua massima preoccupazione come imperatore d’Oriente era di restaurare la propria autorità in regioni più vicine a Costantinopoli.
Di fatto i normanni erano padroni di se stessi.
Questo era altresì il periodo in cui il re germanico era meno in grado di intervenire nel Sud in veste di imperatore d’Occidente.
Non solo lo travagliavano problemi interni, ma gli effetti della lotta per le investiture impedivano una sua venuta nel Sud.
Il solo potere che avesse titoli tradizionali per agire nell’Italia meridionale dopo la morte del Guiscardo era perciò il papato.
Dall’inizio del pontificato di Urbano Secondo (1088), il papato cominciò in effetti a costruire una presenza più autorevole e prestigiosa nell’Italia meridionale.
L’importanza del Sud fu ulteriormente accresciuta dopo il 1095 dalla crociata, perché la regione rappresentava naturalmente il principale trampolino per l’Oriente.
Il predecessore di Urbano, Vittore Terzo, quale abate Desiderio di Montecassino, era stato tra i primi ad apprezzare il valore potenziale di un’amicizia con i normanni.
Gregorio Settimo, nonostante i suoi contrasti con il Guiscardo, aveva avuto bisogno dei normanni per salvarsi e lasciare Roma occupata da Enrico Quarto.
Il conflitto con l’impero costrinse tutti i papi successivi ad ammettere che l’aiuto dei normanni era indispensabile, per quanto ingrata fosse questa dipendenza.
Dopo la morte di Gregorio, i suoi successori sul trono papale dovettero imparare ad essere più flessibili.
Pag. 30
Cap. 2. La fondazione del regno
La monarchia normanna fu fondata nel nuovo contesto determinato dalla accettazione generale della successione di Ruggero Secondo nel ducato di Puglia: tuttavia, l’idea di fare Ruggero re emerse solo nel 1130.
Essa non ottenne subito universale approvazione e i nemici di Ruggero contestarono le sue pretese per quasi trent’anni.
Nessun altro regno medievale ebbe così strane doglie di parto.
Nonostante le ostilità suscitate dal progetto in varie sfere, re Ruggero Secondo (1130-54) e suo figlio Guglielmo Primo (1154-66) dimostrarono una fede incrollabile nella possibilità di tenere insieme, come regno, il loro conglomerato di territori.
Ma anche se è abbastanza naturale che la storia della fondazione della monarchia venga raccontata facendo riferimento all’eroica tenacia di questi due re di fronte al persistere di anguste vedute, le qualità personali di Ruggero e di suo figlio non possono bastare a spiegare il successo della monarchia stessa.
Pag. 38
Il regno normanno in Italia fu concepito, a quanto pare, in un incontro tra il papa Anacleto Secondo e il duca Ruggero nel settembre 1130.
Si presume spesso che l’idea di creare una monarchia venisse da Ruggero e questi certamente si mostrò per tutta la vita determinato a spingere il papato in una posizione formale di superiorità.
La concessione scritta di una corona regia a Ruggero fatta da Anacleto può quindi essere interpretata come una pura ratifica delle dettagliate proposte di Ruggero, anziché come un gesto interpretato del papa.
Tuttavia, dato che Ruggero non avrebbe mai proceduto di propria iniziativa senza l’”autorità” papale che legittimasse le sue azioni, è necessario capire perché il consenso del papa ci fu.
Ruggero in quell’occasione non coartò il papa con la forza militare come aveva fatto con Onorio Secondo e come fece più tardi con Innocenzo Secondo.
Pag. 39
Quanto entusiasmo suscitò nel regno l’elevazione di Ruggero?
Chi, a parte il papa e il re, ne trasse vantaggio?
Per molti dei potenti delle terre ruggeriane, la monarchia non portò cambiamenti nei loro obblighi di vassalli, es essi si comportarono con il re come si erano comportati con il conte o duca, accettando o resistendo alla sua autorità secondo i loro variabili calcoli politici.
Tuttavia è ovvio che la monarchia non avrebbe potuto essere proclamata senza la partecipazione di grandi quali il principe di Capua, portacorona nella notte della cerimonia, e senza il consenso di una folla di signori che aveva reso quest’ultima imponente, accompagnando le processioni e banchettando con piatti d’oro e d’argento, serviti da domestici vestiti di seta.
Lo splendore del re ispirava la reverenza ma anche il timore; c’era chi riteneva di avere più da perdere che da guadagnare dall’innovazione.
Pag. 42-43
Dalla Sicilia, dove Ruggero era più al sicuro, non abbiamo testimonianze contemporanee, a parte gli atti ufficiali; lo stesso vale per la Calabria e le province adriatiche.
Invece due o tre cronache di questi anni furono scritte significativamente nella regione a sud di Roma.
La più interessante proviene dalla città papale di Benevento.
Il suo autore, Falcone, che ottenne l’ufficio di iudex (un titolo che allude alle funzioni di un magistrato civile più che a quelle di un giudice) sotto il papa Innocenzo Secondo, era ostile a Ruggero e alla sua monarchia, ma la sua faziosità lo rende portavoce eloquentissimo dell’opposizione.
La sua esperienza personale del periodo e delle traversie subite da Benevento, insieme alla sua consapevolezza di come le fortune della guerra spazzassero via la debole resistenza locale, rendono affascinante la sua concitata narrazione degli avvenimenti.
Il suoi appelli retorici al senso di meraviglia del lettore e i discorsi messi in bocca ai personaggi principali rivelano il suo talento artistico e insieme la sua animosità.
Dato che l’interesse di Falcone è concentrato prevalentemente su Benevento, e non su Ruggero, la sua cronaca non è una guida per capire la mentalità di quest’ultimo.
Ma per lo storico, come fa intendere lo stesso Falcone, la cognizione di tale mentalità è uno degli elementi più importanti per interpretare gli avvenimenti.
Pag. 45
Fino al cambiamento della politica di Anacleto, Capua aveva potuto contare di solito sull’appoggio papale nei suoi sforzi per resistere al dominio degli Altavilla, perché il papato, rendendosi conto del pericolo di venire a dipendere da un solo grande principe nell’Italia meridionale, aveva cercato nel 1076 di mantenere l’attrito tra i signori di Capua e di Salerno.
Anche quando Onorio nell’agosto 1128 riconobbe duca Ruggero, egli volle che questi giurasse di rispettare l’autonomia di Capua.
Nondimeno Ruggero aveva saputo da allora trarre vantaggio dal riconoscimento concessogli dal papa.
Nelle sue campagne del 1129 aveva soggiogato la Puglia adriatica e ottenuto l’omaggio dei grandi.
Era diventato chiaramente il padrone dell’Italia meridionale, tanto che il papa si era recato personalmente da lui per ottenere il suo aiuto contro la ribelle Benevento.
Dipendendo egli stesso dall’aiuto di Ruggero, Onorio non era più in grado di salvare Capua e quella estate Roberto, intimorito (timore commotus), rese omaggio a Ruggero.
Senza l’appoggio papale, Roberto di Capua non poteva mantenere la sua indipendenza.
Pag. 47
Il nemico che Ruggero non aveva potuto sconfiggere era papa Innocenzo Secondo, che nell’autunno 1133 si era ritirato nella sicurezza di Pisa, e ivi rimase fino al 1137, implacabilmente ostile al principale sostenitore politico del suo rivale Anacleto.
Innocenzo non era molto temibile; neanche Lotario aveva potuto riportarlo al potere a Roma.
Soltanto la morte di Anacleto, all’inizio del 1138, gli permise di agire come un papa con cui era necessario fare i conti.
Nel frattempo Innocenzo cercò di tornare alla politica di Onorio Secondo e di fomentare il malcontento nell’Italia continentale per rovesciare la monarchia di Ruggero.
Come Onorio aveva riposto la sua fiducia in Roberto di Capua, Innocenzo ripose la sua, con più ragione, in Rainolfo di Alife.
Ma un solo grande capo non bastava.
Quando alla fine di aprile 1139 Rainolfo morì, non ci fu nessun altro che prendesse il suo posto.
Gli avvenimenti, perciò, avrebbero dimostrato di nuovo, e più di una volta, che l’autorità di Ruggero nell’Italia meridionale non poteva essere facilmente minata dall’ostilità papale.
Non si può presumere che Innocenzo Secondo probabilmente valutava assai bene la realtà politica del proprio regno.
Nessuno dei nemici gli era pari per intelligenza politica, con la possibile eccezione del suo energico cognato Rainolfo di Alife.
Pag. 55
La fonte principale di notizie per il quinquennio successivo è fornita da Falcone, esule da Benevento.
Egli concentra l’attenzione sul suo protettore, Innocenzo, la cui vittoria soltanto poteva ripristinare il suo alto ruolo nella città.
Nella cronaca dell’anni 1136 egli tratta solo dei negoziati tra il papa e l’imperatore, così che i movimenti di Ruggero sul continente rimangono un mistero.
Tuttavia in quell’anno Ruggero introdusse un’innovazione destinata ad avere importanza nel futuro del suo governo: cessò di chiamarsi nei suoi atti “re di Sicilia e d’Italia” e adottò la formula curiosa “re di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua”.
Nel Sud, seguendo l’uso bizantino, il nome “Italia” era usato all’epoca per significare la Puglia; ma altrove era usato per indicare tutta la penisola, anche se i tedeschi lo usavano spesso in senso più ristretto, per il regno tosco-padano dell’Italia del Nord.
La decisione di Ruggero di togliere nel 1136 questo nome dal proprio titolo può aver avuto, quindi, l’intento diplomatico di assicurare a Lotario che egli non aspirava alla corona italiana dell’imperatore.
Il titolo plurimo conferma anche che Ruggero considerava il suo regno tutt’altro che unito.
Il cambiamento di titolo consacrò il nuovo regime da lui inaugurato a Benevento nel 1135.
Pag. 58-59
Né Innocenzo né i suoi immediati successori si rassegnarono alla vittoria di Ruggero e alla sua morte il papato cercò di negare al suo erede i frutti della campagne di lui.
Bosone, biografo di Innocenzo Secondo, non parla della sua umiliazione per mano di Ruggero e non riconosce le concessioni fatte al re.
Ruggero probabilmente era conscio di non poter contare sulla remissività romana e che all’occasione sarebbe stato necessario tornare alla carica.
Innocenzo Secondo, tornato a Roma nell’ottobre 1139, non se ne allontanò più fino alla morte (1143) e non creò altri problemi, pur deplorando che i figli di Ruggero, decisi a recuperare tutte le terre del principato di Capua, violassero le sue frontiere.
Il suo successore, Celestino Secondo (settembre 1143-marzo 1144), non ratificò gli atti del luglio 1139; Lucio Secondo (marzo 1144-febbraio 1145) chiese la restaurazione di un principato di Capua indipendente e in seguito accondiscese soltanto a una tregua nelle continue dispute di confine in Campania e intorno a Benevento; Eugenio Terzo, infine, costretto a lasciare Roma prima ancora di essere consacrato, per alcuni anni non ebbe rapporti diretti con il re.
Sembra che Innocenzo avesse sperato nel soccorso di una terza invasione tedesca, ma dopo la sua morte il progetto di una nuova crociata distolse l’attenzione dei principi del Nord dai problemi papali e Ruggero ebbe quindi minore motivo di temere un ripetersi degli interventi imperiali.
Dopo il 1139 il papato cessò dunque per alcuni anni di essere un ostacolo grave al governo di Ruggero.
Ma aspettava il momento di vendicarsi delle umiliazioni subite.
Pag. 61-62
L’esempio migliore di come Ruggero sconcertasse i contemporanei è forse il modo in cui egli si comportò riguardo al problema rappresentato dalla decisione del re di Francia Luigi Settimo, proclamata a Vézelay nel maggio 1146, di bandire la crociata.
Luigi, e dopo di lui il re di Germania Corrado terzo, erano apparentemente spinti dalla fede a muovere in soccorso della Terrasanta, ma Ruggero doveva valutare il nuovi interesse di questi sovrani per gli affari mediterranei alla luce dei propri programmi.
A Ruggero era necessario, fin dall’inizio del suo governo, mantenere buoni rapporti con le principali forze dell’area mediterranea che avevano interessi marittimi: Venezia, Pisa, Genova, Savona, il conte di Barcellona, varie città del Nord Africa, l’Egitto e l’Impero bizantino.
La sua visione inoltre doveva essere necessariamente tanto pragmatica quanto ad ampio raggio, ma nessun altro principe occidentale del tempo eguagliava la sua esperienza e la sua freddezza di giudizio.
Di fronte alla prospettiva della spedizione del re id Francia in Oriente, dobbiamo credere che l’attenzione di Ruggero non fosse rivolta anzitutto alla nobile causa per la quale i crociati partivano, perché lo spostamento oltremare di tanti soldati aveva inevitabilmente, gli piacesse o no, implicazioni per la sua posizione.
Come l’imperatore bizantino, egli doveva cioè in primo luogo valutare le conseguenze per il proprio governo.
Nel 1146 i bizantini erano ancora abbastanza sicuri di sé per credere di potersela vedere con i crociati senza pericolo, ma Ruggero era comprensibilmente timoroso.
Crociati provenienti dal Nord che attraversavano le sue terre non potevano non creare turbamenti nei domini di recente conquista e sull’appoggio del papato, anche qualora quest’ultimo si fosse mostrato meno ostile, non c’era da far conto.
La complessità delle reazioni del re può suscitare commenti di vario genere, ma non era certo eccezionale.
Calcoli politici analoghi faceva Corrado Terzo: questi aveva pensato a una spedizione in Italia per liquidare Ruggero e le sue trattative per un’alleanza matrimoniale con Costantinopoli diretta contro di lui non rimasero senza frutto.
L’Impero orientale a sua volta sperava di volgere al crociata a proprio vantaggio, sia per rafforzare la posizione cristiana in Terrasanta sia, eventualmente, per trovare alleati occidentali per eventuali campagne di riconquista in Italia.
Questa crociata, a differenza di quella del 1095, era guidata insomma da sovrani mossi da obiettivi politici, i quali percepivano che i propri atti non sarebbero stati privi di conseguenze.
Ruggero aveva più da perdere degli altri e badò a come trarre profitto dalla spedizione.
Nella peggiore delle ipotesi, distrarre Corrado e l’imperatore bizantino gli avrebbe dato respiro; Nella migliore, egli poteva inserirsi nella spedizione in modo da ottenere il controllo di Antiochia, dove molti tarantini e baresi avevano rapporti di vecchia data.
La mente audace e ingegnosa di Ruggero gli fece cogliere l’occasione di farsi amico Luigi Settimo dando risposta pronta e positiva a un sondaggio avanzato nell’estate del 1146, offrendosi cioè di trasportare per mare i crociati del re francese.
Questa offerta fu rifiutata per prudenza da Luigi nella primavera del 1147.
Alla luce degli eventi posteriori, e certo al momento del viaggio di ritorno di Luigi, questo rifiuto dovette apparire un errore; ma nel 1147 i contemporanei di Ruggero erano restii ad affidarsi alle sue navi.
I principi settentrionali temevano che dipendere da Ruggero avrebbe pregiudicato la loro buona accoglienza a Costantinopoli.
E’ anche probabile che papa Eugenio Terzo dissuadesse Luigi Settimo dallo stringere amicizia con Ruggero.
Pag. 65-66
Mentre le forze di Ruggero nell’estate 1148 andavano di vittoria in vittoria, molti crociati francesi erano già sulla via del ritorno, delusi e ansiosi di ridare lustro alla loro appannata reputazione.
Luigi Settimo attese fino all’estate 1149 prima di tornare per mare e la sua nave cadde allora in un’imboscata greca da cui scampò solo grazie all’aiuto di una scorta siciliana.
Anche sua moglie Eleonora sfuggì ai bizantini grazie agli uomini di Ruggero e fu portata a Palermo.
Sembra che Ruggero sperasse allora di ottenere l’alleanza di Luigi contro i propri nemici, gli imperatori Corrado Terzo e Manuele Primo Comneno, con i quali egli riteneva che Luigi Settimo avesse ora conti da regolare.
Ruggero ebbe tre giorni di colloqui con Luigi a Potenza, che gli diedero ampio modo di misurare la poca fermezza di carattere del re francese; ma anche la diplomazia diede i suoi frutti, perché la proposta di bandire un’altra crociata, questa volta contro i perfidi bizantini, diede a Ruggero altro respiro e creò preoccupazione in Germania e nella curia romana.
Eugenio Terzo temeva che il solo risultato di una crociata del genere sarebbe stato di rafforzare Ruggero e di incitarlo ad ampliare il suo regno in Toscana e in Romagna.
Perciò l’atteggiamento del papato verso Ruggero non si ammorbidì, nonostante le vittorie del re contro i musulmani e la sua capacità di affascinare l’impressionabile Luigi.
Pag. 70
Gli avvenimenti avrebbero dimostrato che il papato continuava a sperare in circostanze propizie che permettessero di eliminare il regno di Ruggero: il pontefice non cambiò mai volentieri atteggiamento né ebbe mai un ripensamento sincero.
Ruggero, dal canto suo, non lasciò che ciò lo deviasse dalla sua strada.
La sua autorità affettiva nel regno non dipendeva dalla benedizione papale; una volta consacrati i suoi vescovi, egli non si trovava vincolato dagli obblighi di alcun “trattato”.
Nella Pasqua del 1151 Ruggero associò al regno il suo unico figlio superstite, Guglielmo, facendolo consacrare a Palermo senza altra autorità che quella dell’arcivescovo Ugo, provvedendo così alla successione nel modo tradizionale del regno di Francia.
Dopo l’incoronazione di Guglielmo, poco sappiamo dell’attività di Ruggero nei quasi tre anni che passarono prima della sua morte.
Alla fine del 1152 Eugenio rientrò a Roma, dove lui e i suoi successori risiedettero abitualmente fino alla primavera del 1155.
I papi romani e i re palermitano non ebbero a quanto pare contatti fra loro.
La politica papale è chiara nella sua determinazione di persistere nell’intento di riportare in Italia i compiacenti tedeschi.
Dopo la morte di Corrado Terzo, il suo nipote ed erede Federico Barbarossa concluse un’alleanza con Eugenio Terzo contro i comuni nemici: i romani ribelli, re Ruggero e l’imperatore bizantino.
Ma quando Federico arrivò in Italia alla fine del 1154, Ruggero ed Eugenio, e anche il successore di quest’ultimo, Anastasio Quarto, erano tutti morti.
Pag. 72
La frontiera concordata agganciò gli interessi territoriali del papato a quelli del regno.
Pag. 77
Con il trattato di Benevento, il regno ideato da Anacleto Secondo nel 1130 aveva ottenuto finalmente il riconoscimento del papato, e con ciò il riconoscimento della cristianità occidentale.
L’ultimo scontro con i nemici del regno era avvenuto soltanto dopo la morte di Ruggero, perché essi, tenuti in soggezione da lui, avevano sperato di sconfiggere almeno il suo successore.
La vittoria di Guglielmo, perciò, non era solo una dimostrazione personale della sua capacità di difendere la creazione del padre: dimostrava che il regno non era l’avventura di un uomo soltanto, rivelandosi invece una realtà più solida di quanto all’esterno si fosse immaginato.
Pag. 78
La creazione del regno nell’arco di un quarto di secolo aveva richiesto a entrambi i monarchi un impegno continuo, tra vicende di cui è complicato fare la cronistoria, ma che non si possono semplificare senza falsare il carattere delle sfide che essi dovettero affrontare e superare.
Ad onta di ogni opposizione, il nuovo regno sopravvisse e perdurò in una forma o nell’altra fino alla caduta dei Borboni nel 1860.
Il regno di Ruggero Secondo, nonostante il modo singolare in cui fu messo insieme, diede dunque prova di una vitalità invidiabile.
E’ difficile credere che a ciò bastasse la sola forza di volontà di un re, ed è ancora meno plausibile chiamare in causa un qualche sentimento nazionale, sia pure in seno alla cerchia relativamente ristretta dei capi normanni.
Malgrado tutto c’era una ragione profonda nel nuovo organismo.
Il regno offrì all’Italia meridionale uan struttura formale per il suo sviluppo, struttura la cui mancanza in passato aveva molto danneggiato la regione.
Sotto la monarchia le varie parti del Mezzogiorno, per quanto disparate, scoprirono ciò che tutte avevano in comune: un rapporto con il bacino centrale del Mediterraneo, che la monarchia unita permetteva di dominare nell’interesse generale.
Riconosciuto da Roma ma senza grandi obblighi verso di essa, libero dal timore degli imperatori germanici e sciolto dai ceppi bizantini e musulmani, il regno aveva finalmente la possibilità di fabbricare il proprio destino.
Pag. 79
Parte seconda. Il regno.
Cap. 3. Le risorse materiali.
I territori governati dai re normanni coprivano un’area di circa 100.000 chilometri quadrati, pari a un terzo dello Stato italiano odierno.
Le stime demografiche si basano su incompleti dati fiscali del tardo Tredicesimo Secolo, che indicano una popolazione di circa quattro milioni e mezzo, sifra inaspettatamente alta.
Data la notevole proporzione di terreni montuosi e destinati al pascolo nel Sud, alcune zone dovevano dunque sostenere, al tempo di quel rilevamento, un numero cospicuo di abitanti.
Al tempo delle conquiste normanne, tuttavia, queste terre non erano sovrappopolate e si cercava di attirarvi gente, in particolare per migliorare la produzione agraria.
Coloni venivano non solo cercati al di fuori del regno, ma nuclei di popolazioni venivano anche incentivati a spostarsi da una regione all’altra.
Nel complesso, le terre del Regno meridionale avevano un’antica fama di fertilità e i contemporanei davano per scontata la loro ricchezza e prosperità.
Anche se oggi non c’è speranza di fornire una descrizione oggettiva della ricchezza del regno, le notizie desumibili da una gran parte delle migliaia di documenti superstiti danno l’impressione di un generale benessere economico, nonostante l’occasionale verificarsi di calamità naturali quali terremoti, eruzioni vulcaniche, annate cattive ed epidemie.
Pag. 83
Il benessere delle città marittime del regno si basava chiaramente sull’esportazione oltremare dei prodotti agricoli locali, anziché sull’importazioni di merci straniere.
La creazione del regno aiutò ad abbattere le barriere commerciali tra una parte e l’altra del regno stesso, ma prima del 1130 sembra che gran parte dell’interscambio commerciale avvenisse con l’esterno, poiché le varie regioni trovavano i mercati migliori per le loro eccedenze non tanto nelle regioni vicine, quanto nelle popolose città del Nord Africa e dell’Oriente.
Il principale prodotto d’esportazione era il grano duro, per il quale la Sicilia era famosa fin dall’Antichità, anche se altre regioni del regno, come la Campania e la Puglia, ne producevano anch’esse in quantità sufficiente per esportarne una parte.
Il Sud esportava legname e olio e frutti stagionali come nocciole, noci e castagne, specialmente in Egitto.
I prodotti esportabili erano dunque molti.
L’abbazia di Santa Maria Latina a Gerusalemme apprezzava la Sicilia come fonte di alimenti quali lardo, tonno e formaggio, ma anche per le pelli d’agnello, di coniglio e di bue, per le ciotole di legno, la canapa, i tessuti di lino e di lana.
Edrisi parla delle ricche pinete del regno da cui si ricavava catrame e pece, utili per le costruzioni navali ed esportati in molti paesi.
Pag. 85
E’ necessario ricordare come si svolgeva il commercio in quella età, senza attribuire ai governi logiche anacronistiche.
L’atteggiamento di Ruggero Secondo in materia si può intravedere nelle condizioni imposte alla fedele città di Salerno, che nel 1137 era stata la sola a resistere alle pretese dell’imperatore tedesco.
Uno dei favori offerti dal re fu di ridurre le decime commerciali (decatias) e le altre tasse pagate dai mercanti salernitani ad Alessandria allo stesso livello di quelle pagate dai mercanti di Sicilia.
Ruggero, quindi, non mirava a stabilire un’unica politica commerciale per tutti i mercanti dell’intero regno.
Tutt’al più si preoccupava di assicurare determinati vantaggi a particolari gruppi d’interesse che avevano qualche titolo all’intervento regio.
Il commercio era condotto da gruppi di mercanti che agivano in società (consortia) di concittadini, come quelli di Amalfi, che avevano un loro quartiere a Palermo e negoziavano per proprio conto nel regno crociato.
Le grandi città dovevano fare assegnamento, per il loro successo, non sul governo regio ma sull’iniziativa dei propri cittadini.
L’esempio più notevole di questo fatto è l’impresa di un gruppo di marinai che nel 1087 portarono il corpo di san Nicola da Mira a Bari, senza nessuna autorizzazione o iniziativa dall’alto.
In questo periodo ciò che noi intendiamo per vita e intrapresa economica non era promosso dalle ambizioni dei principi e naturalmente non c’erano teorie economiche che influenzassero la politica a qualsiasi livello.
Pag. 87
Queste condizioni erano diffuse generalmente in tutto il regno.
Non sembra che tra una regione e l’altra ci fossero grandi divari di ricchezza.
Sotto Federico Secondo, per esempio, l’onere fiscale era distribuito in modo da suggerire che l’eredità del conte Ruggero Primo al suo pronipote valesse circa un terzo dell’intero regno; se si include il valore degli altri territori tolti all’Impero d’Oriente, l’insieme costituiva quasi il settanta per cento; il resto era costituito da terre dei precedenti principi longobardi e dei conti dell’Abruzzo.
All’interno di queste regioni potevano essere molte variazioni: nondimeno occorre ricordare, per esempio, che in questo periodo la Calabria non aveva ancora subito l’impoverimento che la colse in seguito.
Nelle condizioni del tempo, la Calabria traeva ancora beneficio dall’essere la testa di ponte per la Sicilia.
Sarebbe un errore dunque trasporre la povertà moderna nel Mezzogiorno di allora.
Pag. 91
Cap. 4. Le comunità religiose.
- Musulmani
Gli abitanti della maggior parte dei regni del Dodicesimo Secolo traevano il senso di una qualche identità comune dal fatto di condividere la stessa religione.
In passato i cristiani inglesi, per esempio, si erano stretti insieme politicamente di fronte all’assalto dei vichinghi pagani.
Il Regno del Sud non poteva contare sulla solidarietà religiosa, perché nell’isola c’era una numerosa popolazione musulmana, e molti cristiani di rito greco erano disseminati con varia densità nei suoi territori.
Il “problema” confessionale non aveva la stessa importanza in tutte le parti del regno.
Non c’erano veri precedenti a guidare i normanni nel modo di trattare i musulmani o di governare i sudditi cristiani di un’altra tradizione.
I normanni dovettero procedere a tentoni, anche se certamente fu per loro un elemento di forza l’essere cristiani di rito latino, risoluti a stabilire usi latini in campo sia temporale sia ecclesiastico.
Ciò non li rese persecutori intolleranti di tradizioni estranee, anche se fin dall’inizio essi seppero trattare duramente sia i greci sia i musulmani.
I greci persero subito l’autonomia ecclesiastica quando i loro vescovi furono obbligati a riconoscere le prerogative della Chiesa di Roma nell’Italia meridionale, ma non ci su nessun tentativo di cambiare i riti greci.
La gran parte dei musulmani fu ovviamente sottoposta a un potere loro estraneo, anche se alcune parti della Sicilia sembra rimanessero prevalentemente musulmane e se la pratica religiosa continuò senza interruzioni.
I normanni, con i loro alleati longobardi, agivano nell’ambito di una tradizione latina e a lungo andare l’egemonia normanna comportò l’emergere di uan Chiesa latina dominante.
Pag. 100
La Sicilia non era rinomata nel mondo islamico per le sue scuole o per la sua cultura; prima della conquista normanna era considerata, al contrario, poco ortodossa.
Nondimeno aveva i suoi dotti e i suoi poeti; costoro erano peraltro inclini a emigrare in Spagna o nel Nord Africa e ciò indica che in un regno cristiano non c’erano buone opportunità per musulmani fieri delle proprie tradizioni culturali, i quali preferivano naturalmente svolgere la loro attività in paesi musulmani.
L’isola diventò sempre meno attraente per i musulmani devoti con l’affluire da altre parti della cristianità di coloni latini, tendenzialmente ostili ai musulmani.
Già nel Regno di Guglielmo Primo vi furono disordini, che probabilmente contribuirono ad accelerare l’esodo musulmano da certe città e regioni, favorendo forse per un periodo il concentrarsi dei musulmani in aree dove essi si sentivano meno vulnerabili.
Nondimeno, ancora nel 1183 risulta, da un atto di concessione a Cefalù di dieci villani e dei loro poderi, che soltanto tre di essi si erano convertiti dall’islam al cristianesimo.
Nella Sicilia orientale, in inchieste condotte nel 1172 dal Gran giustiziere in Val di Noto compaiono ancora notabili saraceni di Siracusa che rendono testimonianza circa confini terrieri stabiliti una ventina di anni prima.
Tuttavia Catania già nel 1179 la moschea era stata abbandonata e convertita in una chiesa dedicata a san Tommaso Becket [quindi non fa scandalo il contrario accaduto recentemente a Istanbul].
Qui l’occupazione normanna aveva fatto sparire completamente dalla città, in circa un secolo, la presenza musulmana.
La rottura con le autorità a partire dal 1190 circa in poi è in netto contrasto con la situazione relativa alla maggior parte del Dodicesimo Secolo, quando rapporti discreti tra le comunità cristiane e musulmane erano generalmente la norma.
I musulmani non erano i soli contadini sottoposti a dominio signorile o soggetti a esazioni arbitrarie.
In alcuni luoghi musulmani e cristiani vivevano insieme negli stessi villaggi.
A distinguerli era la religione più che la condizione sociale, e sappiamo che quando la protezione regia, per una qualunque ragione, era inefficace, essi erano esposti a persecuzioni scatenate dai nuovi arrivati latini, i quali non condividevano l’atteggiamento tollerante del governo verso gli infedeli.
Pag. 107
- Ebrei
Se i vescovi bizantini dovettero accettare la giurisdizione papale, i monaci mantennero i loro legami con Costantinopoli e il Monte Athos.
Pag. 109
- Latini
- Monasteri
I normanni arrivarono dalla Normandia già pieni di entusiasmo per il monachesimo e con l’idea che favorire e proteggere i monasteri era un dovere dei potenti.
Nell’Italia meridionale gli Altavilla furono per lo più patroni generosi e fondarono nuovi monasteri per rispondere alle esigenze religiose dei loro compagni normanni, reclutando monaci e abati nella loro terra d’origine.
In terraferma i normanni trovarono molti monasteri illustri e d’antica data, con propri patroni tradizionali.
Le fondazioni normanne non istituirono modelli cenobitici più elevati, né mutarono il carattere del monachesimo locale.
Monasteri prestigiosi quali Montecassino e Cava dei Tirreni godettero nell’Undicesimo Secolo di un nuovo patronato normanno, ma per lo più sembra che le vecchie e le nuove comunità provvedessero ai bisogni di differenti gruppi sociali.
Pag. 124
Il movimento monastico più originale del Dodicesimo Secolo fu nel regno quello legato a san Guglielmo di Vercelli, fondatore di Montevergine.
La straordinaria espansione della sua comunità è probabilmente la massima testimonianza nel Sud di quanto acceso fosse l’entusiasmo spontaneo per la santità.
La comunità, situata a un’altitudine di 1270 metri, attirò sulla montagna conversi provenienti da sedi sovraffollate.
Alla comunità eremitica si unirono anche dei preti.
Facendo forza alle sue inclinazioni, Guglielmo aveva consentito la costruzione di una grande chiesa nuova, consacrata nel 1126 dal vescovo di Avellino e i preti della comunità non tardarono a reclamare uno stile di vita più tradizionalmente clericale.
La loro arroganza, nella sua casa, riuscì intollerabile a Guglielmo, che affidò la direzione al suo discepolo Alberto e se ne andò, riprendendo la sua vita errabonda di asceta in luoghi inaccessibili; salvo a lasciarsi indurre in seguito, da altri discepoli, a nuove fondazioni.
Gli ideali ascetici dei monaci ispirarono un gran numero di donazioni di piccole proprietà, offerte da umili benefattori, e col tempo la comunità generò una serie di priorati dipendenti.
Il carattere di questa vasta congregazione ricorda le pie tradizioni precedenti di Camaldoli e anticipa l’attrazione poi esercitata dai francescani.
Sfortunatamente, i molti documenti superstiti e le vite alquanto leggendarie del santo fondatore sono guide poco attendibili per la storia spirituale della congregazione e per la ricostruzione della sua influenza religiosa nella regione.
Pag. 126-27
L’abate dell’Italia meridionale che ebbe la massima influenza sui futuri francescani fu Gioacchino da Fiore.
Probabilmente di origine contadina, Gioacchino trascorse la giovinezza, come tante celebri figure religiose del regno, errando qua e là e vivendo da anacoreta.
Alla fine entrò nell’ordine cistercense a Sambucina, una filiazione di Casamari, donde fu eletto abate di Corazzo.
Formatosi intellettualmente come cistercense, approfittò delle opportunità di vita religiosa offerte dall’ordine ai rustici di lingua latina.
In seguito, scontento dell’ordine, se ne staccò e fondò un monastero indipendente nella Sila, San Giovanni in Fiore, che lui vivente diventò il fulcro di una piccola congregazione, poi molto ingrandita.
Il suo intento di fondare un’austera comunità nell’alta Sila, dove esistevano già varie comunità religiose greche, sembra indicare una sua stretta affinità con antiche tradizioni monastiche calabresi.
I rigori della vita monastica non precludevano neanche là un alto livello di istruzione e di cultura, e la compatibilità della fondazione di Fiore con le tradizioni greche è confermata dalla successiva incorporazione di parecchie case greche nella congregazione florense.
Gioacchino ebbe anche successo terreno, ottenendo una conferma e diverse donazioni da re Tancredi e dall’imperatore Enrico Sesto, e fu per certi versi incoraggiato dai papi, sia come interprete della Scrittura sia come riformatore monastico.
Pag. 128-29
I latini del Sud, quali che fossero i vantaggi politici loro derivanti dal dominio normanno, trovarono in loco ispirazione religiosa.
La natura delle nostre fonti – vite di santi, storie di miracoli, prediche, lettere – non è insolita, ma i particolari che esse rivelano mostrano come fossero peculiari i fervori religiosi del regno nel quadro del Dodicesimo Secolo.
Se le figure di santi spiccano con maggiore risalto, esse si stagliano su uno sfondo di pietà popolare formato da vigorose personalità individuali.
La gente comune del regno ci è rivelata nel modo più eloquente proprio nel vivo delle diverse dimensioni religiose.
Potenzialmente il regno cristiano aveva modo di attingere a risorse spirituali, oltre che materiali, di qualità eccezionale.
I visitatori stranieri del tempo erano colpiti favorevolmente da ciò che vedevano e non come quelli di età posteriori depressi da testimonianze di povertà, superstizione e degrado.
Il Sud di allora non costituiva un problema: si presentava come una terra promessa.
Pag. 130
Cap. 5. Aspetti della vita intellettuale e artistica.
La mescolanza di religioni e culture presenti nel Regno meridionale del Dodicesimo Secolo ha suscitato l’ammirato interesse dell’immaginazione moderna.
L’attenzione di è concentrata su edifici straordinari quali la Cappella palatina di Palermo, dove i talenti di artefici di tradizioni diverse furono messi all’opera per la gloria del re.
I visitatori coevi del regno, che trovavano motivi propri di meraviglia, non parlano tuttavia delle attrattive offerte da una società cosmopolita.
Chi viveva nel regno avvertiva piuttosto le animosità reciproche dei vari gruppi che non i potenziali vantaggi di una mescolanza culturale.
I latini avevano il predominio politico e col tempo la cultura del loro gruppo prevalse in tutto il regno.
La cultura musulmana in Sicilia fu ovviamente la prima a essere sommersa, perché la differenza di religione rendeva i musulmani a lungo andare inammissibili.
Alla fine del Dodicesimo Secolo essi si sentivano abbastanza estranei per ribellarsi apertamente contro l’autorità latina.
Federico Secondo trattò spietatamente i ribelli e molti ne deportò a Lucera in terraferma, e alla fine del Tredicesimo Secolo l’ultima comunità musulmana superstite fu dissolta e i suoi membri venduti schiavi.
I greci non subirono mai persecuzioni analoghe: quali cristiani che accettavano l’autorità della Chiesa di Roma, le loro differenze erano conciliabili.
Tuttavia alla fine anch’essi furono sommersi in un ambiente prevalentemente latino.
La dimensione multiculturale del Regno meridionale fu perciò solo un fenomeno transitorio ed è improbabile che vi fosse mai un vero interesse per la promozione dei rapporti interculturali o per la protezione delle culture minoritarie.
D’altro canto, poiché non c’era una politica deliberatamente intesa a imporre l’uniformità, questa si realizzò soltanto come conseguenza indiretta della crescente sicurezza di sé dei latini.
A poco a poco il loro numero aumentò e il governo formò il proprio apparato di funzionari, artigiani e ecclesiastici; lentamente ma inesorabilmente i “non-conformisti” furono emarginati.
Non è possibile seguire passo passo il processo di imperialismo culturale nei secoli, ma i punti nodali sono abbastanza chiari.
A parte le differenze di religione, la lingua rappresentava un fattore di divisione.
In Inghilterra (il caso più simile), il francese diventò la lingua del governo, della legge e della cultura ed ebbe un’influenza marcata sullo sviluppo dell’inglese.
Nondimeno la sua influenza fu temporanea.
L’inglese rimase la lingua della maggioranza e a suo tempo recuperò il proprio predominio culturale diventando strumento di letteratura cortese.
Uno degli elementi di forza che aiutarono l’inglese a sopravvivere alla conquista normanna era la propria tradizione letteraria.
Niente di paragonabile esisteva nell’Italia longobarda.
Nel Sud, l’esistenza di una grande varietà di parlate doveva essere considerata cosa normale molto prima che arrivassero i normanni e probabilmente la capacità di parlare più di una lingua era abbastanza diffusa.
Il francese fu soltanto una lingua in più.
Sebbene fosse parlato nella corte regia del Dodicesimo Secolo, ovviamente non era usato in tutto il sistema dell’amministrazione pubblica.
Probabilmente i francofoni erano troppo pochi per imporlo, e forse riusciva loro facile imparare le lingue locali.
Non è possibile accertare quali parole francesi fossero adottate dall’italiano in questa fase, ma si suppone che normanni e longobardi comunicassero tra loro abbastanza facilmente, appartenendo a gruppi linguistici non eterogenei.
Nessuna lingua volgare aveva la prevalenza e anche negli ambienti di corte non risulta si coltivasse una letteratura volgare fino alla comparsa, al tempo di Federico Secondo, dei poeti della cosiddetta “scuola siciliana”.
Per gli scopi sociali ufficiali e legali, l’arabo, il greco e il latino erano tutti scritti da gente del mestiere.
La cosa più probabile è che le lingua parlate in uso fossero molte, ma rimanessero poco influenzate dall’amministrazione o dalla cultura dotta.
I bizantini in particolare appaiono buoni traduttori di opere greche in altino e accurati traduttori dell’arabo; fin dall’inizio essi ebbero un ruolo importante come interpreti e mediatori.
I normanni dal canto loro dovevano avere buona pratica delle lingue, data la loro dama di abilità nell’ingannare gli avversari.
Il Guiscardo, in particolare, sembra fosse oratore persuasivo non solo nella sua lingua, ma un tale talento potrebbe essere stato deliberatamente coltivato anche da altri potenti e sovrani.
Ibn Giubair riferisce con ammirazione che re Guglielmo Secondo parlava l’arabo.
E’ in questa tradizione che va letta l’osservazione di Giovanni Villani, secondo cui Federico Secondo parlava cinque lingue.
Pag. 131-33
Se nelle tradizioni artistiche c’erano scambi reciproci, altrettanto non sembra avvenisse in materia di religione.
Ci sono poche tracce di interesse latino per gli studi religiosi greci, anche se è possibile che la versione greca dei Settanta della Bibbia abbia stimolato la critica testuale della Vulgata.
A questo proposito, è degno di nota un salterio della Vulgata scritto prima del 1153 contenente una glossa interlineare in arabo, che potrebbe indicare un intento di aprire le scritture cristiane ai musulmani.
A sostegno di questa ipotesi esiste anche un testo dei Vangeli in greco e in arabo.
Mentre in tempi moderni la variegata composizione razziale, linguistica e religiosa del regno meridionale sembra aver costituito di per sé un ambiente favorevole alla ibridazione culturale, è chiaro che il contributo della Sicilia alla diffusione della cultura musulmana nell’Occidente latino fu assai meno importante di quello della Spagna.
Cordova era stata per molto tempo uno dei grandi centri intellettuali dell’Islam, e fino alla fine del Dodicesimo Secolo i dotti e gli studiosi islamici svolsero la loro attività in Spagna, specialmente a Toledo, per trovare i libri, i contatti e gli interpreti di cui avevano bisogno.
La Sicilia, invece, era rimasta in posizione periferica nella cultura islamica.
Era famosa per i suoi giardini, la sua fertilità e la sua ricchezza, non per le sue scuole.
Anche la sua ortodossia era risultata controversa.
Dopo la conquista normanna, i dotti musulmani preferirono in misura crescente abbandonare la bella isola, forse con rammarico, ma riconoscendo realisticamente di non poter più partecipare alle tradizioni intellettuali dell’Islam sotto una dominazione straniera.
In modo analogo, i greci erano rimasti culturalmente all’ombra di Costantinopoli.
Sembra però che nel periodo normanno, spezzati i legami politici con Costantinopoli, la cultura greca in certo modo rifiorisse, per iniziativa di alcuni monasteri.
Il riconoscimento da parte degli imperatori Comneni che i normanni andavano presi sul serio fece anche sì che nel Dodicesimo Secolo i rapporti diplomatici furono condotti a un più alto livello e i greci poterono per qualche tempo trarne vantaggio.
Ma a parte la corte regia, non c’era una tribuna dove le differenti tradizioni culturali del regno potessero incontrarsi su un piano di parità intellettuale.
L’eclettismo culturale che rese la corte, anziché la Chiesa, il centro focale della vita intellettuale del regno accentuò probabilmente l’interesse per materie di carattere profano.
Pag. 140-41
Da questi documenti si può tratteggiare il carattere della cultura alfabetizzata del Sud.
C’è l’evidente importanza in ciascun luogo del rispetto per le consuetudini locali, accoppiato con il regolare ricorso a uomini versati nella legge ed esperti nella sua applicazione.
La forma legale dei documenti nel regno variava naturalmente da una regione culturale all’altra.
Le consuetudini ebbero naturalmente uno sviluppo alquanto diverso nelle aree dove i longobardi vivevano sotto la legge imperiale bizantina e in quelle dove i longobardi governavano direttamente.
In Sicilia, dove i musulmani e greci mantennero le loro consuetudini, il talento dei notari sono nominati di rado.
I documenti latini, comunque, non erano scritti nei progrediti stili calligrafici del continente, e i notari dovettero avere minore importanza nella vita culturale dell’isole.
Pag. 145-46
La posizione della Calabria e della Sicilia sotto la monarchia differiva da quella delle province settentrionali.
In queste due regioni la cultura e gli insediamenti latini erano necessariamente uan novità, innestata forzosamente in società estranee, quindi le influenze nordeuropee vi furono probabilmente più forti.
La conoscenza dell’influenza normanna in tutta la sua ampiezza è stata però pregiudicata dal declino della Calabria dopo la guerra dei Vespri siciliani e dall’abbandono secolare che ha cancellato tanta parte del periodo aureo della storia calabrese, vale a dire i secoli Dodicesimo e Tredicesimo.
Solo in tempi molto recenti gli storici locali hanno cominciato a rimetterla in luce e a mostrare come l’occupazione latina della Calabria segnò una fase importante nell’assimilazione di influenze nordiche, per esempio in architettura, prima dell’erezione dei più celebri monumenti siciliani.
Parecchie grandi cattedrali furono certamente costruite alla vigilia della fondazione della monarchia.
Resti visibili rimangono soltanto di quella di Gerace, a suo tempo una delle più grandi e belle della regione.
Questo gusto per gli edifici grandiosi deriva appunto dal Nord e attraverso la Calabria esso raggiunse la Sicilia.
Ruggero Primo trasse due dei primi vescovi siciliani, Stefano di Mazara e Angerio di Catania, dall’abbazia di Sant’Eufemia, es essi probabilmente progettarono le loro cattedrali nel nuovo stile francese.
Elementi di somiglianza sono stati anche rilevati tra le superstiti cattedrali normanne di Sicilia e d’Inghilterra.
La lunghezza delle navate (per esempio a Palermo), le torri frontali di Cefalù e certi dettagli delle arcate e dei capitelli trovano riscontri in esempi inglesi.
La spiegazione più semplice può essere che queste somiglianze fossero il risultato dell’arrivo di artigiani inglesi nell’isola, ma non a squadre, perché la sopravvivenza di tradizioni edilizie locali indica anche l’impiego di lavoratori locali.
La disponibilità di artigiani provetti nel Regno meridionale era naturalmente molto più ampia di quanto appare dalle opere superstiti, perché gran parte dei loro lavori sono andati inevitabilmente perduti.
Delle seterie palatine di Palermo, soltanto lo splendido manto fatto per Ruggero Secondo nel 1133-34 può essere ancora ammirato a Vienna.
Ci sono anche altri ornamenti d’oro e d’argento e stoviglie smaltate, ispirate dagli stili sia del Limousin sia di Costantinopoli.
La richiesta di artigiani esperti nella lavorazione di materiali preziosi e semipreziosi si sviluppò probabilmente soprattutto nel Dodicesimo Secolo.
L’abate Desiderio di Montecassino aveva dovuto importare da Costantinopoli quasi tutto ciò che gli occorreva per la sua nuova abbazia e quando il regno fu fondato i tentativi di addestrare lavoratori indigeni erano ancora recenti.
Palermo aveva già un buon numero di abili artigiani e i re, se incoraggiavano l’immigrazione di artigiani da fuori, non erano alieni dall’importarli a forza, come quando Ruggero Secondo nel 1147 si impadronì dei setaioli di Tebe in Grecia.
Al rapido rifiorire di arti tanto varie contribuì non poco l’afflusso di talenti da molte nazioni, ma anche gli italiani del Sud furono lesti ad approfittare di queste opportunità.
Il regno insomma non fu una colonia nordica istituita da uomini che imponessero il proprio dominio sopra una popolazione ritenuta primitiva e inferiore.
Ci furono bensì innovazioni normanne, ma esse si innestarono in un organismo vivo e vitale, ricco di originalità e di energia propria.
Pag. 148-49
Cap. 6. L’ordinamento della società
L’impressione di esotismo che gli stranieri ricavavano visitando il regno è stata amplificata da molte descrizioni moderne della realtà meridionale del Dodicesimo Secolo.
Basta un momento di riflessione per rendersi conto di quali difficoltà scaturissero per la società e per il governo dalla riunione di genti di tradizioni tanto diverse in una singola entità politica.
Neanche la creazione della monarchia impose immediatamente l’autorità e i mores di un gruppo governante coeso, come avvenne in Inghilterra.
Lo stesso Ruggero Secondo cercò di attirare al proprio servizio persone capaci appartenenti a culture diverse, non trovando nel regno tutti i talenti necessari.
Durante tutto il Dodicesimo Secolo i re indussero uomini dell’Italia settentrionale, di Spagna, Francia e Inghilterra a entrare al loro servizio; mercanti pisani, genovesi e veneziani stabilirono colonie per promuovere i propri interessi commerciali.
Il gruppo di governo, permeabile esso stesso a nuovi elementi, comprendeva la necessità che tutta la società, a ogni livello, accogliesse immigrati; principalmente, ma forse non del tutto consapevolmente, al fine di rafforzare il predominio dell’elemento latino nell’isola, dove tutti i latini venivano da fuori.
Anche la manodopera era limitata, e si fecero sforzi deliberati per attirare lavoratori e per aumentarne il numero, perfino con deportazioni forzose dalla Grecia e dal Nord Africa.
Perciò alle diversità originarie altre se ne aggiunsero.
Se a lungo andare tutti questi elementi sarebbero stati sommersi dalla marea latina, nel breve periodo le diversità locali si accentuarono anziché livellarsi.
Tutto ciò rende difficile considerare lo stato del regno secondo i semplici criteri adottati nell’analisi delle culture relativamente omogenee dell’Europa occidentale moderna.
A Catania il vescovo Giovanni offrì a tutte e quattro le popolazioni – latini, greci, musulmani ed ebrei – il beneficio delle loro leggi, come se il re dal canto suo non avesse statuito nello stesso senso in materia di personalità del diritto.
Potevano esserci attese in questo senso, ma ciò che accadeva in pratica dipendeva dalle condizioni locali.
Pag. 150-51
Dopo le esperienze avute da Ruggero Secondo con Bari negli anni 1130-40, non fa meraviglia che i re si guardassero dal permettere alle città di mantenere le proprie difese.
Quale e quanta autonomia le città piccole e grandi continuassero ad agognare sotto la monarchia non sappiamo.
Certo non tutte le città erano ostili alla monarchia.
Ad esempio la grande capitale longobarda, Salerno, rimase fedele a Ruggero nel 1137 anche contro Lotario.
Per ricompensarla Ruggero Secondo non offrì concessioni istituzionali bensì finanziarie, quali l’esenzione da tasse sugli scambi (mediaticum) o dal plateaticum per le navi provenienti da altre parti del regno (Calabria, Lucania o Sicilia) e per il pescato locale, e dal dazio sulle misure liquide.
Vietò anche ai funzionari regi di appropriarsi per uso pubblico degli animali dei cittadini.
Le città del regno non avevano probabilmente tutte le stesse aspirazioni, né queste erano sempre rivolte all’autonomia.
Le migliori indicazioni ricavabili in proposito sembrano venire dai termini dei privilegi concessi da re Tancredi a una serie di città tra l’aprile 1190 e il luglio 1193.
Questi diplomi non furono onorati dai suoi successori e possono essere definiti un grave cedimento da parte del re, con la concessione di preziose prerogative in un momento difficile per la monarchia.
Nondimeno le città non imposero o non poterono imporre condizioni di sorta.
Lo splendido diploma originale di Barletta sopravvive ancora come documento che attesta una fedeltà premiata: vale a dire essere annessa in perpetuo al demanio regio.
In particolare i cittadini chiesero il privilegio di non essere citati in giudizio fuori della città senza speciale autorizzazione regia e di avere giudici della propria città.
Fu vietato il duello giudiziario, salvo per accuse di tradimento o per reati punibili con la morte o con la mutilazione.
Una clausola si occupa dettagliatamente della validità dei testamenti fatti da viaggiatori (peregrini), sempre numerosi a Barletta; in particolare nel caso in cui la sola prova del testamento fosse la testimonianza orale del padrone della locanda dove il viaggiatore era morto.
Ai cittadini era consentito il libero pascolo negli acquitrini tra Barletta e Trani, purché questi non risultassero deteriorati.
Pag. 157
Le città siciliane, anche le maggiori come Palermo e Messina, non avevano tradizioni di indipendenza urbana paragonabili a quelle di città continentali come Bari e Napoli e l’eterogeneità della loro popolazione contribuiva certamente a rendere più difficile lo sviluppo di un senso di comunità e identità civica capace di espressione istituzionale.
Messina aveva una popolazione prevalentemente greca ed era già porto fiorente nel Dodicesimo Secolo.
Ibn Giubair parla della sua rada profonda, dove le navi potevano essere attraccate presso le banchine e la considerava certamente la città principale dell’isola, anche se Palermo era più bella e vantava il primato come sede del governo regio.
I messinesi erano gente incline ad agire arditamente per fini propri, ma le loro imprese piratesche li rendevano certo elementi preziosi nelle spedizioni marittime in Nord Africa e in Grecia.
La conquista normanna aveva dato alla città la sua grande occasione, perché Messina era il transito indispensabile per la Calabria.
La maggior parte dei viaggi marittimi dall’isola al continente e viceversa passavano per Messina e la sicurezza offerta dal regno attirava nello stretto il traffico diretto in Oriente di tutti i mercanti settentrionali, come i pisani e i genovesi.
La città vibrava di energia e di audacia e la sua ricchezza la rendeva naturalmente oggetto di ambizioni e cupidigie.
Pag. 159-60
Le fonti ci inducono, dunque, a vedere il regno come un mosaico di comunità distinte, urbane e rurali, preoccupate dei diritti e delle condizioni locali e tutte generalmente orientate a governarsi facendo capo a se stesse anziché a poteri lontani.
Il governante giusto confermava le buone antiche consuetudini locali.
L’innovazione era opera di coloro che abusavano del loro potere attuale per imporre esazioni inconsuete.
Per molte località locali, queste novità – quali l’uso di nuove ordalie nei giudizi o i nuovi tributi finanziari pretesi per i possessi militari – erano associate con i normanni.
Contro queste cattive usanze, la comunità si aspettavano che il re si schierasse dalla loro parte e non esprimesse solidarietà al potere signorile di origine normanna.
Pag. 163
Ruggero Secondo doveva ai grandi l’accettazione della sua signoria; senza di loro, la monarchia non avrebbe significato nulla.
Come esigeva che il principe di Capua riconoscesse la sua sovranità, egli aveva esigenze analoghe riguardo ai conti all’interno del regno.
I singoli conti che dopo il 1130 si si mostrarono sleali furono imprigionati o esiliati, ma le loro contee non furono smembrate.
Esse venivano affidate a nuovi conti appartenenti a famiglie fedeli, come a Conversano dopo il 1133, o a funzionari regi finché i vecchi conti non fossero tornati a fare pace col re.
I diplomi mostrano che i conti di Ruggero Secondo aggiungevano al loro titolo la formula gratia regia, ma significativamente mantenevano anche, al primo posto, la formula tradizionale “per grazia di Dio”.
Il re perciò non faceva che riconoscere l’autorità che ad essi veniva dall’alto.
Non è possibile seguire le fortune di tutti i numerosi conti del regno.
Il poco che sappiamo non giustifica l’idea che ci fosse una politica regia verso i conti in generale.
Il problema, in realtà, era di assicurarsi la fedeltà dei singoli.
Alcuni di essi entravano per matrimonio a far parte della famiglia Altavilla, come in passato, il che doveva contribuire a legare i grandi alla monarchia con vincoli di parentela.
Non si deve vedere, in questo, un piano per assorbire le contee in un unico grande patrimonio regio.
La corona aveva anche un interesse politico a guadagnare dalla sua famiglie potenti e ad allargare la sua base di sostegno.
Essa riconosceva che i conti formavano parte della struttura ordinaria di governo e non cercava di diminuire la loro autorità.
Pag. 165
Dalle notizie disponibili sulle grandi famiglie del regno può sembrare che queste avessero nel governo un ruolo marginale.
Ma gli studi su di esse sono relativamente recenti, e se si lasciano da parte le idee preconcette sul carattere del governo regio, è chiaro che le grandi famiglie avevano considerevoli possibilità di esercitare la loro influenza localmente.
Tuttavia, data la scarsa documentazione, molti quesiti circa il loro ruolo non saranno mai risolti.
In che misura i signori normanni si imparentarono per matrimonio col potere locale?
Presero sotto di sé molto vassalli longobardi, o assorbirono terre longobarde nei propri appannaggi?
Certamente i normanni non erano abbastanza numerosi per soppiantare diritti fondiari più diffusi e gettare le basi, come fecero in Inghilterra, di una legge generale relativa ai possessi militari protetti dai tribunali del re, i quali, col tempo, avrebbero stabilito nuove norme.
Al contrario, le consuetudini giuridiche longobarde sopravvissero e le norme franche che si applicavano principalmente, ma neanche allora esclusivamente, ai possessi militari erano quelle considerate anomale.
Pag. 168
Nel sud longobardo, i normanni avevano acquistato influenza tramite alleanze matrimoniali più di quanto ciò era stato possibile in Inghilterra.
Nondimeno, il loro predominio nei territori longobardi, come in quelli precedentemente greci e musulmani, fu ottenuto grazie allo sviluppo di signorie che diedero il loro controllo politico.
Per loro la monarchia era il logico sbocco dell’ordine che essi avevano introdotto.
La popolazione indigena, che preferiva l’autonomia, non aspirava affatto a creare un ordinamento politico più ampio; ma i normanni, che non avevano nessun particolare radicamento locale, rispettavano il potere di signorie superiori, purché queste sapessero effettivamente dimostrare la loro forza.
Anche se non tutti i normanni se ne resero conto subito, la monarchia poteva anche aiutarli a consolidare la loro presa nel Sud.
Senza di essa, dato che le singole signorie erano limitate nello spazio, i normanni isolati sarebbero stati assorbiti prima o poi nelle culture locali, perché da soli non avrebbero potuto resistere a lungo alle pressioni longobarde e greche.
La monarchia aiutò i “normanni” ad avere una nuova coesione in tutto il regno, quale nuovo ceto dirigente dotato di speciali vantaggi sociali e politici.
Pag. 175
Nell’Inghilterra del Tredicesimo Secolo, una importante distinzione giuridica venne tracciata tra coloro le cui persone e i cui beni erano protetti dai tribunali regi e coloro che non erano liberi, ossia erano soggetti a signoria.
Analogamente, Federico Secondo, nelle sue costituzioni del 1231 (Liber Augustalis, 3., 4), affermò che coloro che erano direttamente sotto la protezione del re (nullo mediante) dovessero essere considerato liberi (liberi censeatur), sebbene nel contesto di questa legge egli tentasse di recuperare dipendenti al demanio regio.
E’ possibile che nel regno di Federico, fin dagli inizi, molti si considerassero abbastanza liberi per appellarsi al re al fine di ottenere giustizia, pur trovandosi sotto signoria: il tribunale regio ereditò le responsabilità di tutti i tribunali pubblici prima attribuite ai predecessori del re mediante i titoli di duca di Puglia, di principe di Capua e di altri ancora.
Lo stesso Federico Secondo consentì appelli ai suoi tribunali da parte di villani sotto signoria, chiamandoli suoi fideles es esaminando le loro lagnanze verso signori che pretendevano tributi e servizi non consuetudinari.
Di fronte alla prospettiva del controllo regio, è probabile che i signori desiderassero definire con maggiore precisione i loro diritti sui dipendenti, in modo che soltanto quelli classificati come “liberi” conservassero la facoltà di invocare la protezione regia.
E’ quindi probabile che la monarchia abbia avuto un ruolo importante nel concentrare l’attenzione sulla natura della libertà giuridica.
La creazione della monarchia lasciò intatti alcuni dei poteri preesistenti tanto dei conti quando di altri soggetti.
Di fatto, la monarchia avallò l’esistenza di signorie dotate di giurisdizione, anche se non c’è modo di stabilire in che misura tali signorie fossero già formate prima del 1130.
Alcuni vescovi e monasteri privilegiati costituivano certamente il tribunale competente per i propri affittuari.
Non ci sono documenti circa i poteri dei vassalli laici all’interno di contee e principati.
Recenti argomentazioni secondo le quali la signoria era nel regno meno comune di quanto si supponeva una volta sembrerebbero indicare, tuttavia, che la maggioranza della popolazione era ancora soggetta alle autorità pubbliche locali almeno per quanto riguarda la giustizia e che la monarchia continuò a provvedere in questo senso.
Al tempo stesso, la corona aveva anche bisogno dell’appoggio dei suoi magnati, ed era in condizione di fare concessioni eccezionali di poteri giurisdizionali a titolo di favore: la sua azione, perciò, poteva subire spinte in direzioni del tutto diverse.
Pag. 175-76
Lo sviluppo della signoria nel Dodicesimo Secolo non si può spiegare interamente in termini di iniziativa signorile o di favori regi.
Tale sviluppo derivò anche dalla tendenza e dalla capacità dei contadini di cercare condizioni migliori per sé, se non altro migrando da un luogo all’altro.
I signori erano in competizione gli uni con gli altri, oltre che con l’autorità pubblica, cioè con il re, al fine di ottenere affittuari che essi potevano controllare soltanto bloccando ogni pretesa pubblica sui loro servizi.
Ciò indica una generale scarsità di contadini nel regno.
In tutte le terre possedute in signoria furono sperimentati vari mezzi per risolvere questo problema.
Alcune chiese furono in grado di ottenere privilegi che erano in contrasto con la consuetudine generale.
Il duca Ruggero di Puglia, per esempio, consentì nel 1110 ai monaci di Cava di rivendicare come servi dell’abbazia tutti i figli dei servi e delle ancillae che si sposavano liberamente.
Non c’era nessun impedimento legale o consuetudinario ai matrimoni misti in quanto tali, e lo scopo del privilegio sarebbe stato vanificato se esso in futuro li avesse di fatto impediti.
Ma il privilegio dimostra che in Campania la consuetudine aveva normalmente considerato liberi i figli dei servi nai matrimoni misti.
L’abbazia di Cava intendeva mantenere in soggezione tutti i discendenti dei suoi affittuari, nonostante la consuetudine locale.
Pag. 183
Al livello più infimo della società meridionale c’erano gli schiavi, che compaiono nei documenti soprattutto come domestici.
Calcolarne il numero non è possibile.
Poiché non era lecito rendere schiavo un cristiano, tutti gli schiavi provenivano da fuori, e una delle fonti principali di reperimento dovevano essere le azioni di pirateria.
Prima della conquista normanna, musulmani ed ebrei avevano posseduto schiavi, probabilmente anche questi in qualità di domestici, e sebbene più tardi fosse loro vietato di avere schiavi cristiani ciò non impediva che essi acquistassero neri o altri infedeli del Nord Africa.
Alcuni schiavi erano forse impiegati negli orti e frutteti intorno a Palermo.
Il re stesso aveva schiavi musulmani, forse acquistati generalmente all’estero anziché fra i musulmani di Sicilia.
Alcuni di essi assursero a posizioni di responsabilità, non solo nella casa del re ma inevitabilmente anche nel governo: per esempio il gaitus Pietro, emancipato soltanto dal testamento di Guglielmo Primo.
Questo pio atto trova riscontro in alcuni documenti privati superstiti, in cui il testatore libera i suoi schiavi personali.
A Bari la cerimonia formale in chiesa dava pubblicità al fatto della manomissione.
In una controversia sulla condizione legale di un uomo, i testimoni dichiararono che sua madre era bulgara e cristiana, il che significava che egli non poteva essere schiavo, poiché era lecito avere soltanto schiavi di origine “slava” o pagana.
Anche se questi schiavi ricevevano il battesimo, ciò apparentemente non bastava ad assicurare la loro libertà; ma è probabile che la manomissione alla morte del proprietario fosse considerata normale.
Una donna lasciò il suo servus a un prete a condizione che dopo cinque anni di servizio, giorno e notte (die et noctu), egli fosse formalmente manomesso (se non era fuggito nel frattempo).
In quanto singoli individui, impiegati come servitori, è probabile che la sorte degli schiavi non fosse in pratica peggiore di quella degli altri domestici.
Una vedova di Amalfi, nel 1090. Estingue un debito di quattro tarì d’oro assegnando sua figlia a due coniugi, perché li serva giorno e notte per tutta la loro vita.
La madre pattuisce che la figlia sia trattata bene e provveduta di cibo, vestiario e scarpe secondo le possibilità dei coniugi; ma nell’eventualità di una fuga, il padrone avrà il diritto di recuperarla, anche se essa sia tornata a casa.
In compenso, alla morte del padrone la ragazza riceverà otto tarì e un corredo per sposarsi.
Di fatto, e non sempre per libera scelta, alcune schiave erano certamente trattate da concubine e generavano figli al padrone.
Alcuni contratti matrimoniali impongono allo sposo di allontanare da casa ogni ancilla, ed è una clausola significativa.
I testamenti provvedono spesso a queste donne e ai loro figli.
Nel 1198 i monaci di Montevergine ricevono un lascito a condizione che essi permettano ai figli naturali che il benefattore ha avuto dalla sua “serva Rocca” di possedere terra per un canone fisso di due tarì all’anno.
Nei testamenti in cui si fa menzione di schiavi, il benefattore dimostra considerazione e cura per chi lo ha servito fedelmente.
Pag. 188-89
Se gli schiavi fossero stti numerosi, li troveremmo menzionati incidentalmente più spesso nei vari materiali disponibili, ritenendo pure che essi non fossero in grado di lasciare documenti propri.
Essere schiavi era una condizione molto miserevole, ma insolita, che derivava da qualche calamità: guerra, crimini o rovina economica.
Nel regno, il presupposto era che gli abitanti fossero liberi.
Pur vivendo secondo le proprie leggi, essi si aspettavano che il re li difendesse dall’oppressione, anche da quella dei loro signori, i vassalli del re.
Pag. 189
Parte terza. La monarchia.
Cap. 7. I re nel proprio regno.
I monarchi europei del Dodicesimo Secolo, salendo al trono, assumevano normalmente una dignità regia già riconosciuta; diverso il caso di Ruggero Secondo, che dovette definire ex novo e imporre il proprio ruolo.
L’idea del re che si propone di foggiare il destino dei suoi sudditi è piaciuta agli storici da quando l’Illuminismo rese attraenti i monarchi innovatori.
E’ tuttavia improbabile che Ruggero Secondo apprezzasse una tale opportunità o si gloriasse dei suoi poteri di innovazione.
All’opposto, egli preferiva mettere in sordina le novità e ottenere rispetto collegando la sua monarchia ad autorevoli precedenti.
Per mettere radici, la nuova corona aveva bisogno di affermarsi disturbando il meno possibile i poteri esistenti; affrontando i nemici dichiarati, ma non suscitandone di nuovi.
Il titolo stesso assunto da Ruggero e dai suoi successori, “Re di Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua”, indicava che le vecchie entità erano state unite dalla monarchia, non cancellate.
Pag. 193
Senza una sequenza di documenti governativi da usare o da cui trarre deduzioni, gli storici devono arrangiarsi con gli atti regi superstiti, conservati per lo più in archivi ecclesiastici (come è normale per tali documenti in tutta l’Europa occidentale).
Soltanto adesso è in via di pubblicazione un’edizione critica di questi acta.
Si stima che sotto Ruggero Secondo almeno tre quarti dei documenti emanati dalla cancelleria reale fossero scritti in greco.
In seguito il loro numero diminuì drasticamente.
Nel 1200 il greco non era più nemmeno in uso come lingua ufficiale della cancelleria.
La maggior parte dei documenti greci conosciuti consistono in concessioni effettuate ai monasteri greci del regno.
Altri se ne conosceranno quando si potrà studiare l’archivio di Messina, trasportato in Spagna nel Diciassettesimo Secolo e recentemente riscoperto a Siviglia.
Una valutazione adeguata dell’importanza nel regno dei fattori connessi alla grecità sarà possibile solo con la pubblicazione in edizione moderna di tutti i documenti pertinenti.
Al momento sono noti soltanto cinquanta testi greci, ma ce ne sono altri trentanove superstiti in traduzioni latine fatte in vari periodi dopo il Dodicesimo Secolo.
Di tutti questi, soltanto sedici sono originali, e da essi occorre ricavare criteri affidabili per accertarne l’autenticità.
Le argomentazioni basate su documenti di provenienza greca vanno perciò trattate con prudenza, certo con una prudenza maggiore di quella dimostrata da alcuni storici.
Pag. 197
Ora, il contesto storico della monarchia era la frammentazione del potere nel Sud e una tradizione culturale mista.
Sebbene documenti ufficiali fossero emanati sia in greco sia in arabo, relativamente parlando la loro importanza andò declinando nel corso del Dodicesimo Secolo, mentre il latino diventava sempre più la lingua principale del governo.
Ciò significa che i re non possono aver modellato deliberatamente il loro governo sugli schemi del governo di Sicilia anteriore al 1127, quando la gente che parlava greco e arabo formava la maggioranza della popolazione.
Non si può stabilire in modo categorico se la posteriore predominanza dell’elemento latino fosse dovuta all’influenza di procedure tratte dalle tradizioni continentali del regno, o all’attività di uomini provenienti da Nord come Roberto di Selby e Riccardo Palmer, o ancora alla ricettività del regno verso le correnti occidentali della pratica cavalleresca.
Ma certo tale predominanza rende meno probabile che il regno derivasse qualcosa più che un beneficio residuale dalla sua eredità greca e araba.
In altre parole, l’ispirazione del suo governo non era greca, ma occidentale.
Se esso mutuò qualcosa da Costantinopoli, fu il nòcciolo romano, non il guscio bizantino.
Pag. 198-99
Norme regie. La legislazione regia può fornire altre indicazioni utili per accettare quale fosse la funzione svolta dal sovrano nella sfera dell’amministrazione della giustizia.
In una norma eccezionalmente estesa, Guglielmo Secondo ricorda quante denunce erano state presentate alla sua persona quando egli era in transito per la Puglia: è ragionevole supporre che, per quanto fosse inusuale, il re in occasioni come queste sanasse ingiustizie e fissasse nuove regole.
Le proteste relative agli abusi in materia di diritto di pascolo perpetrati dagli ufficiali forestali – non solo quelli regi ma anche quelli dipendenti da conti e baroni – giungevano dai proprietari di animali da allevamento, compresi quelli che transitavano da un distretto a un altro, nonché da coloro che possedevano muli e cavalli da soma, tassati per il trasporto dei rami degli alberi adoperati probabilmente per i fuochi da bivacco.
Il re ritenne di risolvere questi problemi attraverso alcuni mutamenti di ordine giuridico, riducendo il numero dei forestali così da limitare il livello delle vessazioni, e stabilendo che i danni causati dagli animali dovevano essere valutati da vicini onesti.
Pag. 217
I re non erano obbligati a investire tutte le loro energie nell’attività di governo vera e propria per poter venire incontro alle aspettative dei sudditi e promuovere un atteggiamento di fiducia nei confronti della corona.
In base ai loro personali interessi, per quello che si può percepire, dovettero essere spinti a fare della stessa curia regia il cuore del regno.
I re davano sicuramente libero sfogo alle proprie inclinazioni culturali ed artistiche, in particolare assecondando il proprio entusiasmo per le costruzioni: chiese, palazzi e padiglioni privati collocati dentro giardini e parchi.
Tale interesse risulta già chiaro in Ruggero Secondo.
Lo stesso Romualdo Salernitano dà notizia dell’edificazione da parte di Ruggero Secondo del palazzo regio a Palermo, uan parte del quale è ancora oggi visibile, e del ritiro della Favara, costruito, quest’ultimo, vicino al mare, nei pressi di un laghetto artificiale destinato a un uso invernale e primaverile.
Dopo avere delimitato con un muro di pietra un grande parco abbellito da una vegetazione preziosa che si sviluppava tra i boschi e le colline fuori Palermo e nel quale veniva cacciato il capriolo e l’orso selvaggio, il re fece costruire un’altra residenza, il “Parco”, situata poco sopra la Conca d’Oro, dotata di una propria riserva d’acqua e destinata alle battute di caccia estive.
A questi luoghi di delizie Guglielmo Primo aggiunse La Zisa, ricca di splendidi giardini con alberi da frutto e canali, per la quale si disse che il re non aveva badato a spese.
Il suo nome deriva da un termine arabo che significa “glorioso”.
Un’iscrizione araba indica che Guglielmo Secondo completò l’opera dopo la morte del padre.
La Cuba, invece, circondata dall’acqua, venen fondata, secondo quanto riporta la sua iscrizione, da Guglielmo Secondo.
Pag. 222-23
I re normanni non mutuarono perciò una simbologia esotica dai loro nemici ma da coloro che erano loro sudditi.
I normanni non avevano importato simboli visibili della regalità e in ogni caso, dal loro punto di vista, il rispetto per la monarchia dipendeva dalla concreta capacità dei sovrani di imporre la loro forza militare e politica.
Invece, per quanto riguarda la maggioranza dei sudditi, interessata solo raramente dal governo del re, vennero compiuti sforzi perché venisse educata a un modello di regalità elaborato, nell’Oriente mediterraneo, dagli imperatori bizantini di Costantinopoli.
Parlare greco offriva a Ruggero accesso alla cultura dell’Impero bizantino, ma è bene non dimenticare che nel Dodicesimo Secolo l’imperatore di Costantinopoli era visto come il sovrano ma dell’Impero romano, il rappresentante vivente di una tradizione culturale mai interrottasi.
I bizantini, nel regno di Ruggero come altrove, calcolavano il tempo non sulla base degli anni di regno dei loro sovrani e neppure a partire dalla incarnazione, ma dall’origine biblica del mondo (5508 prima di Cristo).
Ruggero Secondo pensava a se stesso non come uno che vestiva panni eleganti ma non propri, immaginando piuttosto di rientrare a buon diritto in una tradizione che dopo molti secoli di decadenza, provvidenzialmente conservatasi in Oriente, veniva così restituita all’Occidente.
Pag. 224-25
Le perduranti difficoltà fra il papa e la monarchia, relative soprattutto alla originaria influenza papale nel Mezzogiorno, rendono ancor più significativo che non ci fossero esponenti del clero meridionale che si mostrassero proclivi a schierarsi accanto al papa contro Ruggero Secondo: atteggiamento opposto a quello dei prelati inglesi, i quali, come Anselmo e Becket, invocarono e ottennero l’appoggio del papa quando si opposero ai loro re.
Sebbene non ci fosse una consuetudine di deferenza del clero nei riguardi della monarchia in Italia meridionale, il clero medesimo si mostrò docile ai desideri del sovrano.
Ciò si può forse spiegare col fatto che non c’erano chiese tanto forti per ricchezza e privilegi da potere sfidare la volontà del re.
Più semplicemente esse non coltivavano el ambizioni di autonomia e di prestigio che caratterizzavano alcune chiese settentrionali, capaci per questo di contrapporsi ai sovrani.
Inoltre, sebbene i prelati meridionali in passato fossero entrati in conflitto con i titolari del potere pubblico, in generale i legami con la nobiltà locale e con i principi avevano costituito un fruttuoso sistema di relazioni.
Né d’altra parte essi erano tanto ricchi da accendere gli appetiti dei principi.
Se è vero che la creazione della monarchia determinò in questo senso nuovi problemi, non si può dire però che tutta una storia precedente di tensioni fra Chiesa e poteri laici condizionasse la possibilità di reciproca intesa fra il re e il clero.
Nessuno si aspettava, insomma, che sarebbe sorta tensione fra il papato e la monarchia.
Pag. 226
L’energia di Ruggero nella conduzione della politica ecclesiastica in Sicilia è innegabile, ma in quanto legato del papa il re non poteva ignorare del tutto il punto di vista del pontefice.
Giovanni di Salisbury fa un resoconto dei negoziati intercorsi fra Ruggero ed Eugenio Terzo riferendo come il re confermasse alle chiese del regno il diritto di eleggere liberamente i propri vescovi.
Giovanni aggiunge che gli elettori ecclesiastici giuravano senza eccezione che essi non ricevevano pressioni dal re e che non c’erano indizi di pratiche simoniache: sembrerebbe perciò che davvero Ruggero avesse cura di nominare candidati degni.
Lo stesso Giovanni obiettava però che Ruggero concedeva le chiese come fossero beni personali; aggiungendo d’altra parte che Eugenio doveva a sua volta badare a non accettare favori dai candidati a un ufficio: il papato stesso non sempre agiva in maniera ineccepibile.
Pag. 229
Dal 1130, ovunque in Europa, non c’era solo una storia già lunga di protezione regia dei monasteri; il vecchio ordine benedettino era già stato toccato dall’entusiasmo per il movimento per la riforma, nel quale i cistercensi avevano avuto modo di distinguersi.
Il regno non aveva monasteri impegnati da lungo tempo a considerare la regalità come potere di ispirazione divina finalizzato a proteggere la Chiesa di Dio; così come mancavano, d’altra parte, abati riformatori impazienti di offrire ai sovrani i loro consigli.
Ruggero stesso non aveva molta cognizione dei caratteri del monachesimo tradizionale.
Prima del 1130 l’unico monastero benedettino esistente in Sicilia, e ancora privo di status vescovile, era quello di Lipari, che era stato scelto dalla madre dello stesso Ruggero come sua sepoltura.
L’ipotesi di patronato coltivata da Ruggero consisteva nella realizzazione dell’originale progetto paterno di elevare il monastero al rango di sede vescovile.
Pag. 232
La creazione di Guglielmo Secondo divenne una delle meraviglie della Sicilia.
Tutte le vicende successive alla morte del suo fondatore consentirono che Monreale diventasse in effetti il baricentro religioso della monarchia normanna come Guglielmo Secondo aveva progettato.
Per questa ragione Monreale fu piuttosto il canto del cigno della monarchia degli Altavilla.
Il cugino di Guglielmo, Federico Secondo, non lasciò con la sua presenza un forte segno artistico in Sicilia.
La sua visione fu consapevolmente di tipo imperiale ancora più di quella dei suoi predecessori e fu Roma piuttosto che Costantinopoli a stimolare la sua fantasia.
Tuttavia questo contrasto non va esagerato.
E’ vero infatti che Ruggero Secondo fin dall’inizio favorì l’attività di artigiani ed artisti bizantini che portasse a compimento i suoi progetti; ma la Sicilia non era, come la Serbia o la Russia, una colonia culturale di Costantinopoli.
I mosaici greci si adattavano in Sicilia a decorare costruzioni di impianto stilistico latino e a Monreale uan grande chiesa occidentale incorporò una decorazione di tipo bizantino ma su una scala che per grandezza non aveva precedenti nelle terre dell’Impero orientale.
La monarchia sapeva molto bene ciò che voleva e come raggiungerlo e di sicuro era molto lontana dalla sua prospettiva l’idea di vivere all’ombra di Costantinopoli.
Enfatizzando alcuni elementi esotici gli storici rischiano di minimizzare l’importanza reale dell’impresa normanna nel suo complesso, che riuscì a condurre tutte le terre del Mezzogiorno all’interno dello stesso ordine religioso e politico dell’Europa continentale.
Come parte integrante di questo intreccio di interessi la monarchia fu costretta a venire a patti con il papato quando con l’Impero occidentale e non deve sorprendere che entrambi questi poteri tentassero di attirare il regno all’interno delle loro sfere egemoniche.
Fino al 1189 la monarchia si rivolse al papato e all’Impero con deferenza ma tenendo in qualche modo entrambi a distanza.
I mosaici regi, più di ogni altra opera voluta dai sovrani, mostrano la sicurezza e la consapevolezza di questi ultimi, la loro capacità di impressionare, la loro energia, il loro talento soprattutto nel mettere insieme risorse e capacità al fine di guadagnare rapidamente risultati significativi.
Per quanto diluito potesse essere il sangue normanno che circolava nelle loro vene, essi rimanevano eredi riconoscibili del mondo dei padri.
Pag. 247
Cap. 8. Governo e amministrazione
La coerenza dell’impianto amministrativo del regno normanno venne descritta per la prima volta da Rosario Gregorio nell’età della Rivoluzione francese.
Lo storico siciliano attribuì a Ruggero Secondo la formulazione di una struttura politica che affidava al sovrano la responsabilità unica del benessere generale e dell’ordine pubblico.
Egli esaminò, per respingerla, l’idea che i normanni costruissero la monarchia sulla base di frammenti istituzionali bizantini o musulmani, insistendo invece sulla originalità normanna.
Stabilì anche numerosi punti di comparazione fra Ruggero Secondo e Guglielmo il Conquistatore, che aveva potuto imporre rapidamente un nuovo ordine sulla base della conquista.
Non soddisfatto di accertare che i guerrieri normanni avevano conservato in Italia i propri costumi giuridici, Gregorio ipotizzò anche che Ruggero adottasse consapevolmente alcune delle istituzioni politiche progettate da Guglielmo in Inghilterra.
Una monarchia feudale veniva così presentata nella luce del dispotismo illuminato.
Il testo del Dodicesimo Secolo che aiuta più di altri a capire la formazione interna della monarchia meridionale è il Liber de Regno Siciliae: esso rappresenta un regno nel quale i re contano meno dei loro maggiori ufficiali.
E’ difficile immaginare una più lucida descrizione degli eventi degli anni Sessanta.
Sarebbe più facile valutarlo se riuscissimo a identificare il suo autore.
Nessuno scrittore latino del Dodicesimo Secolo, e forse di tutto il Medioevo, scrive con una tale sicurezza stilistica e con un tale superiore distacco dalle vicende pubbliche, ossia con un impegno tanto coerente a giudicare e a criticare la moralità dei comportamenti politici.
Egli sottopone a critica tutti gli schieramenti, riuscendo però a non fornire la minima indicazione sulla propria provenienza o sulla propria collocazione, così che persino il suo status, se laico o ecclesiastico, rimane incerto.
Dato che, di regola, gli ecclesiastici latini contemporanei lasciano trapelare i pregiudizi legati alla loro condizione, sembra più appropriato concludere che l’autore fu un laico di buona condizione.
Egli dimostra un’appassionata avversione per la “tirannia” come forma di governo, ma ammette, ciò nonostante, l’impossibilità di governare efficacemente senza una calcolata durezza.
Il testo è concepito, tratto inusuale per l’epoca, come un racconto unitario e non è opportuno suddividerlo in parti scandite da date o episodi.
Prende avvio da una giustificazione storiografica derivata da Sallustio e da una fredda valutazione delle grandi qualità di Ruggero Secondo come sovrano prima di affrontare il tema principale, ossia le disgrazie arrecate alla Sicilia dai suoi indegni successori.
Il libro termina senza perorazione o climax, e ciò prova che rimase incompiuto.
E’ impossibile stabilire fino a che punto l’autore avrebbe spinto il racconto se ne avesse avuto la possibilità: in quello che resta appaiono comunque chiaramente centrali due questioni.
La prima è relativa ai piani orditi da Maione di Bari, ministro di Guglielmo Primo, per conquistare la corona.
Piani che vennero resi vani da una congiura lealistica, progettata dentro i circoli aristocratici, che condusse all’assassinio di Maione nel 1160, ma non alla restaurazione della grande tradizione di governo di Ruggero Secondo.
Si passa quindi repentinamente all’altro tema centrale della narrazione: alcuni anni più tardi (1166) la regina reggente Margherita di Navarra affidava le redini del governo a Stefano di Perche, francese e suo cugino, i cui tentativi di riforma dell’organizzazione di governo furono cinicamente contrastati in nome di interessi ben radicati che alla fine ottennero la sua sconfitta (1168).
La raffigurazione degli ambienti di governo del regno come emerge dal Liber difficilmente potrebbe essere più fedele e anche più sconfortante, ed è difficile credere che un autore tanto consumato non abbia raggiunto gli obiettivi che si era prefisso.
Non ci sono episodi irrilevanti e il narratore conduce il lettore da una scena all’altra con la sicurezza di un vero scrittore.
Le qualità letterarie dell’autore emergono anche nei vivaci schizzi dei caratteri personali, nell’aneddotica salace, nei discorsi elaborati che egli fa pronunciare ai suoi personaggi.
E’ imputabile che questi ultimi siano stati scritti molto tempo dopo gli eventi a cui si riferiscono.
L’autore si mostra capace di comprendere come i problemi politici venissero affrontati da uomini differenti per ambizioni, per retroterra e moralità, e di cogliere, ancora, come progetti ammirevoli potessero essere annullati dagli interessi personali dei personaggi preminenti: tutto ciò conferisce alla narrazione un realismo inquietante.
Si sfiora la caricatura nei ritratti di Guglielmo Primo e di Maione, brillanti nel sottolineare l’inadeguatezza del primo e la smodata ambizione dell’altro, ma non si può dire che il tono melodrammatico di questa parte del Liber di fatto deformi oltre misura l’effettiva realtà siciliana.
Anche oggi la spietatezza dei siciliani può apparire bizzarra agli osservatori stranieri.
Il testo dà anche notizia, quando l’occasione lo richiede, di eventi accaduti in Italia continentale o in Nord Africa, anche se in esso l’attenzione è concentrata sulla Sicilia e in particolare sulla corte di Palermo, come l’autore dichiara esplicitamente nell’introduzione, quando afferma di scrivere di ciò che ha osservato personalmente o di ciò che ha appreso da testimoni oculari.
Il Liber de Regno Siciliae dà per acquisiti il diritto e il dovere dei potenti del regno – potenti per lignaggio o per ricchezza – ad avere voce in capitolo nel governo, e critica Guglielmo Primo per la fiducia accordata a un uomo di origine tanto modesta come Maione, descritto, falsamente, come figlio di un mercante barese di olive: Maione avrebbe eliminato uno alla volta gli uomini migliori, che per personalità, per indipendenza e per reputazione avrebbero potuto sfidare la sua supremazia.
Altrove l’autore ribadisce il proprio punto di vista, affermando coem Maione, abbagliato dalla superiorità dei nobili, avrebbe cercato di gratificarsi con la conquista delle loro donne oppure attraverso alleanze matrimoniali che legassero i suoi parenti alle famiglie aristocratiche.
Queste ultime mostrarono un certo senso di solidarietà nel fronteggiare questo parvenu, e d’altra parte le loro fortune erano sicuramente abbastanza solide da resistere alle difficili vicende personali, fra cui, per alcuni conti, anche la cattività.
Le grandi famiglie del regno godevano di una posizione consolidata dal potere signorile che esse esercitavano all’interno del regno, una posizione che gli intrighi di corte a Palermo non potevano mettere in discussione.
A partire dal regno di Guglielmo Primo le famiglie aristocratiche sono in grado di esibire una storia, sostenuta da forza economica e da protagonismo politico, tanto in Sicilia quanto nel Mezzogiorno, che comprende ormai più generazioni.
Certo, gli avvenimenti in Italia meridionale tra il 1127 e il 1140 avevano dato a Ruggero Secondo maggiori opportunità di quante egli ne avesse trovate in Sicilia di sbarazzarsi di coloro che erano troppo indipendenti e id promuovere altri, quelli meglio disposti nei confronti della monarchia: ma questi ultimi non venivano reclutati da strati sociali differenti.
Per questo, se anche i protégés del re a loro volta crearono problemi ciò non fu dovuto all’endemica turbolenza dell’aristocrazia pugliese ma al fatto che il governo di Palermo aveva cercato di affidare il maggiore potere in Italia meridionale ai soggetti di condizione più eminente: a quelli cioè che erano in grado di esigere obbedienza.
D’altra parte, i nobili puntavano a essere garantiti nel possesso delle cariche regie, o almeno a essere confermati nelle loro posizioni di potere in Italia: per l’alta aristocrazia radicata nel mezzogiorno la sicurezza di esercitare i poteri signorili per diritto naturale faceva sì che gli uffici di curia e la vita di corte a Palermo le apparissero meno appetibili.
Di conseguenza essi abbandonavano la politica di palazzo agli ufficiali palermitani.
Eppure, Il Liber de Regno Siciliae rivale che la nobiltà lamentava il fatto che i grandi ufficiali, Maione e Stefano di Perche, tenessero sotto controllo i sovrani.
Pag. 248-251
L’unico ufficio del governo centrale ricostruito dagli storici con qualche sicurezza è il cosiddetto diwan, un termine di origine araba.
Latinizzata come dohana o duana, la parola serviva a denominare pratiche amministrative che corrisponderebbero oggi a momenti diversi dell’attività di governo e in particolare dell’organizzazione tributaria.
Le funzioni del diwan nel Dodicesimo Secolo sono scarsamente documentate.
Ci sono più notizie tratte dai documenti in greco che da quelli in arabo, ma non esiste una serie di atti d’ufficio comparabili ad esempio con i Pipe Rolls dello Scacchiere inglese.
Da alcuni indizi ricaviamo che il diwan doveva compilare e conservare documenti di diversa natura: informazioni e descrizioni relative ai confini delle terre, liste di servi del re e ancora registri dei conti.
Non abbiamo però nessuna informazione circa l’esistenza di regolari revisioni annuali come quelle effettuate sui conti degli sceriffi inglesi.
Il significato di una struttura di governo competente destinata all’amministrazione delle terre e dei redditi della corona non ha bisogno di essere sottolineato, ma è ancora davvero problematico scrivere qualcosa di convincente su come questa struttura operasse nel Dodicesimo Secolo.
Pag. 265-66
L’attività del diwan in questo periodo sembra concentrarsi sulla gestione del patrimonio fondiario della corona piuttosto che sull’amministrazione generale delle finanze regie, cioè sul controllo, sulla riscossione e sulla verifica delle imposte.
Naturalmente se l’ufficio vendeva o affittava beni appartenenti al patrimonio regio, il denaro che veniva ricavato e debitamente registrato negli appositi libri contabili veniva incamerato con ogni probabilità nel tesoro regio.
Riccardo è indicato come tesoriere nel 1169 e forse assunse l’incarico di questo ufficio in quanto magister palatinus camerarius.
In quel momento non c’erano ufficiali che portassero il titolo di emiro degli emiri e può essere che a Riccardo fosse stata assegnata una generale supervisione dell’attività del diwan.
Per quanto riguarda altri possibili uffici in attività, come la zecca o la dogana, non disponiamo di conoscenze particolari.
In conclusione dunque l’amministrazione del diwan riguardava specificamente il patrimonio regio e sembra certo che esso fu istituito a questo scopo: proprio per questo non è corretto giudicarlo un equivalente di uffici come quelli del tesoriere o dello scacchiere del regno normanno d’Inghilterra.
Pag. 272
In verità le congetture sono piuttosto oziose, a meno che non richiamino l’attenzione sui problemi reali che hanno bisogno di essere affrontati.
Di sicuro però le informazioni suggestive e stimolanti come quelle di cui disponiamo consentono di escludere l’esistenza di un sistema amministrativo organico e coerente introdotto fin dall’inizio con obiettivi ben definiti.
Anche dopo cinquant’anni dalla nascita della monarchia c’era spazio per l’improvvisazione, per i mutamenti nelle pratiche amministrative e per l’interazione di strutture separate.
Pag. 277
Seguendo gli scrittori precedenti Edrisi divise le parti del globo abitate dagli uomini, a seconda delle latitudini, in cinque “climi”, ciascuno dei quali diviso a sua volta in dieci sezioni descritte procedendo da Ovest a Est.
Effetto di questo metodo era che i domini di Ruggero non erano descritti unitariamente: ad esempio la parte relativa alla Calabria è separata da quella della vicina Puglia, non solo dalle ricche informazioni delle terre che vanno dalla Grecia alla Cina, cioè quelle che comprendono la gran parte del clima quattro, ma anche dalle prime sezioni del clima cinque, che si collocano fra la Bretagna e la Toscana.
Né Edrisi né Ruggero avvertirono la necessità di riunire insieme le descrizioni relative alle terre sottoposte alla monarchia, modificando in questo modo gli schemi intellettuali dei geografi; solo, le mappe che rappresentavano i domini di Ruggero vennero disegnate su una scala un po’ più grande.
E’ significativo allora che questa geografia tendesse a rafforzare l’idea che la Calabria e la Sicilia appartenessero insieme a uno spazio specifico, distinto dal resto del regno.
Pag. 278
La scarsissima attenzione prestata alla geografia amministrativa del regno costituisce una marcata differenza rispetto al Domesday Book.
Edrisi si limita a dire qualcosa su un’unica frontiera, quella che divide i franchi dai longobardi, o la Calabria dalla regione tarantina.
Riguardo alla Sicilia non viene neanche menzionata l’antica divisione dell’isola, proprio di origine musulmana per altro, in tre regioni: Val Demone, Val di Noto e Val di Mazara.
Secondo l’autore invece la Sicilia era divisa dal punti di vista amministrativo in ben centotrenta distretti, diversissimi l’uno dall’altro per caratteri, dimensioni, densità di popolazione; sebbene, non tutti, in realtà, ricevessero uan descrizione puntuale.
Dopo aver definito questi distretti come unità amministrative comparabili e di antica formazione, Edrisi non aggiunge altro e non dà informazioni rilevanti sulle implicazioni di questa geografia appena abbozzata: nulla, ad esempio, sui confini amministrativi più ovvi, come quelli delle diocesi.
A questo proposito, almeno alcuni di questi confini erano già stati definiti al tempo di Ruggero Primo, ma probabilmente Edrisi fa ancora uso delle vecchie ripartizioni distrettuali.
Egli aveva raggiunto la piena padronanza dell’isola, ma non si deve ritenere che potesse per questo ridisegnare la geografia amministrativa.
Pag. 279
Nel Tredicesimo Secolo la Sicilia era divisa, a scopo amministrativo, in due zone dal fiume Salso.
Questo confine deve avere avuto qualche importanza già in età musulmana, poiché esso contribuiva a formare la linea di separazione tra le diocesi di Agrigento e il distretto di Castrogiovanni nell’anno 1092.
Alla metà del Duecento Federico Secondo rimproverò i suoi ufficiali siciliani perché essi mantenevano ancora il fiume Salso come vera e propria frontiera che separava due distinte regioni.
Da questo deduciamo che quel confine doveva assolvere a una funzione precisa in età normanna, separando due regioni per molti aspetti diverse.
Gran parte della Sicilia occidentale, a predominanza musulmana, doveva essere ancora governata all’inizio del Dodicesimo Secolo da capi indigeni leali nel confronti di Ruggero Secondo; questi esercitavano il loro potere all’interno dei distretti tradizionali descritti nell’opera di Edrisi.
I bizantini del val Demone dovevano anch’essi essere organizzati sulla base di una qualche forma di autogoverno dei villaggi nei quali abitavano.
Ma di fronte alla debolezza o alla assenza di una forte tradizione di notabilato bizantino, i normanni ebbero presumibilmente più opportunità in questa parte dell’isola che non in quella a predominanza musulmana di selezionare essi stessi gli ufficiali locali.
Alcuni di questi ultimi vengono definiti nelle fonti come stratigoti, vale a dire uomini di governo o comandanti militari, che potevano avere anche responsabilità relative alla milizia locale, di cui in verità sappiamo molto poco.
Troviamo ufficiali di questo tipo in molte importanti località, come Agrigento, Catania, Lipari e Noto.
Altri ancora dei distretti di Edrisi sarebbero stati direttamente assoggettati ai nuovi potenti arrivati nell’isola al seguito dei normanni, vale a dire i conti e i titolari di signorie ecclesiastiche.
La complessità di questo quadro finisce per ridurre il ruolo protagonistico di Ruggero Secondo nel processo di costruzione di una struttura di governo nell’isola.
Guardiamo adesso alla parte settentrionale del regno, dove le specifiche caratteristiche di ciascuna regione sono ben note e le distinzioni fra di esse sono ancora ben riconoscibili al tempo di Federico Secondo, quando i giustizieri amministravano province che un tempo erano state indipendenti.
Tracciamo rapidamente le linee essenziali di questa geografia.
Il Principato e la cosiddetta “terra beneventana” comprendevano le terre dei principi di Salerno e di Benevento, all’incirca le stesse che furono dominate da Roberto il Guiscardo e da suo figlio, il duca Ruggero.
La Capitanata era la nuova provincia bizantina, occupata dopo il 1042 da diversi avventurieri normanni.
La Basilicata invece era la regione nella quale erano state costituite alcune contee normanne in un territorio precedentemente bizantino e nel quale Boemondo aveva costituito il suo principato di Taranto.
La “terra di Bari” era il dominio del principe Grimoaldo dopo il 1118, mentre la “terra d’Otranto” costituiva la zona del profondo Sud-Est più intensamente bizantinizzata, anche dal punto di vista linguistico.
La geografia politica del Mezzogiorno non subì un congelamento che mantenesse inalterata la situazione precedente al 1130, ma i mutamenti dovevano essere compatibili, in regime monarchico, con le complesse realtà degli insediamenti e delle strutture politiche locali.
Così, ad esempio, gli Abruzzi mutarono la loro fisionomia dopo la morte dell’erede di Ruggero Secondo, duca Ruggero, nel 1140, allorché il conte di Manoppello assunse i poteri speciali in quell’area per difendere un territorio da poco conquistato contro le mire espansive dell’imperatore tedesco.
Pag. 280-81
Questo testo tuttavia è stato ora acquisito al servizio degli storici, ed Eveline Jamison, sulla base di esso, ha potuto congetturare che Ruggero Secondo aveva creato un sistema di governo locale nuovo e generale consistente in una rete di distretti chiamati comestabulie, nei quali un connestabile svolgeva funzioni tanto militari quanto giurisdizionali.
Nella sua edizione del Catalogus la studiosa provvede a fornire una mappa con i confini di questi distretti.
Il termine comestabulia ricorre però solo dieci volte nell’intero Catalogus.
L’indagine sulle obbligazioni di carattere militare dovette sicuramente procedere in modo molto ordinato da una regione all’altra, rispettando una geografia amministrativa che in larga misura doveva essere molto più antica della monarchia.
L’indagine comincia da Sud-Est, prendendo in considerazione le terre dell’antica provincia bizantina di Longobardia; segue la provincia ecclesiastica di Benevento la cui configurazione era ancora quella degli inizi dell’Undicesimo Secolo; quindi il principato di Salerno con la stessa fisionomia del tempo in cui venne conquistato da Roberto il Guiscardo (cioè nel 1076); le terre della nuova contea del Molise addossata al ducato di Puglia e al principato di Capua e quello che restava dello stesso principato di Capua e infine le terre dislocate a Nord dove il conte Beomondo di Manoppello dominava un’intera regione, quella che più tardi sarà chiamata Abruzzo.
I segni lasciati dall’antica organizzazione territoriale, ma anche su di essa così come sulla contea del Molise, le tracce degli antichi confini amministrativi e delle antiche giurisdizioni non vengono cancellate del tutto.
In quanto principe di Capua, solo di recente, negli anni quaranta del Dodicesimo Secolo, Anfuso, figlio di Ruggero Secondo, aveva tentato di reimporre la sua autorità sulle regioni settentrionali, così che non era possibile trascurare il peso dei diritti che risalivano indietro, fin dentro l’Undicesimo Secolo.
Pag. 282-83
Gli altri riferimenti alla sfera della connestabilia sono ancora più oscuri.
Laddove essi sono più frequenti, come nell’area di Benevento e di Salerno, risulta difficile distinguere i confini dei distretti.
In un caso specifico, l’autorità assegnata a Guglielmo Scalfo (che succedeva a Ruggero Bursel) sembra anche qui essere quella del comandante dei titolari dei feudi della contea di Loritello.
Un altro caso è quello di Guimondo de Montellari, conosciuto da altre fonti per essere stato un giustiziere regio, sicché la sua connestabilia potrebbe implicare un’autorità di carattere militare all’interno dello stesso distretto.
Altri riferimenti, relativi al principato di Salerno, riguardano Lampo de Fasanella e Gilberto de Balvano.
Il primo, di nobile famiglia longobarda, era stato un vassallo fedele dei conti normanni di Principato; sebbene egli avesse servito la corona come giustiziere a Salerno, si unì alla ribellione del conte Guglielmo Terzo di Principato nel 1155 e di conseguenza perse le terre e gli uffici.
La connestabilia di cui Lampo appare titolare nel Catalogus corrisponde di fatto geograficamente al giustiziariato che egli esercita in nome del re sui territori dell’antico principato di Salerno.
Pag. 284
La sfera della comestabulia non esiste fuori dalle pagine del Catalogus e non lascia tracce neppure sulla più tarda geografia amministrativa del regno.
Al tempo di Federico Secondo infatti il regno risulterà diviso, anche per gli obiettivi di carattere militare, in giustizierati che per estensione e per nome riflettono ancora la situazione premonarchica.
Evidentemente i re normanni non ebbero la possibilità di ridisegnare i confini delle circoscrizioni locali.
D’altra parte è sicuramente improbabile che i re abbiano mai concepito schemi del tutto nuovi di governo periferico: essi operavano all’interno di una mappa territoriale stabilita durante i regimi precedenti la fondazione della monarchia.
Sul lungo periodo, a poco a poco, i nuovi ufficiali regi avrebbero cessato di comportarsi come i capi locali da essi rimpiazzati, ma ci sarebbe voluto molto tempo per spegnere la memoria delle vecchie divisioni amministrative.
I contemporanei avevano un ricordo delle vicende recenti relative alle regioni da essi abitate più lungo di quanto gli storici non ammettano.
Un solo esempio.
Nel 1194 il nuovo arcivescovo di Bari cercava di far rispettare il suo diritto a un reddito che proveniva da una donazione che risaliva ai tempi del principe Grimoaldo.
Alla rivendicazione dell’arcivescovo si opponevano i notabili della città, ma è singolare che, a fini opposti, entrambe le parti si richiamassero con forza alle consuetudini della loro città piuttosto che alle norme di tutto il regno, anche sessant’anni dopo la nascita della monarchia.
Ci capita di dimenticare insomma che l’attività di governo nel Dodicesimo Secolo si svolgeva soprattutto a livello locale e ce ne dimentichiamo perché è proprio rispetto alla conoscenza di questo livello che gli storici di solito dispongono di informazioni imperfette e molto spesso del tutto casuali.
Pag. 285-86
Nel 1130 Ruggero era il maggiore signore fondiario del regno.
E un secolo più tardi, attraverso confische e acquisizioni, il patrimonio personale del re risultava ancora più grande.
Naturalmente il sovrano considerava l’amministrazione delle sue terre da una prospettiva squisitamente signorile, mirando dunque a riscuoterei suoi diritti e tributi dai vari affittuari, coloni o piccoli clienti sottoposti al suo dominio.
Incoronato re, Ruggero non pensò subito di imporre nuove obbligazioni dovute alla monarchia e non mirò affatto a concentrare nelle sue mani il diritto a pagare i tributi tradizionali ai propri signori.
Poiché la tassazione regia è essa stessa di origine signorile riesce difficile distinguere i tributi che erano dovuti a Ruggero in quanto signore fondiario da quelli che egli riscuoteva come sovrano o titolare della corona.
Pag. 288
Rimane da considerare una fonte importante di entrata: l’emissione di moneta d’oro o d’argento.
Era antica nel Mezzogiorno, precedente alla fondazione della monarchia, la tradizione di coniare monete d’oro, la cui area di circolazione era costituita dai mercati del Nord Africa e da quelli bizantini.
I capi della Sicilia musulmana, a differenza di quelli del Nord Africa, emettevano monete non corrispondenti a un dinar ma solo a un quarto di dinar (chiamato in arabo ruba’i); e ciò sembra indicare una relativa arretratezza dell’isola sotto il dominio arabo.
In Italia meridionale però queste monete siciliane erano ben diffuse ed erano conosciute come tarì, un termine di probabile derivazione araba che doveva significare “coniate da poco”.
Dalla metà del Decimo Secolo anche i principi di Salerno cominciarono a battere monete chiamate tarì a imitazione di quelle siciliane e monete simili vennero battute anche ad Amalfi probabilmente prima della fine dello stesso Decimo Secolo.
Quando i normanni conquistarono Palermo e Salerno essi continuarono a battere monete di questo tipo, mantenendo le iscrizioni in caratteri cufici, in modo da soddisfare le richieste che venivano dal tipo di mercato cui esse erano destinate.
L’unificazione politica del Mezzogiorno realizzata da Ruggero Secondo conferì a quest’ultimo un reale monopolio di fatto della coniazione delle principali monete del regno.
Egli era l’unico sovrano cristiano d’Occidente che coniava monete d’oro.
Il suo tarì era battuto con un oro a sedici carati e un terzo, in una lega di argento e di rame, e la monarchia mantenne un alto standard di emissione, effettuata formalmente in suo nome attraverso il marchio regio impresso sulle monete.
Queste vennero battute a Palermo fino al 1194 e una nuova zecca installata a Messina si mantenne in attività fino alla morte di Manfredi.
In Italia meridionale la zecca principale rimase quella di Salerno fino a che non venne trasferita a Brindisi alla fine del Dodicesimo Secolo.
Pag. 295
In circostanze del tutto differenti Federico Secondo si propone nel 1241 di raccogliere per mezzo della tassazione quasi due milioni di tarì, cifra che raddoppia nel 1248.
Solo al tempo del suo regno ci sono prove sufficienti per l’individuazione di un sistema di finanza regia, ma perfino Federico, che non aveva ereditato un sistema finanziario centralizzato, non può essere ricordato per averne creato uno.
Anche se nulla fa credere che i normanni avessero a loro disposizione un sistema comparabile a quello di Federico: Ruggero Secondo e i suoi figli subentrarono nella direzione degli uffici appartenenti agli ordinamenti preesistenti in Italia meridionale.
Poterono essere sostituiti gli individui ma ciò non significò il superamento del sistema nel suo complesso.
Pag. 297
Ciò nonostante è significativo che quando venne riconosciuta al re la suprema autorità giurisdizionale nel regno, i crimini più gravi cominciassero a essere descritti come oggetto della giustizia regia.
In un documento del 1153, esaminato dal conte del Molise, è contenuta una lista di fattispecie riservate alla giustizia regia: omicidio, incendio, ratto, violazione del domicilio, violenza e rapina, furto di animali da lavoro (latrocinia), furto di beni del valore superiore a un’onza d’oro (furtum) e il taglio degli alberi da frutto e delle vigne.
In apparenza però tutti questi delitti venivano giudicati dal conte nel proprio tribunale.
Sebbene nulla sia precisato intorno alla lesa maestà, per molte specie di giudizio, se non per tutte, i conti agivano come giustizieri del re nei propri distretti.
Solo laddove non c’erano conti che assicurassero la giustizia il re doveva nominare ufficiali speciali che operassero in suo nome.
E i conti stessi venivano, a quanto pare, giudicati da loro pari nella curia regia in Sicilia, ammesso che l’unico resoconto dettagliato di giudizi di questo tipo fornito dal Liber de Regno Siciliae possa essere giudicato tipico.
Pag. 306
In sostanza, nonostante la cura con cui i giudici regi avevano definito i termini dell’accordo, si temeva che potessero ricorrere nuovi conflitti fra i vassalli o fra i loro signori.
E in questi casi entrambe le parti si mostrarono concordi nel non ricorrere nuovamente al re ma nel dominare invece un arbitro.
Ciò che vale la pena di sottolineare in questa vicenda è dunque l’orientamento degli attori a non considerare indispensabile il ricorso all’autorità giurisdizionale della corona e a cercare uan soluzione locale alla controversia.
Limitazioni effettive al potere della corona di imporre decisioni non appellabili sono dunque apertamente dichiarate.
Dopo circa sessant’anni la monarchia si muoveva ancora entro i confini di una società del tutto tradizionale.
Pag. 313
Cap. 9. La difesa del regno e i suoi nemici
Per molte buone ragioni, la guerra era una condizione endemica in molte realtà dell’Occidente medievale europeo.
I sovrani erano, invariabilmente, soldati essi stessi e i loro domini erano abitati da élite costituite da uomini di guerra, le cui file includevano senza imbarazzo anche il clero.
Regni e principati non avevano frontiere stabili e sebbene la difesa si concentrasse attorno ai castelli di confine, anche all’interno del territorio c’erano importanti fortificazioni nelle città e nei luoghi di controllo strategico che potevano divenire centri di manovra militare.
I sovrani non limitavano però i loro obiettivi militari alla difesa.
Essi potevano prevenire l’offensiva nemica non solo con le minacce ma anche attraverso raid improvvisi, adducendo qualche motivo plausibile che giustificasse l’annessione di un territorio confinante: potevano muovere guerra anche quando i vicini non destavano vere preoccupazioni, per impegnare i baroni in una felice campagna di conquista evitando che combattessero per proprio conto.
Quei baroni che non erano guidati in battaglia da signori vittoriosi non erano disposti infatti a un’umile sottomissione; solo una marziale superiorità procurava ammirazione incondizionata e generava rispetto nei confronti di chi governava.
E’ vero che le guerre vittoriose si ripagavano in termini di conquiste e bottino, ma le grandi imprese avevano bisogno di essere pianificate su una scala straordinariamente grande.
Ciò era costoso, e solo i sovrani che disponevano di risorse considerevoli e di una solida base finanziaria potevano competere.
I sovrani mostravano nel contempo abilità nel ricavare efficacemente al di là delle entrate ordinarie e capacità nell’escogitare nuovi motivi per imporre tasse ai propri soggetti.
L’attività militare giocava certo un ruolo importante nei progetti dei potenti, per ragioni che tuttavia sfuggono alla nostra piena comprensione.
A parte la scarsa simpatia nei confronti delle loro predominanti inclinazioni alla guerra, noi siamo anche assai condizionati dal fatto che le informazioni provengano o da scrittori ecclesiastici che apprezzavano poco l’attività militare o da poeti che di quest’ultima illustravano, più che la realtà effettiva, gli aspetti eroici e romantici.
Pag. 314-15
I problemi militari del regno meridionale erano per molti riguardi diversi da quelli degli altri regni dell’Europa occidentale.
In particolare, il regno possedeva l’inusuale caratteristica di avere un territorio chiaramente delimitato fin dal 1156; esso dunque non fu costretto all’espansione territoriale o a tentare di sottomettere vicini turbolenti.
Inoltre la frontiera che tagliava l’Italia aveva uno sviluppo brevissimo: solo la metà circa della lunghezza dell’intero confine del ducato di Normandia.
Attraversandola si entrava in un territorio accidentato, che risultava perciò facilmente difendibile dai suoi abitanti contro invasori che non ne conoscessero la conformazione.
Il problema principale per il governo non era tanto militare quanto politico: assicurarsi la lealtà dei signori locali.
Oltre le frontiere i nemici potenziali erano ora il papato, ora l’imperatore tedesco.
Dopo il 1156 il papato non fu più in grado di sostenere il vecchio atteggiamento di ostilità e divenne esso stesso timoroso nei confronti di Federico Barbarossa.
Da parte sua, Barbarossa non aveva speranze di raggiungere il regno finché il papato avesse avuto relazioni con esso.
La presenza di una forza di invasione avrebbe messo a rumore il Sud nel caso tanto di un’avanzata lungo il versante adriatico quanto di una penetrazione attraverso il territorio papale.
Era impossibile che il regno potesse essere sorpreso dai suoi nemici.
In ogni caso poiché questi non puntavano a fini di espansione territoriale, essenso mossi piuttosto dall’obiettivo di rovesciare la monarchia, sarebbero stati obbligati a penetrare in profondità all’interno del regno, dove sarebbero risultati molto più vulnerabili.
Il regno era perciò facilmente difendibile.
Per quanto riguarda la sfera sua propria di iniziativa militare, il re era soprattutto interessato agli scontri navali contro greci e musulmani e per questo doveva interessarsi di più a mantenere alto il morale dei marinai che a tener conto della volontà del baronaggio.
A differenza degli altri rigni sorti nel Dodicesimo Secolo in Terrasanta, quello siciliano non doveva convivere con uan continua emergenza militare e questo influì sulla sua prospettiva politica.
Guglielmo Primo, che aveva una fondata reputazione di soldato, rinunciò alle campagne militari, mentre Guglielmo Secondo, sebbene avesse promosso con successo alcune spedizioni navali, non si impegnò mai direttamente in una guerra.
Non aveva neppure guardie di palazzo da tenere occupate.
Pag. 315-16
I cronisti coevi raramente provarono a nascondere i loro sentimenti verso i sovrani e gli effetti dell’azione di governo di questi ultimi sulle popolazioni del Mezzogiorno; in ogni caso, per quanto parziali e casuali appaiano le considerazioni di questa natura, gli storici non possono evitare di tenerne conto nelle loro ricostruzioni.
Le questioni di politica estera, in quanto chiaramente distinte da quelle di politica interna, raramente sollecitavano un interesse comparabile nei cronisti: pochi fra questi avevano una concezione precisa della natura dei conflitti fra i popoli o fra i regni.
Non si era ancora delineata un’analisi seria dei problemi di politica estera e si può dubitare che i sovrani stessi abbiano mai avuto una precisa cognizione di quelli che potevano essere riconosciuti come i tratti salienti di quella dimensione.
Le crociate, che costituirono un nuovo tentativo di unire la cristianità contro i musulmani, riuscirono solo parzialmente a determinare una simile consapevolezza e non emerse uno sforzo comparabile di promozione di solidarietà nazionali.
Il clero anteponeva naturalmente gli interessi della Chiesa rispetto a quelli delle monarchie; l’aristocrazia laica dal canto suo obbediva a un codice che enfatizzava la fedeltà alla parentela e alle alleanze piuttosto che la subordinazione incondizionata ai sovrani.
I nobili credevano certamente che, nella misura in cui la loro preminenza aveva un indiscutibile fondamento giuridico, essi erano abilitati a interpretare autonomamente i propri doveri nei confronti dei re e dei signori superiori e non si sentivano obbligati a piegarsi alla volontà del sovrano o dei suoi rappresentanti.
I nobili avevano dunque intimità col potere e con il suo esercizio, la loro superiorità non era affatto una mera dignità formale.
Se entravano in conflitto con i loro superiori e venivano costretti all’esilio essi provavano in genere a recuperare le posizioni perdute cercando il sostegno dei sovrani più vicini.
Essi potevano essere accusati di tradimento dai loro signori legittimi, ma i nuovi protettori si sentivano impegnati nel fornire aiuto ai fuggiaschi e nel fomentare intrighi che potessero se non garantire vantaggi concreti almeno creare qualche fastidio ai loro avversari.
Tali attività si avvalevano necessariamente delle opportunità che potevano presentarsi.
Si trattava di allargare il raggio di eventuali tumulti locali, che non fossero determinati da fattori che costituivano la sostanza della politica estera: la geografia o l’impiego di risorse materiali, i uomini e in denaro.
Pag. 324-25
L’impero bizantino. Qualunque sfida lanciata al regno da parte dell’Impero orientale dopo il 1159 può apparire illusoria; ma non ci si può aspettare che i contemporanei cogliessero che la vicenda dell’Impero fosse giunta al suo compimento.
La brillante dinastia dei Comneni che aveva salvato l’Impero dopo il 1080, in un certo qual modo non riuscì a risolvere tutti i suoi maggiori problemi.
Dopo la morte di Manuele nel 1180 ciò risultò del tutto evidente giacché le incertezze relative alla successione e la violenza diffusa nella società mostravano la debolezza dell’Impero.
Questa situazione aprì la strada all’occupazione e alla divisione effettuata dall’esercito crociato nel 1204, che distrusse per sempre la forza effettiva dell’Impero.
I normanni e il re di Sicilia in particolare avevano contribuito all’indebolimento dell’Impero: il regno dunque, in altre circostanze, avrebbe certamente approfittato dell’ultimo assalto occidentale e della spartizione del 1204 per acquisire territori nei Balcani, così come aveva fatto Roberto il Guiscardo, allorquando la dinastia macedone era entrata in crisi nell’Undicesimo Secolo.
Per ragioni del tutto fortuite il regno siciliano nel 1204 non si trovava in una situazione tale da poter trarre vantaggio dalle difficoltà bizantine.
In questo si dimostrò assai sfortunato; perché, bene o male, il destino dell’Impero orientale aveva conseguenze per il regno.
La scomparsa dell’Impero bizantino come protagonista della lotta politica in Italia determinò dunque una situazione del tutto nuova nella penisola e quasi subito l’Impero tedesco [ma si può usare questo aggettivo per questo periodo?] e il papato poterono entrare in competizione senza temere complicazioni derivanti dalla presenza bizantina.
Gli eventi che so consumarono in Oriente, sul cui sviluppo l’Occidente aveva scarse possibilità dirette, dell’Occidente stesso contribuirono però a trasformare l’equilibrio.
Nessuna valutazione da parte del Regno siciliano circa i propri plausibili interessi in Oriente poteva sottostimare, nel Dodicesimo Secolo, l’importanza dell’Impero.
Anche se afflitto da una condizione di crisi latente l’Impero orientale continuava a esprimere, alla metà del Dodicesimo Secolo, piena vitalità.
Sebbene dopo la disfatta di Manuele in Italia l’Impero concentrasse la sua presenza nei Balcani ein Anatolia, ciò produsse in Occidente piuttosto sollievo che non nuove aspettative di possibili vantaggi determinati dalla debolezza dell’Impero stesso.
Manuele appariva in qualche modo vicino allo spirito occidentale, circostanza che per un verso colpì positivamente i sovrani europei, per un altro turbò molti dei sudditi dell’imperatore.
Fu proprio la reazione antioccidentale che si scatenò nell’Impero dopo la sua morte che offrì alle potenze cattoliche il pretesto e la giustificazione per un intervento in Oriente.
Questa reazione antioccidentale mostra quanto fossero profondamente radicate le tradizioni bizantine.
Il biografo nonché ammiratore di Manuele, Giovanni Cinnamo, che trovava imbarazzanti alcuni aspetti dell’entusiasmo personale di Manuele, enfatizzò senza titubanza il tradizionale ruolo dell’imperatore come intellettuale difensore dell’ortodossia.
Cinnamo dava per scontata la consapevolezza in Manuele del ruolo storico dell’imperatore in Italia, una consapevolezza che i bizantini colti traevano dalla lettura di Procopio.
Questo senso della storia conferiva ai bizantini la capacità di comprendere i rapporti esistenti tra poteri diversi e una prospettiva della geografia storica che era sconosciuta in Occidente.
Pag. 326-37
Salendo al trono nel 1154 Guglielmo Primo aveva apparentemente più motivi per temere come imminente un’invasione da parte del sovrano tedesco che non da parte dell’imperatore bizantino.
Egli realizzò un notevole sforzo diplomatico per staccare tanto i papato quando l’imperatore orientale da Federico, e, possibilmente, per concludere un’alleanza con il re di Ungheria.
Cinnamo ci dice che Guglielmo offrì in cambio ai bizantini il bottino razziato nel 1147, quali che fossero esattamente le proposte.
Manuele respinse il negoziato e preparò una flotta e un esercito per l’invasione dell’Italia.
La posizione di Guglielmo sembrava veramente vacillante e Manuele non poteva fermarsi e aspettare le mosse del Barbarossa.
L’imperatore bizantino inviò lo zio, Costantino Angelo, a capo di una parte della forza militare, con l’ordine di attendere il resto delle truppe nella Grecia meridionale.
Costantino però, avvertito della presenza di una flotta siciliana che faceva ritorno carica di bottino dell’Egitto, decise di intercettare il nemico.
Una mossa audace ma avventata: i bizantini vennero dispersi e Costantino venne catturato.
Ma l’occasione di punire l’insolente re di Sicilia non poté giungere prima dell’anno seguente.
Pag. 332
Egli contrapponeva le speranze attribuite a Guglielmo Secondo di poter proseguire la guerra santa contro i musulmani a quella dei sovrani che avevano realizzato accordi con essi: una frecciata indirizzata allo stesso Manuele.
Odio e disprezzo dei bizantini erano sentimenti che avevano preso il posto dell’inquietudine e del rispetto suscitati da Manuele nei suoi primi anni di governo.
La pace negoziata a Venezia nell’estate del 1177, che aprì una nuova fase della politica italiana, ignorava del tutto Manuele Comneno, anche se i bizantini tenevano ancora Ancona quasi come un simbolo della loro presenza in Italia.
Nel corso degli anni successivi le incertezze che seguirono, a Bisanzio, alla successione del figlio di Manuele, l’undicenne Alessio, fornirono nel 1180 a Guglielmo Secondo l’opportunità di interferire negli affari dell’Impero e ricevendo bizantini esiliati e mandando propri soldati e proprie navi in Grecia.
Pag. 337-38
L’Impero d’Occidente. Il progetto di Federico Primo Barbarossa di restaurare l’autorità imperiale in Italia doveva tenere conto del regno meridionale, che, affermando la sua piena autonomia, poteva danneggiare la posizione dell’imperatore lungo tutta la penisola.
Federico realizzò sei viaggi in Italia, senza mai avere la possibilità di scendere a sud di Roma.
Anche se osservati a distanza i suoi discorsi bellicosi non produssero altro che rare scaramucce di frontiera, tuttavia i contemporanei guardavano alle mosse dell’imperatore con timore.
All’inizio del suo regno egli aveva concluso un’alleanza con papa Eugenio Terzo contro la corona meridionale, ed anche Adriano Quarto aveva accolto con favore il rinnovarsi di una politica che nel 1137 aveva quasi raggiunto l’obiettivo di distruggere Ruggero Secondo.
Guglielmo Primo aveva costretto il papa a mutare suo malgrado l’atteggiamento nei confronti del regno, e il papato cominciò effettivamente ad apprezzare i vantaggi dell’alleanza con il suo regno vassallo, mentre Federico diventava una presenza sempre più temibile e il suo dominio in Italia settentrionale sempre più oppressivo.
Quando il cardinale Rolando Bandinelli, colui che aveva organizzato a Benevento nel 1156 confrontandosi poi con Federico alla dieta di Roncaglia nel 1158, venne eletto papa alla morte di Adriano nel 1159, la decisione di Federico di opporre un candidato rivale eletto da pochi cardinali appare comprensibile ma si dimostrò un grave errore.
Invece di blandire il nuovo papa Alessandro Terzo coinvolgendolo in un rapporto stretto con l’Impero, Federico spinse questi nelle braccia del re di Sicilia, valorizzando una rete di relazioni internazionali dalle quali egli risultò totalmente escluso.
La frenetica attività di Alessandro volta a costruire la condizione durante la sua permanenza in Francia del 1162, indusse Barbarossa ad astenersi da azioni aggressive durante la sua breve visita in Italia durante il 1163-64, sebbene nuove tensioni si riproponessero lungo la frontiera nell’area di Frosinone e di Alatri.
Piani assai più impegnativi vennero prestabiliti in occasione del suo quarto viaggio in Italia subito dopo la morte di Guglielmo Primo.
Quando la regina Margherita offrì una generosa amnistia ai ribelli, Federico non poté più contare sulla loro cooperazione, nonostante che Andrea di Rupecanina e Riccardo di Fondi rinnovassero le incursioni nella zona nord-occidentale.
Federico intento intendeva allontanare l’imperatore Manuele dall’Italia e per farlo convinse gli ungheresi a tenerlo occupato nei Balcani.
L’esercito di Federico, comandato da Cristiano arcivescovo di Magonza, si accinse dunque all’assedio della base italiana dell’imperatore bizantino, Ancona, nella primavera del 1167, con sufficiente fiducia.
L’armata imperiale era stata raggiunta anche da Andrea Rupecanina e dal conte di Loritello.
Le truppe di Guglielmo Secondo si raccolsero con non poche apprensioni lungo il Tronto immaginando di dover affrontare un’invasione su larga scala.
Ci furono schermaglie ma gli eserciti non si scontrarono in campo aperto.
In poche settimane però l’imperatore, battuto non dalle armi ma dalle malattie, fu costretto a una ritirata in piena regola.
Ciò nonostante la sua affermazione era apparsa sufficientemente temibile, così da indurre gli avversari a negoziare con Venezia, spendendo danaro per incoraggiare le città lombarde a formare una lega.
Pag. 338-39
La fiducia ininterrotta di Guglielmo nel proprio futuro è suggerita dalla sua deliberazione di riprendere l’aggressiva politica marinara di Ruggero Secondo.
La sua capacità di capire le possibilità del ruolo siciliano nella politica mediterranea ci dice che da questo punto di vista egli era veramente il precursore di Federico Secondo.
Guglielmo perseguì dunque quelli che gli sembravano essere gli interessi vitali del regno, e questo determinò la scelta di mettere da parte ogni progetto finalizzato unicamente a contrastare il potere di Federico Primo in Italia.
Alla luce delle precedenti esperienza Guglielmo Secondo poté capire che i tedeschi avrebbero sempre avuto troppi problemi in Italia settentrionale per diventare un reale pericolo per il regno meridionale.
D’altra parte egli non aveva più da temere dai nobili che si erano opposti alla corona; un’analisi appropriata della situazione indicava cioè come questi ultimi, alla fine, non avrebbero mai preferito i tedeschi alla monarchia indigena.
Soprattutto egli non doveva più temere l’ostilità del papa nei confronti del regno, giacché la forza del Barbarossa in Italia obbligava il papato a procedere con maggiore cautela.
Pag. 343
Dopo che l’intesa con Costantinopoli del 1158 entrò in crisi, nel 1172 Guglielmo Secondo non ebbe più scrupoli.
Egli fu incoraggiato in questo dalle iniziative che vennero prese dagli esponenti bizantini che si erano posti in contrasto con il proprio governo: un omaggio evidentemente al rango della corte di Guglielmo, luogo di approdo dei dissidenti stranieri e degli esiliati, assai simile in questo a quella di Roberto il Guiscardo un secolo prima.
L’appoggio di Guglielmo ai dissidenti non era solo dimostrazione che il regno possedeva lo statuto di una “grande potenza”: era semplicemente una risposta dovuta alle iniziative di medesimo tipo che i bizantini praticavano regolarmente.
In questo senso censurare i comportamenti di Guglielmo significa fraintendere la logica della politica del Dodicesimo Secolo.
Ma l’attacco contro Bisanzio del 1185 va inoltre inquadrato in un contesto più largo, quello delle reazioni suscitate a livello internazionale dalla usurpazione del trono bizantino da parte di Andronico Comneno nel settembre del 1183: una vicenda che aveva provocato rivolte e secessioni nell’Impero e anche interventi stranieri come quello di Bela Terzo, re d’Ungheria, o quello di Kilig Arslan Secondo, sultano di Iconio.
Sarebbe forse parso uno sciocco segno di codardia, al sovrano siciliano, non trovarsi coinvolto in questa congiuntura.
Pag. 345
La partecipazione siciliana non era in discussione, e la monarchia di Guglielmo Secondo sembrava non corresse alcun pericolo immediato.
Ma la morte del re nel novembre del 1189 cambiò radicalmente ogni cosa.
L’Impero orientale poteva forse non trarre vantaggio dall’avvenimento, ma per chiunque altro la morte di Guglielmo ebbe implicazioni profonde.
La rivendicazione dei diritti di Costanza, ancora senza figli, alla successione, venne manifestata da suo marito Enrico, mentre il papato dal canto suo attribuiva un nuovo significato alla propria funzione di sovrano feudale del regno normanno.
E anche ai popoli e alle comunità del regno veniva data dalle circostanze una responsabilità politica che essi non sapevano bene come esercitare.
Rispetto al 1155 era meno evidente l’impazienza da parte dei nobili di cogliere l’opportunità di rafforzare i propri poteri locali: al contrario si affermavano, diventando visibili, solo ambizioni politiche di largo respiro valide per l’intera monarchia.
La monarchia naturalmente vacillò quando le candidature rivali alla corona furono presentate, anche se la dinastia normanna non fu subito eliminata dai tedeschi: quando nel 1194 infine Enrico Sesto ottenne la successione del regno, il papato risultava del tutto incapace di fare uso alcuno dei suoi diritti di sovranità imposti dai re normanni.
La monarchia meridionale era ormai un’entità politica stabile e vitale, ma proprio per questo, come l’Inghilterra nel 1066, il controllo su di essa poteva affermarsi solo unitariamente.
Giacché, bene o male, il regno risultò fermamente ancorato d’allora in poi ai destini dell’Europa continentale e la prospettiva, disegnata da Guglielmo Secondo, di farne la base di un impero mediterraneo a vocazione predatoria, risultò bruscamente interrotta.
Pag. 351
Parte quarta. L’eredità dei normanni.
Cap. 10. Il regno in crisi.
La morte di Guglielmo Secondo, senza diritti successori, il 17 novembre 1189, aprì un lungo periodo di incertezze.
Il suo immediato effetto sul governo del regno può essere direttamente osservato attraverso il racconto, contenuto nel Chronicon di Carpineto, della lunga controversia che oppose il monastero a Riccardo de Padula.
Nella vigilia di Natale questi occupò le terre del suo proavo, che aveva cercato fino ad allora di recuperare legalmente, e siglò il successo spedendo l’abate Boemondo al suo monastero di provenienza, Casauria, con l’accusa di simonia.
Poiché Riccardo aveva il sostegno di Ruggero conte di Teramo, che aveva giurato fedeltà all’imperatore, i monaci di Carpineto inviarono un loro rappresentante in Lombardia per chiedere al maresciallo imperiale, Enrico Testa di Bappenheim, di fare pressione sul conte.
Dal punto di vista degli osservatori settentrionali l’autorità effettiva della monarchia siciliana era azzerata.
La premura con cui alcuni gruppi cercarono di trarre vantaggio dal vuoto di governo apparve subito chiara anche a Napoli, i cui cittadini si impossessarono di beni appartenenti agli abitanti di Aversa.
Tanto a Napoli quanto ad Amalfi furono stabilite forme di autogoverno di tipo comunale.
Sebbene non ci fossero le condizioni, in questa fase, di una dissoluzione del regno in piccole unità, non c’è dubbio che alcuni gruppi premessero per approfittare dell’opportunità di agire autonomamente.
Non sappiamo bene come andassero le cose in tutte le diverse parti del regno, poiché le fonti di informazioni sono insufficienti e discontinue; tuttavia nel corso della generazione seguente uno stato di continua incertezza rispetto al futuro incoraggiò molto il dissenso e le agitazioni.
Come effetto di tutto ciò il regno di Guglielmo Secondo si andò configurando come un periodo ideale di pace e di giustizia e questa nostalgia ci fa vedere come nel regno non prevalesse la volontà di una completa dissoluzione.
In effetti, poiché la monarchia fondata da Ruggero Secondo si mostrò capace di sopravvivere anche in periodi di ridotta autorevolezza della corona, dal 1189 la stessa monarchia dovette risultare largamente bene accetta a gran parte della classe dirigente dell’Italia meridionale e della Sicilia.
Anche ammettendo che, a partire da allora, la vìvolontà di conservare il regno fosse divenuta un’esigenza che andava oltre la figura stessa del monarca, rimane comunque capire esattamente da dove il giovane monarchia traesse in questo periodo la sua forza essenziale: lo si può intuire piuttosto che dimostrare.
La morte di Guglielmo lasciava una sola legittima consanguinea, la zia Costanza, sposata nel 1186 al re tedesco Enrico.
Si dice che Guglielmo avesse fatto giurare ai suoi uomini fedeltà nei confronti di Costanza, indicandola come erede legittima, ma le fonti scritte indicano che dopo la sua morte, proprio nel 1189, solo alcuni dei potenti del regno accettarono le richieste di lei come vincolanti; Costanza non aveva molte possibilità di essere accettata.
Fra i trenta e i quarant’anni, ella non aveva ancora figli e il suo sposo tedesco incarnava le antiche e non sopite ambizioni dell’Impero occidentale sul regno meridionale.
Con essi l’indipendenza di quest’ultima sarebbe stata compromessa, e anche se Costanza fosse morta senza figli Enrico avrebbe certamente cercato di annettere il regno al suo impero.
Le richieste di Costanza nel 1189 avrebbero potuto imporsi solo con la forza, e giacché l’imperatore era partito per la crociata nel maggio dello stesso anno, c’era la ragionevole possibilità che i tedeschi fossero troppo distratti per assumere l’impegno ulteriore di combattere in aiuto di Costanza.
In ogni caso il regno aveva avuto fino ad allora buon gioco nel logorare la minaccia tedesca.
Solo al confine settentrionale, nelle zone più vicine alle basi imperiali in Italia centrale, avrebbe potuto maturare un atteggiamento favorevole ai tedeschi.
L’interesse per una rivendicazione germanica derivava qui dal consolidamento dell’autorità imperiale in Italia centrale nel decennio precedente.
Ciò rendeva in ogni caso obbligatorio che il regno trovasse un modo per accordarsi con la nuova realtà italiana: c’era il pericolo che esso si ritrovasse concretamente in una condizione di marginalità se il centro di governo, a Palermo, avesse fallito nell’azione di riaffermare la propria autorità sul Mezzogiorno continentale e di annullare, nello stesso tempo, l’attrazione dalla rivale potenza imperiale.
Pag. 355-57
Quando il progetto della crociata venne delineato per la prima volta, Guglielmo Secondo prevedeva di giocarvi un ruolo di primo piano.
Anche per questo Tancredi si sentì obbligato ad accogliere Filippo Secondo e Riccardo Primo.
L’atteggiamento di quest’ultimo non era del tutto benevolo per via dei diritti rivendicati in nome della sorella Giovanna, vedova di Guglielmo Secondo, nonché delle promesse fatte da quest’ultimo di assicurare alla causa della crociata navi, rifornimento e danaro.
Benché i sei mesi trascorsi da Riccardo in Sicilia fossero molto difficili per Tancredi, questi non perse il controllo della situazione e riuscì anche con successo a stringere con Riccardo un’alleanza per affrontare Enrico nel caso lo svevo avesse deciso di invadere il regno in tempi brevi, cioè durante la permanenza del re d’Inghilterra nel Mezzogiorno.
Pag. 358
Enrico non fece rientro nel regno se non nel novembre del 1196 e non raggiunse la Sicilia prima del marzo successivo.
Qui, a maggio, egli sfuggì a una cospirazione che puntava alla sua vita, che, secondo l’opinione che si diffuse in Germania, venne selvaggiamente repressa.
I dettagli dell’episodio non sono chiari ma è certo che si trattò di una ribellione che culminò nell’assedio di Castrogiovanni, che tenne impegnato Enrico per alcune settimane.
In ogni caso questa vicenda determinò in Italia il diffondersi e il radicarsi di un giudizio sulla crudeltà dei tedeschi.
Ma Enrico non visse abbastanza per assaporare la rivincita: ammalatosi durante una battura di caccia in Sicilia orientale all’inizio di agosto, egli morì di dissenteria il 28 settembre 1197.
Pag. 366-67
In Germania si diceva che Enrico e Costanza fossero entrati in contrasto in merito a come il regno andava governato e la regina venne a tal punto sospettata di essere coinvolta nella cospirazione contro la vita dello sposo da essere obbligata a presenziare al macabro rito di esecuzione dei suoi ispiratori.
Durante l’assenza di Enrico, comunque, Costanza aveva diretto con energia il governo del regno per circa due anni, e questa nuova esperienza, nuova tanto per Costanza quando per il regno, incoraggiò probabilmente le speranze di potere far a meno dei tedeschi dopo la morte dell’imperatore.
I sospetti di Enrico nei confronti della lealtà della consorte non dovevano avere veri fondamenti, ma riflettevano il risentimento dell’imperatore nei riguardi del senso di autonomia esibito da Costanza.
Pag. 367
Dopo che la brutale presa di possesso del regno da parte di Enrico Sesto aveva aperto un periodo, che durò meno di tre anni, di governo durissimo, la morte improvvisa dell’imperatore minacciò di precipitare il regno medesimo in una nuova fase di incertezza politica.
Il suo unico figlio, Federico, che non aveva neppure tre anni, aveva incontestabili diritti alla successione, eppure sulla sua posizione pesava il fatto che in assenza del padre era stato già eletto re dei romani.
Naturalmente i sostenitori tedeschi di Enrico Sesto si trovarono di fronte innanzitutto al problema di come realizzare i diritti di Federico sull’impero.
Alla morte di Enrico, suo fratelli, Filippo si Svevia, fece immediato ritorno in Germania dall’Italia per radunare i suoi sostenitori, i quali insistevano naturalmente sull’idea che la sua sarebbe stata una leadership più efficace di quella rappresentata da una reggenza.
Probabilmente fu solo dopo che Costanza venne a sapere che anche Filippo era stato formalmente eletto re in Germania, l’8 marzo 1198, che Federico venne condotto dalla Puglia a Palermo, per esservi incoronato re di Sicilia, il 17 maggio dello stesso anno.
Dopo questa data ogni richiamo a Federico come re dei romani venne lasciato cadere.
Pag. 368
Nessun papa prima di Innocenzo Terzo aveva avuto una simile opportunità di incarnare il ruolo di signore feudale del regno assegnato formalmente al pontefice fin dal 1130, e nessun papa, fino a quel momento, aveva posseduto neppure la metà dei poteri da lui esercitati.
Non era prevedibile tuttavia che Innocenzo potesse anche comprendere e ancora meno adempiere a favore di altri i doveri della regalità.
Insomma Costanza aveva ottenuto giustizia: certo, essa in pratica non aveva avuto scelta e in punto di morte dovette nutrire numerose preoccupazioni per le possibili conseguenze del suo operato: ma i tedeschi erano stati tenuti lontani dal regno, l’eredità del figlio appariva salva e Innocenzo operava per garantire l’indipendenza del regno medesimo.
Come primo atto il papa ordinò a tutti i potenti meridionali, i nobiles, di prestare giuramento di fedeltà a lui stesso e al re.
Il suo obiettivo principale non era tuttavia quello di assicurare la disfatta dei progetti tedeschi finalizzati alla restaurazione dell’impero di Enrico Sesto.
Nel contempo Innocenzo Terzo si propose di approfittare delle circostanze per sottrarre alla corona le sue peculiari prerogative in ambito ecclesiastico e per stabilire significativi precedenti per quanto riguarda le implicazioni del suo ruolo di signore feudale.
Pag. 373
In quel momento Federico era già saldamente insediato in Germania.
Egli, in quanto figlio di Enrico Sesto e pupillo del papa, aveva rapidamente acquisito sostegni alla sua causa in Germania meridionale, ma la sua incoronazione a re dei romani nel dicembre del 1212 aveva dovuto avere luogo a Magonza, poiché Aquisgrana, dove per consuetudine si celebravano le incoronazioni dei sovrani germanici, rimaneva ancora sotto il controllo di Ottone Quarto: tale situazione dovette protrarsi fino a quando quest’ultimo non fu sconfitto dal re di Francia Filippo Augusto a Bouvines nel luglio del 1214, perdendo così ogni credibilità politica.
Nel luglio del 1215 Federico poté infine entrare in Aquisgrana per celebrarvi la sua incoronazione ufficiale e fu per questo evento, per lui, a segnare formalmente l’inizio del suo regno.
Il suo primo atto fu un voto solenne di partecipare alla crociata che Innocenzo Terzo andava progettando, anche se egli non poteva prevedere di potere realmente lasciare la Germania in tempi brevi.
La prospettiva della crociata gli serviva però a fissare uan meta ulteriore, che implicava già la sua intenzione di non trascorrere il resto della propria vita in Germania.
In effetti, l’impegno religioso, sicuramente sincero, lo affrancava politicamente dall’esilio fuori d’Italia dove Innocenzo Terzo aveva provato a relegarlo.
Pag. 391
La crociata costituiva insieme un dovere dell’imperatore e un modo di portare avanti l’opera di riconciliazione in Germania.
Se avesse desiderato di evitarla, difficilmente questo sarebbe stato nelle possibilità di Federico, per una serie di ragioni concomitanti: le pressioni di tutti i principi del tempo, le tradizioni della sua famiglia, il fatto che la crociata rappresentava il progetto che stava più a cuore al papato.
Allorché il piano della crociata venne annunciato, nel corso del Quarto Concilio Lateranense del 1215, venne proposto che i partecipanti si riunissero a Brindisi e a Messina nel giugno del 1217.
Il regno meridionale risultava dunque profondamente coinvolto nell’impresa e difficilmente Federico Secondo avrebbe potuto rimanere in disparte.
La Puglia nuovamente sotto il suo controllo, dal 1215 egli compare in atti di beneficienza, effettuati nei porti di Barletta e di Brindisi a favore di diversi ordini religiosi: in particolare l’ordine dei Cavalieri teutonici che egli aveva fatto tanto per promuovere e da cui si aspettava di essere sostenuto nell’allestimento di una solida piattaforma per l’imminente campagna militare.
Nonostante ciò, si è dubitato che la crociata fosse la ragione principale della partenza di Federico dalla Germania: gli storici lo hanno descritto per lo più come un uomo catturato da un forte richiamo sentimentale che lo attirava verso sud e che gli procurava avversione per la Germania.
Ma la sua non fu una partenza precipitosa e poco decorosa: furono anzi preparate con cura le sue condizioni e innanzitutto il governo che avrebbe dovuto reggere il regno in sua assenza.
Enrico venne così eletto re dei romani nell’aprile del 1220 e gli venne affiancato un consiglio di reggenza.
Dopo la sua partenza Federico riuscì a conservare per sé il favore dei principi.
Così quando dovette tornare nel 1235, era sì necessario far fronte alle tensioni determinate dal governo del figlio, ma non perché bisognasse reimporre la sua autorità, che non veniva contestata da forze ribelli.
In altre parole, le sue emozioni non condizionavano la lucidità degli atti: anche questo spiega come mai divenne un formidabile uomo di potere.
Pag. 392-93
Cap. 11. La ripresa del regno
Federico Secondo trascorse in Italia gran parte degli anni che seguirono il suo ritorno nel 1220, con due lunghe parentesi: un anno speso per la crociata, tra il 1228 e il 1229, e, tra il 1235 r il 1237, numerose trasferte in Germania.
In seguito, fino alla tarda età moderna, nessun altro uomo di governo si sarebbe dedicato con pari zelo e intelligenza ai problemi e agli impegni relativi alla penisola intera.
Nel Mezzogiorno Federico non ebbe molte difficoltà a restituire vigore alla monarchia e i conflitti che dovette affrontare altrove non indebolirono significativamente il suo regime nel regno.
Quest’ultimo rimase fedele e fu effettivamente amministrato da ufficiali pubblici devoti al re, esecutori tempestivi delle sue istruzioni e costantemente sotto esame.
Ma il regno non poteva garantirgli uno splendido isolamento rispetto agli accadimenti che turbavano l’altra parte della penisola.
La regolarità nell’azione di governo e la prosperità facevano del regno un modello ponendolo come la maggiore potenza italiana, e ciò non poteva essere senza conseguenze.
Se non avesse assunto un ruolo di comando negli affari della penisola, la monarchia meridionale avrebbe corso il rischio di subire seri contraccolpi.
Sebbene Federico potesse governare il regno in absentia, è naturale che egli preferisse comunque essere sempre presente quando ne aveva la possibilità e solo problemi urgenti lo tenevano lontano.
Soggiornando nella regione preferita, la Capitanata, era facile raccogliere informazioni provenienti per un verso dalla Sicilia, per un altro, lungo la costa adriatica, fin dalla Lombardia e dalla Germania.
Proprio in Capitanata, a Foggia, già nel 1223 volle che fosse costruito un palazzo dove, in numerose occasioni, egli riunì grandi assemblee per discutere le maggiori questioni di governo.
Trascorse nel regno quasi il doppio del tempo dedicato alle altre regioni italiane.
Nella prima parte del suo governo, prima del lungo intervallo tedesco, trascorse nel regno tre quarti del suo tempo.
Durante questo periodo, egli dovette ripristinare la forza effettiva della monarchia, organizzare la crociata, fronteggiare, al ritorno da questa, le conseguenze dell’invasione pontificia nel regno avvenuta durante la sua assenza e restaurare la propria autorità.
Dopo anni di esilio, quasi mai poté godere di un momento di riposo pieno.
Tuttavia il suo regno sorse laddove egli avvertì di essere più amato e dove egli poté meglio sviluppare i suoi interessi nell’architettura, nella cultura e nell’attività fisica.
Non c’è motivo di dubitare della sua sincerità quando affermava con orgoglio di essere uomo di Puglia.
Federico in realtà era nato a Iesi, poco più a nord del confine settentrionale del regno e aveva trascorso la sua giovinezza in Sicilia; di fatto non aveva visto molto altro del Mezzogiorno prima di recarsi in Germania nel 1212.
Non può essere stata la nostalgia per la sua giovinezza siciliana a riportare di nuovo Federico in Italia meridionale, giacché egli non aveva nessuna ragione politica per fare un bilancio felice degli anni difficili che egli aveva trascorso nell’isola da bambino.
Fin dall’inizio egli capì che, per la complessità di tutti i suoi impegni, non poteva fare di Palermo la sede stabile della sua residenza alla maniera dei suoi antenati normanni.
Lo stile itinerante del governo di Federico costituì un distacco dal modello normanno.
Pag. 397-98
Il protrarsi della permanenza in Sicilia impedì che Federico agisse direttamente sul processo di ripristino dell’autorità regia in Italia meridionale.
Sulla base della sua corrispondenza, sembrerebbe che l’imperatore dovesse frenare lo zelo dei suoi ufficiali, invece che spingerli a un impegno più deciso a vantaggio della corona.
Mentre si trovava in Sicilia, nell’estate del 1224, Federico prese l’importante decisione di fondare uno studium generale a Napoli, con l’obiettivo principale di formare esperti di diritto necessari al servizio della corona.
In tal modo si sarebbero ridotti i costi di formazione per coloro che altrimenti avrebbero dovuto recarsi a Bologna per studiare: in questo senso la decisione di Federico ha sicuramente qualcosa a che fare con le difficili relazioni tra l’imperatore e il vivace comune bolognese.
Più specificamente essa indica che dopo tre anni dal suo arrivo nel regno, Federico percepiva la necessità di disporre di ufficiali più preparati.
Per risolvere il duplice problema, l’insufficienza delle risorse umane rispetto alla natura delle sue ambizioni e l’impossibilità di affidarsi alle iniziative di maestri privati che rispondessero all’esigenza di un insegnamento specializzato, Federico decise dunque di fondare un’università.
Si trattava della prima università in Europa che veniva formalmente istituita.
Federico non accordò alternative.
Ai suoi sudditi venne proibito di lasciare il regno per studiare in altri luoghi.
Inoltre per promuovere la nuova istituzione offrì ai professori contratti vantaggiosi per attirarli a Napoli mater antiqua studii: in una città prospera e feconda, unica per le sue bellezze naturali e per la sua collocazione.
Sappiamo poco dell’attività dell’università nei primi anni di vita, ma un’indicazione relativa alle conseguenza che la sua fondazione dovette produrre nel regno è data da un contratto del 1224, con cui uno scriba professionista di Bari si impegnava a redigere per un cliente di Salerno una copia della raccolta di decretali con al glossa di Ugolino dei conti di Segni, il futuro Gregorio Nono.
Forse nel regno ancora non c’erano molti professori, ma sicuramente circolavano numerosi copisti che potevano trarre profitto da questa nuova forma di patronato.
Pag. 408-9
Non è possibile prendere posizione di fronte alle divergenze dei punti di vista dei papi da un lato e di Federico dall’altro: la sincerità degli atteggiamenti delle due parti non è in discussione, ma non è neppure rilevante, giacché esse si richiamavano a principi incompatibili.
E’ probabile che Federico non si rese subito conto di quali ostacoli il papato avrebbe innalzato per impedirgli di raggiungere i suoi obiettivi.
Naturalmente egli prevedeva all’inizio di procedere con calma e diplomazia.
Il papato, che inizialmente guardava a Federico come a un vassallo devoto e volenteroso, rimase sorpreso e inorridito allorché l’orfano disgraziato si trasformò in un capace uomo di governo dotato di un autonomo punto di vista.
Ma le strategie dei papi non erano tutte uguali: Onorio Terzo immaginò di potere risolvere il problema manifestando semplicemente il proprio dissenso; Gregorio Nono si rese conto che era necessario allearsi con i nemici di Federico e i successori di Gregorio infine dovettero fare ricorso a tutte le risorse materiali e spirituali della cristianità occidentale per ottenere la liquidazione della famiglia di Federico.
Osservato a distanza, tuttavia, il punto di vista di Federico è apparso storicamente più apprezzato di quello del papato, perché coincide, almeno in apparenza, con un tentativo, che non sapremmo come definire, se reazionario, prematuro o del tutto anacronistico, di costruire un vero sistema di governo laico, in un tempo nel quale fuori dei confini del regno gli uomini colti e capaci di produrre idee sull’organizzazione sociale concentravano tutta la loro fiducia in uno spazio di spiritualità rappresentato e istituzionalizzato dalla Chiesa.
In un contesto del genere, comunque, doveva apparire illusorio a Federico persistere in un atteggiamento che non tenesse conto della presenza del papato.
Nello stesso tempo però gli osservatori contemporanei non previdero mai con chiarezza fino a che punto entrambe le parti sarebbero risultate in grado di sostenere e portare avanti la controversia.
Il richiamo di Federico alle tradizionali consuetudini non sembrava più provocatorio o astratto di quello che Enrico Secondo aveva espresso contro Thomas Becket in Inghilterra.
E da parte sua il papato era ben lontano dal ritenere sicura la sconfitta di Federico.
Pag. 420-21
L’occasione della prima rottura fra Gregorio e Federico fu offerta dal ritorno di quest’ultimo in Puglia poco dopo la partenza per la crociata nell’agosto del 1227: un atto che rendeva l’imperatore automaticamente passibile di scomunica.
Certamente Federico non era in condizioni perfette, ma probabilmente neppure tanto malato da non potere proseguire il suo viaggio, sostando magari da qualche parte lungo l’itinerario.
Il fatto è che l’imperatore, a quanto pare, dava per scontato che, in un modo o in un altro, avrebbe evitato la condanna papale.
Con ciò Federico esibiva un’incoscienza pari alla spietata determinazione con cui il papa intendeva cogliere l’occasione di ridimensionare l’avversario: non per nulla aveva assunto il nome del papa che più di ogni altro aveva legato la propria identità alla lotta contro le pretese dei principi secolari.
Da cardinale Gregorio aveva assistito al progressivo deperimento della prospettiva politica inaugurata dallo zio Innocenzo nelle mani del debole Onorio: adesso gli premeva dimostrare che a Roma il tempo dei tentennamenti era finito.
Come il suo nome suggeriva, Gregorio non aveva il minimo dubbio sulla correttezza del proprio operato: che senso aveva fermarsi a calcolare le proprie possibilità di successo, dal momento che, senza possibilità di errore, Dio non avrebbe mai abbandonato la sua Chiesa?
Pag. 423
Il re non ammise mai che la sua opera di riorganizzazione potesse essere oggetto di critiche di alcun tipo.
Le preoccupazioni di Federico relative al governo, dopo gli accordi con Gregorio, non devono essere valutati fuori dal loro contesto politico.
Più in particolare, le forti pressioni che il sovrano esercitò nei confronti del regno non devono essere giudicate come derivanti da qualche programma ideologico, ma come la necessaria risposta al tipo di congiuntura politica.
In altre parole, se Federico non avesse sviluppato una giustificata diffidenza nei confronti delle intenzioni del pontefice, o se avesse deciso di rafforzare la sua autorità imperiale, minacciata tanto in Italia settentrionale – dalla nuova Lega lombarda – quanto in Germania, è possibile che lo sviluppo dei poteri monarchici nel regno fedele avrebbe assunto altre caratteristiche.
Quanto grandi fossero le risorse potenziali di quest’ultimo era stato accertato dalla capacità di sopportare il peso economico della crociata: ma in base unicamente alla permanenza in Sicilia durante la giovinezza, difficilmente Federico avrebbe potuto immaginare l’entità di tali riserve.
Dopo il 1230 la pressione non si allentò mai e con essa le richieste (fiscali o di altro genere) rivolte ai sudditi: sebbene poi il sovrano non abbia avuto tempo e modo di individuare nuove modalità di gestione e continuasse a operare all’interno del contesto amministrativo e istituzionale che aveva ereditato.
Che fondamento ha la tendenza degli storici moderni a giudicare Federico come il creatore dello Stato moderno?
In verità egli si considerava il rinnovatore del regno normanno e dell’ideale imperiale romano, mentre i suoi contemporanei, coloro che abitavano il regno, non trovavano particolarmente nuova la sua identità politica: bene o male, fin dal 1220 egli aveva affermato di volere semplicemente restaurare, dopo un periodo di sconvolgimenti, le buone consuetudini del tempo di Guglielmo Secondo.
Per quel che sappiamo il regno espresse una sostanziale acquiescenza nei confronti della gestione amministrativa del re: era stata la precedente fase di disordine a chiarire ai più che ogni alternativa a Federico avrebbe significato in realtà la prevalenza di interessi particolari.
Persino una larga parte del clero non considerava desiderabile un indebolimento della sua autorità, pur continuando a sperare intensamente in un miglioramento delle relazioni con il papato.
Nonostante le denunce, dure ed enfatiche, dei comportamenti tirannici di Federico, a opera del papa e dei suoi alleati, denunce che proseguirono anche dopo la morte dell’imperatore, la percezione che possediamo della sua attività di governo indica con certezza che nessun altro sovrano avrebbe potuto fare di più per i suoi sudditi.
La popolazione del regno non aveva motivo di ritenere che gli altri principi del tempo potessero assolvere ai propri doveri con più intelligenza o con maggiori scrupoli.
La documentazione amministrativa che sopravvive è assai lacunosa, ma riesce a mostrarci un re consapevole delle propria funzione, circondato da ufficiali ubbidienti; lasciando scorgere anche nella gran parte dei sudditi la fiducia nel carattere misericordioso del re e nella sua capacità di attuare la giustizia, come era nelle aspettative di quei tempi.
Pag. 427-28
Osservando queste misure contradditorie ci accorgiamo dell’esistenza di un conflitto non facilmente sanabile fra le esigenze immediate del tesoro e le prospettive a lungo termine di crescita della prosperità del regno.
Un anno dopo Federico era a Venezia e concedeva ai suoi cittadini il privilegio di spostarsi liberamente nel regno e di commerciarvi pagando dazi al tasso fisso dell’1,5 per cento, esigibili in natura secondo la decisione degli ufficiali regi.
Il re rinunciava inoltre a ogni pretesa sui beni dei veneziani che morivano nel regno o le cui navi subivano naufragio.
Ancora, i mercanti veneziani potevano commerciare nella loro città beni acquistati nel regno, anche se nulla veniva specificato sul dazio che dovevano pagare per questo tipo di attività.
Certamente le concessioni di Federico erano finalizzate ad allontanare Venezia dalla prospettiva di un’adesione alla Lega Lombarda.
Tant’è che quando, sei mesi più tardi, il comune di Genova nominò un esponente milanese della lega come suo podestà, Federico reagì arrestando tutti i mercanti genovesi presenti nel regno e impadronendosi delle loro merci.
Tutto ciò conferma che il controllo dell’imperatore sull’economia del regno non può essere analizzato separatamente dagli altri aspetti della sua politica.
Le città italiane settentrionali volevano tutti i vantaggi economici che il commercio con il regno prospettava, ma Federico non poteva accettare che esse fossero, al contempo, libere di godere di tali vantaggi e di usare la propria forza contro di lui.
I pisani compresero bene il problema e ottennero, nell’aprile del 1224, il permesso di muoversi e di commerciare in tutti i domini dell’imperatore, e in modo particolare a Messina e a Palermo.
Pag. 435
Gran parte della legislazione fredericiana, tuttavia, non cerca tanto di riformare, quando di chiarificare e di sistematizzare.
Traspare allora, attraverso le leggi, la personale venerazione di Federico per il diritto, e di conseguenza l’insistenza affinché nei giudizi sia mantenuto un comportamento pieno di rispetto, senza grida o vuote declamazioni, da parte di tutti i soggetti della gerarchia sociale, dai conti in giu.
Le norme contenute nel Liber Augustalis riflettono non solo l’intelligenza e l’autorità dell’imperatore, ma anche la matrice culturale di un’intera generazione di ufficiali e consiglieri, compresi molti membri del clero.
Un’importantissima innovazione per il diritto siciliano, e cioè la regolamentazione degli appelli dalle corti di primo grado fino alla corona stessa, certamente mutuò un modello tratto dalla logica gerarchica della Chiesa.
Federico insomma era pienamente consapevole delle proprie responsabilità, tanto come legislatore che come fonte di giustizia.
Pag. 438-39
Lo sviluppo dell’organizzazione burocratica di Federico sulla base dell’apparato esistente al momento del suo rientro nel 1220 derivava più dalla capacità dell’amministrazione di incrementare il ritmo delle sue diverse attività che da un qualche intervento deliberativo.
Analogamente, durante i cinque anni che precedettero il suo viaggio in Germania del 1235, quando Federico ebbe modo di analizzare da vicino lo stato del suo governo, i mutamenti eventualmente introdotti non furono desunti da un astratto modello preconcetto.
Le disposizioni venivano così costantemente sottoposte a revisione, non solo per adeguarle a successivi cambiamenti di contesto, come, ad esempio, le assenze del re o l’esplosione dell’ostilità papale, ma, senza dubbio, anche per adeguarle alla disponibilità di ufficiali idonei.
L’amministrazione fredericiana rimaneva dunque una struttura flessibile che procedeva attraverso prove e sperimentazioni, finalizzata a soddisfare esigenze immediate.
E l’imperatore non aveva l’obiettivo di imporre precocemente un ordinamento autocratico.
Quindi non ha alcun senso tenere in vita l’immagine di Federico come incarnazione di un modello di cesarismo fascista, coltivata in Germania e in Italia nel periodo compreso fra le due guerre mondiali: quel che è certo è che essa è riuscita a fuorviare gli storici.
Alle ragioni della comprensione storica, come spesso succede in questi casi, non è risultato utile il manto che copre le spalle di quell’immagine e che ne ha troppo modernizzato i caratteri.
Pag. 443
Negli anni in cui circolavano questi discorsi il governo del regno si poté giovare molto dell’apporto degli irreprensibili vescovi di Palermo e Capua: anche per questo è difficile credere che le condizioni delle chiese del regno fossero davvero precarie.
Gregorio invece volle convincersi che tutto era responsabilità di Federico: nessuno, a dire del papa, poteva alzare un dito nel regno senza che lo volesse Federico.
Ciò significa non che il papa non avesse argomenti più specifici, ma solo che le accuse mosse nel 1239 non erano particolarmente nuove.
Il migliore motivo per incrementare le lagnanze era dato dalla ricerca e dalla costruzione di una buona occasione per procedere alla scomunica, data l’impossibilità di ammettere le vere ragioni della rottura con l’imperatore nell’inverno del 1238-39.
Dopo aver stabilito che non c’erano più speranze di un’effettiva collaborazione con Federico.
Gregorio decise di appoggiare la Lega lombarda, vedendo in questa l’unica concreta possibilità di indebolire il dominio politico dell’imperatore in Italia.
Da questa posizione, il papato non volle più tornare indietro, nonostante Federico non rinunciasse mai alla speranza che un diverso atteggiamento del papa riaprisse la strada della riconciliazione.
Pag. 445-46
Il regno non ricavò grandi motivi di turbamento dalla scomunica di Federico.
La situazione interna ad esso rimaneva del tutto priva di tensioni, al punto che, osservati dal Mezzogiorno, i problemi che incombevano altrove su Federico sfuggivano a un’esatta valutazione, non riuscivano cioè ad essere apprezzati nella loro giusta portata.
Riccardo di San Germano, che mostra scarso interesse per le questioni che non riguardavano direttamente il regno, riflette probabilmente l’atteggiamento generale dei suoi abitanti nei confronti degli altri domini dell’imperatore.
Lo scontro con il papa ad esempio non determina né sconvolgimenti delle identità religiose né un’attenuazione del sentimento collettivo di fedeltà nei confronti del re.
Proprio perché la lealtà del regno era sostanzialmente sicura, Federico non aveva bisogno di concentrare qui la sua attenzione: c’erano suoi ufficiali a sostituirlo fedelmente.
Durante la vita di Federico, il papato del resto non avvertì mai l’esistenza di situazioni di malcontento che potessero mettere in crisi l’autorità del re.
Per sconfiggerlo, per raggiungere cioè l’obiettivo che il papato infine si era posto, era necessario attaccarlo nel suo ruolo di imperatore, non in quello di re: così facendo il papa aveva la necessità però di reperire risorse in tutta la cristianità.
In definitiva la condotta del papato conferma nel modo più eloquente quanto forte fosse il radicamento di Federico nel regno.
Pag. 446
Di fatto non c’erano alternative a questo sistema, poiché la corona non aveva l’intenzione di pagare per ottenere un servizio professionale.
Fra coloro che tenevano in piedi il sistema e il re esisteva un livello intermedio, composto da un numero relativamente piccolo di gestori provinciali, la cui azione era diretta dal re a proprio beneficio, ma ad alcuni dei quali la corona poteva affidare gli uffici in questione.
Federico poteva sostituirli se non davano una prova soddisfacente delle proprie capacità, ma, almeno fino ad un certo punto, egli non poteva farne a meno: dipendeva cioè da uomini che servendo nella sua amministrazione coltivavano interessi personali.
Questa singolare organizzazione, nonostante i suoi limiti, rimase sufficientemente coesa durante la vita di Federico e può, in generale, essere considerata efficiente.
Pag. 454
Gli impegni di Federico in Germania, la guerra in Italia settentrionale e la rottura aperta con Gregorio Nono nel 1239: tutti questi fattori resero più difficile il governo del regno, ma anche se non si fosse venuto a trovare in contrasto con il papato l’imperatore avrebbe comunque continuato a sviluppare e rafforzare la sua pratica di governo, perché la verifica sistematica e continuata delle proprie attività gli era connaturale.
Nel tempo in cui furono adottate, tuttavia, alcune delle sue innovazioni dovettero certo essere giudicate necessariamente provvisorie.
Risultava, ad esempio, praticamente impossibile pensare che la separazione del regno e del suo clero dal papato potesse durare a lungo.
Il controllo ravvicinato delle chiese da parte della corona era tollerabile per il clero solo nella misura in cui esso poteva continuare a sperare che un cambiamento nel trono pontificio o in quello regio o, ancora, un mutamento di sentimenti avrebbe alla fine restaurato normali relazioni fra Chiesa e Corona.
Una prospettiva che avrebbe inevitabilmente riportato il clero a occupare ruoli nell’amministrazione del regno.
Per questa ragione il papa aveva in mano un atout: il re cioè non poteva sottrarre in permanenza al regno la cura e la sollecitudine del papa.
Nonostante la sua autorità in questo mondo, anche Federico, in altre parole, era una figura di transizione che alla fine sarebbe stata sostituita da altri.
I papi che attendevano questo giorno, pregando per il suo arrivo al più presto, erano forse ingenerosi, ma certamente non stupidi.
Per quanto ansiosi fossero divenuti nell’animo, essi avevano anche buone ragioni per avere fiducia e senza tirare in ballo la loro fede nella provvidenza divina.
Pag. 461
Sebbene le linee principali del drammatico confronto con il papato siano note, resta difficile capire cosa accadde nel regno negli ultimissimi anni di Federico.
La casuale sopravvivenza di un registro ufficiale del 1249, conservato a Montecassino, contenente atti di incameramento a favore del fisco, mostra notevoli interventi di confisca di terre a danno di traditori, riferendosi però solo alla Capitanata.
Gli elementi di conoscenza che ne possiamo trarre non sono dunque sorretti da altre prove, relative ad altre aree, anche se alcuni documenti angioini più tardi aggiungono altri nomi di potenti che avevano perso le loro terre sotto Federico Secondo, senza indicare però né cosa avessero fatto per attirare l’ira dell’imperatore né quale fosse il loro effettivo peso politico.
In realtà l’impatto della censura papale sul regno nons i avvertì immediatamente dopo l’atto di scomunica del 1239, ma solo quando Innocenzo Quarto depose, il 17 luglio 1245, formalmente Federico al Concilio di Lione.
Solo allora alcune figure di spicco della compagine di governo si piegarono alle pressioni che venivano dal papa.
Pag. 462
Cap. 12. Il regno tradito.
Questi drammatici eventi sulla costa occidentale dell’Adriatico ebbero immediate ripercussioni sul versante opposto dello stesso mare.
Nella primavera dell’anno seguente numerose città dell’Epiro riconobbero la signoria di Manfredi.
Michele Angelo, despota dell’Epiro, riconoscendo il suo primato, aprì un negoziato grazie al quale Manfredi ottenne alla fine che la figlia di Michele, Elena, diventasse la sua seconda moglie, recandogli come dote alcuni porti e alcune isole dell’Epiro fra cui Corfù.
Come il suo grande predecessore Roberto il Guiscardo, Manfredi non aveva bisogno di un titolo regio per guadagnare una grande influenza negli affari di un impero orientale che si trovava a un punto critico della sua storia.
In quegli anni i principi bizantini erano occupati a risolvere il problema di chi fra di essi dovesse recuperare Bisanzio occupata dagli imperatori latini (come poi sarebbe avvenuto nel 1261 ad opera di Michele Ottavo di Nicea): ad essi Manfredi appariva già un principe altino abbastanza forte da meritare rispetto.
Pag. 474
Dopo la battaglia di Benevento, Carlo acquisì in realtà un regno in buona efficienza, amministrato alla maniera di Federico Secondo: non possiamo avere dunque dubbi sul fatto che Manfredi fosse riuscito effettivamente a restituire al regno forza e vitalità.
Il successo di Manfredi può essere misurato guardando l’interesse con cui altri principi cercavano di ottenere la sua amicizia e osservando anche la rapida ripresa del fronte ghibellino nel resto d’Italia.
Sebbene non fosse né erede legittimo né imperatore, Manfredi fu realmente in grado di risollevare l’autorità della tradizione federiciana in Italia.
Fino alla sua morte il papato lo temette e lo detestò, ed è chiaro che ciò ha pesato fortemente sulla sua reputazione storica.
Pag. 476
Alessandro Quarto non pensò seriamente di occupare il posto lasciato vuoto da Edmondo quando il progetto costruito intorno a quest’ultimo fallì, nonostante che il successo di Manfredi rendesse naturalmente indispensabile l’individuazione di un altro campione pontificio, persistendo la linea secondo cui il principe svevo non poteva essere riconosciuto.
Lo stato di grave confusione nel quale versava la curia romana in questa fase era aggravato dal fatto che Alessandro Quarto venne costretto quasi contemporaneamente ad abbandonare Roma a causa dell’ostilità della città nei suoi confronti: soprattutto Viterbo, Orvieto e Perugia divennero così, per lui e per i suoi successori, le basi nelle quali progettare la reazione.
Quando Alessandro morì nel 1261, la curia si mostrò talmente irresoluta da occupare ben tre mesi per scegliere il suo successore e non si trovò nessuno negli ambienti più prossimi, laici o ecclesiastici che fossero, capace di ricondurre il collegio ad un maggiore senso dell’equilibrio e della responsabilità.
Toccò ad un nuovo outsider, e cioè al nuovo papa, Urbano Quarto, impegnarsi per un drastico mutamento di indirizzo.
Pag. 483
In realtà non fu l’ambizione a compromettere Manfredi, ma la collocazione del regno di Sicilia nell’Europa cristiana.
Ormai da diverse generazioni tanto l’impero quanto il papato si erano rifiutati di accettare che il regno normanno vivesse una vita tranquilla.
Dopo aver consentito che il regno si formasse e si affermasse, non appena ne ebbero la possibilità, papato e impero provarono a colpire la sua autonomia e la sua unità in modo tale che si uniformasse alle loro esigenze.
Il regno però era diventato una realtà molto solida, un potere con cui era necessario fare i conti, e che d’altra parte non poteva essere isolato dagli eventi che agitavano la politica fuori dai suoi confini.
E’ assurdo pensare dunque che Manfredi potesse tagliare i suoi rapporti con i sostenitori e gli alleati sparsi in tutta Italia.
Pag. 485
Manfredi non era imperatore e non aspirava a diventarlo: egli non rappresentava un partito imperiale che sfidasse la sovranità papale in Occidente.
In un certo senso però egli rappresentava un punto di vista nettamente opposto alla visione papale della politica: Manfredi lavorava cioè per un equilibrio pragmatico che il papa non avrebbe mai accettato.
Se il regno fosse stato una diretta pertinenza del papato, quest’ultimo ne avrebbe configurato direttamente il volto politico e istituzionale senza sopportare opposizione di sorta.
Per tutto ciò un negoziato fra parti connotate da visioni del potere così differenti non avrebbe potuto mai condurre a un accordo duraturo.
Pag. 486
Gli storici moderni tuttavia non hanno guardato a Manfredi con molta simpatia.
Essi si sono occupati meno della storia del regno meridionale che non delle prospettive successive della storia italiana.
Essi pensano che l’appoggio a Manfredi fuori dai confini del regno cominciò a vacillare non appena Carlo apparve al di qua della Alpi e considerando inoltre Manfredi un sovrano dello stesso stampo del padre, mostrano pochi rimpianti rispetto al fallimento dei progetti svevi relativi all’Italia intera, delineati come una potenziale minaccia delle libertà cittadine, come un annuncio di un possibile governo autoritario.
Per tali ragioni, la sconfitta di Manfredi è stata considerata più una sventurata vicenda personale che una reale tragedia politica.
Eppure, in un certo senso, la battaglia di Benevento è un passaggio che può essere paragonato alla battaglia di Hastings.
Nessun contemporaneo poteva immaginare che conseguenze avrebbe determinato un semplcie mutamento di dinastia.
Coloro che equivocarono o tradirono Manfredi nel 1266 non avevano modo di intuire cosa sarebbe seguito: essi pensavano unicamente ai propri interessi e al proprio tornaconto senza soppesare il prezzo che avrebbero dovuto pagare.
Le strutture del regno di Federico sopravvissero sotto il dominio angioino e negli anni successivi Carlo divenne la presenza più autorevole della penisola, anche se ogni somiglianza con Federico è solo superficiale.
Gli angioini dovevano infatti il proprio ruolo in Italia all’iniziativa papale, identificandosi essenzialmente come i sostenitori della causa guelfa.
Essi non avevano rivendicazioni da esercitare nei confronti delle forze politiche italiane dislocate fuori dai confini del regno, simili a quelle che gli svevi, in quanto imperatori, avevano a lungo alimentato.
Federico Secondo aveva offerto al regno meridionale la vitale prospettiva di diventare la formazione maggiore e più influente nella penisola: quando il regno passò nelle mani degli angioini fu condannato alla decadenza e alla stagnazione.
Dopo la separazione della Sicilia, determinata dalla guerra dei Vespri (1282), il grande regno di Federico risultò diviso e dominato da due dinastie straniere.
Ciò rappresentava il primo passo verso la subordinazione di tutta l’Italia a una dominazione esterna.
Gli storici sono stati ipnotizzati dalle conquiste delle città italiane settentrionali dopo la caduta di Manfredi e non si sono accorti che la disfatta del regno normanno voluta dal papa portava in sé un significato che andava molto al di là dei destini del Mezzogiorno.
Il papato stesso ne uscì talmente corrotto e indebolito da diventare politicamente dipendente dall’egemonia francese e ciò ebbe conseguenze profonde sul suo sviluppo.
Italia e Germania dal canto loro hanno portato le cicatrici della rovina dell’impero svevo fino a tempi molto recenti.
Paragonando ancora Benevento a Hastings, non è difficile individuare gli elementi di continuità tra le epoche che la battaglia nettamente distingue.
Gli angioini erano pochi e non furono in grado di introdurre grandi cambiamenti, ma lo slancio della monarchia che Ruggero Secondo aveva saputo accendere e che Federico Secondo aveva potuto sostenere adesso cominciò a rallentare.
In qualche modo era il campo di battaglia che avrebbe determinato il futuro di un regno vinto dal ferro delle armi.
Nessun re a partire da Guglielmo Primo a Benevento nel 1156 aveva dovuto combattere personalmente per la sopravvivenza e nessun re era mai stato ucciso in battaglia.
Il temerario eroismo di Manfredi non è un’invenzione del romanticismo, in cerca di miti da ammirare.
Il principe era pronto a morire pur di salvare il regno, pronto a trionfare o a perire nell’impresa che aveva voluto, alla maniera dei suoi grandi predecessori di stirpe normanna.
Un giovane temerario degno di chi l’aveva preceduto: il regno non avrebbe avuto mai più sovrani degni della memoria dei suoi fondatori.
Pag. 491
Bibliografia
Storia del mondo medievale. – Garzanti, 1979
Il Mezzogiorno dai bizantini a Federico Secondo / A. Guillou … et al. – In: Storia d’Italia. – UTET, 1983
Storia dei musulmani in Italia / M. Amari. – Catania, 1933
I normanni e la loro espansione in Europa nell’Alto Medioevo. – Spoleto, SCIAM, 1969
Bizantini e bizantinismo nella Sicilia Normanna / F. Giunta. – Palermo, 1950
La Longobardia meridionale, 570-1077 / F. Hirsch, M. Schipa. – Roma, 1968
Italia meridionale longobarda / N. Cilento. – Milano, 1971
Storiografia e politica nell’Italia normanna / V. D’Alessandro. – Napoli, 1978
La sovranità pontificia sull’Italia meridionale e sulla Sicilia / A. Trombetta. – Casamari, 1981
Villani e cavalieri nella Sicilia medievale / I. Peri. – Bari, 1993
Tra Roma e Palermo: aspetti e momenti del Mezzogiorno medievale / J. M. Martin. – Galatina, 1989
Storia del Mezzogiorno. – Napoli, 1988
La Sicilia e i normanni: le fonti del mito / G. M. Cantarella. – Bologna, 1989
I longobardi di Claudio Azzara
- Visite: 160
Cap. 1. La nascita della stirpe
La nascita della stirpe dei longobardi come quella di tutte le tribù barbare dell’epoca antica e altomedievale, è avvolta nelle nebbie di un passato remoto sul quale non esistono sufficienti fonti storiche che siano in grado di far luce in misura adeguata.
La cultura dei barbari era orale e quindi dall’interno di quel mondo non sono giunte a noi, perché non furono prodotte, testimonianze scritte se non in tarda età, dopo l’acculturazione delle diverse etnie a contatto con la civiltà romano-cristiana.
Dal canto loro, gli autori romani trascurarono quelle genti finché esse non entrarono in contatto con l’impero e comunque non furono in genere interessati a fornirne precise e particolareggiate descrizioni e a raccontarne la storia.
La genesi delle varie tribù barbare è dunque taciuta o, in alcuni casi, ricostruita a posteriori in maniera approssimativa quando non addirittura fantastica.
Pag. 7
Cap. 2. Dalla Scandinavia alla Pannonia
Durante il successivo regno di Vacone i longobardi sottomisero gli svevi che erano insediati nelle province della Valeria e della Pannonia 1. (cioè in gran parte dell’odierna Ungheria) e strinsero importanti alleanze con diverse stirpi attraverso al politica matrimoniale del loro monarca, che sposò prima la figlia del re dei turingi, poi quella del re dei gepidi, infine quella del re degli eruli.
In questo modo essi si assicurarono rispettivamente la protezione del confine settentrionale del loro dominio, di quello a est, e la possibilità di inglobare nel proprio esercito gli eruli sopravvissuti alla guerra.
Infine, Vacone fece sposare due sue figlie con dei principi franchi, alleandosi quindi anche con questa fortissima tribù occidentale, e strinse accordi con Bisanzio.
Insomma, durante il quasi trentennale regno di Vacone (all’incirca dal 510 al 540) i longobardi riuscirono a consolidare una grande dominazione che andava dalla Boemia all’Ungheria e che era ben inserita nel quadro geopolitico internazionale.
Pag. 16-17
Cap. 3. L’invasione dell’Italia
Nella primavera del 569 (o l’anno precedente secondo altri calcoli) i longobardi fecero irruzione in una penisola italiana che scontava ancora le conseguenze della terribile guerra che per quasi vent’anni, dal 535, aveva opposto l’Impero bizantino, retto allora da Giustiniano, al regno dei goti, e che si era chiusa con la disfatta di quest’ultimo.
Il lungo conflitto aveva sconvolto molte regioni, soprattutto al centro-sud, con un crollo demografico che si accompagnava allo spopolamento di vaste aree, alla rovina di numerose città e di molte infrastrutture ereditate dall’epoca romano-imperiale (a cominciare dal sistema stradale), alla crisi delle attività economiche e produttive.
Inoltre, il reintegro dell’Italia nell’Impero, in sostituzione del dominio dei goti, non era stato accolto con favore da tutta la popolazione indigena, che avvertiva i militari e i funzionari imperiali, provenienti dall’Oriente, come stranieri (malgrado agissero nel nome di Roma) e che mal tollerava l’opprimente pressione fiscale imposta dalle autorità a un paese dissanguato dagli eventi bellici.
Pag. 19
Sfondato il confine, occupato il Friuli, i guerrieri di Alboino subito dopo dilagarono per il Veneto, quindi, nel giro di tre anni, entrarono in Lombardia, si spinsero fino al Piemonte e, oltrepassato il Po, fecero irruzione in Emilia e in Toscana.
Nelle loro mani caddero molte delle più importanti città dell’Italia settentrionale, comprese le due sedi di residenza predilette da Teodorico, cioè Verona e Pavia, e la vecchia capitale tardoimperiale, Milano.
La presa di possesso del territorio avvenne però in maniera disorganica.
Diverse tra le più salde piazzeforti tenute dai bizantini furono aggirate dai longobardi, anziché prese d’assalto, per non sfiancarsi in assedi prolungati e difficili da sostenere (anche per le limitate capacità poliorcetiche dei barbari); inoltre, fu debole l’effettivo coordinamento politico-militare delle operazioni da parte del re, poiché i guerrieri si muovevano in bande ciascuna delle quali sottostava al comando del proprio capo, chiamato dalla fonti col termine latino di dux (duca), desunto dal lessico militare tardoromano.
Pag. 21
Al termine di questo periodo di governo ducale, che fu particolarmente turbolento con un aumento dei saccheggi a danno dei romani, la consapevolezza che un assetto politico-istituzionale frantumato, e con strategie discordi, esponeva a grandi rischi di fronte ai tentativi dei bizantini di riconquistare almeno una parte dei territori occupati dai longobardi convince i duchi a creare re il figlio di Clefi, Autari.
Per rendere più solido il potere di una base economica, un patrimonio del re, cedendogli ciascuno la metà dei propri beni: per tutto il regno, da allora, si ebbe all’interno di ogni ducato proprietà fiscali regie, denominate curtes, rette da ufficiali di fiducia del monarca, i gastaldi.
Ad aumentare i timori dei longobardi, tanto da convincerli a darsi di nuovo una guida unitaria, fu anche l’accordo stipulato in quel periodo dall’impero con i franchi, loro tradizionali nemici, i quali nel 584 effettuarono scorrerie al di qua delle Alpi.
Pag. 23
A fronte di un simile quadro generale, la preoccupazione di Autari (584-590) e poi del suo successore Agilulfo (591-615) fu quella di garantire quanto più possibile uniformità territoriale al regno, rafforzandone i confini esterni, riassorbendo le diverse enclaves imperiali che sopravvivevano al suo interno e sottomettendo con patti o con la forza delle armi i duchi refrattari all’autorità del monarca (come, tra gli altri, quelli di Treviso, Verona, Bergamo, Trento, Cividale).
Allo stesso tempo ci si sforzò di contenere i franchi, tramite accordi diretti o alleandosi in funzione anti franca con altre stirpi transalpine, coem quella dei bavari.
Per questo motivo Autari sposò la principessa bavara Teodolinda, che, una volta rimasta vedova, scelse come nuovo marito il duca di Torino Agilulfo, trasferendogli la dignità regia.
Pag. 24-25
Nell’autunno del 593 Agilulfo, spingendo la propria incisiva azione militare fino alle regioni dell’Italia centrale, giunse alle porte di Roma e mise sotto assedio la città.
Questa, mal difesa dalle truppe bizantine, da tempo sentiva stringere attorno a sé la morsa longobarda, rappresentata non solo dall’avanzata del re, ma soprattutto dalle ripetute scorrerie dei più vicini duchi di Spoleto e di Benevento.
Nell’emergenza la tutela della popolazione romana fu assunta dal pontefice, che allora era Gregorio magno.
Costui si era fatto carico delle diverse incombenze ormai trascurate dai funzionari imperiali, comprese la cura degli approvvigionamenti e perfino l’organizzazione della difesa delle mura urbane, non solo per la città di cui era vescovo, ma anche per diversi altri centri dell’Italia centrale e meridionale, come, ad esempio, Nepi o Napoli, consapevole della responsabilità verso il gregge di fedeli a lui affidato che discendeva dal suo ufficio pastorale in quanto vescovo e metropolita.
Si trattava di una condotta da lungo tempo divenuta familiare ai vescovi dell’Occidente, i quali, di fronte alla progressiva disgregazione dell’ordinamento imperiale, avevano dovuto surrogare le magistrature dello Stato, spesso mettendo a frutto l’educazione che avevano ricevuta provenendo essi stessi in larga misura da famiglie aristocratiche e talora, come nel caso di Gregorio Magno, avendo maturato esperienze di funzionario civile prima di abbracciare la carriera ecclesiastica.
Gregorio cercò sempre di collaborare con gli ufficiali imperiali, ma di fronte all’inerzia di questi none sitò a prendere iniziative autonome, avviando trattative con i longobardi e attirandosi perciò i rimproveri dell’esarca e dell’imperatore, che lo accusarono di ingenuità o addirittura di intelligenza con il nemico.
Per tutta la durata del suo pontificato egli insistette sulla necessità di un accordo di pace generale tra l’Impero da una parte e il Regno e i due ducati di Spoleto e Benevento dall’altra, proponendosi quale mediatore e garante delle tregue, che rimasero sempre di precaria tenuta.
Pag. 26-27
Per i piccoli proprietari e per i contadini lo stanziamento dei longobardi, anche se non fu certo indolore, ebbe probabilmente conseguenze meno gravi sulle loro condizioni di vita, sebbene la matrice delle fonti scritte, prodotte tutte dalle élite, renda assai complicata ogni concreta valutazione di simili aspetti.
I contadini videro semplicemente nuovi padroni barbari sostituirsi ai vecchi padroni romani, mentre i piccoli proprietari versarono ad altri destinatari i canoni e le prestazioni che già dovevano al fisco imperiale, il quale era forse più meticoloso e opprimente nell’esazione di quanto non lo fossero i nuovi venuti.
Alcune lettere di Gregorio magno fanno cenno del fatto che molte famiglie di contadini preferivano rifugiarsi presso i longobardi piuttosto che sostenere il peso delle imposizioni fiscali richieste dall’impero, che le costringevano a vendere i propri figli per sopravvivere.
Lo stesso papa scriveva anche ad Agilulfo per ricordargli coem fosse nel suo interesse risparmiare la vita dei contadini, del cui lavoro gli stessi longobardi traevano giovamento.
Insomma, una volta attenuatasi la violenza diffusa dei primi tempi, l’esistenza quotidiana di questi ceti dovette riassestarsi su livelli non troppo difformi da quelli dal passato e quindi la loro condizione complessiva non dovette peggiorare.
Nelle città, poi, la popolazione romana, rappresentata e organizzata dal proprio vescovo, e depositaria di saperi e capacità tecniche ed economiche che i longobardi non possedevano, ebbe forse uan capacità ancor maggiore di contrattare con i nuovi dominatori i termini della forzata convivenza.
Abbandonata da tempo la vecchia immagine storiografica, in larga misura ottocentesca, di una popolazione romana asservita dai padroni longobardi e ridotta a uan massa indistinta dai padroni longobardi e ridotta a una massa indistinta di schiavi schiacciata sotto il tallone di un “occupante” straniero, la valutazione oggi generalmente condivisa in ambito scientifico dei rapporti tra le due componenti etniche del regno restituisce un quadro più articolato, in cui la condizione dei romani, oltre che meno cupa nel suo insieme, appare diversificata per contesti sociali, di luogo di residenza (con una dicotomia fra città e campagna) e forse anche doganali.
Nella cultura dei longobardi, l’uomo libero dotato di pienezza di diritti e di capacità politica era soltanto l’exercitalis, o arimanno, vale a dire il maschio adulto in grado di portare le armi, membro dell’assemblea tribale, il thinx o gairerhinx, autentica sede del potere.
I soggetti liberi longobardi che non portavano le armi, coem le donne o i minori, si trovavano in una condizione di detentori di diritti affievoliti, dovendo sottostare alla protezione di un maschio adulto, che interveniva al loro fianco, o per loro conto, nei vari negozi giuridici.
Pag. 31-33
Se longobardi e romani rimasero all’inizio separati, sui piani sociale, giuridico (ciascuno dei due gruppi si regolava secondo il proprio diritto), e talora anche insediativo, la prolungata convivenza e lo stesso scarso numero complessivo dei longobardi favorirono un processo di avvicinamento reciproco che non fu nemmeno tanto lento.
La contiguità fu forte soprattutto nelle città: qui i longobardi si stabilirono nei vecchi edifici romani, installando nei palazzi pubblici la propria amministrazione locale, a cominciare dalla sede del duca, mentre i guerrieri con le loro famiglie trovarono dimora nelle case esistenti, dapprima in quartieri e loro riservati, dai quali potevano controllare tutto lo spazio urbano, e poi, con il tempo, in modo più distribuito, mischiandosi con gli autoctoni.
Tra la popolazione urbana i longobardi erano una piccola minoranza: di fronte a sé avevano la maggioranza romana, organizzata dal vescovo e dal clero cattolico e depositaria di una cultura più adatta a una vita stanziale e cittadina.
I barbari erano inoltre indotti a ricorrere quotidianamente ai servizi degli artigiani e dei mercanti romani.
In simili condizioni era difficile pensare che una minoranza militarizzata, anche se detentrice del potere politico e del monopolio delle armi, potesse conservare a lungo la propria separatezza, senza fare eventualmente ricorso a misure coercitive, quale, per esempio, una legislazione che ostacolasse espressamente gli scambi tra i due gruppi (come avevamo fatto invece i goti),
Di simili iniziative non si riscontra traccia e ben presto si ebbero, tra l’altro, matrimoni misti.
Una spinta determinante alla graduale fusione etnica all’interno del regno tra longobardi e romani, che accelerò i processi di avvicinamento testé accennati, fu costituita dalla conversione dei primi al cattolicesimo, completatasi nel corso del secolo 7. e ufficialmente sancita, al vertice, dal ripudio dell’arianesimo da parte di re Ariperto nel 653.
Tale evoluzione è confermata anche dall’abbandono, proprio alla fine del secolo 7., dell’uso di seppellire con il corredo funerario, a riprova che era stato ormai superato ogni residuo retaggio pagano della stirpe, del resto funzionale a un assetto sociale e a un’identità di gruppo che si erano completamente trasformati.
L’avvenuta fusione è misurabile pure tramite l’analisi di altri elementi, quali la commistione dei nomi propri, con i longobardi che ne adottarono di romani e cristiani e i romani che ne impiegarono a loro volta germanici, o la condivisione della medesima lingua: nell’8. secolo il longobardo sembra essere scomparso dall’uso.
Nello stesso secolo, al tempo di re quali Liutprando, su cui si tornerà, il superamento delle barriere, non solo culturali ma anche giuridiche, appariva ormai definitivamente compiuto e l’intera società del regno mostrava di avere acquisito una fisionomia del tutto nuova.
Pag. 34-36
Cap. 4. Forme di insediamento e organizzazione del territorio
La gens Langobardorum che scese in Italia era organizzata come un esercito in marcia, cioè in distaccamenti militari di exercitales-arimanni, verosimilmente legati fra loro anche da vincoli di parentela e subordinati a un capo (il dux) al quale giuravano fedeltà e ai cui ordini combattevano.
Il termine fara è stato a lungo interpretato da molti studiosi come un equivalente di Sippe, che designava il gruppo parentale germanico, anche sulla scorta di una testimonianza di Paolo Diacono che traduceva la parola longobarda come “generatio vel linea”.
In realtà il vocabolo sembra doversi ricondurre piuttosto a faran, o fahren, equivalente del latino expeditio, e va inteso quindi come indicante, etimologicamente, un distaccamento militare che si separava dal corpo della gens per partecipare a una spedizione.
Per alcuni tale struttura, disegnata su assetti tradizionali, era stata ulteriormente elaborata dai longobardi in occasione della loro militanza nell’esercito imperiale in veste di foederati e fu assunta in modo naturale nel momento della grande impresa Italia.
Pag. 37
Concettualmente la dimora del longobardo, detta con termine latino curtis, costituiva un’unità soggetta alla potestà indiscussa del capo famiglia ed era coperta da una fortissima immunità giuridica, per cui la violazione del suo recinto da parte di estranei rappresentava un reato di straordinaria gravità, punito con la massima durezza.
Chi vi faceva ingresso senza essere autorizzato e senza un valido motivo poteva essere ucciso legittimamente dai residenti.
Pag. 38
Un esempio, tra i diversi possibili, di come l’impressione fornita da un testo scritto abbia generato un’interpretazione imprecisa può essere fornito dalla vicenda di Padova, uan città di primaria importanza nel Veneto romano, che secondo Paolo Diacono sarebbe stata distrutta dalle fondamenta dal re Agilulfo, con conseguente fuga in massa dei suoi abitanti.
In realtà la fonte impiegava nella circostanza una terminologia convenzionale, letterariamente rappresentativa della violenza di un’aggressione di barbari, parlando di un centro urbano divorato dalle fiamme e “raso al suolo” per ordine del re; un esito smentito invece da differenti riscontri, dal lato archeologico alla consapevolezza che non molto tempo dopo Padova riacquistò un ruolo di primo piano negli equilibri regionali, recuperando in fretta abitanti e funzioni, come non sarebbe stato possibile se le sue strutture fossero state rovinosamente distrutte.
Più in generale, per i secoli dell’alto Medioevo, e anche al di là della sola epoca longobarda, viene ora sottoposto a revisione il concetto stesso di decadenza urbana, che si dimostra troppo palesemente condizionato dai modelli di raffronto, storici o ideali, di volta in volta assunti, soprattutto quello della città antica.
Per l’età altomedievale si preferisce adesso parlare di fenomeni di ridefinizione degli spazi urbani in ragione delle mutate esigenze abitative del tempo, anche per il forte calo demografico complessivo, con il verificarsi di fenomeni di selezione, di trasferimento di funzioni, di cambio d’uso delle varie superfici e costruzioni, che non appaiono più interpretabili come casi di semplice abbandono e di regresso.
Il confronto sistematico fra le testimonianze scritte e quelle archeologiche, inoltre, denuncia la difficoltà, e al contempo la necessità, di utilizzare dati per loro natura disomogenei, che spostano continuamente l’analisi per il tema qui considerato dal piano delle rappresentazioni culturali e dei modi di sentire e descrivere a quello delle concrete strutture materiali e della loro evidenza oggettiva.
Pag. 40
Con l’avanzare del processo di romanizzazione e di cristianizzazione, che iniziò molto presto, già nel secolo 7. le tombe longobarde risultano indistinguibili con sicurezza da quelle della popolazione romana (l’unico indicatore certo resta l’eventuale presenza di armi), fino alla totale scomparsa dei corredi, come detto, alla fine del secolo.
Pag. 41
In ogni caso, la sovrapposizione dei diversi indicatori permette di tracciare una carta che mostra una maggiore densità insediativa per il regno lungo tutta la valle del Po, nella valle dell’Adige, strategicamente rilevante, in Friuli e nei territori di particolari ducati quelli di Verona, Trento, Brescia, Reggio Emilia, Torino.
Al di fuori del regno, siti importanti si trovano nei ducati di Spoleto (Castel Trosino, Nocera Umbra) e id Benevento.
Pag. 42
Cap. 5. La costruzione del regno
Durante Il regno di Agilulfo (591-615) e della sua consorte Teodolinda si ebbe un primo consapevole, anche se faticoso, tentativo da parte dei monarchi longobardi di connotare il proprio potere in termini che trascendessero la sola tradizione della stirpe, facendo ricorso pure al bagaglio concettuale e lessicale proprio del modello ellenistico-cristiano della sovranità imperiale.
La ricerca di moduli teorici e “propagandistici” estranei ai valori radicati nella storia e nel mito della gens Langobardorum rispondeva a una duplice esigenza: per un verso quella di emanciparsi, quanto più possibile, dal condizionamento posto dall’assemblea del populus-exercitus, cioè in sostanza dall’aristocrazia di stirpe, depositaria di ogni fonte del potere; dall’altra parte quella di superare una caratterizzazione solo etnica dell’autorità regia, alla ricerca, piuttosto, di una sua definizione territoriale, capace di renderla accettabile anche dai sudditi romani.
Così, ad esempio, nella corona del tesoro del duomo di Monza appariva inciso il titolo di rex totius Italiae anziché quello di rex Langobardorum e il figlio ed erede di Agilulfo, Adaloaldo, venne battezzato nella chiesa di San Giovanni a Monza e poi incoronato all’interno del circo di Milano con uan cerimonia dal forte simbolismo d’imitazione imperiale, dato che il circo nella tradizione romana (e così pure a Bisanzio) si configurava come luogo non solo di spettacoli e gare ma anche di espressione di una specifica comunicazione politica, celebrando l’incontro ritualizzato fra il princeps che compariva nella tribuna a lui riservata tra i simboli del potere e il popolo acclamante assiso sugli spalti.
L’avvicinamento ai romani durante l’età di Agilulfo, nello sforzo di definire su basi più ampie e solide l’autorità regia, si manifestò pure nella ricerca della collaborazione di consiglieri romani, che restano, come detto, poco individuabili, eccetto l’ecclesiastico Secondo di Non, padre spirituale di Teodolinda.
Pag. 45-46
Lo sviluppo della monarchia longobarda nel corso di tutto il secolo 7. fu segnato da un processo di graduale, seppur contrastato, consolidamento della potestas del re, che avvenne attraverso strumenti quali un più sicuro controllo militare del territorio, all’interno e verso l’esterno, l’accentuazione della tendenza all’ereditarietà della carica in senso dinastico (comunque mai raggiunta), in sostituzione dell’antica consuetudine dell’idoneità personale, tramite conquista militare del potere o legittimazione mediante il matrimonio con la vedova o una figlia del predecessore, l’incremento del patrimonio regio, potenziato anche dalle misure di legge che rendevano il fisco regio destinatario di una quota rilevante delle composizioni, cioè delle somme di indennizzo previste per una vasta serie di reati.
Pag. 48
Tuttavia, se simili coloriture letterarie condizionano il modo di raccontare una vicenda, dando spazio anche a elaborazioni di fantasia, non escludono alcuni elementi concreti: in primo luogo il fatto che durante i due secoli di vita del regno longobardo in Italia le lotte di palazzo, combattute entro la corte, e la costituzione violenta di un re in carica con un nuovo monarca non furono certo rare; inoltre, l’impressione che l’insistenza su una siffatta maniera di rappresentare i conflitti a corte rispondesse a una percezione diffusa, condivisa da chi scriveva e dal pubblico dei lettori, di quali fossero i modi e i luoghi di espressione della lotta politica.
La corte, insomma, era vista non solo come la struttura di sostegno e la sede d’esercizio dell’autorità del re, ma anche come il principale teatro dello scontro per il potere.
Pag. 57
Gli anni di governo del re Rotari (636-652) costituirono un momento di particolare significato nell’opera di consolidamento territoriale e politico del regno.
Innanzitutto egli dimostrò di saper imporre con la forza la disciplina ai duchi più irrequieti; inoltre, si rese protagonista della campagna militare contro i bizantini più impegnativa e fortunata dai tempi di Agilulfo, strappando territori all’impero sia a ovest, con la conquista della costa ligure, sia a est, dove l’avanzata nel cuore del Veneto respinse gli imperiali nella regione entro il solo ambito lagunare, scacciandoli dalla terraferma.
In seguito alle operazioni condotte da Rotari trovò uan sistemazione più netta e stabile l’assetto geopolitico della penisola italiana, già delineatosi nei suoi tratti essenziali all’indomani dell’invasione.
A circa settantacinque anni da questa, l’Italia risultava sostanzialmente bipartita in modo più omogeneo fra la dominazione longobarda e quella imperiale, con la prima che si estendeva su quasi tutto il nord e la Toscana (cioè il regno propriamente inteso), oltre ai ducati autonomi di Spoleto e di Benevento, e la seconda che comprendeva, da nord a sud, le lagune venetiche, Ravenna e la regione esarcale, la Pentapoli (nelle odierne Marche) con il corridoio di castelli appenninici che portava a Roma e la porzione del Mezzogiorno esterna al ducato beneventano (vale a dire, tratti delle coste campana, con Napoli e Amalfi, e pugliese, specie nel Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia).
Rispetto all’epoca ostrogota, durante la quale l’intero territorio della penisola aveva conosciuto un governo unitario, così come era accaduto già in età romana, con i longobardi si verificò uan frantumazione politica che era destinata a incrementarsi e a perpetuarsi fino al risorgimento e all’unità nazionale sotto i Savoia nel 19. secolo.
Va tuttavia tenuto presente che i confini tra le regioni longobarde e quelle imperiali, in ambiti quali quello veneto, quello emiliano-romagnolo, quello umbro-marchigiano-laziale, una volta superate le contingenze di emergenza militare ebbero un carattere di sostanziale permeabilità, lasciando ampio spazio alle frequentazioni tra gli uomini delle due parti e ai flussi di merci e di modelli culturali.
Come emerge sempre più dalle ricerche in corso sull’argomento, le frontiere dell’Italia altomedievale non funzionarono affatto quali barriere capaci di separare in modo rigido le dominazioni diverse, ma figurarono piuttosto come fasce di territorio fluide e indeterminate, anche per la scarsa capacità di un loro controllo puntuale, anche per la scarsa capacità di un loro controllo puntuale, aperte agli scambi e pronte, in taluni casi, a proporsi addirittura come tessuto connettivo tra realtà politicamente distinte ma socialmente ed economicamente assai vicine.
Le fonti serbano traccia, per esempio, di patti, nell’area veneta, che consentivano agli allevatori di ciascuno die due lati del confine di attraversarlo per portare su pascoli migliori le proprie bestie.
I rapporti economici attraverso la frontiera vennero proibiti per legge solo durante la guerra, come fece Astolfo in concomitanza con la sua campagna militare contro l’esarcato.
Tutto ciò non significa che non ci fosse affatto lo scrupolo di proteggere il confine da ingressi indesiderati: le leggi prescrivevano che chi entrava in Italia dal regno dei franchi per recarsi in pellegrinaggio a Roma, lungo l’itinerario della futura via Francigena, doveva munirsi di un lasciapassare da mostrare a ogni richiesta lungo il cammino.
Chi violava la frontiera per spiare, o chi faceva entrare le spie da oltre confine, era colpito da durissime sanzioni.
Particolarmente tutelati erano i delicatissimi valichi alpini, porta d’accesso all’Italia per ogni invasore passato e futuro (longobardi inclusi).
Lungo la catena alpina i longobardi riutilizzarono il sistema di chiuse già introdotto dai romani e sfruttato dai romani e sfruttato dai goti, che aveva il compito di serrare le vie d’accesso sui passi montani, controllando gli ingressi e, in caso di invasione, cercando di rallentare l’avanzata del nemico dando il tempo agli eserciti stanziati nella pianura retrostante di preparare le difese.
Fu proprio violando una chiusa alpina nella Val di Susa che Carlo magno nel 774 penetrò nel regno, fino a prendere Pavia.
Pag. 62
Le leggi raccolte nell’Editto si applicarono inizialmente ai soli longobardi, mentre i romani del regno continuarono a regolarsi secondo il proprio diritto.
Si può immaginare che, come con gli ostrogoti, particolarmente delicate dovessero risultare le cause miste, sempre più frequenti nel corso del tempo con l’incremento dei rapporti tra i due gruppi etnici, incerte nella loro risoluzione ed esposte a possibili arbitrii da parte della stirpe dominante.
L’ingresso dei romani nell’esercito e di conseguenza nel ceto dirigente, concomitante con la ridefinizione su base non più etnica dell’intera società del regno, condusse però nel secolo 8. all'estensione della validità dell’Editto anche ai romani, con carattere territoriale.
Ciò non significò peraltro l’uniformità giuridica piena, dal momento che continuarono a coesistere nel territorio del regno altri sistemi normativi, tra cui quello romano, che restava il diritto del clero.
Pag. 65
A partire dal 666 si verificò pure l’ultimo deciso tentativo da parte bizantina di rientrare in possesso di almeno una parte dei territori italiani occupati dai longobardi, allorquando lo stesso imperatore Costanzo 2. sbarcò in Puglia e mise sotto assedio Benevento.
Le scarse risorse militari e finanziarie su sui il princeps poteva contare e le pronta reazione del re Grimoaldo, che scese subito nel suo ex ducato alla testa di un forte esercito, costrinsero Costante a riparare dapprima a Napoli, poi a Roma e infine a Siracusa, dove fu assassinato da un uomo del suo seguito nel 668.
Il fallimento del tentativo di Costante confermò come per l’Impero fosse ormai impossibile sperare di riprendersi le regioni perdute in Italia, dovendo accontentarsi piuttosto solo di puntellare i residui possessi, sparsi dal nord al sud specie lungo le coste, che a loro volta si governavano con crescenti margini di autonomia da Costantinopoli.
Un ulteriore fattore della politica dei re longobardi del 7. secolo fu la loro ricerca di un nuovo atteggiamento nei riguardi della chiesa cattolica, non solo, com’è comprensibile, da parte dei monarchi che abbracciarono il cattolicesimo nella seconda metà del secolo, quali Ariperto (653-661), Pertarito (671-688), ma perfino a opera di alcuni loro predecessori ariani, come Arioaldo (625-636).
Una simile attenzione si rese concreta nel susseguirsi di fondazioni di nuove chiese e monasteri per iniziativa regia, oltre che nella protezione loro accordata, fino alla sconfessione ufficiale dell’arianesimo con Ariperto, che guadagnò ai re longobardi la piena solidarietà delle istituzioni episcopali e monastiche, prospettando nuove forme di collaborazione istituzionale.
Pag. 66-67
Cap. 6. L’ottavo secolo: apogeo e rovina
L’ottavo secolo fu decisivo nel perfezionare i diversi processi di trasformazione della società longobarda e di consolidamento delle istituzioni del regno che erano in atto da tempo, giungendo alla definizione di assetti inediti e originali.
Contemporaneamente, un repentino mutamento del quadro politico generale, in termini di buona misura imprevedibili, ebbe quale esito una brusca svolta, l’alleanza in funzione anti longobarda tra il papato e il regno dei franchi, che portò infine, nel 774, alla conquista del regnum Langobardorum da parte del franco Carlo.
Pag. 69
Lo sforzo di consolidamento del potere regio nel corso del secolo ottavo si espresse, in larga misura, oltre che in termini di elaborazione concettuale e nel nuovo rapporto con la chiesa, per mezzo di un’opera che mirava al contempo a creare strutture burocratiche più efficienti e centralizzate e a disciplinare, con la forza o con altri mezzi di controllo politico, le solite spinte centrifughe locali, mai sopite.
Il palazzo di Pavia venne sempre più concepito come un centro amministrativo e id governo, secondo il modello romano, nel quale operavano uffici di cancelleria progressivamente strutturati, che facevano ricorso alla documentazione scritta in precedenza assai poco utilizzata dai longobardi.
Ora le carte venivano prodotte, conservate e sfruttate in misura crescente, anche come prova nei processi.
I vari ufficiali pubblici, centrali o periferici, tendevano ad avere profili definiti e mansioni precise, anche se non è certo possibile pensare a una gerarchia ordinata che rispecchiasse il rigore di quella romano-imperiale o bizantina.
Malgrado l’indiscutibile volontà ordinatrice della monarchia e l’immagine di una qualche coerenza che emerge soprattutto dalle fonti normative, la verifica delle situazioni concrete che si può realizzare attraverso i documenti mostra, al contrario, un quadro ricco di asimmetrie, sovrapposizioni, buchi e apparenti contraddizioni, che non costituiscono un’anomalia rispetto a una piramide ben ordinata che è solo immaginaria (e che costituirebbe un anacronismo, per le condizioni dell’epoca), ma che denunciano piuttosto l’inevitabile natura sperimentale di realizzazioni graduali e non da tutti condivise.
Pag. 76-77
Simili forme di controllo rimanevano, però, pur sempre deboli, consentendo alle aristocrazie locali di continuare a perseguire le proprie strategie, con sufficiente libertà d’azione e spiccata empiria, giocando sugli equilibri politici generali in continua evoluzione, con il crescente ruolo svolto, accanto all’impero, dal papato; e mantenendo come obiettivo di fondo la salvaguardia dei propri interessi personali e della propria identità.
Esemplare risulta al riguardo, tra gli altri casi, la condotta tenuta nell’ultimo, convulso, trentennio di vita del regno longobardo in Italia dai beneventani e dagli spoletini, che alternativamente si collocarono al fianco dei re pavesi oppure fecero riferimento, all’opposto, al nascente asse franco-pontificio.
In uan tale prospettiva non deve sorprendere quindi se, mentre nel 756 i longobardi di Benevento avevano preso parte all’assedio di Roma insieme con il re Astolfo, appena due anni più tardi venivano presentati, nelle parole rivolte dal papa Paolo 1. al re franco Pipino, quali ottimi alleati su cui poter contare contro Pavia, tanto da lamentare l’aggressione contro Benevento compiuta dal nuovo re Desiderio, che aveva imposto al vertice del ducato un proprio fedele.
Pag. 79
Le emergenze per Bisanzio erano allora costituite piuttosto dal dilagare in oriente degli arabi, accelerato dal collasso dell’Impero sassanide avvenuto nel secolo precedente, e dalla pressione nei Balcani di bulgari e slavi, che portavano una minaccia diretta alla stessa capitale.
Per queste ragioni l’investimento di risorse finanziarie e militari in Italia dovette necessariamente essere ridotto al minimo, lasciando l’incombenza di fronteggiare i longobardi alle realtà bizantine locali, le quali, da parte loro, pur se continuavano a riconoscersi politicamente nell’impero, avvertivano ormai in maniera evidente tutta la propria lontananza dal cuore dello stesso e vivevano in uno stato di sempre più spinta autonomia di fatto.
Pag. 80
Il crollo dell’esarcato, rimuovendo l’estremo cuneo imperiale nel cuore dell’Italia longobarda, lasciò campo aperto a evoluzioni ulteriori dagli esiti potenzialmente ancor più radicali: il regno aveva ora l’opportunità di estendersi a tutta la penisola, inglobando al proprio interno la stessa Roma.
Agli occhi dei papi non rappresentavano affatto garanzie rassicuranti al fede cattolica dei re longobardi e la loro pretesa di proporsi addirittura quali difensori della chiesa.
La soddisfazione per le cessioni al patrimonio di San Pietro effettuate da Ariperto e da Liutprando non bilanciava, nel racconto del Liber Pontificalis romano, l’angoscia per lo stringersi del cappio longobardo attorno a Roma, con uno stillicidio di occupazioni di città e di castelli.
Viva era la memoria di come Liutprando, nella sua campagna contro Spoleto e Benevento, avesse potuto agevolmente accamparsi nella piana compresa tra il Tevere, il Vaticano e Monte Mario, minacciando i romani e venendo placato solo dall’intervento del papa, in conformità con il solito paradigma introdotto da Leone con Attila e rinnovato da Gregorio Magno con Agilulfo.
Pag. 81
Di fronte alla crescente minaccia longobarda, constatata la debolezza di Bisanzio con cui si era oltretutto in urto sul culto delle icone, ai papi non era rimasto allora che cercare l’aiuto dell’unico interlocutore presente sulla scena che apparisse in grado di soccorrerli in maniera efficace; vale a dire il regno dei franchi, nel quale il maestro di palazzo di Austrasia Pipino il Breve aveva da poco soppiantato la dinastia dei Merovingi.
Da costui, a Ponthion, si era recato personalmente il papa Stefano 2., nel 754, per sollecitare un intervento dei franchi in Italia, allo scopo di strappare ai longobardi tutti i territori già appartenuti all’esarcato e di affidarli alla chiesa di Roma, che si proponeva ormai come la sostituta dell’impero in Italia nella rappresentanza e nella tutela delle popolazioni romane.
Quest’ultimo attributo rivestiva a quest’epoca un’accezione meramente politica, cioè identificava coloro che abitavano province già imperiali da poco occupate dai longobardi, come l’esarcato e la Pentapoli, per contro al regno longobardo propriamente inteso, e non aveva dunque più alcuna connotazione etnica, dal momento che, coem si è detto, gli stessi “longobardi” del tempo erano in realtà un ceto dirigente etnicamente misto.
Pag. 83
Peraltro, a differenza di quanto era occorso in Italia con la breve parentesi ostrogota, con i longobardi si ebbe la genesi di una nuova società e di una nuova cultura, almeno in un’assai ampia porzione del paese.
La conclusione del regno longobardo non ebbe un carattere di inevitabilità nei modi in cui si svolse, ma scaturì piuttosto dalla combinazione di fattori contingenti, per il precipitare di fenomeni di larga scala che andavano maturando da tempo ma che conobbero d’un tratto accelerazioni improvvise e svolte imprevedibili.
Si combinarono insieme, nel giro di pochi decenni, l’impossibilità per il papato di superare l’antica diffidenza politica e la sostanziale estraneità culturale verso i longobardi, malgrado la loro conversione al cattolicesimo, il definitivo disimpegno dall’Italia dell’Impero bizantino, che si accompagnava al processo di crescente divaricazione politica e culturale fra le sue province italiche e il suo baricentro greco-orientale, l’improvvisa saldatura d’interessi fra Roma e la dinastia franca dei Pipinidi, bisognosa a sua volta della legittimazione dei pontefici per giustificare la propria presa del potere violenta a danno dei Merovingi.
Pag. 85
Le diverse parti della penisola italiana si trovarono dunque sottoposte, in seguito all’avvento dei franchi, a dominazioni politiche distinte, con il nord assorbito nella sfera carolingia e il sud ripartito fra longobardi e bizantini (prima dell’ulteriore sopraggiungere degli arabi in Sicilia), venendo così a far riferimento ad ambiti anche culturali distinti.
Tutto ciò, comunque, non impedì affatto gli scambi e gli incroci di esperienze e modelli istituzionali, sociali, economici e culturali di diversa matrice, a formare un quadro d’insieme particolarmente ricco e fertile.
Pag. 86
Cap. 7. Il Ducato di Spoleto
Se in momenti del genere non mancarono motivi di contrasto tra i papi e i duchi di Spoleto, è anche vero, a riprova dell’estrema fluidità degli schieramenti in campo, che nello stesso giro di anni gli spoletini intervennero in armi al Ponte Salario, con altri longobardi delle regioni limitrofe e a fianco dei cittadini romani, per difendere il papa Gregorio Secondo dal tentativo di cattura messo in atto dalle forze imperiali, decise a costringerlo ad accettare i decreti iconoclastici.
E, da qualche tempo dopo , lo stesso Transamondo, cioè colui che aveva aggredito Gallese, e che aveva giurato fedeltà al re Liutprando attorno al 729, riparò a Roma, ponendosi sotto la protezione del pontefice Gregorio Terzo e del duca di Roma Stefano, quando Liutprando marciò su Spoleto per imporre al vertice dei ducato un proprio uomo, do nome Ilderico.
Pag. 90-91
Nel momento del collasso del regno dei longobardi e della sua conquista per mano del franco Carlo, mentre il duca di Benevento Arechi si autoproclamava erede della tradizione politica autonoma dei longobardi assumendo il titolo di princeps e garantendo l’indipendenza della sua gente, le aristocrazie spoletine, preoccupate piuttosto di salvaguardare la propria egemonia sociale e politica locale, non trovarono altra soluzione che quella di individuare nel papato romano il proprio termine di riferimento e di garanzia.
Si trattò di una scelta che, se in buona sostanza, risultava priva di alternative in quella specifica contingenza, era tutt’altro che nuova nella condotta dei longobardi di Spoleto, i quali a più riprese nel corso del secolo ottavo si erano rivolti a Roma quando avevano voluto controbilanciare la montante pressione dei re di Pavia, in un gioco di equilibri sempre precari, ridefiniti volta per volta.
Alla fine del 775 Ildeprando di Spoleto si sganciò dall’alta protezione del papa, che pure egli stesso aveva ricercato, per subordinarsi direttamente alla potestà del nuovo dominatore Carlo.
I missi del re franco ricevettero i sacramenta del duca longobardo.
Solo nel 781 il papa avrebbe formalmente rinunciato a Spoleto in cambio di una porzione della Sabina, il cosiddetto patrimonium Sabinense, il cui scorporo danneggiò non poco sul piano economico diversi individui eminenti del ducato spoletino, che vi avevano loro proprietà.
Nel 779 Liutprando si recò di persona da Carlo a Vircinianum (Verzenay, vicino a Reims) per ribadire la propria fedeltà al sovrano.
Con questo atto il vecchio ducato longobardo di Spoleto cessò la propria esistenza autonoma, sempre difesa in passato con tenacia e a ogni costo, seppur con fortune alterne, di fronte ai re longobardi di Pavia, per sottomettersi al potere dei franchi e inserirsi nel nuovo ordine politico e istituzionale carolingio.
Pag. 94
Cap. 8. La “Langobardia” meridionale
Con Grimoaldo si ebbe forse un’opportunità di più piena integrazione territoriale di tutta l’Italia longobarda, compresi cioè i due ducati autonomi di Spoleto e di Benevento, ma essa non venne colta e svanì del tutto con la sua morte per un incidente di caccia e l’ascesa al trono dell’esule Pertarito.
In questa vicenda si espressero ancora una volta i cronici antagonismo tra i diversi schieramenti dell’aristocrazia, un blocco friulano legato a Benevento da una parte e uno occidentale (sostenitore di Pertarito), lungo l’asse Pavia-Asti, dall’altra, che sempre impedirono un assetto per davvero unitario del potere longobardo e un pieno rafforzamento in senso dinastico della carica regia.
Tra la fine del secolo settimo e gli anni Trenta dell’ottavo alcuni duchi di Benevento, Romualdo 1., Gisulfo 1. e Romualdo 2., aumentarono la superficie del ducato conquistandosi Brindisi e Taranto, sottoponendo quindi alla propria autorità quasi tutta la Puglia, e avanzando nel Lazio, fino alla valle del Liri.
Da questo momenti i bizantini si accontentarono di difendere il poco che loro rimaneva (Napoli e le costiere sorrentina e amalfitana, il Salento, la Calabria meridionale) e non costituirono più una minaccia per i duchi, i quali dovettero piuttosto guardarsi dalle pretese dei vari re longobardi, a cominciare da Liutprando e fino a Desiderio, di portare Benevento sotto il loro diretto controllo.
Pag. 96-97
Contro la nuova realtà longobarda del Mezzogiorno si appuntò subito l’ostilità dei pontefici, che stimolarono Carlo magno a condurre una spedizione al sud nel 786/787.
Arechi si asserragliò subito a Salerno e convinse il franco a ritirarsi dopo averne riconosciuto la sovranità e avergli concesso un tributo e dato in ostaggio il proprio figlio di nome Grimoaldo.
Allo stesso tempo però Arechi riallacciò i rapporti con Costantinopoli, cui promise fedeltà: s’inaugurò allora una lunga stagione in cui Benevento per salvaguardare la propria indipendenza dovette giocare costantemente su due sponde, barcamenandosi tra i due grandi imperi con spregiudicato pragmatismo.
Pag. 99
Una nuova fase della vicenda storica della Longobardia meridionale, ormai tripartita fra Benevento, Salerno e Capua, si aprì in seguito alla morte di Ludovico 2., nell’975, e all’affievolirsi dell’ascendente carolingio sul mezzogiorno d’Italia, dopo anni di assidua presenza e pure di collaborazione con i longobardi in funzione anti saracena.
Gli arabi erano diventati un problema per l’Italia meridionale almeno dalla metà del 9. secolo, quando, dopo aver militato come mercenari per i principi longobardi in lotta fra loro, avevano preso ad agire in proprio, razziando diffusamente e anche conquistando una città dell’importanza di Bari, che era stata ordinata in emirato.
Ludovico 2. aveva condotto diverse spedizioni anti saracene nel Mezzogiorno, con il sostegno dei longobardi, anche se alla fine, entrato in urto con loro, era stato tenuto prigioniero per quaranta giorni a Benevento.
Il vuoto politico lasciato nel sud dai Carolingi nell’ultimo quarto del 9. secolo fu colmato da Bisanzio, cui allora soprattutto le città pugliesi si rivolsero per essere protette dalla costante minaccia araba.
Tra l’881 e l’883 i saraceni avevano razziato anche i due grandi monasteri di San Vincenzo al Volturno e Montecassino.
La flotta di Costantinopoli riuscì allora a riprendere il controllo di numerosi centri costieri in Puglia (tra cui Taranto) e in Calabria, mentre truppe di terra dell’impero aiutarono Guaimario 1. di Salerno contro la roccaforte di Agropoli.
Pag. 102-3
Nella seconda metà del 10. Secolo, un mutamento del quadro internazionale, con l’affermazione in Occidente della dinastia imperiale ottoniana, e il conseguente ennesimo riposizionarsi dei longobardi meridionali a fianco degli imperatori germanici e contro Bisanzio, coincise con al massima espansione dell’egemonia capuana sull’intero Mezzogiorno longobardo, grazie all’azione di Pandolfo Capodiferro (961-981).
Resosi longa manus di Ottone nell’Italia del sud, Pandolfo compattò sotto il proprio controllo tutta la Langobardia, non solo acquisendo Salerno, ma anche limitando l’influenza dei pontefici romani tramite la creazione delle metropoli ecclesiastiche di Capua e di Benevento.
Le chiede del Mezzogiorno, prima incardinate direttamente alla Sede di Roma, trovarono ora un termine di riferimento negli episcopati che coincidevano con le città principesche e che erano magari retti da congiunti del principe stesso (come Giovanni, fratello di Pandolfo, imposto come presule di Capua).
Dopo che Ottone ebbe concesso al fedelissimo Pandolfo anche il ducato di Spoleto (che rimase ai capuani-beneventani fino al 982) e la marca di Camerino, il longobardo si trovò a essere il signore più potente di tutta l’Italia centro-meridionale.
Peraltro nemmeno l’energica opera accentratrice di Pandolfo, abile nello sfruttare la congiuntura internazionale a proprio favore, riuscì a contrastare le spinte autonomistiche dal tempo in atto e negli anni 981-982 anche i principati tornarono a separarsi.
Con la sua morte, infatti, la sua vasta creazione politico-territoriale unitaria andò in frantumi: sia a Salerno sia a Benevento i suoi eredi designati furono cacciati e sostituiti da esponenti locali e la stessa Spoleto fu consegnata a Transamondo 3., il figlio del conte di Chieti.
Pag. 104-5
La vera novità del quadro italo-meridionale del tempo era tuttavia data dalla comparsa sulla scena di un protagonista destinato ben presto a far saltare ogni equilibrio e a provocare la rovina finale dei longobardi.
Dalla fine del 10. secolo cavalieri normanni erano stati reclutati dai vari principi longobardi per essere impiegati come mercenari nelle incessanti guerre intestine ai due principati e al ducato capuano e contro i bizantini.
I normanni avevano combattuto al soldo di tutti ma avevano poi assunto iniziative autonome, consapevoli sia delle grandi ricchezze e quindi delle opportunità di bottino che il Mezzogiorno, malgrado tutto, offriva sia della debolezza militare e politica dei loro stessi reclutatori.
Soprattutto dopo la vittoria da loro riportata sugli eserciti del papa a Civitate nel 1053 e l’immediatamente successiva alleanza con la chiesa di Roma, ai normanni si offriva l’opportunità di procedere alla conquista di un sud che, dissanguato dalle ripetute guerre e indebolito dalla frammentazione politica, appariva ormai alla loro mercé.
Capua cadde nelle loro mani nel 1057, quando ottenne il controllo della città il conte normanno Riccardo di Aversa.
A Benevento nel 1053 il principe Landolfo 6. si sottomise al papa Gregorio 7., portando a definitiva realizzazione un orientamento già delineatosi da almeno un ventennio.
La città, originaria sede del ducato longobardo e cuore dell’intera Langobardia meridionale, passò così sotto il dominio diretto della chiesa di Roma, che la governò tramite rettori scelti tra il patriziato locale.
L’ultima a cedere fu Salerno, difesa fino al 1076 da Gisulfo 2., ma infine, rimasta ormai isolata, costretta ad arrendersi nelle mani di Roberto il Guiscardo, che l’affidò al figlio, il duca Ruggero Borsa
Pag. 103
Cap. 9. I longobardi nella storia d’Italia
Il periodo della storia d’Italia compreso tra la fine dell’Impero romano d’Occidente nel 476 e la conquista delle regioni centro-settentrionali della penisola già appartenute al Regno dei longobardi a opera di Carlo Magno nel 774 ha tradizionalmente goduto nel suo complesso di un limitato interesse storiografico e di una valutazione nella sostanza negativa, in quanto bollato come un’epoca non solo di generale declino nei diversi campi delle istituzioni, dell’economia, delle strutture sociali, della cultura, rispetto al precedente della Roma imperiale, ma anche di arretratezza in confronto alle posteriori e più significative realizzazioni originali del Medioevo italiano, dalla civiltà comunale fino allo splendore dell’Umanesimo e del Rinascimento.
L’arco cronologico che comprese il breve governo del capo barbaro Odoacre, il regno dei goti fondato da Teodorico l’Amalo e il più lungo regno dei longobardi (cioè, in totale, dall’anno 476 all’anno 774), con la minima parentesi della restaurazione del potere imperiale per iniziativa di Giustiniano tra il 554 e il 568, destinata a perpetrarsi in seguito solo in alcune regioni della penisola, è stato, insomma, a lungo ridotto a cupo intervallo nel fluire della storia patria, a una vera e propria “epoca buia”, esito dell’”assassinio” della civiltà romana per mano dei barbari invasori, incapaci di costruirne uan nuova e di lasciare alcuna eredità significativa ai secoli successivi.
Solo una volta superato tale diaframma la vicenda storica della penisola avrebbe ripreso a scorrere verso nuovi brillanti risultati, frutto anche della riscoperta dell’eredità classica in età umanistica.
Una simile lettura dell’alto Medioevo “barbarico” dell’Italia è stata innanzitutto influenzata, in misura determinante, dal pregiudizio circa l’indiscussa eccellenza dell’antichità romana, in senso quasi più assoluto che storicamente determinato, spesso considerata quale fondamento della tradizione italiana più autentica.
Basti pensare, a questo proposito, all’esaltazione della classicità romana compiuta dal fascismo, pronto a indicare una pretesa linea di continuità diretta, perfino in termini razziali, fra gli antichi romani e gli italiani del secolo 20. e fra la politica, estera e interna, della Roma imperiale e quella del regime di Mussolini.
Inoltre, la riluttanza a formulare un giudizio obiettivo, scientifico, sull’età delle dominazioni barbare è stata conseguenza anche della singolare capacità di quei secoli di prestarsi a letture impropriamente attualizzanti: immediata è risultata infatti la creazione di un parallelismo più o meno consapevole tra l’”assoggettamento” degli italici dei secoli 5.-8. a stirpi “germaniche” quali quelle dei goti o dei longobardi e la subordinazione politica di buona parte dell’Italia agli austriaci nel secolo 19. o all’occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale.
In questo quadro d’insieme, il periodo longobardo, con tutte le complicazioni che presentò (il rapporto fra un’etnia immigrata dominante e una maggioranza romana politicamente subordinata, la bipartizione politica della penisola tra le regioni occupate dai nuovi arrivati e quelle rimaste all’impero, dopo lunghi secoli di unità, l’assunzione di un ruolo politico da parte del papato, a difesa dei valori della romanità cristiana), da sempre si è prestato a deformazioni di prospettiva e di giudizio.
Ben nota è la lettura che ne è stata fatta durante il Risorgimento negli ambienti cattolico-liberali antiasburgici, immortalata in letteratura dalla tragedia di Alessandro Manzoni Adelchi, ambientata per l’appunto nell’Italia longobarda: l’asserita, ma in realtà inesistente, schiavitù dei romani sotto il giogo degli “occupanti” longobardi simboleggiava la sottomissione degli italiani del 19. secolo al potere della casa d’Asburgo.
Analogamente, in pieno Novecento gli echi della drammatica occupazione tedesca hanno indotto molti storici a respingere il contributo alla costruzione dell’identità italiana di un “popolo giovane” quale poteva essere etichettato quello longobardo sulla scia della repulsione per le teorie razziste del nazismo.
Non sono mancate nel tempo anche forme di rivalutazione della vicenda longobarda che rappresentarono attualizzazioni di segno opposto rispetto a quelle elencate in precedenza, ma che pure risultano altrettanto criticamente infondate.
Così Niccolò Machiavelli poté scorgere nella fine del regno dei longobardi per iniziativa dei papi e dei loro alleati franchi l’”occasione mancata” di una possibile unificazione politica della penisola sotto i re longobardi, nonché il primo episodio della per lui biasimevole prassi, costante nella storia d’Italia, di far intervenire gli stranieri (qui, i franchi) nella contesa politica nazionale.
Dal canto loro, gli illuministi dimostrarono di apprezzare molto l’azione da loro attribuita ai longobardi contro la chiesa (o, meglio, contro il papato) e le sue ingerenze temporali.
Insomma, siano stati visti come i potenziali artefici di un regno “italiano” unitario e i paladini di un’opposizione alla “prepotenza” pontificia, oppure, al contrario, come un corpo estraneo rispetto all’identità nazionale, mai assimilato e infine rimosso proprio dalla chiesa, vera custode della tradizione romano-cristiana, e comunque percepiti sempre come rozzi al cospetto di una civiltà incomparabilmente superiore, i longobardi hanno di rado beneficiato di un’analisi che non fosse condizionata da tesi precostituite.
Le eccezioni in passato sono state scarse e si possono osservare soprattutto nel grande sforzo storiografico compiuto dal pioniere della longobardistica italiana, Gian Piero Bognetti, di proiettare la vicenda longobarda su uno sfondo più ampio della sola storia nazionale, quale incontro di civiltà su dimensioni europeo-mediterranee.
Oggi sul piano della ricerca scientifica l’attenzione per i secoli “barbari” della storia d’Italia appare più viva ed è contraddistinta da nuovi approcci epistemologici e metodologici, in gran parte interdisciplinari, coinvolgendo anche diversi studiosi stranieri (mentre gli altomedievalisti italiani restano nel complesso pochi).
A tutto questo concorrono sia una prospettiva più generalmente europea della ricerca, capace di scavalcare nello studio del passato i confini geopolitici attuali emancipandosi dalla pura storia nazionale, sia un miglior incrocio di fonti di natura diversa e di differenti specialismi.
Appare soprattutto importante la propensione ad adottare una nuova periodizzazione capace di abbattere lo steccato convenzionale tra l’età classica e il Medioevo, per considerare piuttosto una lunga epoca di transizione fra il mondo antico e quello medievale in cui le trasformazioni, le persistenze, le radicali innovazioni vengono ricostruite e valutate sui tempi lunghi, al di fuori degli stereotipi del tipo “continuità/decadenza”.
Con approcci di tal genere si svuotano di significato le vecchie classificazioni e convenzioni e si può rinnovare in profondità la ricerca, recuperando al grande fluire della storia d’Italia anche l’esperienza longobarda, senza pregiudizi di sorta.
Negli ultimi decenni in Italia uan rinnovata attenzione per i longobardi sembra testimoniata anche dal buon successo riportato presso un pubblico più vasto di quello dei soli specialisti di diverse mostre e iniziative loro dedicate, spesso anche con realizzazioni su scala locale e di piccola entità, o con espliciti fini didattici e divulgativi, a cominciare dalla grande mostra tenutasi in Friuli, tra Cividale e Passariano, nel 1990.
In questo fenomeno talora giocano anche, accanto alle più serie motivazioni scientifiche, facili mode pseudo-culturali o perfino qualche strumentalizzazione politica, per esempio quando si vogliono individuare asserite componenti “germaniche” delle regioni dell’Italia settentrionale per contro a quelle “romane” del centro-sud nel tentativo di contrapporre un’area settentrionale sviluppata perché parte integrante dell’Europa continentale, anche in forza di tali sue pretese radici etniche, a una meridionale, “naturalmente” appartenente a un contesto mediterraneo più arretrato.
Qualche volta la dicotomia fra origini “longobarde” e “romano-bizantine” si esprime anche nel gioco della contrapposizione di campanile, per esempio tra l’Emilia “longobarda” e la Romagna “esarcale”, o, al sud, tra le “longobardissime” Benevento e Salerno e la “bizantina” Napoli.
Contro le perduranti tendenze a una qualche distorsione (o banalizzazione) dei dati storici appare auspicabile non solo l’ulteriore intensificarsi della ricerca scientifica (con il sistematico incrocio tra il dato archeologico e le fonti scritte) ma anche un’opera di corretta divulgazione storica da parte degli studiosi professionisti, secondo un modello soprattutto anglosassone che in Italia è assai poco seguito.
A smentire ogni sovrastima del peso e della distribuzione delle componenti etniche “germaniche” nella miscela dell’Italia odierna, basti poi rammentare, in primo luogo, come le stirpi barbare immigrate nella penisola, anche se acquisirono il predominio politico come i goti e i longobardi, costituirono pur sempre un’infima minoranza quantitativa rispetto alla massa della popolazione romana.
Inoltre, se il regno longobardo propriamente inteso occupò le regioni del centro-nord, si deve tener conto del fatto che, dopo l’avvento dei franco-Carolingi nel 774, la tradizione politica longobarda autonoma continuò fino all’11. secolo nell’Italia meridionale, che fu quindi in una sua larga porzione longobarda per un totale di oltre quattrocento anni, il doppio del nord.
Ma soprattutto non va mai scordato che le istituzioni e la cultura dell’Italia longobarda ebbero un carattere non certo “etnicamente” puro e distintivo, ma al contrario misto, ibridato, con componenti diverse che non rimasero giustapposte ma si influenzarono a vicenda, adottando di volta in volta le soluzioni più adatte al mutare degli equilibri complessivi e alle esigenze di una società in perenne trasformazione.
Le più tradizionali letture dell’esperienza dei longobardi in Italia hanno in genere posto l’accento sulla drastica rottura degli assetti tardoromani prodotta dall’invasione di questa stirpe.
In qualche modo riecheggiando le testimonianze delle fonti del tempo, molti studiosi hanno insistito a loro volta sulla particolare estraneità culturale dei longobardi rispetto ai valori della civitas romana, sulla radicale disarticolazione dal oro causata degli ordinamenti sia civili sia ecclesiastici dei territori conquistati, sulla rapacità dei loro saccheggi, sulle persecuzioni a danno dei romani, o almeno dei loro ceti dirigenti, e sull’esclusione di questi ultimi della vita politica del nuovo regno.
Con forza è stata marcata al contrapposizione fra gli ordinamenti delle regioni prese dai longobardi e di quelle conservate delle regioni prese dai longobardi e di quelle conservate dall’Impero.
Oggi, invece, l’interpretazione appare assai più articolata e delimitata semmai ai primi tempi dell’invasione gli effetti di più accentuato stravolgimento dei quadri tradizionali e l’antagonismo dell’exercitus barbaro invasore nei confronti della popolazione romana.
Per il resto del percorso storico del regno longobardo in Italia, attraverso tutto il 7. secolo e per quasi due terzi dell’8., si privilegia piuttosto l’individuazione di un processo di progressiva, anche se lenta e non priva di contrasti, acculturazione romano-cattolica della gens Langobardorum e di adattamento dei suoi istituti originari, che portò alla trasformazione degli stessi e a una sostanziale fusione etnico-culturale con l’elemento romano, fino a formare, come detto, una società del tutto nuova e significativa in sé.
Questa, se rimase travolta al nord dall’imposizione del dominio carolingio, fu libera di completare le proprie dinamiche evolutive nella Langobardia meridionale, che si offre pertanto all’attenzione del ricercatori quale campo d’indagine particolarmente interessante e fertile.
I Longobardi devono essere recuperati alla storia d’Italia, e di tutta l’Italia, a pieno e giusto titolo, senza forzature e con rigore scientifico.
E il lascito, contenuto rispetto ad altre esperienze ma non irrilevante, da loro trasmesso alla multiforme identità del nostro paese ha trovato proprio di recente un’importante sanzione nel riconoscimento da parte dell’Unesco del sito seriale I Longobardi in Italia: i luoghi del potere, 568-774 d. C., con il correlato Centro di studi longobardi a Milano, che raccoglie e tutela sette luoghi (Cividale del Friuli, Brescia, Castelseprio, Spoleto, Campello sul Clitunno, Benevento, Monte Sant’Angelo), in cui la presenza di monumenti longobardi ancora integri continua a tramandare la memoria di quella antica stirpe e della sua vicenda italiana.
Pag. 107-112
Bibliografia
Longobardia e longobardi nell’Italia meridionale / a cura di G. Andenna e G. Picasso. – 1966
Le invasioni barbariche / C. Azzara. – 2003
Il regno longobardo in Italia e i tre capitoli / C. Azzara. – In: The crisis of the oikoumene. – 2007
Le leggi dei longobardi: storia, memoria e diritto di un popolo germanico / a cura di C. Azzara e S. Gasparri. – 2005
Invasione o migrazione? I longobardi in Italia / C. Azzara e G. Sergi. – 2006
Il futuro dei longobardi: l’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno / a cura di C. Bertelli e G. P. Brogiolo. – 2000
Roma di fronte a Bisanzio e ai longobardi / O. Bertolini. – 1941
L’età longobarda / G. P. Bognetti. – 1966-68
Origo gentis Langobardorum: introduzione, testo critico, commento / a cura di A. Braciotti. – 1998
Capitali e residenze regie nell’Italia longobarda / G. P. Brogiolo. – In: Sedes regiae. – 2000
I longobardi: dalla caduta dell’Impero all’alba dell’italia / a cura di G. P. Brogiolo e A.Chavarria. – 2007
Il “Liber pontificalis”: i longobari e la nasicta del dominio territoriale della Chiesa romana / L. Capo. – 2009
Paolo Diacono: uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio / a cura di P. Chiesa. – 2000
Italia meridionale longobarda / N. Cilento. – 1971
Le storie dei longobardi: dall’origine a Paolo Diacono / S. M. Cingolani. – 1995
Le antichità germaniche nella cultura italiana da Machiavelli a Vico / G. Costa. – 1977
Mito di una città meridionale, Salerno, secoli 8.-11. / P. Delogu. – 1977
Il Regno longobardo / P. Delogu. – In: Storia d’Italia Einaudi. – 1980
Il Ducato di Spoleto. – 1983
Piccola storia dei longobardi di Benevento / a cura di L. A. Berto. – 2013
I duchi longobardi / S. Gasparri. – 1978
La cultura tradizionale dei longobardi: struttura tribale e resistenze pagane / S. Gasparri. –1983
Prima delle nazioni: popoli, etnie e regni fra antichità e Medioevo / S. Gasparri. – 1997
Il regno dei longobardi in Italia: archeologia, società e istituzioni / S. Gasparri. – 2004
Italia longobarda: il regno, i franchi, il papato / S. Gasparri. – Laterza, 2012
Langobardia: i longobardi in Italia / T. Indelli. – 2013
I longobardi e la storia: un percorso attraverso el fonti / a cura di F. Lo Monaco e F. Mores. – 2012
I longobardi e la guerra: da Alboino alla battaglia sulla Livenza, secc. 6.-8. – 2004
I “magistri commacini”: mito e realtà del Medioevo lombardo. – 2009
I longobardi / / a cura di G. C. Menis. – 1990
Storia dei longobardi / Paolo Diacono , a cura di L. Capo. – 1992
Salerno: una sede ducale della Langobardia meridionale / a cura di P. Peduto…et al. – 2013
I longobardi del sud / a cura di G. Roma. – 2010
Pagina 1 di 2