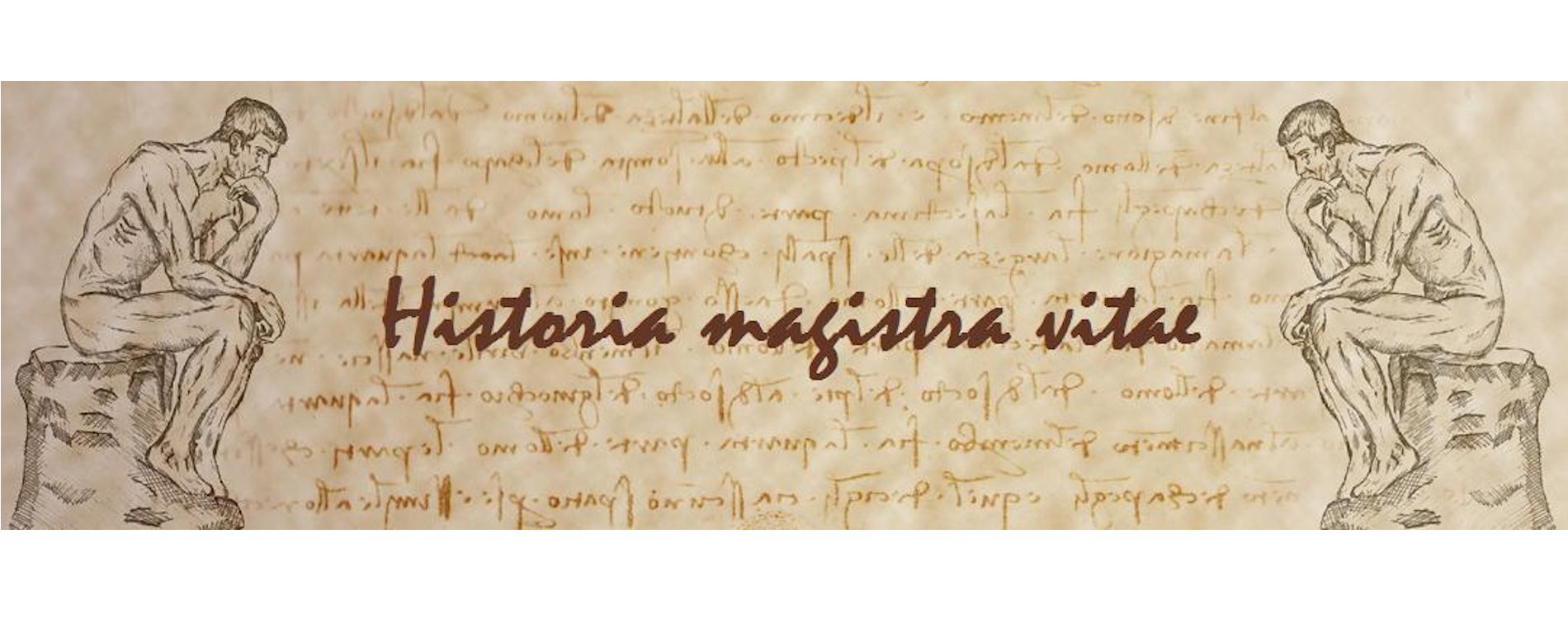Il mondo contemporaneo dal 1848 a oggi di Sabbatucci Vidotto.
- Visite: 116
Cap. 1. Le rivoluzioni del 1848.
Parola chiave. Suffragio universale.
Nell’antica Roma lo ius suffragii era il diritto del cittadino di votare nei comizi, ossia nelle assemblee popolari in cui si prendevano le decisioni più importanti.
Dopo aver assunto nel corso del tempo altri e diversi significati (nel linguaggio della Chiesa la parola sta per “aiuto”, “soccorso”, e anche “preghiera” per le anime dei defunti), il termine “suffragio” è tornato in età moderna e contemporanea come sinonimo di voto, o diritto di voto, per l’elezione dei membri delle assemblee rappresentative.
Il suffragio può essere diretto, se serve a designare direttamente i rappresentanti, o indiretto, se esprime un corpo ristretto che poi procederà all’elezione; uguale, quando ogni voto conta come tutti gli altri, o plurimo, se si riconosce un peso maggiore al voto di alcune categorie di elettori rispetto ad altre.
Può essere inoltre – e su questo punto soprattutto si incentrò il dibattito nel corso dell’800 – universale, se attribuito a tutti i cittadini senza distinzione, o ristretto, se limitato in base a criteri economici (censo) o di merito (titolo di studio, professione o altro).
In realtà anche il suffragio nominalmente universale poteva soffrire di limitazioni di diverso tipo: la più vistosa era quella che riguardava le donne, i cui diritti, per tutto l’800, furono sostenuti solo da poche voci isolate (fra queste quella di John Stuart Mill).
Ma si poteva essere esclusi dal voto anche per motivi di “indegnità morale” o perché di condizione servile.
Nei primi decenni del secolo Diciannovesimo il suffragio universale – s’intende maschile – fu invocato dai democratici, mentre i liberali moderati erano per lo più favorevoli al suffragio ristretto (di fatto limitato a strati assai sottili della popolazione).
Dopo l’esperienza delle rivoluzioni del ’48, le cose si fecero più complicate: molti democratici, infatti, pur mantenendo ferma la richiesta di principio, si mostrarono in realtà perplessi nei confronti di una riforma che avrebbe portato alle urne anche i ceti rurali, sospetto in quanto influenzabili dai grandi proprietari e dal clero.
Per gli stessi motivi, alcuni osservatori, sull’esempio di quanto avevano fatto Napoleone Terzo in Francia e Bismarck in Prussia, si schierarono in favore del suffragio universale, visto come strumento di stabilizzazione politica e sociale.
Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, anche in coincidenza con la diffusione dell’istruzione, il suffragio maschile si affermò a prescindere dai regimi politici, in tutti i paesi dotati di istituzioni rappresentative.
Per suffragio veramente universale, quello esteso ad ambo i sessi, si dovette aspettare ancora qualche decennio.
In Italia le donne votarono per la prima volta nelle elezioni del 1946.
Sommario.
La crisi rivoluzionaria del ’48 interessò gran parte dell’Europa continentale, anche a causa di alcuni elementi comuni presenti nei vari paesi: crisi economica del 1946-47, azione dei democratici, attesa di un nuovo grande sommovimento rivoluzionario.
Simili furono anche i contenuti delle varie insurrezioni: richiesta di libertà politiche e id democrazia e - in Italia, Germanie e Impero asburgico – spinta verso l’emancipazione nazionale.
La novità delle rivoluzioni del ’48 risiedette nella massiccia partecipazione dei ceti popolari urbani e nella presenza di obiettivi sociali accanto a quelli politici.
Il centro di irradiazione del moto rivoluzionario fu la Francia.
L’insurrezione parigina di febbraio portò alla proclamazione della repubblica, che ebbe all’inizio un indirizzo democratico-sociale.
Le elezioni per l’Assemblea costituente dell’aprile ’48 sancirono la vittoria dei repubblicani moderati.
L’insurrezione di giugno dei lavoratori di Parigi fu duramente repressa e segnò la svolta in senso conservatore della Repubblica, concretizzatasi in dicembre con l’elezione e dicembre di Luigi Napoleone Bonaparte.
In marzo il voto rivoluzionario si propagò all’Impero asburgico, agli Stati italiani e alla Confederazione germanica.
A Vienna, Metternich dovette lasciare il potere e venne concesso un parlamento dell’Impero.
In Ungheria l’agitazione ebbe un accentuato carattere indipendentistico.
Anche a Praga e negli altri territori della monarchia asburgica si estesero, sia pure in forma meno accentuata, le rivendicazioni di autonomia.
La repressione militare della sollevazione di Praga (giugno 1848) segnò l’inizio della riscossa del potere imperiale, che utilizzò abilmente le rivalità fra gli slavi e i magiari.
Dopo la repressione di una nuova insurrezione a Vienna (ottobre ’48), saliva al trono imperiale Francesco Giuseppe.
La rivoluzione di Berlino portò inizialmente ad alcune concessioni da parte del re Federico Guglielmo Quarto; il movimento federal-democratico conobbe però un rapido declino.
In maggio, sulla spinta delle agitazioni e sommosse scoppiate nei vari Stati tedeschi, si era riunita a Francoforte un’Assemblea costituente con l’obiettivo di avviare un processo di unificazione nazionale tedesca.
Il rifiuto da parte di Federico Guglielmo Quarto della corona imperiale offertagli dall’Assemblea di Francoforte nell’aprile ’49 segnò in pratica la fine di quest’ultima.
All’inizio del 1848, e prima della rivoluzione di febbraio in Francia, negli Stati italiani c’erano forti aspettative di un’evoluzione interna dei vecchi regimi.
La sollevazione di Palermo, in gennaio, induceva Ferdinando Secondo di Borbone a concedere una costituzione; il suo esempio era subito seguito da Carlo Alberto, Leopoldo Secondi di Toscana e Pio Nono.
Lo scoppio della rivoluzione in Francia dava nuova spinta all’iniziativa dei democratici italiani e riportava in primo piano la questione nazionale.
A Venezia si proclamava la Repubblica; a Milano, dopo “cinque giornate” di insurrezione, fu costituito un governo provvisorio.
Il 23 marzo ’48 Carlo Alberto dichiarava guerra all’Austria, ottenendo l’appoggio del re delle due Sicilie, del granduca di Toscana e del papa, appoggio che sarebbe stato ritirato di lì a poco.
I piemontesi, anche per la scarsa risolutezza con cui condussero le operazioni militari, vennero sconfitti a Custoza (luglio ’48) e costretti a firmare un armistizio con l’Austria.
A combattere contro l’Impero asburgico restavano i democratici italiani (oltre a quelli ungheresi9.
In Sicilia resistevano i separatisti, a Venezia era proclamata di nuovo la repubblica, in Toscana si formava un triumvirato democratico, a Roma, dopo la fuga del papa (novembre ’48), si proclamava la repubblica.
Nel marzo ’49 il Piemonte riprendeva la guerra contro l’Austria.
Subito sconfitto a Novara, Carlo Alberto abdicava a favore del figlio Vittorio Emanuele Secondo.
I governi rivoluzionari venivano sconfitti in tutta Italia: terminava la rivoluzione autonomistica siciliana, gli austriaci ponevano fine alla Repubblica toscana e occupavano le Legazioni pontificie, i francesi intervenivano militarmente contro la Repubblica romana.
Gli ultimi focolai rivoluzionari a soccombere furono quelli ungherese e veneto, in entrambi i casi per l’intervento asburgico.
La causa fondamentale del generale fallimento delle rivoluzioni del ’48 va individuata nelle fratture all’interno delle forze che di quelle rivoluzioni erano state protagoniste: nei contrasti, cioè, fra correnti democratico-liberali e gruppi liberal-moderati.
Avevano pesato inoltre, nel determinare la sconfitta delle esperienze rivoluzionarie italiane, l’estraneità delle masse contadine, che costituivano la stragrande maggioranza della popolazione.
In Francia si accentuava, nel 1849, l’evoluzione della situazione politica in senso conservatore.
Nel dicembre 1851 Bonaparte effettuò un colpo di Stato e riformò la costituzione.
L’anno successivo un plebiscito sanzionava la restaurazione dell’Impero: Luigi Napoleone Bonaparte diventava imperatore con il nome di Napoleone Terzo.
Bibliografia.
Per uno sguardo ‘’insieme sulle rivoluzioni del ’48-49.
L’età della borghesia / a c. di G. Palmade. – Feltrinelli, 1975
Sull’esperienza repubblicana in Francia.
La Francia della Seconda Repubblica, 1848-1852 / M. Agulhon. – Ed. Riuniti, 1979
Sulle rivoluzioni nell’Impero asburgico e in Germania.
Grandezza e caduta dell’Impero asburgico, 1815-1918 / A. Sked. – Laterza, 1992
Storia della Germania tedesca / H. Holborn. – Rizzoli, 1973
Tra Asburgo e Prussia: la Germania dal 1815 al 1866 / H. Lutz. – Il Mulino, 1992
Per l’Italia
Storia dell’Italia moderna, vol. 3 / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1960
Fra le opere dei contemporanei:
Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1859 / K. Marx. – Ed. Riuniti, 1973
Una rivoluzione fallita. – In: Scritti politici / A. De Tocqueville. – UTET, 1969
Il 1848 in Italia / C. Cattaneo. – Einaudi, 1972
Cap. 2. Società borghese e movimento operaio.
Parola chiave. Progresso.
Nel linguaggio comune, “progresso” è sinonimo di “avanzamento” o di “sviluppo”.
In termini storico-filosofici, credere nel progresso significa pensare che il corso della storia sia necessariamente orientato verso un graduale miglioramento della condizione umana, verso un aumento della felicità – o del benessere materiale, o della ricchezza spirituale – dei singoli e della collettività.
L’idea moderna di progresso è nata con l’Illuminismo: tipica della cultura illuministica è infatti una concezione laica della storia, che considera la natura umana perfettibile e la felicità realizzabile nel mondo degli uomini (e non solo nell’aldilà).
Nell’età romantica, l’idea di progresso viene mutando i suoi tratti e si lega alle concezioni idealistiche e storicistiche che vedono la storia come un processo di continuo arricchimento dello spirito universale: un processo che è inarrestabile e necessario, ma non dipende dall’azione dell’uomo, anzi la determina.
L’epoca del positivismo è stata quella in cui l’ideale di progresso ha conosciuto la sua maggiore affermazione, fino a costituire il nucleo centrale e l’idea-guida della cultura borghese nella seconda metà dell’800.
Anche per i positivisti il progresso è il risultato di leggi immanenti allo sviluppo storico, più che delle volontà dei singoli (gli uomini possono tutt’al più agire per accelerare il progresso o per rallentarlo).
Ma si tratta di leggi scientifiche, analoghe a quelle che regolano l’evoluzione del mondo naturale e l’accento è posto non tanto sul progresso “spirituale” quanto sullo sviluppo tecnico e materiale.
Questa idea di progresso è entrata in crisi alla fine dell’800, assieme a tutto il sistema culturale e filosofico legato al positivismo.
Le vicende drammatiche del 900 – in particolare le due guerre mondiali – hanno ulteriormente incrinato la fiducia in un corso razionale e ordinato della storia dell’umanità e la cultura del ‘900, in tutte le sue molteplici correnti, ha assunto nei confronti dell’idea di progresso un atteggiamento più critico e disincantato.
Nemmeno il grande processo di sviluppo economico e di avanzamento scientifico verificatosi nell’epoca successiva al secondo conflitto mondiale (epoca per altro verso dominata dall’incubo della guerra nucleare) è valso a riproporre l’idea di progresso nei termini ottimistici in cui veniva concepita nell’800.
Sommario.
Al conservatorismo politico che, dopo il fallimento delle rivoluzioni del ’48-49, caratterizzava la situazione europea, faceva riscontro un processo di profondo mutamento sociale.
Il ventennio successivo al ’48 vide la crescita della borghesia : un ceto sociale attraversato da notevoli differenziazioni interne e tuttavia portatore di uno stile di vita e di un insieme di valori sostanzialmente unitari.
Centrale, tra questi valori, era la fede nel progresso generale dell’umanità, che poggiava sull’imponente sviluppo economico e scientifico della seconda dell’800.
Sul piano culturale, il progresso scientifico diede origine a una nuova corrente filosofica, il positivismo, che diventò l’ideologia della borghesia in ascesa e influenzò tutta la mentalità dell’epoca.
Il rappresentante più noto del nuovo spirito “positivo” fu Darwin, cui si deve la teoria dell’evoluzione e della selezione naturale.
Dalla fine degli anni ’40, l’economia europea conobbe una fase di forte sviluppo durata quasi un quarto di secolo.
Lo sviluppo interessò anzitutto l’industria, principalmente nei settori siderurgico e meccanico.
Si generalizzò in quest’epoca l’impiego delle macchine a vapore e del combustibile minerale.
I fattori principali del boom industriale degli anni ’50 e ’60 furono: la rimozione dei vincoli giuridici che ostacolavano le attività economiche, l’affermarsi del libero scambio, la disponibilità di materie prime, la diminuzione dei tassi di interesse e l’espansione del credito a favore degli impieghi industriali, lo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto (navi a vapore e, soprattutto, ferrovie) e di comunicazione (telegrafo).
Si diffondeva, nello stesso periodo, la figura dell’operaio di fabbrica, le cui dure condizioni di vita e di lavoro favorivano il formarsi di una coscienza di classe e delle prime associazioni operaie (soprattutto in Gran Bretagna, Germania e Francia).
La teoria socialista assunse, con l’opera di Marx, il carattere di teoria “scientifica” contenente un’indicazione di superamento del capitalismo.
Progressivamente il marxismo si sarebbe affermato quale dottrina ufficiale del movimento operaio.
Nel 1864 venne fondata la Prima internazionale, la cui storia fu caratterizzata da i contrasti fra le varie correnti – principalmente tra marxisti e anarchici – che avrebbero presto condotto alla sua dissoluzione.
Il maggior teorico dell’anarchismo fu Bakunin, le cui teorie di distinguevano per alcuni aspetti sostanziali da quelle di Marx.
Bakunin, tra l’altro, riteneva che, una volta abbattuto il potere statale, il comunismo si sarebbe instaurato spontaneamente, senza dunque la fase di “dittatura del proletariato” prevista da Marx.
Egli considerava, inoltre, le masse diseredate (e non il proletariato industriale) il soggetto della rivoluzione.
Per quest’ultimo motivo il bakunismo si diffuse soprattutto nei paesi più arretrati.
Di fronte alla società borghese, il mondo cattolico da un lato assunse un atteggiamento di dura condanna (Sillabo, 1864), dall’altro, si fece promotore, con i movimenti cristiano-sociali, di un intervento dello Stato a favore dei lavoratori e di un associazionismo cattolico.
Bibliografia
Il trionfo della borghesia, 1848-1875 / E. J. Hobsbawm. Laterza, 1976
L’età della borghesia / a c. di G. Palmade. – Feltrinelli, 1975
La vita privata: l’Ottocento / a c. di P. Aries, G. Duby. – Laterza, 1988
Il secolo di Darwin / L. Eiseley. – Feltrinelli, 1975
Prometeo liberato / D. S. Landes. – Einaudi, 1978
Storia economica e sociale del mondo, vol. 1.: Il capitalismo, 1840-1914 / a c. di P. Leon. – Laterza, 1980
Storia economica dell’Europa continentale, vol. 1. 1780-1870 / A. S. Milward, S. B. Saul. – Il Mulino, 1977
La conquista pacifica: l’industrializzazione in Europa dal 1760 al 1970 / S. Pollard. - Il Mulino, 1984
Storia del pensiero socialista / G. D. H. Cole. – Laterza, 1967
Antologia del pensiero socialista / a c. di A. Salsano. - Laterza, 1980
Introduzione a Marx / G. Bedeschi. – Laterza, 1981
Storia del marxismo. – Einaudi, 1978
Liberalismo e integralismo: tra Stati nazionali e diffusione missionaria, 1830-1870. – Jaca Book, 1977
Il pontificato di Pio Nono, 1846-1878 /R. Aubert. – Einaudi, 1976
Cap. 3. Città e campagna.
Parola chiave. Piano regolatore.
Il piano regolatore è lo strumento normativo – ossia l’insieme di regole e prescrizioni – impiegato per dare ordine alla costruzione delle città.
I regolamenti per lo sviluppo urbano sono in realtà antichissimi: si ritrovano nelle città mesopotamiche, cinesi, romane.
La maglia regolare delle strade, la distinzione fra le diverse funzioni dei quartieri non riguarda solo la città contemporanea.
In età moderna è celebre il piano di papa Sisto Quinto (1585-90) per Roma con la definizione di un tridente che si diparte da piazza del Popolo e collega i percorsi verso le grandi basiliche (S. Maria Maggiore, S. Croce in Gerusalemme, S. Giovanni in Laterano).
Ma con la trasformazione delle città tradizionali in centri industriali e commerciali, con l’ampliamento delle loro funzioni burocratico-amministrative, con la costruzione delle grandi stazioni ferroviarie, dei parlamenti e dei municipi (tutti fenomeni che furono accompagnati, nel corso del Diciannovesimo Secolo, da un vistoso incremento della popolazione urbana) la redazione dei piani regolatori divenne un passaggio obbligato.
La spinta iniziale venne dalla necessità di risanare igienicamente i vecchi quartieri e dotarli di una rete fognaria.
Seguirono i grandi interventi di trasformazione delle città: i boulevards di Haussmann a Parigi (1855-70), la costruzione del Ring a Vienna (1860), gli inizi della metropolitana a Londra (1863).
L’Italia fissò una legge del 1865 (rinnovata ed ampliata con uan nuova legge urbanistica del 1942) le norme relative ai piani regolatori e ai criteri di espropriazione per cause di pubblica utilità.
Nel 1865 Firenze (allora capitale d’Italia) ebbe il suo piano regolatore, seguita da Roma nel 1882, Napoli nel 1885, Milano nel 1889.
In molti casi, però, il piano regolatore non veniva rispettato nella sua integrità: lo sviluppo urbano non riusciva a seguire le previsioni del piano e gli interessi in gioco – rappresentati dai proprietari di aree, dai costruttori e anche dalle esigenze dei cittadini alla ricerca di una casa – erano troppo forti per essere disciplinati.
Si aprivano così innumerevoli contese con le autorità pubbliche per modificare e attenuare le disposizioni vigenti tanto da rendere la redazione dei nuovi piani regolatori un’impresa lunga e difficile, realizzabile solo in presenza di amministrazioni comunali in grado di costruire (o di imporre) un largo consenso tra le parti.
In anni recenti si è giunti a rinunciare a un piano regolatore generale per ricorrere a strumenti più agili per risolvere i problemi caso per caso.
Sommario.
Nell’800 ebbe inizio quel grande processo storico che va sotto il nome di urbanesimo: aumentò non solo la popolazione urbana ma anche il numero delle grandi città.
In Gran Bretagna, in particolare, piccoli centri si trasformarono in grandi città in pochi decenni: accadde in quei luoghi che, per la particolare posizione geografica, acquisirono nuova importanza dopo la rivoluzione industriale.
Nella seconda metà dell’800 furono soprattutto gli Stati Uniti a offrire un nuovo modello di sviluppo della città, con la costruzione di grattacieli e l’espansione dei sobborghi periferici.
Nella seconda metà dell’800 molti grandi centri urbano assunsero una forma simile a quella che ancora oggi conosciamo.
Punti di riferimento essenziali divennero le stazioni ferroviarie, la Borsa, i centri commerciali, il tribunale, i palazzi dei ministeri.
I ceti popolari andarono ad addensarsi nelle grandi periferie, ben distinte dai quartieri residenziali borghesi.
Nello stesso periodo, quasi tutte le grandi città europee videro moltiplicarsi le iniziative dei poteri pubblici per favorire lo sviluppo dei trasporti e per cercare di risolvere i più urgenti problemi igienici.
La ristrutturazione di Parigi fu un esempio di intervento attuato dallo Stato.
Haussmann sventrò buona parte del centro medievale e aprì una serie di larghi viali.
Principi completamente diversi guidarono lo sviluppo di Londra.
Qui l’intervento pubblico risultò quasi assente: l’espansione della città rimase nelle mani dell’iniziativa privata.
Vienna rappresentò invece un modello urbanistico per la costruzione della Ringstrasse, dove furono collocati i principali edifici pubblici e una serie di eleganti palazzi privati.
Alla fine dell’800 Chicago fu uno dei simboli più efficaci del dinamismo americano.
Distrutta da un incendio nel 1871, la città venne in breve tempo ricostruita e da allora cominciò a espandersi a ritmi straordinari.
Alla metà dell’800, in tutta l’Europa continentale, erano i lavoratori della terra a costituire la grande maggioranza della popolazione attiva.
Diversi furono gli effetti della privatizzazione delle terre: in alcune regioni la scomparsa del regime feudale lasciò posto alla piccola e media proprietà, in altre andò invece a vantaggio dei grandi latifondisti.
Ovunque, comunque, i lavoratori agricoli occupavano i gradini inferiori della scala sociale.
Fra il 1840 e il 1870 milioni di persone lasciarono il vecchio continente per andare a dissodare le terre vergini del Nord America.
Bibliografia
Storia della città / L. Benevolo. – Laterza, 1975
La città moderna e contemporanea / A. Caracciolo. – Guida, 1982
La città europea dal Medioevo a oggi / P. M. Hohenberg, L. Hollen Lees. – Laterza, 1987
La città europea dal Quindicesimo al Ventesimo Secolo / C. De Seta. – Rizzoli, 1996
La città dell’Ottocento / G. Zucconi. – Laterza, 2001
Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea / a c. di P. Bevilacqua. – Marsilio, 1989-91
Cap. 4. L’unità d’Italia.
Parola chiave. Plebiscito.
Nella Roma repubblicana con il termine plebiscitum (“decisione della plebe”) si indicavano le deliberazioni che venivano espresse dai comizi della plebe, su proposta dei tribuni, e che, in alcuni casi, assumevano valore di legge.
Il termine riapparve nella Francia rivoluzionaria per indicare un solenne pronunciamento del popolo, unico depositario della sovranità.
Il primo vero plebiscito dell’età moderna fu quello a cui Napoleone Bonaparte fece ricorso per legittimare a posteriori il colpo di Stato del 1799.
Anche le successive tappe della costruzione del potere napoleonico – dalla nomina a Primo Console in quello stesso anno all’assunzione del titolo imperiale nel 1804 – furono segnate da plebisciti: ovvero da consultazioni popolari, a suffragio universale maschile, in cui gli elettori dovevano semplicemente approvare decisioni già prese, conferendo ad esse la ratifica della sovranità popolare.
L’istituto dei plebiscito fu ripreso in Francia da Luigi Napoleone Bonaparte, che anche in questo senso ripercorse il cammino analogo a quello del primo Napoleone (attraverso le due tappe della presidenza a vita, dopo il colpo di Stato del 1851 e della restaurazione dell’Impero l’anno seguente); e fu successivamente adottato in Italia dalla monarchia sabauda, che se ne servì per legittimare le annessioni con cui nacque e poi si ingrandì il Regno d’Italia e per rendere omaggio al principio della sovranità popolare, rompendo con la tradizione della monarchia per diritto divino.
Gli elettori furono chiamati a pronunciarsi con un sì o un no, senza alcuna garanzia di segretezza del voto, sulla scelta di una “Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele re costituzionale”.
Nel ‘900 il ricorso alle forme plebiscitarie fu ampiamente praticato dai regimi totalitari: sia per ratificare la scelta imposta dall’alto dei componenti degli organismi rappresentativi (in Italia le elezioni fasciste su lista unica del 1929 e del 1934), sia per conferire maggior forza a decisioni di speciale importanza (ad esempio, nella Germania nazista, l’uscita dalla Società delle nazioni nel novembre 1933).
Da allora il termine, usato per lo più in senso negativo, sta a indicare lo strumento di cui si servono i regimi autoritari per richiamarsi alla legittimazione popolare e rafforzare così il ruolo del capo, senza correre i rischi connessi alla libera espressione del voto democratico, che presuppone la possibilità di scegliere senza costrizioni fra alternative reali.
Più in generale si parla di “voto plebiscitario” o di “consenso plebiscitario” per designare l’esito schiacciante, e per questo a volte sospetto, di una consultazione elettorale.
Sommario
In Italia, la “seconda restaurazione” – cioè il ritorno dei sovrani legittimi dopo il fallimento delle rivoluzioni del ’48-49 – bloccò ogni esperimento riformatore e frenò pesantemente lo sviluppo economico dei vari Stati, mentre veniva sancita l’egemonia austriaca nella penisola.
Aumentava anche il fossato che separava i sovrani dall’opinione pubblica borghese, fenomeno evidente soprattutto nei due Stati che più perseguirono una politica repressiva: lo Stato pontificio e il Regno delle Due Sicilie.
Solo in Piemonte la situazione era diversa.
Qui fu conservato il regime costituzionale; inoltre, superata la crisi legata alla ratifica del trattato di pace con l’Austria, venne intrapresa dal governo D’Azeglio un’opera di modernizzazione dello Stato, soprattutto nel campo dei rapporti con la Chiesa (legge Saccardi).
Nel 1850 Cavour entrava nel governo (come ministro dell’agricoltura e commercio) e, due anni dopo, diveniva presidente del consiglio.
Si affermava, così, un politico dai vasti orizzonti culturali e dall’ampia conoscenza di problemi economici, animato dalla fede nelle virtù della libera concorrenza e da un liberalismo pragmatico e moderno.
Spostato a sinistra l’asse del governo (“connubio” con Rattazzi), Cavour pose mano anzitutto alla modernizzazione economica del paese, attraverso l’adozione di una linea liberoscambista, il sostegno dello Stato all’industria, la riorganizzazione delle attività creditizie, le opere pubbliche.
La conservazione delle libertà costituzionali, lo sviluppo economico, l’accoglienza data agli esuli provenienti dagli altri Stati italiani fecero del Piemonte cavouriano il punto di riferimento per l’opinione pubblica liberale di tutta la penisola.
Proseguiva instancabile, dopo le sconfitte del ’48-49, l’attività di Mazzini, volta al raggiungimento dell’indipendenza e dell’unità per via insurrezionale.
I tragici insuccessi contro cui la sua strategia si scontrò fecero crescere i dissensi entro il movimento democratico.
Si affacciava, soprattutto con Pisacane, un’ipotesi “socialista” di liberazione nazionale, che cioè facesse leva sulle masse diseredate del Mezzogiorno.
Il tragico esito della spedizione di Sapri (1857) – dovuto soprattutto all’ostilità delle popolazioni locali – sollecitò l’iniziativa di quegli esponenti democratici che vedevano nell’alleanza con la monarchia sabauda l’unica possibilità di successo (nel 1857) si costituì la Società nazionale).
Dopo aver ottenuto un successo diplomatico dalla partecipazione piemontese alla guerra di Crimea e alla conferenza di Parigi (1855-56), Cavour si convinse che era indispensabile l’appoggio di Napoleone Terzo per scacciare gli austriaci dalla penisola.
Favorito dagli effetti che l’attentato di Orsini ebbe sull’imperatore, strinse con questi a Plombières (1858) un’alleanza militare in vista della guerra contro l’Austria, che scoppiò nell’aprile dell’anno successivo.
Le sorti del conflitto volsero subito a favore dei franco-piemontesi.
Ma l’armistizio di Villafranca – improvvisamente stipulato da Napoleone Terzo – assegnava allo Stato sabaudo la sola Lombardia.
Si dové alla nuova situazione creata dalle insurrezioni nell’Italia centro-settentrionale se il Piemonte poté annettere anche Emilia, Romagna e Toscana.
Rimanevano scontenti i democratici, che cominciarono a pensare a una prosecuzione della lotta attraverso una spedizione nel Mezzogiorno.
Nel maggio 1860 Garibaldi sbarcò in Sicilia con mille volontari e, sconfitte le truppe borboniche, formò un governo provvisorio.
Le aspirazioni dei contadini – desiderosi anzitutto di una trasformazione dei rapporti di proprietà – causarono presto la fine del clima di concordia che aveva salutato i “liberatori”.
Spaventati dalle agitazioni agrarie, i proprietari terrieri guardarono con favore all’annessione al Piemonte.
Dopo lo sbarco di Garibaldi in Calabria e il suo ingresso a Napoli, divenne urgente per il governo piemontese un’iniziativa al Sud tale da evitare complicazioni internazionali e garantire alla monarchia sabauda il controllo della situazione.
Con l’intervento dell’esercito piemontese e le annessioni, la liberazione del Sud veniva così ricondotta entro i binari della politica cavouriana.
Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele Secondo fu proclamato re d’Italia.
Bibliografia.
Storia dell’Italia moderna, vol. 4.: Dalla rivoluzione nazionale all’unità / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1964
Cavour: un europeo piemontese / H. Hearder. – Laterza, 2000
L’Italia del Risorgimento / A. Scirocco. – Il Mulino, 1990
Storia d’Italia, vol. 1.: Le premesse dell’unità / Sabbatucci-Vidotto. – Laterza, 1994
Cavour e il suo tempo / R. Romeo. – Laterza, 1969-84
Vita di Cavour / R. Romeo. – Laterza, 1984
Dal Piemonte sabaudo all’Italia liberale / R. Romeo. – Laterza, 2001
Cavour / L. Cafagna. – Il Mulino, 1999
Garibaldi / A. Scirocco. – Laterza, 2001
Garibaldi: l’invenzione di un eroe / L. Riall. – Laterza, 2007
Sulle correnti democratiche
Democrazia e socialismo nel Risorgimento / F. Della Peruta. – Ed. Riuniti, 1965
Sul ruolo della monarchia sabauda
La monarchia e il Risorgimento / F. Mazzonis. – Il Mulino, 2003
Il dibattito storiografico fino al 1960
Le interpretazioni del Risorgimento / W. Matturi. – Einaudi, 1962
Il Risorgimento: storia e interpretazioni / L. Riall. – Donzelli, 2007
Cap. 5. L’Europa delle grandi potenze, 1850-1890
Parola chiave. Potenza.
Nel linguaggio della diplomazia, sono definiti potenze quegli Stati che si dimostrano in grado, in virtù della loro forza economica e militare o della loro capacità politica, di essere soggetti attivi, e non solo oggetti, della politica internazionale, di assumere autonomamente impegni ed iniziative senza essere condizionati da vincoli di subordinazione.
Si parla poi di grandi potenze in riferimento a quegli Stati che, in un dato periodo, acquistano un ruolo egemonico in una determinata area e sono chiamati per questo ad assumere responsabilità speciali nella conduzione degli affari internazionali.
Nell’800, le grandi potenze erano cinque: Francia, Gran Bretagna, Russia, Prussia (poi Germania) e Austria.
Negli ultimi decenni del secolo a esse si aggiunsero l’Italia (cui non tutti, per la verità, riconoscevano questo ruolo) e le nuove potenze extraeuropee, gli Stati Uniti e il Giappone.
Dopo la Prima guerra mondiale, l’Austria, non più centro di un impero, uscì dal novero delle grandi potenze e ne furono escluse, ma solo temporaneamente, la Germania e la Russia (che vi sarebbe rientrata come Unione Sovietica).
Quella di grande potenza è naturalmente una condizione di fatto, non prevista dal diritto internazionale, fondato sulla presunzione di uguaglianza formale fra tutti i soggetti indipendenti.
Eppure essa fu sancita ufficialmente nello Statuto delle Nazioni Unite, che implicitamente attribuiva questa qualifica a cinque Stati (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina), designati come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.
In realtà, all’indomani del Secondo conflitto mondiale, stava emergendo un nuovo equilibrio internazionale, basato sull’esistenza di due sole superpotenze (Stati Uniti e Urss), capaci di far sentire il loro peso sull’assetto dell’intero pianeta e di esercitare così una sorta di condominio conflittuale a livello mondiale.
Con la crisi del blocco comunista e la fine dell’Urss (1991), gli scenari mutavano di nuovo.
Gli Stati Uniti restavano l’unica superpotenza planetaria.
Ma nel frattempo emergevano altre candidate al ruolo di grande potenza (le due sconfitte della Seconda guerra mondiale, la Germania riunificata e il Giappone, la stessa Russia portata a ereditare il ruolo dell’ex-Unione Sovietica) e nuove potenze regionali (il Brasile e l’Argentina, la Turchia e l’Iran, l’India e l’Indonesia) pronte a inserirsi in una realtà internazionale diventata di nuovo fluida dopo la fine dell’equilibrio bipolare durato quasi mezzo secolo.
Sommario.
Nella seconda metà del Secolo Diciannovesimo, la scena europea continuò ad essere dominata dalle cinque “grandi potenze”, impegnate in una lotta per l’egemonia che, fra il 1850 e il 1870, provocò ben quattro guerre.
In questo periodo, il ruolo più attivo fu svolto dalla Francia del Secondo Impero, che però, nel suo tentativo di indebolire l’Austria, finì col facilitare l’ascesa della Prussia.
Dalla guerra franco-prussiana del ’70-71 uscì un nuovo equilibrio che faceva perno sulla Germania riunificata.
Il regime di Napoleone Terzo cercò di coniugare l’autoritarismo e il paternalismo sociale con l’incoraggiamento allo sviluppo economico.
Al tempo stesso si impegnò in uan politica estera ambiziosa e aggressiva, volta a modificare l’assetto europeo uscito dal Congresso di Vienna.
Una prima manifestazione di tale politica si ebbe con la Guerra di Crimea (1854-55), quando Francia e Inghilterra si unirono per contrastare le mire della Russia sull’Impero ottomano.
Un’altra fu l’appoggio dato ai movimenti nazionali, soprattutto attraverso l’alleanza col Piemonte e le guerra con l’Austria del ’59.
Negli anni ’60 si avviò un’evoluzione liberale del regime.
L’Impero asburgico, dopo le rivoluzioni del ’48-49, accentuò i suoi caratteri autoritari e burocratici.
L’appoggio dei contadini e della Chiesa cattolica non fu sufficiente ad arrestare il declino dell’Impero, travagliato dai contrasti fra i diversi gruppi nazionali.
Nello stesso periodo la Prussia, anch’essa retta da un regime autoritario e dominata dai ceti aristocratici, ripropose la sua candidatura alla guida dei paesi di lingua tedesca, grazie soprattutto al suo sviluppo industriale.
Con l’ascesa al governo di Bismarck, la Prussia scelse la strada di un’unificazione da ottenersi soprattutto per mezzo della forza militare.
La vittoriosa guerra del ’66 contro l’Austria portò alla formazione di una Confederazione della Germania del Nord sotto l’egemonia prussiana e all’adesione della borghesia tedesca alla politica di Bismarck.
L’Impero asburgico sconfitto si riorganizzò in forma “dualistica”, dividendosi in una parte austriaca e una ungherese, dotate di larghe autonomie.
Nel 1870 Bismarck riuscì a provocare una guerra con la Francia (ultimo ostacolo ai suoi progetti di unificazione tedesca), che fu rovinosamente sconfitta a Sedan.
Col Trattato di Francoforte (1871) nasceva il nuovo Reich tedesco, comportò la caduta di Napoleone Terzo e la perdita dell’Alsazia e della Lorena.
La sconfitta ebbe le sue conseguenze la ribellione di Parigi e la proclamazione della Comune, radicale esperienza di democrazia diretta.
Isolata dal resto del paese, la Comune venne schiacciata dalle truppe governative dopo durissimi combattimenti nelle strade della capitale.
Dopo la guerra franco-prussiana si diffuse in Europa un nuovo clima politico: si affermò l’ideologia della forza e tramontò la politica del libero scambio.
Ciononostante l’Europa godette di un lungo periodo di pace destinato a protrarsi fino al 1914.
Fino al 1890 l’equilibrio europeo si fondò soprattutto sul sistema di alleanze costruito da Bismarck allo scopo principale di isolare la Francia.
Il sistema bismarckiano si fondò sul “patto dei tre imperatori” con Austria e Russia, reso però precario dalla rivalità fra queste due potenze: rivalità che emersero con la guerra russo-turca del ’77 e col successivo congresso di Berlino del ’78.
Il sistema di alleanze bismarckiano fu completato nel 1882 dalla Triplice Alleanza con Austria e Italia.
Dal punto di vista degli assetti interni, l’Impero tedesco era caratterizzato dalla prevalenza dell’esecutivo sul legislativo e dalla presenza di un blocco sociale dominante, fondato sull’alleanza fra industriali e aristocrazia agraria.
Ciò non impedì la nascita di nuove formazioni politiche, quali il Centro cattolico e il Partito socialdemocratico.
La lotta di Bismarck contro i cattolici (Kulturkampf) si risolse in un insuccesso e fu abbandonata anche per la necessità di fronteggiare la socialdemocrazia.
Ma né le leggi repressive promulgate a tale scopo né le avanzate riforme sociali varate da Bismarck in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori riuscirono a bloccare la crescita elettorale dei socialisti.
Ripresasi rapidamente dalla sconfitta del ’70-71, la Francia si diede nel ’75 una nuova costituzione repubblicana.
Il nuovo regime, dominato dai repubblicani moderati (gli “opportunisti”), riuscì a consolidarsi e a risolversi in senso parlamentare, nonostante l’instabilità dei governi e i frequenti scandali politico-finanziari.
Alla fine degli anni ’80 una minaccia fu rappresentata dall’emergere di un movimento nazionalista guidato dal generale Boulanger.
In Gran Bretagna gli anni centrali del lungo regno della regina Vittoria coincisero con un periodo di notevole prosperità economica, col rafforzamento del regime parlamentare e con alcune importanti riforme, soprattutto in materia di allargamento del suffragio.
Dopo un lungo periodo di incontrastata egemonia liberale, tra il ’66 e l’86 si alternarono al governo il liberale Gladstone, espressione dell’ala progressista del suo partito e il conservatore Disraeli, fautore di una politica imperialistica non priva di aperture sociali.
Gladstone affrontò fra l’altro la questione irlandese cercando, senza fortuna, di concedere all’isola un regime di autonomia.
In Russia all’arretratezza politica e sociale faceva riscontro una grande vivacità della vita culturale e del dibattito ideologico.
L’avvento al trono di Alessandro Secondo alimentò grandi speranza di rinnovamento, in conseguenza di alcune riforme varate dal sovrano: la più importante id tutte fu l’abolizione della servitù della gleba (1861), che però non produsse i risultati sperati.
Seguì uan nuova stretta autoritaria, con conseguente accrescersi del distacco fra potere statale e ceri intellettuali.
Bibliografia.
Per un quadro generale.
L’età degli imperi, 1875-1914 / E. J. Hobsbawm. – Laterza, 1984
Per l’inquadramento degli aspetti politici e diplomatici
L’Europa delle grandi potenze / A. J. P. Taylor. – Laterza, 1961
Sulla Francia.
Il secolo della rivoluzione / F. Furet. – Rizzoli, 1989
Il “secolo borghese” in Francia, 1815-1914 / R. Margraw. – Il Mulino, 1987
Sulla Comune
La Comune di Parigi: le otto giornate di maggio dietro le barricate / P. O. Lissagaray. – Feltrinelli, 1979
La Comune del 1871 / a c. di J. Bruhat et al. – Ed. Riuniti, 1971
Sulla Terza Repubblica
La febbre francese: dalla Comune al maggio ’68 / M. Winock. – Laterza, 1987
Da contadini a francesi: la modernizzazione della Francia rurale, 1870-1914 / W. Weber. – Il Mulino, 1989
Sull’Impero asburgico.
Grandezza e caduta dell’Impero asburgico, 1815-1918 / A. Sked. – Laterza, 1992
La monarchia asburgica / A. A. May. – Il Mulino, 1973
Per l’ascesa della Prussia e il processo di unificazione tedesca.
Tra Asburgo e Prussia: la Germania dal 1815 al 1866 / H. Lutz. – Il Mulino, 1992
I militari e la politica nella Germania moderna / G. Ritter. – Einaudi, 1967
L’ascesa della Germania a grande potenza: economia e politica nella formazione del Reich, 1848-1881 / H. Bohme. – Ricciardi, 1870
Bismarck / L. Gall. – Rizzoli, 1982
Bismarck: l’uomo e lo statista / A. J. P. Taylor. – Laterza 1988
Sulla Germania imperiale.
L’Impero guglielmino, 1871-1918 / H. U. Wehler. – De Donato, 1981
L’Impero inquieto: la Germania dal 1866 al 1918 / M. Sturmer. – Il Mulino, 1986
Sulla Gran Bretagna
L’Inghilterra vittoriana / E. Grendi. – Sansoni, 1975
L’Inghilterra vittoriana / A. Briggs. – Ed. Riuniti, 1978
L’Inghilterra vittoriana: genesi e formazione / G. Kitson Clark. – Jouvence, 1980
Democrazia e impero: l’Inghilterra fra il 1865 e il 1914 / E. J. Feuchtwanger. – Il Mulino, 1989
Sulla Russia.
La Russia degli Zar / M. Raeff. – Laterza, 1984
La Russia nell’età della nazione e delle riforme / D. Saunders. – Il Mulino, 1997
Cap. 6. I nuovi mondi: Stati Uniti e Giappone.
Parola chiave. Modernizzazione.
“Modernizzazione” è un termine creato dalla sociologia e dalla scienza politica del ‘900 per designare quell’insieme di trasformazioni politiche, economiche e sociali che hanno avuto luogo nelle società occidentali negli ultimi due secoli (a partire, grosso modo, dalle grandi rivoluzioni politiche del ‘700 e dalla rivoluzione industriale inglese) e si sono successivamente verificate – o si stanno verificando, pur fra molte resistenze e contraddizioni – nella maggior parte del mondo.
Nel linguaggio politico contemporaneo il concetto di modernizzazione tende a sostituirsi a quello di “progresso” e a superarne la genericità mediante il riferimento a una serie di parametri “oggettivi”.
Sul piano politico, si ha modernizzazione quando l’autorità statale acquista autonomia dagli altri poteri (in particolare da quello religioso) e capacità di far rispettare le proprie decisioni; quando esistono leggi valide per tutti; quando per la popolazione si verifica il passaggio dalla condizione di sudditi a quella di cittadini dotati, almeno in teoria, di uguali diritti.
Sul piano economico, la modernizzazione è quel processo mediante il quale un sistema acquista razionalità ed efficienza e accresce la sua capacità di produrre beni e di soddisfare bisogni: in questo senso la modernizzazione coincide col passaggio da un’economia agricola a una economia industriale e si misura con indici quali il prodotto nazionale, il reddito pro-capite e, soprattutto, il tasso di sviluppo annuo.
Sul piano sociale, la modernizzazione si identifica con una serie di processi tutti in qualche modo legati fra loro: la diffusione dell’istruzione, premessa essenziale pe rlo sviluppo della partecipazione politica e per la stessa crescita economica; l’urbanizzazione, conseguenza dello sviluppo industriale; l’aumento della mobilità geografica e sociale della popolazione; la rottura delle vecchie stratificazioni legate alla società tradizionale e la creazione di gerarchie basate non più, o non solo, sulla nascita, ma piuttosto sul merito individuale.
Tutti i processi cui abbiamo accennato hanno, nella tradizione culturale occidentale, un valore implicitamente positivo e il processo di modernizzazione nel suo complesso è considerato, in questo contesto, come un fenomeno auspicabile e in qualche misura necessario.
Ma una simile prospettiva non è condivisa universalmente, né all’interno delle società industrializzate, né soprattutto in molti di quei paesi che oggi si definiscono “in via di sviluppo”.
Se alcuni di questi paesi hanno imboccato con decisione la strada dell’industrializzazione, cercando, con alterna fortuna, di imitare l’esempio del Giappone (o quello delle economie pianificate dell’Est europeo), in altri la modernizzazione è stata vista come una “occidentalizzazione” più o meno forzata, e ha provocato reazioni talora molto aspre, a sfondo nazionalistico o religioso-tradizionalistico.
Sommario.
Alla metà dell’800 gli Stati Uniti erano un paese in crescente espansione, benché attraversato da forti differenze tra le diverse zone: il Nord-Est industrializzato, il Sud agricolo e tradizionalista nelle cui grandi piantagioni lavoravano milioni di schiavi neri, gli Stati dell’Ovest con una popolazione di liberi agricoltori e di allevatori di bestiame.
Le popolazioni dell’Ovest cominciarono intorno alla metà del secolo a stringere invece i loro rapporti con il Nord-Est.
Lo scontro sull’estensione della schiavitù ai nuovi territori dell’Unione vide dunque una contrapposizione tra gli Stati dell’Ovest e del Nord-Est e quelli del Sud.
Questa nuova dislocazione dei rapporti reciproci tra le varie zone del paese trovò riscontro nella crisi del Partito democratico e nella nascita del Partito repubblicano (che faceva proprie sia le rivendicazioni protezionistiche degli industriali settentrionali sia le richieste di terre dei coloni dell’Ovest e si qualificava in senso nettamente antischiavista).
La vittoria del repubblicano Lincoln alle elezioni presidenziali del ’60 fece precipitare il contrasto, provocando la secessione degli Stati del Sud.
Era la guerra civile (1861-65), che – dopo i primi successi dei “confederati” – doveva concludersi con la vittoria degli “unionisti”, superiori come popolazione e potenza economica.
La liberazione degli schiavi fu uno dei portati più rilevanti della guerra, benché si riproducesse presto, per la popolazione nera, una situazione di segregazione di fatto.
Superati i traumi della guerra civile, gli Stati Uniti vissero una stagione di intenso sviluppo economico e di grandi trasformazioni sociali, cui non fu estranea la continua crescita del flusso migratorio.
Sul piano della politica estera, gli Stati Uniti – impegnati a proseguire la colonizzazione dell’Ovest e il consolidamento dell’espansione nei territori di recente acquisizione – si limitarono per tutto l’800 a una interpretazione difensiva della “dottrina Monroe”, senza un grande coinvolgimento nelle vicende dell’emisfero meridionale del continente.
Unica eccezione fu l’aiuto dato ai repubblicani messicani contro il tentativo di egemonia francese in Messico (1864-67).
L’isolamento della Cina dal resto del mondo fu violentemente interrotto, alla metà dell’800, dalla pressione esercitata, dopo le due “guerre dell’oppio” (1839-42 e 1856-60), dagli Stati europei (soprattutto dall’Inghilterra), che imposero al paese l’apertura al commercio straniero.
Diverse furono, invece, in Giappone, le conseguenze dell’impatto con l’Occidente.
Anche qui fu la costrizione a permettere, dopo i “trattati ineguali” del 1858, la penetrazione economica delle grandi potenze.
Ma l’umiliazione subita spinse i grandi feudatari e i samurai a una rivolta contro lo shogun, che di fatto esercitava il potere di sovrano assoluto relegando l’imperatore a un ruolo puramente simbolico.
La “restaurazione Meiji” (1868) si risolse in una modernizzazione accelerata dell’intera società giapponese: una “rivoluzione dall’alto” che coinvolse l’economia e la legislazione, il sistema politico e i rapporti sociali, e che consentì al Giappone di compiere in pochi anni la transizione dal feudalesimo allo Stato moderno.
Bibliografia.
Opere generali sugli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti / R. Luraghi. – Utet, 1974
Storia degli Stati Uniti / H. Nevins, H. S. Commager. – Einaudi, 1980
Espansione e conflitto: gli Stati Uniti dal 1820 al 1877 / D. B. Davis, D. H. Donald. – Il Mulino, 1987
Sul problema degli schiavi neri.
L’economia politica della schiavitù / E. D. Genovese. – Einaudi, 1972
Sulla guerra di secessione
Storia della guerra civile americana / R. Luraghi. – Einaudi, 1976
La guerra civile americana / a c. di R. Luraghi. – Il Mulino, 1978
Sulla penetrazione europea in Asia
L’Asia orientale nell’età dell’imperialismo: Cina, Giappone, India e il Sud-Est asiatico nei Secoli Diciannovesimo e Ventesimo / J. Chesneaux. – Einaudi, 1969
La nascita del mondo moderno in Asia orientale: la penetrazione europea e la crisi delle società tradizionali in India, Cina e Giappone / G. Borsa. – Rizzoli, 1977
Per la Cina
Storia della Cina: dalle origini alla fondazione della Repubblica / M. Sabattini, P. Santangelo. – Laterza, 1986
La Cina / J. Chesneaux, M. Bastid. – Einaudi, 1974
Sul Giappone.
Storia del Giappone / E. O. Reischhauer. – Rizzoli, 1974
La nascita del Giappone moderno / E. H. Norman. – Einaudi, 1975
Il Giappone contemporaneo, / F. Gatti. – Loescher, 1976
Analisi comparativa dei processi di modernizzazione in Europa, Asia e America del Nord
Le origini sociali della dittatura e della democrazia: proprietari e contadini nella formazione del mondo moderno / B. Moore, jr. – Einaudi, 1969
Cap. 7. La seconda rivoluzione industriale.
Parola chiave. Liberismo/Protezionismo.
“Liberismo” è quella dottrina che affida al mercato – e solo al mercato – il compito di regolare l’attività economica, che si oppone all’intervento dello Stato nel mondo della produzione e del commercio, che sostiene il principio del libero scambio nei traffici tra paese e paese.
In quest’ultimo senso il liberismo si oppone al “protezionismo”: ossia a quella pratica che tende a proteggere la produzione nazionale imponendo sui prodotti di importazione dazi doganali così elevati da scoraggiarne l’acquisto.
Al contrario del protezionismo – che è solo una prassi adottabile, e adottata, da regimi diversi per motivazioni diverse – il liberismo è anche un’ideologia a sfondo ottimistico che ha il so fondamento nelle teorie di Adam Smith.
Un’ideologia che vede nella libertà economica non solo il mezzo più sicuro per ottenere il maggior benessere possibile per l’intera collettività (attraverso il perseguimento del benessere privato da parte dei singoli soggetti), ma anche il completamento indispensabile della libertà politica.
Il momento di maggior fortuna del liberismo si può collocare attorno alla metà del Secolo Diciannovesimo: in particolare nel periodo che seguì l’abolizione del dazio sul grano in Gran Bretagna (1846).
In questo periodo il liberismo fu, non solo in Inghilterra, l’ideologia delle correnti progressiste (che vedevano in esso anche un mezzo per sconfiggere i privilegi dell’aristocrazia terriera); e finì quasi con l’identificarsi col liberalismo politico.
Successivamente, a partire dagli anni ’70 dell’800, le fortune del liberismo andarono declinando in tutti i paesi, salvo che in Gran Bretagna.
Negli ultimi decenni del secolo, si assisté ovunque all’imposizione di elevati dazi protezionistici e, più in generale, a un intervento crescente dei poteri pubblici nelle vicende economiche (sotto forma sia di leggi sociali, sia di provvedimenti a favore di singoli comparti produttivi).
Nel corso del Ventesimo Secolo, l’intervento statale si è andato continuamente sviluppando in quantità e in qualità, anche all’interno dei sistemi economici fondati sulla proprietà privata e sulla libera impresa.
Soprattutto negli anni della “grande depressione” seguita alla crisi del ’29, l’era del laissez-faire sembrò definitivamente conclusa.
Tuttavia, anche nel ‘900 le teorie liberista hanno trovato numerosi e autorevoli sostenitori, soprattutto fra gli economisti.
Fra gli studiosi formatisi alla fine dell’800, è il caso di ricordare Luigi Einaudi, che diede vita negli anni ’30 a una celebre polemica con Benedetto Croce, postulando un inscindibile legame fra liberismo economico e liberalismo politico (legame che Croce contestava).
Nel secondo dopoguerra, il liberismo ha conosciuto una fase di rilancio, grazie anche alle opere di economisti come Friedrich Hayek e Milton Friedman.
Alle loro teorie si sono in parte ispirate le politiche “neoliberiste” affermatesi verso la fine degli anni ’70 come reazione alla crisi dello “Stato sociale” e applicate nei decenni successivi soprattutto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
L’ultimo trentennio dell’800 vide una profonda trasformazione economica (“seconda rivoluzione industriale”).
La crisi di sovrapproduzione del 1873 dette inizio a una fase di rallentamento dello sviluppo durata oltre un ventennio.
La prolungata caduta dei prezzi che le si accompagnò era però conseguenza soprattutto di profonde trasformazioni organizzative e innovazioni tecnologiche.
Vari fattori – tra cui la diminuzione dei prezzi e l’acuirsi della concorrenza internazionale – portarono allo sviluppo delle grandi concentrazioni produttive e finanziarie e a una stretta compenetrazione tra banche e industrie.
Si affermava contemporaneamente nei vari Stati una politica di appoggio all’economia nazionale attraverso il protezionismo e una maggiore aggressività sul piano dell’affermazione economica all’estero che fu tra le principali cause della politica di espansione coloniale seguita dalle maggiori potenze.
Gli effetti più gravi della caduta dei prezzi si ebbero nell’agricoltura.
Qui i progressi tecnici rimasero limitati ad alcune aree europee più sviluppate.
Diverso, invece, perché privo di tali squilibri, il rilevante sviluppo agricolo degli Stati Uniti, i cui prodotti a buon mercato inflissero un colpo durissimo alla più arretrata agricoltura europea.
Di conseguenza nelle campagne d’Europa aumentarono la conflittualità sociale e l’emigrazione (soprattutto quella transoceanica, che conobbe un vero e proprio boom).
Anche la crisi agraria spinse in direzione di politiche doganali che proteggessero la produzione nazionale dalla concorrenza estera.
Nel complesso, comunque, il calo dell’agricoltura in rapporto al complesso delle attività economiche fu comune a tutti i paesi industrializzati.
Caratteristica fondamentale della seconda rivoluzione industriale fu la stretta integrazione fra scienza e tecnologia e fra tecnologia e attività produttive.
Il rinnovamento tecnologico si concentrò nelle industrie giovani: chimica, elettrica, dell’acciaio (la prima rivoluzione industriale del secolo precedente era stata invece dominata dal cotone e dal ferro).
Soprattutto gli sviluppi della chimica aprirono a quella di prodotti “intermedi” (come acido solforico e soda) con impieghi estesissimi, dalle fibre tessili artificiali ai nuovi metodi di conservazione degli elementi.
L’invenzione del motore a scoppio e la produzione di energia elettrica furono tra le caratteristiche salienti della seconda rivoluzione industriale.
L’energia elettrica, in particolare, forniva una nuova importante forza motrice per gli usi industriali e rivoluzionava – anzitutto con l’illuminazione – la vita quotidiana.
Questo periodo vide anche la trasformazione scientifica della medicina, dovuta a quattro fattori: prevenzione e contenimento delle malattie epidemiche, attraverso la diffusione delle pratiche igieniste: identificazione dei microrganismi; progressi della farmacologia; nuova ingegneria ospedaliera.
I progressi della medicina e dell’igiene, sommandosi allo sviluppo dell’industria alimentare, determinarono in Europa una riduzione della mortalità.
Nonostante il calo delle nascite verificatosi neo paesi economicamente più avanzati (dovuto alla diffusione dei metodi contraccettivi e a una nuova mentalità tesa a programmare razionalmente la famiglia), si ebbe così un sensibile aumento della popolazione.
Bibliografia.
Aspetti economici e tecnologici della seconda rivoluzione industriale
Prometeo liberato / D. S. Landes. – Einaudi, 1978
Storia economica Cambridge, vol. 7. – Einaudi, 1979-80
Storia economica e sociale del mondo, vol. 4. / a c. di P. Leon. – Laterza, 1980
Sviluppi della medicina e dell’assistenza sanitaria in italia
Annali della Storia d’Italia, vol. 7. / F. Della Peruta. – Einaudi, 1984
Storia della medicina e della sanità in Italia / G. Cosmacini. – Laterza, 1987
Tendenze demografiche in Europa.
La trasformazione demografica delle società europee / M. Livi Bacci. – Loescher, 1977
La popolazione italiana dal Medioevo ad oggi / L. Del Panta …et al. – Laterza, 1996
Cap. 8. Imperialismo e colonialismo.
Parola chiave. Imperialismo.
Coniato in Francia ai tempi del Secondo Impero in riferimento ai disegni egemonici di Napoleone Terzo, il termine “imperialismo” ai affermò in Inghilterra alla fine degli anni ’70 per indicare il programma di espansione coloniale del governo Disraeli, per entrare poi nell’uso comune come sinonimo di politica di potenza e di conquista territoriale su scala mondiale.
In generale, l’imperialismo rappresentò la tendenza degli Stati europei a proiettare più aggressivamente verso l’esterno i propri interessi economici, le proprie esigenze di difesa, la propria immagine nazionale e la propria cultura: la fusione di queste diverse componenti (economiche, politiche, ideologiche) si tradusse in una politica realizzata con la forza e spesso perseguita come fine in sé.
Nel tentativo di identificare le forze profonde che erano alla base di questi sviluppi, molte delle teorie sull’imperialismo, avanzate all’inizio del ‘900 soprattutto – ma non soltanto – da parte di studiosi marxisti, hanno posto l’accento sui suoi moventi economici (la ricerca di materie prime a buon mercato e di nuovi sbocchi per merci e capitali in eccedenza) e sui suoi legami con le trasformazioni interne del sistema capitalistico (la svolta protezionistica, le concentrazioni, la prevalenza del capitale finanziario), lasciandone in secondo piano gli aspetti ideologici e politico-militari.
Per il liberale progressista John A. Hobson e per la marxista rivoluzionaria Rosa Luxembourg, la causa principale del fenomeno stava nel “sottoconsumo”, ossia nel divario fra la capacità sempre crescente del sistema capitalistico di produrre merci e la possibilità di acquistarle da parte dei consumatori: donde la necessità di trovare sbocchi nel mercati esteri.
Per Lenin l’imperialismo era legato alla concentrazione industriale e alla formazione del capitale finanziario e costituiva la “fase suprema” dello sviluppo capitalistico (quella che l’avrebbe condotto alla catastrofe).
Al contrario, il sociologo ed economista austriaco Joseph A. Schumpeter sosteneva che l’imperialismo andava contro le tendenze pacifiche dell’economia capitalistica e andava fatto risalire alla permanenza di interessi e valori tipici delle società preindustriali.
Le diverse teorie divergono non solo sugli elementi caratterizzanti dell’imperialismo, ma anche sui suoi termini cronologici.
Secondo molti studiosi il fenomeno va collocato fra gli anni ’70 dell’800 e la Prima guerra mondiale.
Altri en spostano in avanti la data finale, comprendendovi la Seconda guerra mondiale, o, come alcuni marxisti, lo considerano tuttora operante.
In sede storica, si può comunque affermare che, se da un lato è scorretto identificare l’imperialismo col colonialismo (iniziato, fra l’altro, alcuni secoli prima), dall’altro non sarebbe utile dilatare fino ai giorni nostri l’estensione del concetto, staccandolo dal contesto in cui nacque e ai affermò: che è appunto quello della grande espansione delle potenze europee tra la fine del Diciannovesimo e l’inizio del Ventesimo Secolo.
Sommario.
Vari fattori determinarono, negli ultimi decenni dell’800, quella corsa alla conquista coloniale che costituì il più caratteristico tratto dell’imperialismo europeo.
Vi fu certamente la spinta esercitata dagli interessi economici (ricerca di materie prime a basso costo e di sbocchi per i prodotti industriali e i capitali d’investimento), ma non meno importante fu l’affermarsi di tendenze politico-ideologiche che affiancavano a un acceso nazionalismo la fede nella missione civilizzatrice dell’uomo bianco.
Le potenze conquistatrici fecero generalmente un uso indiscriminato della forza contro le popolazioni indigene; sconvolsero l’economia dei paesi afroasiatici sottoponendola a un sistematico sfruttamento; colpirono, spesso irrimediabilmente, antiche culture.
Tuttavia gli effetti della conquista non furono sempre e solo negatici: sul piano economico, essa significò anche, in molti casi, un inizio di modernizzazione, sia pure finalizzata agli interessi dei dominatori; su quello culturale, alcuni paesi con tradizioni e strutture politico-sociali più solide riuscirono a difendere la loro identità ovvero ad assimilare aspetti della cultura dei dominatori; sul piano politico, infine, la colonizzazione, a più o meno lunga scadenza, favorì il formarsi di nazionalismi locali che avrebbero alimentato la lotta per l’indipendenza.
Agli inizi dell’età dell’imperialismo, gli europei avevano già numerosi possedimenti in Asia.
Più importante di tutti, l’India, soggetta dal ‘700 alla dominazione della Gran Bretagna e affidata al controllo della Compagnie delle Indie.
I tentativi inglesi di introdurre elementi di modernizzazione nell’arcaica società indiana suscitarono violente reazioni, cui il governo britannico rispose con uan sanguinosa repressione e con la riorganizzazione della colonia sotto la diretta amministrazione della corona.
L’apertura del Canale di Suez, nel 1809, diede nuovo impulso alla penetrazione europea in Asia.
In questo periodo si ebbero la conquista francese dell’Indocina, la spartizione del Pacifico, lo sviluppo della colonizzazione russa della Siberia.
L’altra direttrice dell’espansionismo russo – quella verso l’Asia centrale – portò l’Impero zarista ad un duro contrasto con l’Inghilterra.
Fu in Africa che l’espansione coloniale si verificò con la velocità più sorprendente, portando nel giro di pochi decenni alla conquista quasi completa – sotto forma di colonie e protettorati – di tutto il continente.
Francia e Inghilterra occuparono rispettivamente Tunisia (1881) ed Egitto (1882).
Poco dopo (1884-85)m la Conferenza di Berlino, convocata per risolvere i contrasti internazionali suscitati dall’espansione belga nel Congo, stabiliva i principi della spartizione dell’Africa e riconosceva il possesso di vari territori a Belgio, Francia, Germania e Inghilterra.
L’incidente di Fashoda (Sudan) nel 1898, quando Francia e Inghilterra furono a un passo dalla guerra, mostrò quali rischi di conflitti internazionali comportasse la corsa alla conquista.
In Sud Africa l’Inghilterra, soprattutto attraverso la politica di Cecil Rhodes, mirò ad estendere il suo dominio dalla Colonia del Capo alle due repubbliche boere dell’Orange e del Transvaal, ricche di giacimenti d’oro e di diamanti.
Il disegno poté realizzarsi solo dopo una lunga e sanguinosa guerra, vinta dalla Gran Bretagna contro i boeri (1899-1902).
Bibliografia
Introduzione agli aspetti teorici dell’imperialismo
Teorie dell’imperialismo / T. Kemp. – Einaudi, 1969
L’economia dell’imperialismo / M. Barratt Brown. – Laterza, 1977
Sull’espansione coloniale e l’imperialismo.
L’età dell’imperialismo, 1830-1914 / D. K. Fieldhouse. – Laterza, 1975
Gli imperi coloniali dal Diciottesimo Secolo / D. K. Fieldhouse. – Vol. 29. della Storia universale Feltrinelli. – 1967
L’età dell’imperialismo / G. Carocci. – Il Mulino, 1979
L’alba illusoria: l’imperialismo europeo nell’Ottocento / R. F. Betts. - Il Mulino, 1986
Al servizio dell’Impero: tecnologia e imperialismo europeo nell’800 / D. R. Headrick. - Il Mulino, 1984
Sull’Asia e il Giappone
Storia dell’India / M. Torri. – Laterza, 2000
La Cina dalla guerra franco-cinese alla fondazione del Partito comunista cinese, 1885-1921 / M. Bastid …et al. – Einaudi, 1974
Storia della Cina / M. Sabattini, P. Santangelo. – Laterza, 2007
Sull’Africa
Africa: dalla preistoria agli Stati attuali / P. Bertaux. – Vol. 32 della Storia universale Feltrinelli. – 1968
Storia dell’Africa nera / J. Ki-Zerbo. – Einaudi, 1977
Cap. 9. Stato e società nell’Italia unita.
Accentramento/Decentramento.
Per tutti il Secolo Diciannovesimo la scena politica europea fu dominata dallo scontro “triangolare” fra conservatori, liberal-moderati e democratici: uno scontro che riguardava essenzialmente le forme e i modi della partecipazione al potere.
Ma un altro scontro non meno importante, anche se meno appariscente, era quello che concerneva l’organizzazione del potere: ovvero la forma accentrata o decentrata delle istituzioni statali.
Su questo tema si fronteggiavano due modelli: quello francese – nato con l’assolutismo regio e rafforzatosi con la rivoluzione giacobina e con l’Impero napoleonico – prevedeva uno stretto controllo del potere centrale sugli organi di governo locale, realizzato attraverso una fitta rete di funzionari che facevano capo ai prefetti, rappresentanti del governo nelle singole circoscrizioni amministrative (dipartimenti); quello britannico lasciava invece ampi spazi, nel campo amministrativo e anche in quello giudiziario, all’iniziativa delle comunità locali.
La linea di divisione fra i sostenitori dell’uno e dell’altro modello non coincideva con quella fra conservatori e progressisti.
Nell’800 furono soprattutto i democratici a farsi paladini dell’accentramento e dell’unità amministrativa vista come strumento di uguaglianza, mentre conservatori e moderati difesero le autonomie e le diversità locali come il contesto più adatto a far valere i tradizionali privilegi sociali delle classi alte.
Ma non mancarono, e non sarebbero mancati in seguito, esempi contrari nell’uno e nell’altro senso.
In Italia esisteva fra i democratici una forte corrente autonomista e federalista (si pensi a Cattaneo), mentre i moderati, al potere dopo l’unificazione, realizzarono un ordinamento fortemente accentrato.
Presi in sé, dunque, l’accentramento e il decentramento non sono né “di destra”, né “di sinistra”: entrambi possono essere usati con scopi politici opposti.
E’ vero invece che la propensione all’accentramento è propria in qualche misura di chi detiene il potere centrale (e cerca di rafforzarne le basi), mentre il decentramento è solitamente rivendicato dalle forze che da quel potere sono escluse o non si sentono adeguatamente rappresentate.
Sommario.
Al momento dell’unità l’agricoltura era l’attività economica nettamente prevalente nel paese; si trattava di un’agricoltura per lo più povera, caratterizzata da una grande varietà negli assetti produttivi: aziende agricole moderne (Pianura Padana), mezzadria (Italia centrale), latifondo (Mezzogiorno).
La condizione di vita dei contadini era generalmente ai limiti della sussistenza fisica.
Questa realtà di arretratezza economica e disagio sociale era assai poco conosciuta dalla classe dirigente.
Morto Cavour (giugno ’61), il gruppo dirigente che tenne le redini del paese proseguendone l’opera – sia pure senza la sua genialità e abilità – fu quello della Destra.
Le si contrapponeva la Sinistra, che faceva proprie le rivendicazioni della democrazia risorgimentale (suffragio universale, decentramento amministrativo, completamento dell’unità attraverso l’iniziativa popolare).
Destra e Sinistra erano espressione d’una classe dirigente molto ristretta (gli aventi diritto al voto erano 400000): il che diede un carattere accentrato e personalistico alla vita politica.
I leader della Destra realizzarono, sul piano amministrativo e legislativo, una rigida centralizzazione.
Tra le circostanze che li spinsero in tale direzione va ricordata soprattutto la situazione del Mezzogiorno, dove l’ostilità delle masse contadine verso i “conquistatori” assunse col brigantaggio caratteristiche di vera e propria guerriglia.
Il brigantaggio fu sconfitto grazie a un massiccio impiego dell’esercito: restò tuttavia irrisolto il problema di fondo del Mezzogiorno, cioè quello della terra (non favorirono i contadini né la divisione dei terreni demaniali né la vendita dei beni ecclesiastici).
Sul piano economico, la linea liberista seguita dal governo produsse un’intensificazione degli scambi commerciali che favorì lo sviluppo dell’agricoltura e consentì l’inserimento del nuovo Stato nel contesto economico europeo.
Fu importante anche l’impegno della Destra nella creazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo economico (strade, ferrovie).
Nell’immediato, tuttavia, il tenore di vita della popolazione non migliorò, anche a causa della dura politica fiscale seguita dalla Destra, soprattutto quando, dopo il ’66, alla necessità di coprire gli ingenti costi dell’unificazione si sommarono le conseguenze di una crisi internazionale e le spese per la guerra contro l’Austria.
Particolarmente impopolare fu la tassa sul macinato, che provocò violente agitazioni sociali in tutto il paese.
Il completamento dell’unità costituì uno dei problemi più difficili che la Destra si trovò di fronte.
Falliti i tentativi di conciliazione con la Chiesa, riacquistava spazio l’iniziativa dei democratici; nel 1862 l’iniziativa garibaldina di una spedizione di volontari si risolse in uno scontro con l’esercito regolare (Aspromonte).
Nel 1864 fu firmata la Convenzione di settembre con la Francia, che prevedeva il trasferimento della capitale a Firenze.
L’alleanza con Bismarck contro l’Austria e la vittoria prussiana consentirono nel 1866 l’acquisto del Veneto, cui si accompagnò però una profonda amarezza nell’opinione pubblica: solo grazie alla Prussia, infatti, l’Italia allargava il suo territorio dopo una guerra in cui aveva subito due cocenti sconfitte (Custoza e Lissa).
Il problema della conquista di Roma – fallito a Mentana (1867) un nuovo tentativo garibaldino – poté risolversi inaspettatamente con la caduta del Secondo Impero, che permise al governo italiano la presa della città (20 settembre 1870).
Con la legge delle guarentigie lo Stato italiano si impegnava a garantire al pontefice le condizioni per il libero svolgimento del suo magistero spirituale.
L’intransigenza di Pio Nono si manifestò nel divieto per i cattolici italiani di partecipare alle elezioni.
Nel marzo 1876, il governo fu battuti alla Camera su un progetto di legge relativo alla statizzazione delle ferrovie.
Il nuovo governo presieduto da Depretis segnava il definitivo allontanamento della Destra dal potere.
L’avvento al potere della Sinistra segnò l’inizio di una nuova fase nella politica italiana: si allontanava il periodo delle lotte risorgimentali e si allargavano in qualche misura le basi dello Stato.
Tuttavia – approvata la legge Coppino sull’istruzione e la riforma elettorale dell’82 – gran parte del programma riformatore della Sinistra fu accantonato.
Il sistema politico italiano perse, col “trasformismo” di Depretis, il suo carattere bipartitico, finendo con l’essere dominato da un grande centro che emarginava le ali estreme.
La Sinistra abolì la tassa sul macinato e aumentò la spesa pubblica.
Se si escludono le zone più sviluppate del Nord, l’agricoltura italiana versava in condizioni assai arretrate.
Situazione ulteriormente aggravata dalle ripercussioni della crisi agraria, tra i cui effetti vi fu il rapido incremento dell’emigrazione.
La crisi agraria finì col favorire indirettamente il “decollo” industriale italiano, dimostrando quanto fosse illusoria l’idea che lo sviluppo economico del paese potesse basarsi solo sull’agricoltura.
Si affermò così una linea di appoggio dello Stato all’industria che si manifestò anzitutto nell’adozione di tariffe protezionistiche (1878 e, soprattutto, 1887).
Il protezionismo era una strada obbligata per l’industrializzazione del paese.
Restava, e anzi si aggravava, lo squilibrio economico fra Nord e Sud.
La stipulazione della Triplice Alleanza (1882) segnò nella politica estera italiana una svolta, determinata dal timore di un isolamento internazionale e dal trauma rappresentato dall’occupazione francese della Tunisia.
Il Trattato costringeva l’Italia a rinunziare implicitamente alla rivendicazione del Trentino e Venezia Giulia, tenuta viva dal movimento irredentista.
Fu avviata in quegli anni un’espansione coloniale sulle coste del Mar Rosso.
Il tentativo di estendersi verso l’interno portò al contrasto con l’Etiopia e all’eccidio di Dogali (1887).
Dati i ritardi nello sviluppo industriale, la classe operaia italiana era costituita solo per una minoranza da proletariato di fabbrica.
Le società di mutuo soccorso, inizialmente dominata da mazziniani e moderati, perdettero via via terreno a favore del movimento internazionalista che in Italia ebbe essenzialmente indirizzo anarchico.
Gli anni ’80 videro una notevole crescita del movimento operaio, con la fondazione di federazioni di mestiere e Camere del lavoro, leghe bracciantili e cooperative agricole.
Nel 1892 fu fondato il Partito dei lavoratori italiani (poi Partito socialista).
Benché il non expedit (1874) vietasse la partecipazione dei cattolici alle elezioni politiche (ma non alle amministrative)m la presenza cattolica nella società italiana, soprattutto nelle campagne, era massiccia.
L’Opera dei congressi sorse per organizzare tale presenza, secondo una linea di rigida opposizione al liberalismo e al socialismo.
L’elezione del papa Leone Tredicesimo (1878), più aperto ai problemi della società moderna, favorì l’impegno sociale dei cattolici e lo sviluppo delle loro organizzazioni.
Alla morte di Depretis (1887) divenne presidente del Consiglio Crispi: la sua politica autoritaria e repressiva si accompagnò a un importante riorganizzazione dell’apparato statale.
La sua politica estera portò alla “guerra doganale” con la Francia e a un maggior impegno in Africa orientale.
Nettamente diversa la politica di Giolitti, a capo del governo nel ’92-93, imperniata su una più equa pressione fiscale e su una linea non repressiva nei confronti dei conflitti sociali.
Il rifiuto di Giolitti di adottare misure eccezionali contro i Fasci siciliano e lo scandalo della Banca romana provocarono le sue dimissioni.
Gli atti di maggior rilievo del nuovo governo Crispi (1893) furono: la riforma bancaria (nascita della Banca d’Italia), la proclamazione dello stato d’assedio in Sicilia e Lunigiana, le leggi antisocialiste, l’ulteriore spinta all’azione coloniale che portò alla guerra con l’Etiopia.
La sconfitta di Adua (1896) causò la fine politica di Crispi.
Bibliografia.
Per la storia dell’Italia unita fino al 1915
Storia d’Italia dal 1871 al 1915 / B. Croce. – Laterza, 1928
Italia moderna. Vol. 1-2-3 / G. Volpe. – Ispi, 1943
Storia dell’Italia moderna. Vol. 5-6 / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1968-70
L’Italia liberale, 1861-1900 / R. Romanelli. – Il Mulino, 1979
Storia d’Italia. Vol. 2 / Sabbatucci/Vidotto. – Laterza, 1995
Storia politica dell’Italia liberale, 1861-1901 / F. Cammarano. - Laterza, 1999
Storia d’Italia. Vol. 4. – Einaudi, 1975-76
Il lungo Risorgimento: la nascita dell’Italia contemporanea, 1770-1922 / G. Pécout. – Mondadori, 1999
Sugli aspetti istituzionali
Storia costituzionale d’Italia, 1848/1948 / C. Ghisalberti. – Laterza, 1974
Storia dello Stato italiano dall’unità ad oggi / a c. di R. Romanelli. – Donzelli, 1995
Storia dell’amministrazione italiana, 1861-1993 / G. Melis. – Il Mulino, 1996
Per la storia economica
Storia economica dell’Italia liberale, 1850-1918 / G. Toniolo. – Il Mulino, 1988
Dualismo e sviluppo nella storia d’Italia / L. Cafagna. – Marsilio, 1989
Dalla periferia al centro: la seconda rinascita economica dell’Italia, 1861-1981 / V. Zamagni. – Il Mulino, 1990
Unità nazionale e sviluppo economico / G. Pescosolido. – Laterza, 1998
Risorgimento e capitalismo / R. Romeo. – Laterza, 1959
Breve storia della grande industria in Italia, 1861-1961 / R. Romeo. – Cappelli, 1972
La formazione dell’Italia industriale / a c. di a. Caracciolo. – Laterza, 1963
L’industrializzazione in Italia, 1861-1900 / a c. di G. Mori. – Il Mulino, 1981
Sulla questione meridionale
Il Sud nella storia d’Italia / a c. di R. Villari. – Laterza, 1961
Il mito del buongoverno: la questione meridionale da Cavour a Gramsci / M. L. Salvadori. – Einaudi, 1960
Breve storia dell’Italia meridionale / P. Bevilacqua. – Donzelli, 1990
Sui ceti dirigenti
Storia della borghesia italiana: l’età liberale / A. M. Banti. – Donzelli, 1996
Sui rapporti tra classe dirigente e “paese reale”.
Il comando impossibile / R. Romanelli. – Il Mulino, 1988
Su scuola e cultura
Fare gli italiani. Vol. 1.: La nascita dello Stato nazionale / a c. di S. Soldani, G. Turi. - Il Mulino, 1993
Sulla politica estera
Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896: le premesse / F. Chabod. – Laterza, 1951
Su Depretis
Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887 / G. Carocci. – Einaudi, 1956
Su Crispi
Creare la nazione: vita di Francesco Crispi / Ch. Duggan. – Laterza, 2000
Per il movimento operaio e il socialismo
Il socialismo nella storia d’Italia: storia documentaria dal Risorgimento alla Repubblica / a c. di G. Manacorda. – Laterza, 1966
Storia del socialismo italiano, 1892-1926 / G. Arfè. – Einaudi, 1965
Storia del socialismo italiano: dalle prime lotte nella Valle Padana ai fasci siciliani / R. Zangheri. - Einaudi, 1967
Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale: il caso italiano, 1880-1900 / S. Merli. – La Nuova Italia, 1972
Movimento operaio e lotte sindacali, 1880-1922 / A. Pepe. – Loescher, 1976
I Fasci siciliani, 1892-94 / F. Renda. – Einaudi, 1977
Sui cattolici.
Storia del movimento cattolico in Italia / G. De Rosa. – Laterza, 1966
Il movimento cattolico in Italia / G. Candeloro. – Ed. Riuniti, 1961
Cap. 10. Verso la società di massa.
Parola chiave. Secolarizzazione.
Nel linguaggio della Chiesa, “secolarizzazione” (da “secolo”, inteso come vita terrena) significa passaggio allo stato laicale di chi ha ricevuto gli ordini religiosi oppure destinazione all’uso profano di beni già destinati al culto.
Nel linguaggio delle scienze sociali contemporanee, per secolarizzazione si intende il processo di emancipazione della società dal condizionamento dei valori sacri o magici e dal controllo delle autorità religiose.
Uan società secolarizzata non è necessariamente una società irreligiosa.
E’ piuttosto una società laica, in cui le credenze e le pratiche religiose non si traducono in norme vincolanti per tutti; in cui i comportamenti collettivi – in materia di attività economiche, di istruzione, ma anche di morale familiare e sessuale – tendono ad allontanarsi dagli schemi della tradizione e a orientarsi secondo criteri di pura razionalità.
In questo senso la secolarizzazione è componente essenziale della modernizzazione e si accompagna ai processi di sviluppo industriale e di urbanizzazione.
Ma è soprattutto con l’avvento della società di massa – e con la conseguente crisi delle culture locali e tradizionali legate al mondo rurale – che la secolarizzazione riceve una spinta decisiva.
Non si deve pensare però alla secolarizzazione come a una tendenza irreversibile, a un portato necessario del progresso scientifico e dello sviluppo economico.
Se nei paesi industrializzati dell’Occidente il processo può considerarsi in larga parte compiuto, nonostante i molti segni di risveglio religioso e nonostante la tenace opposizione delle Chiese (lo testimonia la scarsa osservanza, negli stessi paesi cattolici, delle prescrizioni ecclesiastiche in materia di contraccezione e in genere di morale sessuale), la situazione è molto diversa in altre parti del mondo.
In particolare nei paesi islamici, e non solo in quelli più arretrati economicamente, si è assistito negli ultimi decenni a un prepotente ritorno dell’integralismo, ossia al tentativo di sottomettere all’autorità della religione le scelte dei pubblici poteri e dei privati cittadini.
Sommario.
Alla fine dell’800 cominciarono a delinearsi, nell’Europa occidentale e negli Stati Uniti, i caratteri della moderna società di massa.
La maggioranza della popolazione viveva ormai nei centri urbani ed era inserita nel circolo dell’economia di mercato; i rapporti sociali si facevano più intensi e si basavano non più sulle comunità tradizionali, bensì sulle grandi istituzioni nazionali (apparati statali e organizzazioni di massa).
Gli anni 1896-1913 furono, per i paesi industrializzati, un periodo di intensa espansione economica, cui si accompagnò, tra l’altro, un aumento del reddito pro-capite che determinò un allargamento del mercato.
Le dimensioni di massa assunte dalla domanda stimolarono la produzione in serie, nonché la diffusione di processi di meccanizzazione produttiva (catena di montaggio, taylorismo).
Mutava, parallelamente, la stratificazione sociale.
Se nella classe operaia si accentuò la distinzione fra lavoratori generici e qualificati, la maggiore novità fu il crescere dei nuovi strati del ceto medio.
Di fondamentale importanza nel determinare i caratteri della nuova società di massa fu il diretto impegno dello Stato nel campo dell’istruzione, che ebbe per conseguenza una drastica diminuzione dell’analfabetismo in tutta Europa.
Si allargava, anche per l’incremento nella diffusione dei giornali, l’area dell’opinione pubblica.
Anche l’introduzione generalizzata del servizio militare obbligatorio e la creazione di eserciti di massa (imposta dall’evoluzione delle strategie e delle tecniche militari) contribuirono ad accelerare i processi di socializzazione.
Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 si ebbe un processo di allargamento della partecipazione alla vita politica determinato dall’estensione del diritto di voto, dall’affermarsi di un nuovo modello di partito (il partito di massa) e dalla crescita di grandi organismi sindacali nazionali.
Parallelamente, la politica delle classi dirigenti tenne in maggior conto le esigenze delle classi lavoratrici (legislazione sociale, servizi pubblici urbani, aumento della tassazione diretta).
I primi albori della società di massa segnarono il manifestarsi di una questione femminile, anche per le conseguenze dell’industrializzazione sull’assetto della famiglia e il ruolo della donna.
I primi movimenti di emancipazione femminile, all’epoca nettamente minoritari, concentrarono la loro azione nella lotta per il suffragio delle donne.
Alla fine dell’800 sorsero i principali paesi europei dei partiti socialisti che si ispiravano per lo più al modello della socialdemocrazia tedesca e facevano capo alla Seconda internazionale, fondata nel 1889.
Mella maggioranza di questi partiti il marxismo fu assunto come dottrina ufficiale; si affacciarono presto, tuttavia, contrasti fra il revisionismo riformista di Bernstein, gli esponenti dell’ortodossia marxista e le nuove correnti rivoluzionarie, tra le quali va ricordata quella “sindacalista rivoluzionaria” che aveva il suo maggior ispiratore in Georges Sorel.
L’ascesa al soglio pontificio di Leone Tredicesimo (1878) se non mitigò l’intransigenza dottrinaria della Chiesa favorì però l’impegno dei cattolici in campo sociale, stimolato soprattutto dall’enciclica Rerum Novarum (1881).
Significativa espressione dei fermenti in atto nel mondo cattolico fu l’emergere, soprattutto in Francia e Italia, di movimento democratico-cristiani e, sul piano più strettamente religioso, del modernismo (colpito, nel 1907, dalla scomunica di Pio Decimo).
Sul piano delle ideologie politiche, nell’Europa di fine ‘800 trovò larga diffusione il nazionalismo, ormai divenuto una corrente nettamente conservatrice.
In varia commistione con esso – e grazie all’appello alle componenti irrazionali della psicologia collettiva – si diffusero tendenze apertamente razziste e antisemite.
In Germania e nell’Europa orientale il nazionalismo prese anche la forma, rispettivamente, di pangermanesimo e panslavismo.
Espressione particolare del generale risveglio nazionalistico, ma anche reazione contro l’antisemitismo, fu il sionismo.
Sul piano culturale, la fine del secolo vide la crisi del positivismo, a favore del diffondersi di nuove correnti che ponevano l’accento sul ruolo del soggetto, considerando elementi costitutivi dell’attività umana fattori quali l’istinto e la volontà.
Le certezze del positivismo in campo scientifico entrarono in crisi anche per le scoperte della fisica contemporanea.
Bibliografia.
Sulla società di massa e le nuove stratificazioni sociali.
La ribellione delle masse / J. Ortega y Gasset. – Il Mulino, 1962
La folla solitaria / D. Riesman. – Il Mulino, 1956
Colletti bianchi: la classe media americana / C. Wright Mills. – Einaudi, 1966
Classi e conflitto di classe nella società industriale / R. Darhrendorf. – Laterza, 1963
Voce Masse / B. Geremek. – In: Enciclopedia. – Einaudi, 1979
Sui partiti politici
La sociologia del partito politico nella democrazia moderna / R. Michels. – Il Mulino, 1966
I partiti politici / M. Duverger. – Comunità, 1970
Sociologia dei partiti politici / a c. di G. Sivini. – Il Mulino, 1971
Storia dell’alfabetizzazione occidentale / H. Graff. – Il Mulino, 1989
Alfabetizzazione e sviluppo sociale in Occidente / a c. di H. Graff. – Il Mulino, 1988
Sul problema degli eserciti di massa
Soldati e borghesi nell’Europa moderna / J. Gooch. – Laterza 1982
Sulla questione femminile
Donne, lavoro e famiglia nell’evoluzione della società capitalistica / L. A. Tilly, J. W. Scott. – De Donati, 1981
Storia delle donne in Occidente. Vol. 4-5 / a c. di G. Duby, M. Perrot. – Laterza, 1991-92
Sulla storia del marxismo e della Seconda internazionale
Storia del pensiero socialista / G. D. H. Cole. – Laterza, 1968
Antologia del pensiero socialista / a c. di A. Salsano. – Laterza, 1981
Storia del marxismo. – Einaudi, 1979
La Seconda internazionale / G. Haupt. – La Nuova Italia, 1973
Sul mondo cattolico e la Chiesa
La Chiesa negli Stati moderni e i movimenti sociali, 1878-1914. – Vol. 9. della Storia della Chiesa / diretta da H. Jedin. – Jaca Book, 1973
Il cattolicesimo politico nel Diciannovesimo e Ventesimo Secolo / K. E. Lönne. – Il Mulino, 1991
Sul nazionalismo
Nazioni e nazionalismi / E. J. Hobsbawm. – Einaudi, 1991
La nazionalizzazione delle masse: simbolismo politico e movimenti di massa in Germania dalle guerre napoleoniche al Terzo Reich / G. L. Mosse. – Il Mulino, 1975
Il razzismo in Europa dalle origini all’olocausto / G. L. Mosse. – Laterza, 1980
L’uomo e le masse nelle ideologie nazionalista / G. L. Mosse. – Laterza, 1982
Sulle nuove correnti culturali e la società politica di fine secolo
Coscienza e società: storia delle idee in Europa dal 1890 al 1930 / H. S. Hughes. – Einaudi, 1967
Cap. 11. L’Europa tra due secoli.
Parola chiave. Radicalismo.
Nel linguaggio politico il termine “radicalismo” indica la tendenza contraria al “moderatismo”: cioè la tendenza favorevole alle innovazioni profonde e decisive, alle misura appunto “radicali”.
In questo senso si può parlare sia di un radicalismo di sinistra, sia di un radicalismo di destra.
In senso più stretto, si dicono “radicali” le correnti di sinistra nate dal filone dei movimenti liberali e democratici.
Il radicalismo moderno nacque in Inghilterra tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800, in quei circoli intellettuali e politici che, ispirandosi alla filosofia utilitaristica di Jeremy Bentham e al liberismo economico di Smith e Ricardo, propugnavano una serie di profonde riforme economiche e politiche (prime fra tutte, l’abolizione del dazio sul grano e l’allargamento del suffragio).
Il movimento radicale sopravvisse in Gran Bretagna per tutto il Secolo Diciannovesimo, ma non assunse mai la consistenza di un partito vero e proprio, svolgendo per lo più un ruolo di appoggio alla sinistra liberale.
In Francia, l’appellativo di “radicale”, che fin allora serviva a designare genericamente le correnti democratico-repubblicane, fu assunto nei primi anni della Terza Repubblica da quell’ala dei repubblicani che, sotto la guida di leader come Clemenceau, si opponeva alla politica “opportunista” dei repubblicani moderati alla Jules Ferry.
All’inizio del ‘900, dopo la crisi dell’”affare Dreyfus”, i radicali divennero la forza dominante dello schieramento politico francese, facendosi promotori di una politica energeticamente anticlericale, ma vennero nel contempo attenuando la loro originaria connotazione democratico-riformista per assumere il ruolo di forza stabilizzatrice, tendenzialmente “centrista”, moderatamente progressista, con solide radici nella piccola e media borghesia rurale.
Il Partito radicale francese costituì un modello per altre formazioni analoghe nate tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 in Italia, in Spagna e in molti paesi latino-americani, sulla stessa piattaforma politica progressista e anticlericale e con la stessa base sociale essenzialmente piccolo-borghese.
In Italia il Partito radicale nacque negli anni ’80 dell’800 come frazione dissidente della Sinistra e si sviluppò soprattutto in età giolittiana, ma rimase sempre una forza minoritaria nello schieramento liberal-democratico e finì col dissolversi come forza politica autonoma dopo la Prima guerra mondiale.
Altra e diversa vicenda è quella del “nuovo” Partito radicale (Pr), nato nel 1956 da una scissione a sinistra del Partito liberale e successivamente caratterizzatosi come una formazione politica molto diversa da quelle tradizionali e vivacemente polemica nei confronti dell’intero sistema politico, come un gruppo d’opinione strettamente collegato ai movimenti collettivi (pacifisti, ecologisti, femministi, ecc.) e promotore di specifiche campagne sui temi dei diritti civili, della pace, della lotta contro la fame nel mondo.
Sommario.
Tra l’ultimo decennio dell’800 e i primi anni del ‘900 si delineò un mutamento nelle alleanze che segnò la crisi del sistema bismarckiano.
Attraverso l’alleanza tra Francia e Russia, l’”Intesa cordiale” franco-inglese, l’accordo anglo-russo sulle questioni asiatiche, si venne a costituire uno schieramento – poi detto Triplice intesa – contrapposto alla Triplice alleanza e di questa potenzialmente più forte.
In Francia, alla fine del secolo, restavano forti le correnti contrarie alle istituzioni repubblicane.
Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, queste correnti si coagularono intorno al caso del capitano Dreyfus (un ufficiale ebreo ingiustamente condannato per spionaggio) che divenne simbolo della spaccatura dell’opinione pubblica, divisa tra innocentisti e colpevolisti.
Le forze progressiste ebbero infine una vittoria sul piano elettorale, che diede inizio a un periodo di governi a direzione radicale.
A cavallo fra i due secoli la politica inglese fu dominata dalla coalizione tra conservatori e “unionisti”, che cercarono di unire a una politica imperialistica una certa dose di riformismo sociale.
Il successo dei liberali (1906) segnò un mutamento politico in senso progressista che trovò il suo momento più importante nella battaglia per la riduzione dei poteri della Camera dei Lords.
Contemporaneamente cresceva, a scapito dei liberali, la rappresentanza parlamentare dei laburisti.
Il “nuovo corso” di Guglielmo Secondo non segnò, al di là dell’allontanamento di Bismark (1890), un effettivo mutamento di indirizzi: la più aggressiva politica estera della Germania guglielmina rafforzava, anzi, la tradizionale alleanza tra grande industria, aristocrazia terriera e vertici militari, e finiva con l’ottenere l’appoggio di tutte le forze politiche, socialdemocratici esclusi.
La Spd confermava la sua grande forza, cui si accompagnava però un sostanziale isolamento.
Nell’Impero asburgico lo sviluppo economico rimase limitato ad alcune aree: il sistema politico e la struttura sociale delle campagne erano caratterizzati da un sostanziale immobilismo.
Il più grave problema per la monarchia era rappresentato dalle agitazioni autonomistiche delle varie nazionalità, anzitutto gli slavi.
Grazie all’intervento diretto dello Stato e all’afflusso di capitali stranieri si verificò, nella Russia degli anni ’90, un primo decollo industriale.
Si trattò di uno sviluppo fortemente concentrato (dal punto di vista geografico e per dimensione di imprese); la società russa rimaneva però fortemente arretrata.
Tutte le sue contraddizioni si rivelarono nella rivoluzione del 1905.
Ristabilito l’ordine e svuotato l’esperimento parlamentare della Duma, fu varata dal primo ministro Stolypin una riforma agraria non in grado, tuttavia, di risolvere gli enormi problemi delle campagne.
Il decennio precedente la Prima guerra mondiale vide un acuirsi dei contrasti internazionali.
Dalla due crisi marocchine (1905 e 1911) la Germania uscì sconfitta, mentre la Francia ottenne un protettorato sul Marocco.
Più gravi furono gli avvenimenti nella penisola balcanica.
L’annessione della Bosnia-Erzegovina (1908) da parte dell’Austria, la guerra italo-turca (1911), le due guerre balcaniche (1912-13) segnarono un profondo rivolgimento degli equilibri in questa area.
La Turchia – dove nel 1908 si era verificata la rivoluzione dei “giovani turchi” – veniva definitivamente estromessa dall’Europa, mentre si faceva sempre più acuto il contrasto tra Austria e Serbia (protetta dalla Russia).
Bibliografia.
Sulla storia europea fra i due secoli
L’età dell’imperialismo: Europa, 1885-1918 / W. Mommsen. – Feltrinelli, 1970. – Vol. 28 della Storia universale Feltrinelli
La decadenza dell’Europa occidentale. Vol. 1.: Anni di trionfo, 1890-1914 / M. Silvestri. – Einaudi, 1977
Il potere dell’Ancien regime fino alla Prima guerra mondiale / A. J. Mayer. – Laterza, 1982
Sulla socialdemocrazia tedesca
I socialdemocratici nella Germania imperiale / G. Roth. – Il Mulino, 1971
Sulla Russia
Storia della Russia contemporanea, 1853-1996 / F. Benvenuti. – Laterza, 1999
Cap. 12. Imperialismo e rivoluzione nei continenti extraeuropei.
Parola chiave. Populismo.
Per “populismo” si intende un orientamento politico e culturale che si fonda su una visione idealizzata e indifferenziato del “popolo”, cisto – in opposizione all’aristocrazia e ai ceti privilegiati – come depositario dei più autentici valori nazionali e come protagonista del processo di rinnovamento sociale.
Il populismo si differenzia dunque dal marxismo, che contrappone all’idea del popolo come un tutto unico la visione di una società divisa in classi individuate in base al loro ruolo nel processo produttivo.
In quanto movimento politico organizzato, il populismo nacque e si sviluppò in Russia nella seconda metà dell’800.
I teorici del populismo russo (Herze, Cernisevskij) teorizzavano il dovere degli intellettuali di “andare verso il popolo” (identificato soprattutto con le masse contadine) e si ispiravano a ideali di socialismo agrario.
A ideali di democrazia rurale (ma senza sconfinamenti nel socialismo) si ispirò anche il Partito populista che nacque e si affermò negli Stati Uniti nell’ultimo decennio dell’800 ed esprimeva la protesta dei piccoli e medi agricoltori, messi in difficoltà di accesso di credito, contro il mondo industriale e finanziario.
In epoche più recenti il termine “populismo” è stato usato in riferimento a ideologie e movimenti di stampo nazionalista e autoritario (in questo senso si può parlare di un populismo fascista e nazista).
In particolare, sono definiti populisti quei movimenti e quei regimi sviluppatisi in America Latina a partire dagli anni ’30 – come il “getulismo” in Brasile e il “peronismo” in Argentina – che hanno cercato di combinare il nazionalismo col riformismo sociale, la lotta contro le vecchio oligarchie terriere con una gestione più o meno autoritaria e personalistica del potere, e che hanno trovato la loro principale base di sostegno nel proletariato industriale e nella piccola borghesia urbana.
Sommario.
Il primo quindicennio del ‘900 vide il manifestarsi dei primi segni d’un decimo dell’Europa di fronte all’emergere di popoli extraeuropei.
Preoccupava in particolare la crescita dei paesi asiatici (Cina e Giappone), che fece parlare di un “pericolo giallo”.
Alla fine dell’800 il Giappone avviò una politica espansionistica in Asia: prima mosse guerra all’Impero cinese (1894), poi attaccò e sconfisse la Russia (1905).
Per la prima volta nell’età moderna un paese asiatico riuscì a battere in un’autentica guerra una grande potenza europea.
All’inizio del ‘900 sorse in Cina un movimento nazionalista e democratico guidato da Sun Yat-sen, eletto presidente della Repubblica dopo la rivoluzione del 1911 che rovesciò la dinastia Manciù.
Successivamente le forze conservatrici ebbero il sopravvento, inaugurando così una lunga stagione di guerre civili.
Negli anni tra ‘800 e ‘900 gli Stati Uniti, avviati a diventare la prima potenza economica mondiale, allargarono la loro influenza in America Latina dopo la guerra con la Spagna (1898) in appoggio all’indipendenza di Cuba, che valse loro anche il dominio sull’arcipelago delle Filippine.
Durante la presidenza di Theodore Roosevelt, fu realizzato, sotto il controllo degli Usa, il canale di Panama, che collegava l’Atlantico al Pacifico.
Sul piano interno, Roosevelt realizzò una politica di apertura ai problemi sociali.
Le divisioni nel Partito repubblicano favorirono nel 1912 l’elezione del democratico Wilson, che riprese l’impegno sociale di Roosevelt, inserendolo però in un quadro politico e ideologico assai diverso.
Nei trent’anni precedenti la Prima guerra mondiale, il notevole sviluppo economico dei paesi dell’America Latina non attenuò la loro dipendenza dagli Stati industriali dell’Occidente.
Le campagne erano dominate dal latifondo, mentre una ristretta oligarchia terriera controllava la vita sociale e politica.
I maggiori mutamenti sul piano politico furono la vittoria dei radicali in Argentina e la rivoluzione messicana cominciata nel 1910 e segnata dal conflitto fra le sue varie componenti; conflitto che solo nel 1921 si sarebbe concluso con la vittoria dei democratici.
Bibliografia.
Sul ridimensionamento dell’Europa.
Guida alla storia contemporanea / G. Barraclough. – Laterza, 1971
Sul Giappone
La nascita del Giappone moderno / E. H. Norman. – Bruno Mondadori, 2002
Sulla Cina
La Cina / M. Bastid … et al. – Einaudi, 1974
Storia della Cina / M. Sabbatini, P. Santangelo. – Laterza, 1986
Sugli Stati Uniti
Le origini dell’imperialismo americano: da McKinley a Taft, 1897-1913 / A. Aquarone. – Il Mulino, 1973
Gli Stati Uniti nell’età progressista / a c. di A. Testi. - Il Mulino, 1984
La nascita di una potenza mondiale: gli Stati Uniti dal 1870 al 1920 / J. L. Thomas. - Il Mulino, 1988
Sull’America Latina
Storia dell’America Latina / T. Halperin Donghi. – Einaudi, 1972
L’America Latina nel Ventesimo Secolo / M. Plana, A. Trento. – Ponte alle Grazie, 1992
Cap. 13. L’Italia giolittiana.
Massoneria.
La “Massoneria” è un’associazione segreta che trae il suo nome dalle corporazioni medievali dei “liberi muratori” (free-massons in inglese, franc-maçons in francese), i cui membri erano tenuti all’aiuto reciproco e alla conservazione dei segreti del mestiere.
Nel corso dei secoli, col decadere delle corporazioni artigiane, queste associazioni assunsero un carattere esoterico, allargandosi anche a membri estranei all’arte muratoria e appartenenti agli strati superiori della società (nobili borghesi, intellettuali).
Finché, all’inizio del ‘700, l’associazione perse definitivamente il suo carattere di organizzazione di mestiere, pur conservandone il linguaggio, la simbologia e le strutture organizzative (la divisione in “logge” facenti capo a un “gran maestro”).
Nata in Inghilterra e diffusasi presto in tutta Europa e nel Nord America, la “nuova” Massoneria si ispirava a una filosofia “deista” (Dio era chiamato il “Grande architetto” dell’universo), faceva propri gli ideali illuministi, professava la tolleranza religiosa e imponeva ai suoi affiliati La pratica della filantropia e della mutua assistenza.
Duramente avversata dalla Chiesa cattolica, la Massoneria venne accentuando, durante il Secolo Diciannovesimo, la sua ispirazione anticlericale e assunse una connotazione politica più spiccata.
Legate direttamente o indirettamente alla Massoneria erano molte delle società segrete (come la Carboneria) impegnate nelle agitazioni nazionali e costituzionali dell’età della Restaurazione.
Nella seconda metà del secolo, la Massoneria divenne in molti paesi (in particolare in quelli in cui la parte più forte era la presenza cattolica) una sorta di accademia del “libero pensiero”, un vero e proprio contraltare della Chiesa di Roma, e insieme un luogo di incontro e di raccordo fra gruppi politici di orientamento democratico e anticlericale.
Questa funzione quasi di “superpartito” la Massoneria la svolse principalmente in Francia e in Italia e soprattutto negli anni a cavallo fra ‘800 e ‘900.
In Francia essa fu in prima fila nelle battaglie sviluppatesi intorno all’affare Dreyfus e du ispiratrice della politica anticlericale praticata dai governi di inizio secolo.
In Italia svolse un’importante funzione di appoggio alla svolta giolittiana e favorì, a livello di amministrazioni locali, la formazione di “blocchi democratici” aperti a tutte le forze di sinistra.
In questo periodo, però, la Massoneria fu oggetto di critiche e attacchi sempre più frequenti.
Non solo da parte dei tradizionali avversari cattolici, ma anche di uomini politici e intellettuali di diverse tendenze (dall’estrema destra all’estrema sinistra), che vedevano in essa un centro di potere occulto, in cui i riti iniziatici e la fraseologia umanitaria servivano a coprire il perseguimento di obiettivi tutt’altro che idealistici.
In effetti, nel corso del Ventesimo Secolo, la Massoneria ha finito col perdere buona parte della sua caratterizzazione ideologica e del suo afflato universalistico, per frammentarsi in una serie di gruppi di interesse legati alle specifiche situazioni dei singoli paesi.
Significativo a questo proposito è il caso dell’Italia, che ha visto, negli anni ’70 e ’80, alcune frazioni della massoneria coinvolte in oscuri scandali politico-finanziari e in trame a sfondo autoritario.
Sommario.
Negli ultimi anni dell’800, si fece strada tra le forze conservatrici italiane la tendenza di risolvere in senso autoritario le tensioni politiche e sociali.
Essa si manifestò con la dura repressione militare dei moti per il pane del ’98 e con il tentativo del governo Pelloux di far approvare delle leggi limitative delle libertà.
La dura opposizione incontrata alla Camera e le elezioni del 1900 portarono a un mutamento di rotta, che (dopo l’assassinio di Umberto Primo) fu confermato dal nuovo re Vittorio Emanuele Terzo.
Il governo Zanardelli-Giolitti (1901-3) si caratterizzò per alcuen importanti riforme sociali e per la neutralità nel campo dei conflitti di lavoro.
Quest’ultimo fatto favorì lo sviluppo delle organizzazioni sindacali, che a sua volta fu accompagnato da un brusco aumento degli scioperi (con la conseguenza di un notevole incremento dei salari operai e agricoli).
Negli ultimi anni del secolo iniziò il decollo industriale italiano, preparato – negli anni precedenti – dalla costruzione di una rete ferroviaria, dalla scelta protezionistica, dal riordinamento del sistema bancario.
Lo sviluppo industriale, se non ridusse il divario con i paesi più ricchi, provocò però un aumento del reddito e un miglioramento del tenore di vita degli italiani.
Cresceva - parallelamente – l’emigrazione, conseguenza di una sovrabbondanza della popolazione rispetto alle capacità produttive, dell’agricoltura, che nel Mezzogiorno restava arretrata (provocando così un accentuarsi del divario con il Nord industrializzato).
Leggi speciali per il Mezzogiorno, statizzazione delle ferrovie, conversione della rendita, introduzione del suffragio universale maschile (1912), monopolio statale delle assicurazioni sulla vira rappresentarono i punti qualificanti della politica di Giolitti, che rimase a capo del governo, con alcune interruzioni, dal 1903 al 1914.
Il suo riformismo non era privo di limiti, per il condizionamento delle forze conservatrici e per la costante attenzione di Giolitti a non modificare in senso eccessivamente democratico gli equilibri parlamentari; inoltre, la crisi economica del 1907 accrebbe, da un lato, le lotte sociali mentre, dall’altro, favorì un atteggiamento più duro delle associazioni padronali.
La “dittatura” di Giolitti – realizzata attraverso lo stesso controllo del Parlamento e l’intervento del governo, soprattutto al Sud, nelle competizioni elettorali – trovò molti critici fra le forze politiche (socialisti rivoluzionari, cattolici democratici, liberali-conservatori, meridionalisti) e soprattutto fra gli intellettuali.
Sul piano della politica estera, l’Italia si avvicinò, tra dine ‘800 e inizio ‘900, alla Francia, pur restando fedele alla Triplice alleanza.
Mutò contemporaneamente l’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti delle imprese coloniali, che cominciarono ad essere caldeggiate soprattutto dal nuovo movimento nazionalista.
Proprio la campagna di stampa dei nazionalisti fu, con le pressioni degli interessi della finanza cattolica, tra i fattori che spinsero il governo all’intervento militare in Libia (1911).
La guerra con la Turchia che ne seguì si concluse con l’imposizione della sovranità italiana sulla Libia.
Nel Psi la corrente riformista guardò con simpatia alla politica giolittiana.
Presto crebbe però entro il partito la forza delle correnti di sinistra, in particolare dei sindacalisti rivoluzionari (questi ultimi ne uscirono nel 1907).
La fondazione della Cgi (1906) segnò un rafforzamento della presenza riformista sul piano delle organizzazioni sindacali.
Ma, dopo l’espulsione dei “revisionisti” nel 1912, il controllo del partito passò ai rivoluzionari, uno dei cui maggiori leader era Mussolini.
In età giolittiana si sviluppò, in campo cattolico, il movimento democratico-cristiano, condannato dal nuovo papa Pio Decimo.
Ebbero un grande sviluppo, contemporaneamente, le organizzazioni sindacali “bianche”.
Sul piano politico le forze clerico-moderate stabilirono alleanze elettorali, in funzione conservatrice, con i liberali: questa linea politica avrebbe avuto piena consacrazione, nelle elezioni del 1913, col “patto Gentiloni”.
I mutamenti in atto nel sistema politico italiano alla vigilia della grande guerra (sviluppo del nazionalismo, accresciuto peso dei cattolici, prevalenza dei rivoluzionari nel Psi) segnavano la progressiva crisi della politica giolittiana, sempre meno in grado di controllare la radicalizzazione politica che si stava verificando (e di cui, nel ’14, la “settimana rossa” fu un rilevante sintomo).
In questa situazione la guerra avrebbe significato la fine del giolittismo.
Bibliografia.
Un quadro generale.
Storia dell’Italia moderna. Vol. 9. / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1974
Storia d’Italia. Vol. 3. / Sabbatucci-Vidotto. – Laterza, 1995
L’Italia giolittiana / A. Aquarone. – Il Mulino, 1988
Le origini dell’Italia contemporanea: l’età giolittiana / E. Gentile. – Laterza, 2003
Giolitti e l’età giolittiana / G. Carocci. – Einaudi, 1961
Sulla cultura
La cultura / A. Asor Rosa. – Tomo 2 del vol. 4 della Storia d’Italia. – Einaudi, 1975-6
Sulla questione meridionale
Il mito del buongoverno: la questione meridionale da Cavour a Gramsci / M. L. Salvadori. – Einaudi, 1960
Il Sud nella storia d’Italia / R. Villari. – Laterza, 1988
Breve storia dell’Italia meridionale dall’Ottocento ad oggi / R. Villari. – Donzelli, 1993
Sull’emigrazione
L’emigrazione italiana dall’Unità alla Seconda guerra mondiale / E. Sori. – Il Mulino, 1979
Storia dell’emigrazione italiana. Vol. 1.: Partenze / a c. di P. Bevilacqua et al. – Donzelli, 2001
Sui socialisti
Il socialismo nella storia d’Italia / G. Manacorda. – Laterza, 1966
Storia del socialismo italiano, 1892-1926 / G. Arfè. – Einaudi, 1965
Sui cattolici
Storia del movimento cattolico in Italia / G. De Rosa. – Laterza, 1966
Il movimento cattolico in Italia / G. Candeloro. – Ed. Riuniti, 1961
Le origini del partito cattolico in Italia / M. G. Rossi. - Ed. Riuniti, 1977
Sui nazionalisti
Il nazionalismo italiano / F. Gaeta. – Laterza, 1981
Cap. 14. La Prima guerra mondiale
Parola chiave. Propaganda.
Il termine propaganda deriva dalla locuzione latina “de propaganda fide” (sulla fede da diffondere) con la quale la Chiesa designa la Congregazione che si occupa delle attività di proselitismo e di diffusione dei principi cattolici in tutto il mondo.
Nel linguaggio contemporaneo per “propaganda” si intende la diffusione deliberata e sistematica di informazioni e messaggi volti a fornire un’immagine, positiva o negativa, di determinati fenomeni – ma anche a far apprezzare un prodotto commerciale (in questo caso propaganda è sinonimo di pubblicità).
Praticata per la prima volta su vasta scala dai partito socialisti, la propaganda politica è presto divenuta uan componente essenziale della società di massa: soprattutto a partire dal primo conflitto mondiale, quando furono le autorità statali a impadronirsi dei metodi e delle tecniche propagandistiche per rendere popolare presso l’opinione pubblica la causa della guerra.
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa (la radio e il cinema, poi la televisione) ha dato alle attività di propaganda nuove dimensioni e nuova capacità di penetrazione.
Di queste possibilità si sono avvalsi largamente i regimi autoritari che, controllando direttamente i canali di informazione, hanno potuto realizzare forme di persuasione e di indottrinamento molto più efficaci e sofisticate di quelle attuate in passato (quando la propaganda era affidata essenzialmente alla stampa o, tutt’al più, ai manifesti e ai volantini).
Anche in seguito a queste esperienze, il termine “propaganda” ha finito con l’assumere una connotazione negativa, legata all’idea di manipolazione, o quanto meno di informazione unilaterale e distorta.
Sommario.
L’evento scatenante della Prima guerra mondiale fu l’uccisione a Sarajevo, il 28 giugno 1914, dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono degli Asburgo.
Un mese dopo, l’Austria dichiarò guerra alla Serbia, ritenuta corresponsabile dell’attentato.
La Russia, che proteggeva la Serbia, mobilitò il suo esercito provocando la reazione della Germania, alleata dell’Austria.
Il 3 agosto la Germania dichiarò guerra alla Russia e alla Francia sua alleata.
Il 5, dopo che le truppe tedesche ebbero invaso il Belgio neutrale, anche la Gran Bretagna scese in campo contro gli imperi centrali.
Allo scoppio del conflitto, e alla sua successiva estensione su scala mondiale, concorsero uan serie di tensioni preesistenti, ma anche errori e scelte avventate commesse dai capi politici e militari dei paesi interessati.
Le scelte dei governanti furono del resto appoggiate da una forte mobilitazione dell’opinione pubblica.
Gli stessi partito socialisti si schierarono, nella maggior parte dei casi, su posizioni patriottiche.
Gli eserciti scesi in campo nell’estate del 1914 non avevano precedenti per dimensioni e per novità di armamenti.
Ma le concezioni strategiche restavano legate alle esperienze ottocentesche.
I tedeschi, in particolare, puntavano sull’ipotesi di una rapida guerra di movimento.
Ma, dopo essere penetrati in territorio francese, furono bloccati sulla Marna.
Già alla fine del 1915, il conflitto assunse dunque caratteri di guerra di posizione e di guerra di logoramento.
Allo scoppio del conflitto, l’Italia si dichiarò neutrale.
Successivamente, però, le forze politiche e l’opinione pubblica si divisero sul problema dell’intervento in guerra contro gli imperi centrali.
Erano interventisti: i gruppi della sinistra democratica e alcune frange eretiche del movimento operaio, i nazionalisti, alcuni ambienti liberal-conservatori.
Erano neutralisti: la maggioranza dello schieramento liberale, che faceva capo a Giolitti, il mondo cattolico, i socialisti.
Contrarie alla guerra erano le masse operaie e contadine, mentre i borghesi e gli intellettuali erano per lo più a favore dell’intervento.
Ciò che determinò l’entrata in guerra (maggio 1915) fu la convergenza tra la pressione della piazza e la volontà del sovrano, del capo del governo e del ministro degli esteri.
Nel 1915-16 la guerra sui fronti italiano e francese si risolse in una immane carneficina, senza che nessuno dei due schieramenti riuscisse a conseguire risultati significativi.
Più alterne furono le vicende sul fronte orientale, dove gli imperi centrali ottennero alcuni importanti successi.
Sul piano tecnico, la trincea fu la vera protagonista del conflitto: La vita monotona ma pesante che vi si svolgeva era interrotta solo, di quando in quando, da grandi e sanguinose offensive, prive di risultati decisivi.
Da ciò, soprattutto nei soldati semplici, uno stato d’animo di rassegnazione e apatia che a volte sfociava in forme di insubordinazione.
Altra novità fu l’utilizzazione di nuove armi: gas, aerei, carri armati, sottomarini.
Il conflitto trasformò profondamente la stessa vita civile dei paesi coinvolti.
In campo economico si dilatò enormemente l’intervento statale, teso a garantire le risorse necessarie allo sforzo bellico.
Il potere dei governi fu largamente condizionato da quello dei militari e, in genere, tutta la società fu soggetta a un processo di “militarizzazione”.
Col protrarsi del conflitto si rafforzarono i gruppi socialisti contrari ad esso, divisi però tra il pacifismo dei riformisti e la proposta dei rivoluzionari di utilizzare la guerra come occasione per la rivoluzione.
Il 1917 fu l’anno più difficile della guerra, soprattutto per l’Intesa: molti furono i casi di manifestazioni popolari contro il conflitto e di ribellione fra le stesse truppe.
Questo clima di stanchezza (espresso anche dall’iniziativa di pace lanciata senza successo dal papa) si riscontrava anche in Italia.
La demoralizzazione e la stanchezza delle truppe favorirono la vittoria degli austro-tedeschi dell’ottobre 1917 (Caporetto), dovuta comunque anzitutto ad errori dei comandi italiani.
Sempre nel 1917 si verificarono due avvenimenti di decisiva importanza.
In Russia, dopo la caduta dello zar, in marzo, iniziò un processo di dissoluzione dell’esercito; dopo la rivoluzione di novembre, il paese si ritirò dal conflitto.
In aprile gli Stati Uniti entrarono in guerra con l’Intesa, dando al conflitto, per volontà del presidente Wilson, una nuova connotazione ideologica “democratica”.
Anche grazie alla superiorità militare conseguita con l’intervento americano, nel novembre 1918 la guerra terminava con la vittoria dell’Intesa: un esito cui contribuirono in larga misura la dissoluzione interna dell’Austria-Ungheria (causata dal distacco delle varie nazionalità) e la rivoluzione scoppiata in Germania.
Alla Conferenza della pace, che si tenne e Versailles, il compito dei vincitori si rivelò difficilissimo.
Nelle dure condizioni imposte alla Germania risultò evidente il contrasto fra l’ideale di una pace democratica e l’obiettivo francese di una pace punitiva.
La carta dell’Europa fu profondamente mutata, soprattutto in conseguenza della dissoluzione dell’Impero asburgico, che permise la nascita di nuovi Stati.
L’ideale wilsoniano di un organismo internazionale che potesse evitare guerre future in sostanza non si realizzò: la Società delle nazioni nacque minata da profonde contraddizioni (anzitutto la mancata adesione degli Stati Uniti).
Bibliografia
Sulle origini della guerra
Le origini della Prima guerra mondiale / J. Joll. – Laterza, 1985
La Prima guerra mondiale, 1914-1918 / B. H. Liddell Hart. – Rizzoli, 1968
La decadenza dell’Europa occidentale / M. Silvestri. – Einaudi, 1978
La grande storia della Prima guerra mondiale / M. Gilbert. – Mondadori, 1998
La Prima guerra mondiale: una storia politico-militare / J. Keegan. – Carocci, 2000
Sulla Germanie e sul problema della responsabilità della guerra
Assalto al potere mondiale: la Germania nella guerra, 1914-1918 / F. Fischer. – Einaudi, 1965
I militari e la politica nella Germania moderna / G. Ritter. – Einaudi, 1967-73
Sulla crisi finale dell’Impero asburgico
Requiem per un impero defunto / F. Fejto. – Mondadori, 2000
Sull’Italia
Storia politica della Grande guerra, 1915-1918 / P. Melograni. – Laterza, 1969
La Grande guerra degli italiani, 1915-1918 / A. Gibelli. – Sansoni, 1998
La Grande guerra, 1914-1918 / M. Isnenghi, G. Rochat. – La Nuova Italia, 1999
Caporetto / M. Silvestri. – Mondadori, 1984
Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra / G. Procacci. – Ed. Riuniti, 1994
L’Italia nella Prima guerra mondiale / G. Rochat. – Feltrinelli, 1976
Sui riflessi psicologici e letterari
Terra di nessuno: esperienza bellica e identità personale nella Prima guerra mondiale / E. J. Leed. – Il Mulino 1985
La Grande guerra e la memoria moderna / P. Fussell. – Il Mulino, 1984
Il mito della Grande guerra da Marinetti a Malaparte / M. Isnenghi. – Laterza, 1970
La Grande guerra: esperienza, memoria, immagini / a c. di D. Leoni e C Zadra. – Il Mulino, 1986
La fabbrica della guerra: la Grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale / A. Gibelli. – Bollati Boringhieri, 1991
Cap. 15. La Rivoluzione russa.
Parola chiave. Soviet.
Il termine “soviet” altro non è che il corrispettivo russo di “consiglio” e indica quegli organismi rivoluzionari, espressi direttamente dai lavoratori, che, sorti a Pietroburgo durante la Rivoluzione russa del 1905, avrebbero poi dovuto costituire, almeno in teoria, la struttura fondamentale dello Stato nato dalla rivoluzione bolscevica dell’ottobre ’17: Stato che avrebbe preso appunto il nome di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (o Unione Sovietica).
Nel primo dopoguerra, l’esperienza dei soviet rappresentò per tutta la sinistra rivoluzionaria un esempio da seguire e un mito cui ispirarsi.
In tutti i maggiori paesi europei si formarono, all’interno delle organizzazioni tradizionali del movimento operaio, gruppi “consiliari” (in Italia il più importante fu quello che faceva capo ad Antonio Gramsci e alla rivista torinese “L’Ordine Nuovo”), poi in buona parte confluiti nei partiti comunisti.
Questi gruppi contestavano le forme tradizionali di rappresentanza politica e sindacale e vedevano nei consigli un organo di democrazia diretta (in cui i delegati dovevano essere espressi dalle assemblee e potevano essere revocati in qualsiasi momento) e al tempo stesso la cellula attraverso cui realizzare la gestione dei processi produttivi da parte dei lavoratori.
La fortuna delle ideologie consiliari (o “soviettiste”) declinò rapidamente nel corso degli anni ’20: sia per il riflusso generale dell’ondata rivoluzionaria seguita alla fine della guerra; sia per le vicende stesse dell’Urss, dove i soviet furono ben presto ridotti a una funzione puramente simbolica e di facciata (mentre il potere reale era assunto dalle organizzazioni di partito).
Una ripresa delle tematiche consiliari si ebbe in Europa molto più tardi, per opera di movimenti di contestazione studentesca e operaia del 1968: movimenti che impostarono le loro lotte sul primato dell’assemblea e sul rifiuto della “democrazia delegata”.
Sommario.
Nel marzo 1917, la rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado provocò la caduta dello zar e la formazione di un governo provvisorio dominato dalle forze liberal-moderate.
Nel maggio si formò un secondo governo provvisorio cui parteciparono tutti i partiti, a eccezione dei bolscevichi.
Frattanto, accanto al potere “legale” del governo veniva crescendo il potere parallelo dei soviet, i consigli eletti direttamente dagli operai e dai soldati.
Col ritorno di Lenin in Russia, i bolscevichi accentuarono la loro opposizione al governo provvisorio, chiedendo la pace immediata, la socializzazione della terra e il passaggio di tutti i poteri ai soviet.
Il contributo da essi dato alla sconfitta del tentativo di colpo di Stato di Kornilov rafforzò ulteriormente la loro posizione.
A questo punto, grazie alla determinazione di Lenin, decisero di conquistare il potere con la forza.
La fulminea presa del potere da parte dei bolscevichi (7 novembre 1917) e il governo rivoluzionario da essi formato incontrarono l’opposizione della maggioranza delle forze politiche.
In dicembre i socialisti rivoluzionari riportarono un grande successo nelle elezioni per l’Assemblea costituente: questa, però, fu subito sciolta dai bolscevichi, che in tal modo rompevano definitivamente con la tradizionale democrazia occidentale.
L’uscita della Russia dalla guerra (Trattato di Brest-Litovsk del marzo 1918) provocò l’intervento militare dell’Intesa in appoggio alle armate bianche costituite dalle truppe ribelli al governo.
La gravità della situazione spinse i bolscevichi ad instaurare una vera e propria dittatura.
Grazie alla riorganizzazione dell’esercito operata con la costituzione dell’Armata rossa, il governo rivoluzionario riuscì a prevalere.
Nata ufficialmente nel 1919, ma di fatto effettivamente operante solo dal 1920, l’Internazionale comunista estese a tutto il movimento operaio europeo la frattura tra comunismo e socialdemocrazia che si era verificata in Russia.
I partiti comunisti dei vari paesi nacquero strettamente dipendenti dalle direttive dell’Internazionale, controllata dai russi, e non riuscirono ad ottenere l’adesione della maggioranza della classe operaia.
Nel 1918 il governo bolscevico attuò una politica economica più energica ed autoritaria (“comunismo di guerra”), basata sulla centralizzazione delle decisioni e sulla statizzazione di gran parte delle attività produttive.
Questa politica ebbe tuttavia scarsi risultati, finendo con l’alimentare il malcontento di contadini e operai.
Nel marzo 1921 ci du un mutamento di rotta con la Nep (Nuova politica economica).
Basata su una parziale liberalizzazione delle attività economiche, la Nep stimolò la ripresa produttiva, ma ebbe anche effetti non previsti e non desiderati (crescita dei contadini ricchi, degli imprenditori e degli affaristi).
Le condizioni della grande industria di Stato – e degli operai in essa impiegati – non migliorarono sensibilmente.
Nel 1922 nacque l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Urss).
La nuova costituzione comportava di fatto la dittatura del Partito comunista, l’unico del quale fosse consentita l’esistenza.
I bolscevichi si proposero anche di trasformare cultura e valori tradizionali: da ciò la lotta contro la Chiesa ortodossa, nuove norme sulla famiglia e i rapporti tra i sessi, l’impegno nell’istruzione e nell’educazione dei giovani.
In campo culturale, i primi anni ’20 furono una stagione di fioritura delle avanguardie artistiche.
Con l’ascesa di Stalin alla segreteria del partito (aprile 1922) e la malattia di Lenin (morto nel gennaio 1924), si scatenò una dura lotta all’interno del gruppo dirigente bolscevico.
Stalin riuscì dapprima a emarginare Trotskij (fautore di un continuo sviluppo e di una continua estensione del processo rivoluzionario), contrapponendogli la teoria del “socialismo in un solo paese”.
Quindi si sbarazzò dell’”opposizione di sinistra” (Zinov’ev, Kamenev), che chiedeva la fine della Nep e l’accelerazione dello sviluppo industriale.
Si affermava sempre più il suo potere personale.
Bibliografia
L’Urss di Lenin e Stalin: storia dell’Unione Sovietica, 1914-1945 / A. Graziosi. – Il Mulino, 2010
La tragedia di un popolo: la Rivoluzione russa, 1891-1924 / O. Figes. – Corbaccio, 1997
La Rivoluzione russa / R. Ripes. – Mondadori, 1995
Storia dell’Unione Sovietica / G. Boffa. – Mondadori, 1976
Storia della Russia sovietica / E. H. Carr. – Einaudi, 1964-80
I dieci giorni che sconvolsero il mondo / J. Reed. – Ed. Riuniti, 1961
Lenin e il suo tempo / A. B. Ulam. – Vallecchi, 1967
Le Internazionali operaie / A. Agosti. – Loescher, 1973
Storia del pensiero comunista / M. L. Salvadori. – Mondadori, 1984
Cap. 16. L’eredità della grande guerra.
Parola chiave. Inflazione.
Col termine “inflazione” (dal latino “inflatio”, ossia gonfiamento) si intende la perdita di potere d’acquisto della moneta che si verifica quando la moneta stessa circola in quantità, e con velocità, superiore a quella richiesta dai bisogni del mercato.
Il tasso di inflazione, per lo più calcolato su base annua, indica l’entità di questo deprezzamento: si parla dunque di inflazione al 5, al 10 o al 50 per cento, se in un anno diminuisce di quella percentuale la quantità di beni che si possono acquistare con una determinata quantità di denaro.
Mentre un’inflazione minima è considerata fisiologica, anzi segno di buona salute dell’economia, un’inflazione elevata produce danni economici e sociali rilevanti e mina la credibilità finanziaria del paese che la subisce.
Se il vocabolo è entrato nell’uso corrente negli Stati Uniti ai tempi della guerra di secessione, il fenomeno è antico quanto la moneta.
Quest’ultima, infatti, è anch’essa una merce e dunque è soggetta alla legge della domanda e dell’offerta: se ne circola troppa, il suo valore scende fino ad annullarsi.
L’innesco di un processo inflazionistico è ovviamente diventato più facile da quando la moneta cartacea ha sostituito quella metallica (che ha comunque un suo valore intrinseco ed è più difficile da riprodurre).
Le autorità statali, per soddisfare le esigenze improvvise (è il caso delle guerre) o semplicemente per guadagnare consenso, possono essere infatti indotte a stampare banconote senza rispettare alcun limite: operazione che si risolve spesso in un sequestro di risorse ai danni dei cittadini che hanno prestato soldi allo Stato acquistando titoli del debito pubblico.
Un’altra conseguenza dell’inflazione è la rapida, e spesso traumatica, redistribuzione di redditi e patrimoni fra diverse categorie di cittadini, che penalizza i debitori rispetto ai creditori, i percettori di redditi fissi (più lenti ad adeguarsi al costo della vita) rispetto ai commercianti e ai possessori di beni reali.
Anche per evitare le turbolenze sociali e politiche che in genere accompagnano questi processi, i governi dei paesi industrializzati, dopo le disastrose esperienze dei due conflitti mondiali, hanno cercato con alterna fortuna di controllare e limitare i processi inflazionistici, peraltro ancora diffusi nel mondo (si pensi al caso di molti paesi dell’America Latina negli anni ’70 e ’80 del ‘900).
Un’ulteriore azione di vigilanza è quella esercitata dalle autorità sovranazionali: il controllo dell’inflazione può essere condizione per ottenere prestiti o sussidi o anche per far parte di una determinata comunità, come nel caso dell’area dell’euro all’interno dell’Unione europea.
Sommario.
La guerra era stata un’esperienza di massa senza precedenti e fece sentire i suoi effetti in ogni campo della vita sociale; tutti i valori tradizionali ne furono scossi.
Il problema maggiore che i governi si trovarono di fronte fu quello dell’inserimento dei reduci.
La politica si fece sempre più fenomeno di massa.
Dappertutto si diffondevano le aspirazioni al cambiamento, sia di tipo rivoluzionario, sia sotto dorma di generiche aspirazioni alla pace e alla giustizia sociale.
La Prima guerra mondiale segnò una tappa importante nella trasformazione del ruolo delle donne: nei campi, nelle fabbriche, negli uffici presero il posto degli uomini arruolati nell’esercito.
L’esercizio di mestieri fino ad allora considerati esclusivamente maschili e la crescente consapevolezza delle proprie capacità trasformarono l’immagine stessa della donna.
Questo processo di emancipazione ebbe nel dopoguerra un parziale riconoscimento sul piano dei diritti, ma suscitò anche forti resistenze nei gruppi più conservatori.
Negli anni ’20 e ’30, in molti paesi ci fu una vera e propria ondata di conservatorismo ideologico che cercò di riportare le donne ai loro compiti tradizionali.
Più tardi l’esperienza della Seconda guerra mondiale accelerò ovunque i processi già avviati durante il primo conflitto.
Tranne gli Stati Uniti, tutti i paesi belligeranti uscirono dal conflitto in condizioni di dissesto economico.
L’inflazione modificava la distribuzione della ricchezza, mentre la nuova situazione del commercio internazionale vedeva ridotto il ruolo dell’Europa.
Fu necessario nei vari paesi, di fronte ai problemi posti dal ritorno dell’economia di pace, tenere ancora in piedi le strutture statali di intervento nell’economia.
A un iniziale e artificiale espansione economica seguì, nel 1920-21, una fase di crisi.
Tra la fine del ’18 e l’estate del ’20 (il “biennio rosso”) il movimento operaio europeo fu protagonista di una grande avanzata politica che assunse anche tratti di agitazione rivoluzionaria, sulla scia del mito della Rivoluzione russa.
L’ipotesi rivoluzionaria fallì ovunque, mentre si accentuò, entro il movimento operaio, la divisione fra riformisti e rivoluzionari, con la fondazione del Comintern e la nascita dei partiti comunisti.
Dopo l’armistizio e la caduta dell’Impero, la Germania si trovava in una situazione simile a quella della Russia del ’17.
Ma la socialdemocrazia – che era il partito più forte e controllava il governo repubblicano – si oppose decisamente a esperienze di tipo sovietico, trovando un terreno di obiettiva convergenza con la vecchia classe dirigente.
L’insurrezione tentata nel gennaio ’19 dai comunisti “spartachisti” fu repressa nel sangue.
Le elezioni per l’Assemblea costituente che si tennero poco dopo videro l’affermazione della socialdemocrazia e del Centro cattolico.
L’Assemblea, riunita a Weimar, elaborò uan costituzione democratica fra le più avanzate dell’epoca.
Nel 1920 i socialdemocratici subirono una sconfitta elettorale e dovettero lasciare la guida del governo.
Simili furono le vicende politiche in Austria: dopo che i socialdemocratici governarono nella fase del trapasso di regime, il potere passò nelle mani del Partito cristiano-sociale.
In Ungheria, nel 1919, dopo la breve esperienza comunista, , il potere fu conquistato da Horthy che instaurò un regime autoritario.
Il biennio rosso si concluse con un riflusso delle agitazioni operaie e una ripresa delle forze moderate.
La Francia degli anni ’20 vide sul piano politico un’egemonia dei conservatori (tranne la breve parentesi del “cartello delle sinistre” nel ’24-25); alla stabilizzazione politica si accompagnò – nella seconda metà del decennio – una sensibile ripresa economica.
Più difficile fu la situazione dell’economia britannica, caratterizzata da una fase di ristagno per tutti gli anni ’20.
In questo periodo, il Partito laburista si affermò come secondo partito del paese (nonostante la secca sconfitta subita dal movimento sindacale nel ’26).
La situazione politica della Repubblica di Weimar era caratterizzata da una forte instabilità politica; l’opinione pubblica borghese , in particolare, nutriva diffidenza per un sistema democratico che considerava indissolubilmente associato alla sconfitta.
Il problema delle riparazioni alimentò questo stato d’animo, provocando, sul piano economico, una gravissima crisi del marco.
All’inizio del ’23, Francia e Belgio occuparono la Ruhr, regione vitale per l’economia tedesca.
In Germania la crisi precipitò e l’inflazione raggiunse livelli impensabili.
Vi furono tentativi insurrezionali da parte dell’estrema sinistra (Amburgo) e dell’estrema destra (putsch di Monaco, capeggiato da Hitler, nel novembre ’23).
A partire dall’estate il governo Stresemann avviò una politica di stabilizzazione monetaria e di riconciliazione con la Francia.
Grazie al piano Dawes del 1924, la Germania poté fruire di prestiti internazionali (soprattutto statunitensi), che le avrebbero consentito una rapida crescita economica.
Con il piano Dawes iniziava una fase di distensione internazionale, confermata dagli accordi di Locarno del 1925, che normalizzavano i rapporti franco-tedeschi.
Questa fase si interruppe alla fine del decennio in coincidenza con la crisi economica internazionale.
Bibliografia.
Sugli effetti della Prima guerra mondiale nella cultura europea
La Grande Guerra e la memoria moderna / P. Fussell. – Il Mulino 1984
Le guerre mondiali: dalla tragedia al mito dei caduti / G. L. Mosse. – Laterza, 1990
Il lutto e la memoria: la Grande Guerra nella storia culturale europea / J. Winter. – Il Mulino, 1990
La violenza, la crociata, il lutto: la Grande Guerra a la storia del Novecento / A. Becker. – Einaudi, 2002
Per un’analisi comparata delle vicende economiche e politiche in Germania, Francia e Italia
La rifondazione dell’Europa borghese / C. Maier. – Il Mulino, 1999
Sul “biennio rosso” in Europa
La rivoluzione nell’Europa centrale, 1918-1919 / F. L. Carsten. – Feltrinelli, 1978
Socialismo europeo e bolscevismo / A. S. Lindemann. – Il Mulino, 1977
Sulla Repubblica di Weimar
Storia della Repubblica di Weimar, 1918-1933 / E. Eyck. – Einaudi, 1966
La Repubblica di Weimar: la Germania dal 1917 al 1933 / H. Schulze. – Il Mulino, 1987
La Repubblica di Weimar, 1918-1933: storia della prima democrazia tedesca / H. A. Winckler. – Donzelli, 1998
Per un’analisi in chiave sociologica e politologica
La crisi di Weimar: crisi di sistema e sconfitta operaia / G. E. Rusconi. – Einaudi, 1977
Sugli aspetti culturali
La Repubblica di Weimar / W. Laqueur. – Rizzoli, 1977
La cultura di Weimar / P. Gay. – Dedalo, 1978
Sulla Gran Bretagna e Francia nel periodo fra le due guerre
Storia dell’Inghilterra contemporanea / A. J. P. Taylor. – Laterza, 1968
Storia della Francia nel Novecento / J. Vavasseur-Desperriers. – Il Mulino, 2003
Cap. 17. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
Parola chiave. Squadrismo.
Il termine “squadrismo” entrò nel linguaggio politico italiano nel primo dopoguerra in riferimento alle azioni di violenza organizzata e pianificata condotte dalle formazioni paramilitari fasciste (le squadre d’azione) contro le sedi e le persone fisiche dei loro avversari politici: in primo luogo contro le organizzazioni socialiste delle campagne padane (per questo si parla di squadrismo agrario).
Le origini e gli sviluppi dello squadrismo italiano, come di fenomeni analoghi manifestatisi in altri paesi europei (si pensi soprattutto alla Germania dei “corpi franchi” e delle SA naziste), si collegano strettamente all’esperienza della Grande guerra: sia per le modalità organizzative delle squadre (per lo più comandate da ex ufficiali), sia per i rituali e i simboli adottati.
E certamente all’esperienza bellica vanno fatti risalire la violenza spesso efferata e il diffuso disprezzo per la vita umana che furono orgogliosamente esibiti come tratti caratterizzanti dell’attività squadristica.
Negli anni del suo massimo sviluppo, tra la fine del 1920 e l’estate del 1922, il fascismo squadrista, quello che aveva le sue roccheforti nelle province padane e faceva capo ai “ras” locali, fu considerato da molti cosa diversa dal fascismo politico, a base essenzialmente urbana, impersonato soprattutto da Mussolini, al quale in una breve fase si contrappose esplicitamente.
In realtà i “due fascismi” erano le facce di una stessa realtà, nessuna delle quali avrebbe potuto prescindere dall’altra.
In molti casi le squadre erano nate prima dei fasci e un Partito nazionale fascista si costituì solo nel novembre 1921, assorbendo e inquadrando i gruppi paramilitari: fu così proposto un nuovo modello di formazione politica, quello che più tardi il politologo francese Maurice Duverger avrebbe definito partito milizia (diverso sia dal modello ottocentesco del “partito elettorale” sia da quello del più moderno partito di massa a forte radicamento territoriale, inventato dai socialisti).
Sarebbe dunque riduttivo vedere nello squadrismo un semplice braccio armato del fascismo o della reazione padronale.
Le squadre furono invece non solo il nucleo costitutivo dell’intero movimento, ma anche le depositarie dei suoi rituali (le bandiere, le sfilate, il culto dei caduti), le custodi della sua anima “rivoluzionaria” e della sua vocazione totalitaria.
In quanto fenomeno politico rilevante, lo squadrismo si esaurì con la trasformazione del fascismo in regime e sparì con la morte dei regimi fascisti.
Da allora si parla genericamente di squadrismo per definire, e stigmatizzare, azioni di violenza compiute in gruppo e per motivi politici, contro persone e cose riconducibili a uno schieramento avverso.
Sommario
I problemi del dopoguerra erano aggravati, in Italia, dalla debolezza delle strutture democratiche e dalla crisi della classe dirigente liberale.
I cattolici si organizzarono politicamente con il Partito popolare (1919).
A sinistra, la crescita del Partito socialista corrispondeva ad una prevalenza, in esso, delle correnti rivoluzionarie.
La nascita del fascismo(1919) introdusse nella vita politica un nuovo stile aggressivo e violento.
In relazione alle vicende della Conferenza di Parigi, si diffuse tra l’opinione pubblica un atteggiamento di risentimento verso gli ex alleati (la “vittoria mutilata”) e il governo.
Clamorosa fu la protesta attuata da D’Annunzio con l’occupazione di Fiume (settembre 1919).
Sul piano interno, il ’19-20 fu una fase di acute agitazioni sociali: moti contro il caro viveri, scioperi operai e agrari, occupazione delle terre.
Le elezioni di novembre 1919, tenute col sistema proporzionale, segnarono la perdita del controllo del Parlamento da parte delle forze liberali, nonché un successo di socialisti e popolari.
Nel giugno 1910 Giolitti tornò al potere con un programma molto avanzato.
Durante il suo governo fu risolta la questione di Fiume (trattato di Rapallo e dine dell’impresa dannunziana).
Tuttavia il disegno giolittiano di ridimensionare le spinte rivoluzionarie del Psi attraverso un’apertura riformista fallì.
Il maggior episodio di conflittualità del periodo fu l’occupazione delle fabbriche (settembre 1920), la cui conclusione accentuò le divisioni del movimento socialista e diffuse in tutta la borghesia un desiderio di rivincita.
Al congresso socialista di Livorno del gennaio 1921, la corrente di sinistra guidata da Bordiga e Gramsci si scisse dal Psi e fondò il Partito comunista.
Tra la fine del ’20 e l’inizio del ’21 il fascismo, abbandonando gli originari caratteri radical-democratici, si qualificò decisamente in senso antisocialista.
Le azioni squadristiche colpirono sedi ed esponenti del movimento operaio e contadino del Centro-Nord, in particolare le leghe rosse nella Valle Padana.
Le cause della repentina crescita del fascismo agrario furono varie: forza “militare”, connivenza dei pubblici poteri, tentativo di Giolitti di usare il fascismo per ridurre alla ragione socialisti e popolari, ma anche consensi in quelle categorie contadine (piccoli proprietari, mezzadri, piccoli affittuari) che mal sopportavano il controllo esercitato dalle organizzazioni socialiste nelle campagne.
L’inserimento nei “blocchi nazionali” (elezioni del maggio 1921) diede al fascismo una completa legittimazione.
Profittando della debolezza dei governi liberali (Bonomi e Facta), il fascismo si rese protagonista di imprese sempre più clamorose, culminate nella risposta allo sciopero “legalitario” dell’agosto ’22, estremo tentativo socialista di arginare le violenze squadristiche.
Mentre trattava con i principali leader liberali per una partecipazione al governo, Mussolini lasciò che le milizie fasciste si preparassero per un colpo di Stato.
Il successo della marcia su Roma (28 ottobre 1922) fu reso possibile solo dal rifiuto del re a firmare lo stato di assedio.
Il nuovo governo Mussolini – lungi dal rappresentare come parve a molti, un ritorno alla normalità – preparava la fine dello Stato liberale.
Una volta al potere, Mussolini attuò una politica autoritaria (soprattutto contro il movimento operaio) e creò nuovi istituti (il Gran Consiglio del fascismo e la Milizia) incompatibili con i principi liberali.
Al tempo stesso continuò a promettere la “normalizzazione” e a collaborare con forze politiche non fasciste.
Oltre all’appoggio di liberali e cattolici, Mussolini poteva valersi di quello del potere economico, nonché del sostegno della Chiesa, che vedeva nel fascismo un baluardo contro la minaccia socialista.
Un ulteriore rafforzamento il fascismo ottenne con le le elezioni del ’24, tenute secondo la nuova legge maggioritaria: da esse le opposizioni uscirono notevolmente ridimensionate.
Nel giugno 1924 il deputato socialista Matteotti – che aveva denunciato alla Camera i brogli e le violenze commesse dai fascisti in occasione delle elezioni – fu assassinato da un gruppo di squadristi.
L’ondata di sdegno che ne seguì fece vacillare il potere di Mussolini.
Ma le opposizioni, che abbandonarono la Camera (secessione dell’Aventino), erano troppo deboli per mettere in crisi il governo.
Col duro discorso del 3 gennaio ’25, Mussolini riacquistò il controllo della situazione.
Tra il 1925 e il 1926 si consumò la fine dello Stato liberale: “fascistizzazione” della stampa, persecuzione degli antifascisti, rafforzamento dei poteri del capo del governo, legge “per la difesa dello Stato” (che, tra l’altro, istituiva il Tribunale speciale), scioglimento di tutti i partiti (tranne quello fascista).
Bibliografia
Nascita e avvento del fascismo / A. Tasca. – La Nuova Italia, 1995
Storia di quattro anni, 1919-1922 / P. Nenni. – Sugarco, 1976
Lezioni di Harvard: l’Italia dal 1919 al 1929 / G. Salvemini. – Pubblicate col tit.: Scritti sul fascismo. – Feltrinelli, 1961
Mussolini / R. De Felice. – Einaudi
La conquista del potere: il fascismo dal 1919 al 1929 / A. Lyttelton. – Laterza, 1974
Storia delle origini del fascismo / R. Vivarelli. – Il Mulino, 1991
Storia dell’Italia moderna, vol. 8. / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1978
Storia d’Italia, vol. 4. / Sabbatucci-Vidotto. – Laterza, 1997
Sui partiti politici
Fascismo e antifascismo: i partiti italiani fra le due guerre / E. Gentile. – Le Monnier, 2000
Sul Psi
Storia del socialismo italiano, 1892-1926 / G. Arfè. – Einaudi, 1965
Il Partito socialista italiano dal 1919 al 1946 / L. Guerci. – Cappelli, 1969
Sulla scissione di Livorno e il Pci
Storia del Partito comunista italiano / P. Spriano. – Einaudi, 1967
Il Partito comunista italiano dalle origini al 1946 / V. Vidotto. – Cappelli, 1975
Sul Partito popolare.
Il movimento cattolico in Italia / G. De Rosa. – Laterza, 1966
Sui fasci di combattimento e il Partito fascista
Storia del Partito fascista, 1919-1922: movimento e milizia / E. Gentile. – Laterza, 1989
Sugli aspetti culturali e ideologici del fascismo
Le origini dell’ideologia fascista, 1918-1925 / E. Gentile. – Il Mulino, 1996
Cap. 18. La grande crisi: economia e società negli anni ‘30
Parola chiave. Ceto medio.
L’espressione “ceto medio” (o “classe media”) indica genericamente quegli strati sociali che occupano una posizione intermedia nella distribuzione della ricchezza, del potere e del prestigio in una società che si presume divisa secondo uno schema bipolare (aristocrazia-popolo, poveri-ricchi, borghesia-proletariato).
Già nel tardo ‘700 si parlava di ceto medio in riferimento al “terzo stato”, cioè alla borghesia.
Più tardi, con lo sviluppo del capitalismo e col delinearsi di un antagonismo “primario” fra borghesia e proletariato, l’espressione è diventata sinonimo di “piccola e media borghesia”, ed è passata a designare un arco molto ampio e variegato di classi e gruppi sociali.
Rientravano sotto questa definizione tutti quei gruppi che non potevano essere assimilati alla borghesia propriamente detta (imprenditori e proprietari), ma si distaccavano dalle classi popolari per cultura, mentalità e orientamenti politici, oltre che per condizioni economiche: piccoli proprietari e piccoli commercianti, ma soprattutto impiegati pubblici e privati.
Le trasformazioni economiche e sociali intervenute nel ‘900 – in particolare la crescita degli apparati statali e lo sviluppo del settore dei servizi – hanno gonfiato numericamente questi strati (che invece, secondo lo schema marxista, erano destinati a scomparire o a “proletarizzarsi”) e ne hanno progressivamente aumentato il peso politico.
Nel periodo fra le due guerre mondiali furono soprattutto le inquietudini e le oscillazioni del ceto medio (fin allora considerato come una garanzia di stabilità sociale e come la base più sicura delle istituzioni liberal-democratiche) a determinare le più profonde trasformazioni politiche.
I regimi autoritari e fascisti, in particolare, trovarono il loro principale sostegno di massa proprio nel ceto medio; mentre i partiti operai pagarono spesso duramente l’errore di averne sottovalutato la forza e di averlo giudicato fatalmente subalterno alle scelte della grande borghesia.
Nel secondo dopoguerra, tutti i partiti di massa, compresi quelli di sinistra, hanno riservato un’attenzione crescente alle esigenze di questo strato sociale (da cui, fra l’altro, provengono in gran parte i quadri dirigenti dei partito stessi) e hanno cercato di guadagnarne i consensi.
Ciò è apparso tanto più necessario in relazione ai recenti sviluppi delle società industrializzate (innalzamento generale dei livelli di vita, crescita del settore terziario); sviluppi che, se da un lato hanno ulteriormente dilatato la consistenza numerica del ceto medio, dall’altro hanno reso meno netta la distinzione, in termini di reddito e di status sociale, fra classe operaia e piccola borghesia.
Oggi si parla sempre più spesso, nei paesi economicamente avanzati, di una progressiva scomparsa delle classi tradizionalmente intese; o meglio di un loro assorbimento in un unico grande ceto medio che comprende ormai la maggioranza della popolazione, lasciando fuori solo alcune consistenti sacche di “nuova povertà” (non più coincidenti col proletariato industriale) e alcune esigue minoranze di ricchissimi e privilegiati.
Sommario.
Gli anni ’20 furono per gli Stati Uniti un periodo di prosperità economica che influì sulla stessa vita quotidiana degli americani (con la diffusione dell’automobile e degli elettrodomestici).
Dal punto di vista politico, fu incontrastata l’egemonia del Partito repubblicano, sostenitore di un indirizzo conservatore e liberista.
Si diffondevano, tra l’opinione pubblica, tendenze conservatrici e pregiudizi razziali.
La borghesia americana cercava facili guadagni nella speculazione borsistica, inconsapevole delle fragili basi dell’espansione economica di quegli anni.
Il crollo della Borsa di New York (ottobre 1929) fu a un tempo la spia di un malessere preesistente e la causa di ulteriori episodi di crisi.
Negli Stati Uniti molte aziende dovettero chiudere.
Le misure protezionistiche adottate subito in Usa – e poi negli altri paesi – provocarono una brusca contrazione del commercio internazionale.
La recessione economica – cui si accompagnò un altissimo numero di disoccupati – si diffuse in tutto il mondo.
In Europa una grave crisi finanziaria culminò nella sospensione della convertibilità della sterlina.
Scarso successo ebbero le politiche di austerità perseguite dai governi dei paesi industrializzati, che finirono con l’aggravare la recessione in corso e col ripercuotersi negativamente sugli equilibri politici e sociali.
Nel 1932 divenne presidente degli Stati Uniti il democratico F. D. Roosevelt.
La sua politica (New Deal) si caratterizzò per un energico intervento dello Stato nell’economia e per alcune iniziative di riforma sociale.
Il New Deal, se rappresentò un’importante innovazione, non riuscì a determinare una piena ripresa dell’economia americana, che si sarebbe verificata solo con la guerra.
Un po’ in tutti i paesi la grande crisi finì col far adottare nuove forme di intervento dello Stato in campo economico, che giunsero a configurare una forma di capitalismo “diretto”.
Quanto i governi fecero solo empiricamente fu teorizzato dall’economista Keynes che, in particolare, sottolineò il ruolo della spesa pubblica ai fini dell’incremento della domanda e del raggiungimento della piena occupazione.
Nei paesi europei si verificò proprio durante la grande crisi uno sviluppo di quei consumi di massa che si erano affermati in Usa negli anni ’20.
Grande diffusione ebbero la radio e il cinema, che divennero elementi caratteristici della società di massa: mezzi di svago, di informazione ma anche di propaganda, essi contribuirono ad accentuare il lato spettacolare della politica.
Negli anni ’20 e ’30 vennero fatte alcune scoperte scientifiche destinate a segnare la storia del Ventesimo Secolo: anzitutto quella dell’energia nucleare (che avrebbe portato alla costruzione della bomba atomica).
Sul piano della applicazioni belliche della scienza, sono da ricordare i grandi sviluppi dell’aeronautica.
Nella cultura europea si accentuarono allora i fenomeni di disgregazione e di perdita dell’unità, tanto che nessuna delle correnti del periodo può essere assunta, da sola, come particolarmente rappresentativa.
Furono anni, per gli intellettuali, di grandi contrapposizioni ideologiche (liberalismo-comunismo, democrazia-fascismo) e id impegno politico.
L’emigrazione degli intellettuali tedeschi durante il nazismo provocò un impoverimento culturale dell’Europa.
Bibliografia.
Sul “grande crollo” e la crisi mondiale che ne seguì
Il grande crollo / J. K. Galbraith. – Boringhieri, 1972
La grande depressione del mondo, 1929-1939 / C. P. Kindleberger. - Etas, 1982
Sulle trasformazioni strutturali del capitalismo
La grande trasformazione / K. Polany. – Einaudi, 1974
Sugli Stati Uniti negli anni ’20 e ‘30
L’età dell’ansia: gli Stati Uniti dal 1920 al 1940 / M. E. Parrish. – Il Mulino, 1992
L’età di Roosevelt / A. Schlesinger. – Il Mulino, 1959-65
Roosevelt e il New Deal, 1932-1940 / W. E. Leuchtenburg. – Laterza, 1968
Il New Deal / a c. di M. Vaudagna. – Il Mulino, 1981
Sulla radio e sul cinema
Storia del cinema / G. Fofi, M. Morandini. – Garzanti, 1988
Storia del cinema italiano / G. Brunetta. – Ed. Riuniti, 1993
Storia del cinema e del film / K. Thompson. – Il Castori, 1998
Storia della radio e della televisione: un secolo di costume, società e politica / F. Monteleone. – Marsilio, 2003
Sull’esodo degli intellettuali europei verso gli Stati Uniti
Da sponda a sponda: l’emigrazione degli intellettuali europei e lo studio della società contemporanea, 1930-65 / H. S. Hughes. – Il Mulino, 1977
Cap. 19. L’età dei totalitarismi
Parola chiave. Totalitarismo
Il termine “totalitarismo” fu inventato, a quanto sembra, dagli antifascisti italiani già nella prima metà degli anni ’20.
Successivamente, furono gli stessi fascisti, a cominciare da Mussolini, a usarlo “in positivo” per definire la loro aspirazione, peraltro mai pienamente realizzata, a una identificazione totale tra Stato e società.
Nel secondo dopoguerra, il termine fu adottato dalla scienza politica e dalla pubblicistica dei paesi occidentali per designare quella particolare forma di potere assoluto, tipica della società di massa, che non si accontenta di controllare la società, ma pretende di trasformarla dal profondo in nome di un’ideologia onnicomprensiva, di pervaderla tutta attraverso l’uso combinato del terrore e della propaganda: quel potere, insomma, che non solo è in grado di reprimere, grazie a un onnipotente apparato poliziesco, ogni forma di dissenso, ma cerca anche di mobilitare i cittadini attraverso proprie organizzazioni, di imporre la propria ideologia attraverso il monopolio dell’educazione e dei mezzi di comunicazione di massa.
Il concetto di totalitarismo – così come lo ha definito la scienza politica, da Hannah Arendt a Carl J. Friedrich e Zbigniew K. Brzezinski – è modellato sulla concreta esperienza del nazismo tedesco e del comunismo staliniano.
Più discussa è la sua applicabilità al caso del fascismo italiano (che pure, come abbiamo visto, si autodefiniva totalitario) o a quella dei regimi comunisti imposti all’Europa dell’Est nel secondo dopoguerra.
Certamente scorretto è parlare di “totalitarismo” in riferimento a regimi autoritari più “tradizionali” come il franchismo e il salazarismo.
Per molto tempo la categoria del totalitarismo è stata rifiutata, o quanto meno guardata con sospetto, dalla cultura di sinistra (in particolare da quella marxista) perché, prescindendo da qualsiasi riferimento alla base sociale dei regimi, accomunava fenomeni giudicati incomparabili come il nazismo e lo stalinismo.
Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, il termine si è largamente affermato nel linguaggio politico corrente (e anche in quello della sinistra).
Oggi il termine “totalitarismo” rischia di essere addirittura “inflazionato”.
Lo si usa infatti comunemente – e impropriamente – come sinonimo di “autoritarismo” o di “dittatura” o di “tirannia”.
Sommario
Dopo la crisi del ’29 si diffuse in tutta Europa il fenomeno della disaffezione verso la democrazia.
Parallelamente si affermarono, negli anni ’30, regimi antidemocratici, sia di tipo tradizionale sia di tipo “moderno” (cioè ispirati al fascismo e al nazismo).
La novità del fascismo e del nazismo si evidenziò nel campo dell’organizzazione del potere, con quella ricerca di un controllo totale sui cittadini (comune al regime staliniano) che ha fatto coniare il termine di “totalitarismo”.
Il successo del nazismo è strettamente collegato alle conseguenze della grande crisi.
Fu allora che la maggioranza dei tedeschi perse ogni fiducia nella Repubblica e nei partiti democratici e prestò ascolto in misura crescente alla propaganda del nazismo, che prometteva il ritorno della Germania alla passata grandezza, indicando nelle sinistre e negli ebrei i responsabili delle difficoltà del paese.
Il partito di Hitler, rimasto fin allora ai margini della vita politica, vide crescere i suoi consensi nelle numerose elezioni che si tennero fra il ’30 e il ’32, fino a diventare il primo partito tedesco.
Nel gennaio ’33, Hitler fu chiamato dal presidente Hindenburg a guidare il governo.
La trasformazione della Repubblica tedesca in dittatura avvenne nel giro di pochi mesi.
Nel ’33, traendo pretesto dall’incendio del Reichstag, Hitler assunse i pieni poteri e annientò le opposizioni.
L’anno seguente si sbarazzò dell’ala estremista del nazismo (quella che faceva capo alla milizia armata delle SA) e, morto Hindenburg, si fece nominare capo dello Stato.
Tra i principi base del nazismo stava il particolare rapporto tra il capo (Führer) e le masse (inquadrate nel partito unico e nei suoi organismi collaterali).
Dalla “comunità di popolo” in cui il nazismo voleva trasformare tutti i tedeschi erano esclusi gli ebrei, che una massiccia propaganda additava a bersaglio dell’odio popolare e che vennero legalmente discriminati con le leggi di Norimberga (1935). Le azioni violente contro di essi si sarebbero trasformate, durante la guerra, nella politica dello sterminio.
Non vi fu, durante il nazismo, alcuna opposizione politica.
La Chiesa cattolica e quelle luterane finirono con l’adattarsi al regime.
L’efficienza dell’apparato repressivo spiega la mancanza di un esplicito dissenso, non l’estensione notevole del consenso al regime.
Tale consenso ebbe varie cause: i successi in politica estera, la ripresa economica (dovuta a una politica di riarmo e lavori pubblici), il raggiungimento della piena occupazione e il miglioramento dei servizi sociali; ma anche l’uso molto abile che il nazismo seppe fare delle cerimonie pubbliche e dei mezzi di comunicazione di massa.
Già nel corso degli anni ’20 regimi autoritari si erano affermati in molti paesi: nell’Europa centro-orientale (Ungheria, Polonia), nei Balcani (Bulgaria, Jugoslavia) e nella penisola iberica (Spagna, Portogallo).
L’avvento del nazismo in Germania provocò uan ulteriore diffusione di questi regimi (Austria, Grecia e Romania) e una loro radicalizzazione.
In Urss, alla fine degli anni ’20, Stalin pose fine alla Nep, dando inizio all’industrializzazione forzata.
Le attività agricole vennero collettivizzate (e i kulaki, di fatto, sterminati).
Parallelamente fu varato, nel 1928, il primo piano quinquennale che segnò una strepitosa crescita della produzione industriale (questo suscitò diffusa ammirazione nel mondo occidentale, che subiva le conseguenze della grande crisi).
Il nuovo indirizzo ebbe costi umani assai elevati e si accompagnò ad un clima di forte mobilitazione ideologica.
Gli anni ’30 videro anche il continuo rafforzamento della dittatura personale di Stalin, che eliminò tutti i suoi possibili rivali (in pratica l’intero gruppo dirigente bolscevico).
Col 1934 ebbe inizio la stagione delle “grandi purghe” e del terrore indiscriminato, funzionale al rafforzamento del potere di Stalin.
Quello che si consumò in Urss negli anni dello stalinismo fu un vero e proprio sterminio di massa.
Le prime iniziative hitleriane in politica estera (ritiro dalla Società delle Nazioni, appoggio al tentativo dei nazisti austriaci di impadronirsi del potere) rappresentarono una minaccia all’equilibrio internazionale.
A partire dal 1935, la causa della sicurezza collettiva trovò un sostegno nella nuova politica estera sovietica, ispirata alla lotta al fascismo come principale nemico, che incoraggiò la formazione di alleanze fra comunisti e forze socialiste e democratico-borghesi.
Nel ’36 governi di Fronte popolare sorsero in Spagna e Francia.
In Spagna, alla vittoria del Fronte popolare (febbraio ’36) seguì la ribellione militare.
I ribelli, guidati dal generale Franco, ebbero il decisivo aiuto di Italia e Germania, mentre i repubblicano poterono contare solo sui rifornimenti sovietici e sui reparti di volontari antifascisti.
La sconfitta dei repubblicani fu dovuta anche alle profonde divisioni esistenti al loro interno soprattutto fra comunisti e anarchici.
Nel 1939 la guerra civile terminava con la vittoria di Franco.
Negli stessi anni della guerra di Spagna, la politica di arrendevolezza (appeasement) praticata da Francia e Inghilterra nei confronti della Germania finì con l’incoraggiare la politica espansionistica del nazismo.
Nel 1938 avveniva l’annessione dell’Austria (Anschluss); subito dopo Hitler avanzava mire sul territorio cecoslovacco abitato da popolazione tedesca (Sudeti).
Gli accordi di Monaco (settembre ’38) sembrarono conservare la pace, ma – accettando le richieste tedesche – finirono con lo spianare la strada a un nuovo conflitto mondiale.
Bibliografia.
Sul totalitarismo
Le origini del totalitarismo / H. Arendt. – Comunità, 1967
Il totalitarismo / S. Forti. – Laterza, 2001
Il totalitarismo / E. Traverso. – Bruno Mondadori, 2002
Sulla crisi della Repubblica di Weimar ei nazismo
Da Weimar a Hitler / M. Broszat. – Laterza, 1986
La dittatura tedesca / K. D. Bracher. – Il Mulino, 1973
Storia sociale del Terzo Reich / D. Peukert. – Sansoni, 1989
Lo Stato nazista / N. Frei. – Laterza, 1992
Il Terzo Reich / H. U. Thamer. – Il Mulino, 1993
Hitler e l’enigma del consenso / I. Kershaw. – Laterza, 1997
Hitler / J. C. Fest. – Rizzoli, 1974
Hitler / I. Kershaw. – Bompiani, 1999-2001
Sulla liturgia hitleriana
La nazionalizzazione delle masse: simbolismo politico e movimenti di massa in Germania dalle guerre napoleoniche al Terzo Reich / G. L. Mosse. – Il Mulino, 1975
Sul dibattito in Germania
Germania: un passato che non passa / a c. di G. F. Rusconi. – Rusconi, 1987
Che cos’è il nazismo: problemi interpretativi e prospettive di ricerca / I. Kershaw. – Bollati Boringhieri, 1995
Sulla diffusione dei regimi fascisti
Il fascismo in Europa / a c. di S. J. Woolf. – Laterza, 1968
Sull’Unione Sovietica
Storia del sistema sovietico / V. Zaslavsky. – Nis, 1995
Storia della Russia contemporanea, 1853-1996 / F. Benvenuti. – Laterza, 1999
Sullo stalinismo
Lo stalinismo / R. Medvedev. – Mondadori, 1972
Il fenomeno Stalin nella storia del Ventesimo Secolo: le interpretazioni dello stalinismo / G. Boffa. – Laterza, 1982
Storia sociale dello stalinismo / M. Lewin. – Einaudi, 1988
Lo stalinismo / A. Romano. – Bruno Mondadori, 2002
Sulle purghe staliniane
Il grande terrore / F. Bettanin. – Ed. Riuniti, 1999
Storia del Gulag / O. V. Chlevnjuk. – Einaudi, 2006
Sugli aspetti ideologici
Storia del pensiero comunista / M. L. Salvadori. – Mondadori, 1984
Sull’attrazione esercitata dall’Urss nei confronti degli intellettuali
Il passato di un’illusione: l’idea comunista nel Ventesimo Secolo / F. Furet. – Mondadori, 1995
Per un diverso approccio al problema
Il secolo breve / E. J. Hobsbawm. – Rizzoli, 1995
Per una comparazione tra le vicende del nazismo e del comunismo
Nazionalsocialismo e bolscevismo: la guerra civile europea, 1917-1945 / E. Nolte. – Sansoni, 1989
Sulla guerra civile spagnola
Storia della guerra civile spagnola / H. Thomas. – Einaudi, 1963
La guerra civile spagnola / P. Preston. – Mondadori, 1999
L’eclissi della democrazia / G. Ranzato. – Bollati Boringhieri, 2004
Per uno sguardo d’insieme sulla crisi delle democrazie
Le ombre dell’Europa: democrazie e totalitarismi nel Ventesimo Secolo / M. Mazower. – Garzanti, 2000
Per una sintesi del quadro internazionale fra le due guerre
Crisi fra le due guerre mondiali, 1919-1939 / R. Overy. – Il Mulino, 1998
In un’ottica di più lungo periodo e con particolare riferimento all’Europa orientale
Guerra e rivoluzione in Europa, 1905-1956 / A. Graziosi. – Il Mulino, 2001
Cap. 20. L’Italia fascista
Parola chiave. Consenso
Nel linguaggio politico moderno, il termine “consenso” indica l’accordo fra i membri di una comunità su alcuni valori e principi fondamentali o su alcuni obiettivi specifici che la comunità stessa si pone attraverso l’azione dei suoi gruppi dirigenti.
Nei sistemi democratici e pluralistici, un certo grado di consenso sui principi e sulle istituzioni è considerato indispensabile alla vita dello Stato; ma sulle scelte dei governanti il dissenso è ammesso e in qualche misura istituzionalizzato attraverso meccanismi che permettono il ricambio della classe dirigente.
Invece nei sistemi autoritari – e soprattutto in quelli totalitari – il dissenso è represso o nascosto, mentre il consenso è dato per scontato, sulla base di una arbitraria attribuzione al capo, o al partito dominante, della capacità di rappresentare il popolo e di interpretarne i bisogni.
Questo non significa che anche i regimi autoritari non possono godere di autentico consenso popolare.
Il problema, per gli storici, è di verificare e misurare questo consenso, in assenza di indicatori attendibili (poiché tali non sono i risultati delle consultazioni elettorali “plebiscitarie” e le manifestazioni di massa organizzate dai regimi stessi).
Nel caso del fascismo italiano, ad esempio, si è discusso e si continua a discutere sulla natura e sulle dimensioni del consenso di cui il regime godette.
Negli anni ’70 il più autorevole storico del fascismo, Renzo De Felice, autore di una grande biografia di Mussolini, ha sostenuto che, per la maggioranza della popolazione, questo consenso fu ampio e stabile, soprattutto prima della metà degli anni ’30 (prima che cominciasse la fase delle guerre e dell’avvicinamento alla Germania nazista).
Altri studiosi hanno contestato sia le conclusioni di De Felice, sua l’attendibilità delle fonti da lui prevalentemente utilizzate (la stampa, le carte di Mussolini, i rapporti di polizia); e hanno affermato che il grosso della popolazione diede al regime niente più che un consenso “passivo”, un’accettazione rassegnata (salvo che in alcuni momenti particolari, come la conquista dell’Etiopia o al conferenza di Monaco).
Oggi la maggior parte degli storici tende a riconoscere al fascismo una certa base di consenso, soprattutto fra i ceti medi.
Anche se ci si rende conto della difficoltà di valutarne la natura (come si può distinguere il consenso “attivo” da quello “passivo”) e di misurarne con precisione l’entità.
Sommario
Nel regime fascista l’organizzazione dello Stato e quella del partito venivano a sovrapporsi.
Fu la prima però – per volere di Mussolini – ad avere sempre la prevalenza, mentre la funzione del Pnf, sempre più burocratizzato, fu quella di “occupare” la società civile, soprattutto attraverso le sue organizzazioni collaterali.
Un primo limite ai propositi totalitari del regime era rappresentato dal peso della Chiesa, la cui influenza venne espressamente riconosciuta coi Patti lateranensi (1929).
I Patti rappresentarono anche un successo politico per il fascismo, sancito dal plebiscito di quello stesso anno.
Altro limite ai propositi totalitari era costituito dalla presenza del re quale massima autorità dello Stato.
Negli anni del fascismo, nonostante l’aumento dell’urbanizzazione e degli addetti all’industria e ai servizi, la società italiana restava notevolmente arretrata.
La “fascistizzazione” perseguita dal regime – portatore di un’ideologia tradizionalistica, ma aspirante anche alla creazione di un “uomo nuovo” – poté realizzarsi solo in parte; il fascismo riuscì ad ottenere il consenso della piccola e media borghesia, ma solo in misura limitata e superficialmente quello dell’alta borghesia e delle classi popolari (queste ultime videro diminuire i loro salari e i loro consumi).
Il regime cercò in modo particolare di esercitare uno stretto controllo nell’ambito della scuola e della cultura.
Soprattutto si impegnò nel campo dei mezzi di comunicazione di massa, essendo consapevole della loro importanza ai fini del consenso.
La radio e il cinema furono, così, sia strumenti di propaganda sia mezzi di semplice intrattenimento.
Il fascismo non costituì un nuovo sistema economico: il modello corporativo rimase infatti sulla carta.
Sul piano della politica economica, si passò nel ’25 da una linea liberista ad una protezionistica e di maggior intervento statale.
La “battaglia del grano” doveva servire al raggiungimento dell’autosufficienza cerealicola; la rivalutazione della lira (“quota novanta”) aveva il compito di dare al paese un’immagine di stabilità monetaria.
Di fronte alla crisi del ’29, il regime reagì attraverso una politica di lavori pubblici (“risanamento” di Roma, bonifica delle Paludi Pontine) e di intervento diretto dello Stato in campo industriale e bancario.
Con l’iri lo Stato diventò il proprietario di alcune fra le maggiori imprese italiane.
Superata la crisi, il fascismo indirizzò l’economia verso la produzione bellica.
Fino ai primi anni ’30 le aspirazioni imperiali, connaturate all’ideologia del fascismo, rimasero vaghe.
L’aggressione all’Etiopia (1935) mutò bruscamente la posizione internazionale del regime.
Se l’impresa indubbiamente costituì per Mussolini un grosso successo politico, vista l’adesione della maggioranza dell’opinione pubblica, rappresentò anche una rottura con le potenze democratiche.
Questa rottura fu accentuata dall’intervento nella guerra civile spagnola e del riavvicinamento alla Germania (sancito nel ’36 dall’”Asse Roma-Berlino”).
Tale riavvicinamento era concepito da Mussolini come un mezzo di pressione su Francia e Inghilterra: si risolse invece – con la firma del “patto di acciaio” (1939 – in una subordinazione alle scelte di Hitler.
In Italia la maggioranza degli antifascisti – soprattutto ex popolari e liberali – rimasero in una posizione di silenziosa opposizione.
I comunisti invece si impegnarono, benché con scarsi risultati, nell’agitazione clandestina; sulla stessa linea si mosse il gruppo di “Giustizia e Libertà”, di indirizzo liberal-socialista.
Gli altri gruppi in esilio all’estero (socialisti, repubblicani, democratici, federati nel ’27 nella Concentrazione antifascista) svolsero soprattutto un’opera di elaborazione politica in vista di una sconfitta del regime che l’antifascismo non era in grado di provocare.
Nonostante questa debolezza, l’importanza dell’antifascismo risiedette nella funzione di testimonianza e di preparazione dei quadri e delle piattaforme politiche della futura Italia democratica.
Il consenso ottenuto dal regime cominciò a incrinarsi dopo l’impresa etiopica.
La politica dell’”autarchia” – finalizzata all’obiettivo dell’autosufficienza economica in caso di guerra – ottenne solo parziali successi e suscitò un diffuso malcontento.
Soprattutto l’avvicinamento alla Germania e la politica discriminatoria nei confronti degli ebrei suscitarono timori e dissensi nella maggioranza della popolazione.
Soltanto fra le nuove generazioni il disegno mussoliniano di trasformare in senso fascista la cita e la mentalità degli italiani ottenne qualche successo.
Bibliografia
Mussolini / R. De Felice
Intervista sul fascismo / R. De Felice. – Laterza, 1975
Le interpretazioni del fascismo / R. De Felice. – Laterza, 1986
Il regime fascista: storia e storiografia / a c. di A. Del Boca et al. – Laterza, 1995
Il fascismo: antologia di scritti critici / C. Casucci. – Il Mulino, 1982
Le opere d’insieme sul fascismo
Storia dell’Italia moderna. Vol. 9 / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1981
Storia d’Italia. Vol. 4. / Sabbatucci-Vidotto. – Laterza, 1997
Dizionario del fascismo / a c. di V. de Grazia e S. Luzzatto. – Einaudi, 2002-3
Per gli aspetti istituzionali
L’organizzazione dello Stato totalitario / A. Aquarone. – Einaudi, 1965
Sui rapporti fra Stato e partito
La via italiana al totalitarismo / E. Gentile. – Nis, 1995
Per una storia parallela del Pnf e dei partiti antifascisti
Fascismo e antifascismo: i partiti italiani fra le due guerre / E. Gentile. – Le Monnier, 2000
Sul funzionamento della macchina politica del regime
Il fascismo: la politica in un regime totalitario / S. Lupo. – Donzelli, 2000
Sull’economia
L’economia italiana nel periodo fascista / a c. di P. L. Ciocca e G. Toniolo. – Il Mulino, 1976
L’economia dell’Italia fascista / G. Toniolo. – Il Mulino, 1980
Sull’imperialismo fascista
Fascismo e politica di potenza / E. Collotti. – La Nuova Italia, 1999
Sui rapporti con la Germania
Hitler e Mussolini: la difficile alleanza / J. Petersen. – La Nuova Italia, 1975
Sull’organizzazione del consenso
La fabbrica del consenso: fascismo e mass media / P. V. Canistraro. – Laterza, 1975
Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista: l’organizzazione del dopolavoro / V. De Grazia. – Laterza, 1981
L’opinione degli italiani sotto il regime, 1929-1943 / S. Colarizi. – Laterza, 2000
Il culto del littorio / E. Gentile. – Laterza, 1993
L’educazione dell’italiano / M. Isnenghi. – Cappelli, 1979
Sul fascismo e intellettuali
L’interventismo della cultura: intellettuali e riviste del fascismo / L. Mangoni. – Laterza, 1974
Il fascismo e il consenso degli intellettuali / G. Turi. – Il Mulino, 1980
L’autarchia della cultura / G. C. Marino. – Ed. Riuniti, 1983
Il ventennio degli intellettuali / G. Belardelli. – Laterza, 2005
Sull’ideologia
L’ideologia del fascismo / P. G. Zunino. – Il Mulino, 1985
Sull’antifascismo
Storia dei fuoriusciti / A. Garosci. – Laterza, 1953
L’Italia antifascista dal 1922 al 1940 / a c. di S. Colarizi. – Laterza, 1976
I nemici di Mussolini / C. F. Delzell. – Einaudi, 1966
Storia della Concentrazione antifascista / S. Fedele. – Feltrinelli, 1976
Storia del Partito comunista italiano / P. Spriano. – Einaudi, 1969-70
Sulle leggi razziali
Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo / R. De Felice. – Einaudi, 1961
Gli ebrei nell’Italia fascista: vicende, identità, persecuzione / M. Sarfatti. – Einaudi, 2000
Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia / E. Collotti. – Laterza, 2003
Cap. 21. Il tramonto del colonialismo: l’Asia e l’America Latina.
Parola chiave. Non violenza.
La pratica della non violenza come strumento politico fu adottata sistematicamente e resa popolare presso l’opinione pubblica mondiale da Mohandas Karamchand Gandhi e dai suoi seguaci nella lotta per l’indipendenza dell’India, negli anni fra le due guerre mondiali.
Secondo la strategia gandhiana, gli indiani dovevano rispondere alla violenza della dominazione inglese non con la forza della armi (secondo il modello delle rivoluzioni europee, da quella francese a quella russa), ma con la resistenza passiva, col digiuno volontario, col rifiuto di obbedire alle leggi ingiuste, con lo sfruttamento dei margini legali consentiti dalle leggi esistenti, con la non collaborazione coi dominatori e con il boicottaggio dei prodotti dell’industria europea: una scelta, quest’ultima, che significava anche difendere le strutture tradizionali della società e dell’economia locale, basata sull’agricoltura e l’artigianato.
Del resto la pratica non violenta, se da un lato riprendeva spunti già presenti nel pensiero occidentale (il pacifismo dell’ultimo Tolstoj o la “disobbedienza civile” teorizzata a metà dell’800 dal filosofo statunitense Henry David Thoreau), si collegava, nel pensiero di Gandhi, alla cultura e alla spiritualità induista, tutta volta alla trasformazione interiore dell’uomo, premessa necessaria per qualsiasi trasformazione politica.
Tutto questo non significava dunque rassegnarsi all’ingiustizia, ma combatterla adottando una nuova strategia e particolarmente rischiosa, in quanto non escludeva la risposta violenta degli avversari.
Questa strategia fece proseliti in tutto il mondo, in contesti molto diversi fra loro.
Il movimento per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti, guidato dal pastore Martin Luther King, la fece propria e la applicò con coerenza negli anni ’60 del ‘900.
In Italia il maggiore teorico della non violenza fu il filosofo Aldo Capitini, autore già nel 1937, in pieno ventennio fascista, di un libro (Elementi di una esperienza religiosa) in cui cercava di dimostrare come il ricorso alla forza, anche per i più nobili scopi, aprisse sempre la strada all’ingiustizia e come fosse necessario, per sperare in una società migliore, spezzare il circolo vizioso adottando la non violenza come fine in sé.
Nell’Italia repubblicana, furono soprattutto i movimenti pacifisti e antimilitaristi, sia cattolici sia laici (a partire soprattutto dagli anni ’60 e ancora in tempi recenti), a far propria la lezione gandhiana nella lotta contro gli armamenti nucleari o in quella a favore dell’obiezione di coscienza.
Ma sono stati soprattutto i radicali di Marco Pannella a servirsi delle strategie non violente (dal digiuno alla disobbedienza civile) per condurre le loro battaglie sui temi più svariati: dall’aborto alla pena di morte, dall’informazione alla condizione carceraria.
Sommario.
Il contributo, in uomini e materie prime, dato dalle colonie inglesi e francesi durante la grande guerra, le suggestioni della rivoluzione russa e dell’ideologia wilsoniana avevano alimentato le aspirazioni all’indipendenza delle colonie europee.
I movimenti indipendentisti erano stati spesso strumentalizzati durante la guerra, soprattutto in Medio Oriente, dove l’appoggio inglese al nazionalismo arabo contrastava in realtà con al contemporanea spartizione della regione tra Gran Bretagna e Francia e con il riconoscimento dei diritti del movimento sionista in Palestina.
In Turchia la sconfitta subita dall’Impero ottomano nella Grande guerra suscitò un movimento di riscossa nazionale promosso dalle forze armate e guidato da un generale, Mustafà Kemal.
Dopo aver sconfitto la Grecia, che occupava la zona di Smirne, Kemal proclamò la repubblica e avviò una politica di modernizzazione e di laicizzazione del paese.
La Gran Bretagna cercò di venire incontro ad alcune delle aspirazioni delle sue colonie: concesse l’indipendenza all’Egitto e creò, con il Commonwealth, una libera associazione degli Stati ad essa soggetti.
Più difficile fu per gli inglesi affrontare il problema indiano, dove il movimento indipendentista si sviluppò soprattutto per opera di Gandhi; in India la Gran Bretagna alternò interventi repressivi a concessioni di autonomia.
Negli anni fra le due guerre la Cina fu teatro di una lunga guerra civile.
Fino alla metà degli anni ’20 il contrasto fu trai nazionalisti del Kuomintang – alleati con i comunisti – e il governo centrale.
Negli anni successivi si scatenò una dura lotta fra il Kuomintang, alla cui testa era ora Chang Kai-shek, e i comunisti.
Sconfitto il governo centrale, Chang proseguì nella sua lotta contro i comunisti, relegando in secondo piano quella contro i giapponesi che, nel ’31, avevano invaso la Manciuria.
Il Partito comunista cinese, guidato da Mao Tse-tung, estese la sua presenza tra i contadini e, nel ’34, con la “lunga marcia” riuscì, nonostante notevoli perdite, a salvare il suo gruppo dirigente.
Un accordo tra i comunisti e nazionalisti in funzione antigiapponese non riuscì ad impedire di lì a poco che il Giappone invadesse il paese e ne occupasse un’ampia zona (’37-39).
In Giappone gli anni fra le due guerre videro un notevole sviluppo economico e l’affermarsi di una spinta imperialistica, in coincidenza con lo sviluppo dei movimenti di destra e con un crescente autoritarismo del sistema politico.
In America Latina la grande crisi ebbe conseguenze fortemente negative, ma stimolò comunque in alcuni paesi un processo di diversificazione produttiva.
Sul piano politico, molti Stati latino-americani videro l’affermarsi di dittature personali o di governi più o meno autoritari.
In alcuni casi (Brasile, Messico e, più tardi, Argentina), questi regimi assunsero un indirizzo populista e godettero dell’appoggio dei lavoratori urbani.
Bibliografia.
Sul problema mediorientale.
Storia del Medio Oriente, 1798-2005 / M. Campanini. – Il Mulino, 2006
Sull’India
Storia dell’India / P. Spear. – Rizzoli, 1970
Storia dell’India / M. Torri. – Laterza, 2000
Sulla Cina
Storia della Rivoluzione cinese / E. Collotti Pischel. – Ed. Riuniti, 1972
La Cina contemporanea / J. Chesneaux. – Laterza, 1975
Stella rossa sulla Cina / E. Snow. – Einaudi, 1965
Sul Giappone
Storia del Giappone moderno / W. G. Beasley. – Einaudi, 1969
Storia del Giappone contemporaneo / J. Halliday. – Einaudi, 1979
Sull’America Latina
Storia dell’America Latina / T. Halperin Donghi. – Einaudi, 1982
L’America Latina nel Ventesimo Secolo / M. Plana. – Ponte alle Grazie, 1992
Cap. 22. La Seconda guerra mondiale
Parola chiave. Genocidio.
“Genocidio” (dal greco gènos, stirpe) è lo sterminio deliberato di tutto un popolo, a prescindere dall’età, dal sesso, dalle opinioni politiche e dalle credenze religiose dei suoi membri.
Il termine fu coniato nel 1946, durante il processo di Norimberga contro i dirigenti nazisti, per indicare la più terribile delle colpe che venivano addebitate agli imputati: il massacro degli israeliti nei paesi occupati dall’esercito tedesco.
Quello messo in atto dai nazisti contro gli ebrei fu certo l’unico massacri indiscriminato compiuto nella storia di un intero popolo.
Riferendosi ai secoli passati, si è parlato di genocidio in relazione ad alcune guerre di religione del Medioevo (per esempio, la crociata contro gli albigesi) o alla decimazione degli incas e degli aztechi a opera dei colonizzatori spagnoli.
Per restare al ‘900, basterà ricordare lo sterminio di oltre un milione di armeni perpetrato dai turchi durante la Grande guerra; la deportazione – che comportava un vero e proprio “sterminio di classe” – di milioni di contadini (ma anche di intere popolazioni considerate infide, sulla base di discriminazioni etniche) decisa da Stalin nel corso degli anni ’30 e ’40; infine il trasferimento forzato, risoltosi in una vera e propria strage, di tutta la popolazione urbana della Cambogia di Pol Pot nel ’75-76.
Sul problema dell’”unicità” di quello che impropriamente viene chiamato l’olocausto, ossia il sacrificio, del popolo ebraico (e che gli ebrei preferiscono chiamare shoah, in ebraico sciagura, catastrofe) si è sviluppato in tempi recenti un certo dibattito.
Certo è difficile, e forse inutile, stabilire una graduatoria fra stermini di massa tutti caratterizzati dal fatto di coinvolgere intere popolazioni inermi e di non risparmiare nemmeno i bambini.
Si può tuttavia osservare che nessuno di questi stermini ebbe il carattere sistematico e pianificato della “soluzione finale” progettata da Hitler, che aveva lo scopo di cancellare tutti gli ebrei dalla faccia della terra e aveva l’aggravante di compiersi nel cuore della civilissima Europa.
A maggior ragione appare improprio usare il termine “genocidio” – come spesso si è fatto negli ultimi decenni – per denunciare il carattere di indiscriminata crudeltà (soprattutto nei confronti della popolazione civile) di alcune guerre condotte contro movimenti di guerriglia partigiana (per esempio, dagli americani in Vietnam o dai sovietici in Afghanistan ) o per richiamare l’attenzione sull’oppressione di minoranze etniche e su episodi particolarmente sanguinosi di repressione politica.
Sommario.
La distruzione della Cecoslovacchia (marzo ’39) determinò una svolta nella politica anglo-francese verso la Germania.
In risposta alle mire tedesche sulla Polonia, Francia e Inghilterra conclusero un’alleanza con questo paese.
Decisivo divenne a quel punto l’atteggiamento dell’Urss: ma, per reciproche diffidenze, le trattative fra sovietici e anglo-francesi si arenarono.
Garantitosi a est con il patto di non aggressione con l’Urss (agosto), Hitler poté attaccare subito dopo la Polonia (1. settembre 1929).
Francia e Inghilterra dichiararono guerra alla Germania mentre l’Italia – che da poco aveva concluso il “patto d’acciaio” con i tedeschi – annunciò la “non belligeranza”.
La conquista tedesca della Polonia fu rapidissima, grazie al nuovo tipo di “guerra-lampo” praticato dai tedeschi (uso congiunto di aviazione e mezzi corazzati).
Nei primi mesi la guerra si svolse in pratica solo a nord: la Russia attaccò la Finlandia, la Germania occupò Danimarca e Norvegia.
Nel maggio-giugno 1940 l’offensiva tedesca sul fronte occidentale si risolse in un travolgente successo: la parte centro-settentrionale della Francia fu occupata dai tedeschi, mentre la sovranità francese di esercitava su quella meridionale (la Repubblica di Vichy), di fatto subordinata alla Germania.
Il 10 giugno ’40, convinto che la guerra stesse ormai per finire, Mussolini annunciò l’intervento dell’Italia a fianco dell’alleato nazista.
Ma l’esercito italiano fornì uan pessima prova sia contro i francesi, sia – in Africa e nel Mediterraneo – contro gli inglesi.
I successivi insuccessi in Grecia e nel Nord Africa obbligarono gli italiani a chiedere l’aiuto dei tedeschi: finiva così l’illusione di una “guerra parallela”.
Rimasta sola a combattere contro le potenze fasciste, l’Inghilterra, sotto la guida energica del primo ministro Churchill, riuscì a respingere il tentativo tedesco di invadere le isole britanniche.
La battaglia d’Inghilterra dell’estate ’40 – combattuta soprattutto nell’aria – segnò così per la Germania la prima battuta d’arresto.
Nel 1941 il conflitto entrò in una nuova fase, divenendo effettivamente mondiale.
Nell’estate la Germania invase l’Urss, riportando notevoli successi ma finendo con l’immobilizzare su quel fronte, in una guerra di usura, gran parte del proprio esercito.
In dicembre gli Stati Uniti – che già sostenevano economicamente lo sforzo bellico inglese – entrarono anch’essi in guerra dopo l’attacco che la loro flotta subì a Pearl Harbor ad opera del Giappone (unito alle potenze dell’Asse dal “patto tripartito”).
Nella primavera del 1942 le potenze del Tripartito raggiunsero la loro massima espansione.
Nelle zone occupate, il Giappone e la Germania cercarono di costruire un “nuovo ordine” fondato sulla supremazia della nazione “eletta”.
I tedeschi, in particolare, miravano a ridurre i popoli slavi in condizioni di semi schiavitù.
La persecuzione si concentrò, però, soprattutto contro gli ebrei: dal 5 ai 6 milioni ne furono sterminati nei lager.
Soprattutto dopo l’attacco tedesco all’Urss, si svilupparono in Europa movimenti di resistenza (pur attraversati da divisioni fra comunisti e non comunisti).
In molti dei paesi controllati dai nazisti una parte della popolazione e della classe dirigente accettò di collaborare con gli occupanti.
Nel 1942-43 si ebbe una svolta nella guerra.
I giapponesi subirono alcune sconfitte nel Pacifico.
Sul fronte russo la lunga e sanguinosa battaglia di Stalingrado si risolse in una sconfitta dei tedeschi.
Sul fronte nordafricano gli alleati fermarono le forze dell’Asse a El Alamein e le costrinsero a ritirarsi.
Nel luglio ’43 gli anglo-americani sbarcarono in Sicilia.
Gli insuccessi militari ormai drammatici furono all’origine della caduta di Mussolini (25 luglio ’43).
L’8 settembre veniva annunciato l’armistizio fra l’Italia e gli anglo-americani.
Mentre il re e Badoglio fuggivano a Brindisi, i tedeschi occupavano l’Italia centro-settentrionale; prive di chiare direttive, le forze armate italiane si sbandarono.
A quel punto il paese era diviso in due: lo Stato monarchico sopravviveva nel Sud occupato dagli alleati.
Al Nord Mussolini costituiva la Repubblica sociale italiana, del tutto soggetta al controllo dei tedeschi.
Alla fine del ’43 si formarono le prima bande partigiane.
Tra la fine del ’42 e l’estate del ’43 si erano ricostituiti i partiti antifascisti, che nel settembre ’43 diedero vita al Comitato di liberazione nazionale.
La contrapposizione tra Cln e governo Badoglio si sbloccò per l’intervento di Togliatti, che propose di accantonare ogni pregiudiziale contro il re o Badoglio.
Nell’aprile ’44 si formò il primo governo di unità nazionale, con i partiti del Cln.
Dopo la liberazione di Roma il re trasmise i propri poteri al figlio Umberto e si costituì un nuovo governo (con alla testa Bonomi), più direttamente legato al movimento partigiano che si andava sviluppando in tutta l’Italia settentrionale.
Mentre gli anglo-americani erano impegnati in Italia, fra il ’43 3 il ’44 l’Urss iniziava una lenta ma inarrestabile avanzata.
Nel giugno ’44 gli alleati sbarcavano in Normandia e, di lì a poco, liberavano la Francia.
Frattanto, nelle conferenze di Mosca (ottobre ’44) e di Yalta (febbraio ’45), russi, americani e inglesi si accordavano sulla futura sistemazione dell’Europa.
Nel 1945 i tedeschi dovettero arretrare su entrambi i fronti, sotto la pressione degli anglo-americani e russi.
Il 25 aprile, mentre la Resistenza proclamava l’insurrezione generale, l’Italia era liberata dalle forze alleate (Mussolini fu allora giustiziato dai partigiani).
Pochi giorni dopo, entrati i russi a Berlino, la Germania capitolava.
La guerra proseguiva, a quel punto, solo nel Pacifico contro il Giappone; terminò il 2 settembre, dopo l’esplosione di due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki.
Bibliografia
Sulla guerra
Storia militare della Seconda guerra mondiale / B. H. Liddell Hart. – Mondadori, 1970
Storia della Seconda guerra mondiale / H. Michel. – Mursia, 1977
La Seconda guerra mondiale / A. Hillgruber. – Laterza, 1987
Storia della Seconda guerra mondiale / P. Calvocoressi, G. Wint. – Rizzoli, 1980
Storia della Seconda guerra mondiale / A. J. P. Taylor. – Il Mulino, 1991
La decadenza dell’Europa occidentale / M. Silvestri. – Einaudi, 1982
La Seconda guerra mondiale / W. Churchill. – Mondadori, 1948
Sulla sconfitta della Francia
La strana disfatta: testimonianza del 1940 / M. Bloch. – Einaudi, 1995
Sulla partecipazione italiana
Storia d’Italia nella guerra fascista / G. Bocca. – Laterza, 1969
Sull’uscita dell’Italia dalla guerra
Una nazione allo sbando / E. Aga Rossi. – Il Mulino, 2003
Soldati: le forze armate italiane dall’armistizio alla Liberazione / C. Vallauri. – Utet, 2003
Sulle politiche di occupazione della Germania nazista
Il sogno del grande spazio: le politiche d’occupazione nell’Europa nazista / G. Corni. – Laterza, 2005
Sul genocidio degli ebrei
Il nazismo e lo sterminio degli ebrei / L. Poliakov. – Einaudi, 1955
La soluzione finale / A. J. Mayer. – Mondadori, 1990
La soluzione finale: come e perché si è giunti allo sterminio degli ebrei / H. Mommsen. – Il Mulino, 2003
Auschwitz, 1940-1945 / F: Sessi. – Rizzoli, 1999
Sul problema della responsabilità del popolo tedesco
Uomini comuni / Ch. R. Browning. – Einaudi, 1995
I volenterosi carnefici di Hitler / D. J. Goldhagen. – Mondadori, 1997
Sulla Resistenza in Europa
La guerra dell’ombra: la Resistenza in Europa / H. Michel. – Mursia, 1973
Storia della Resistenza in Europa, 1938-1945 / G. Vaccarino. – Feltrinelli, 1981
Sul regime di Vichy
Vichy / R. O. Paxton. – Net. 2002
Sulla Resistenza e la Repubblica sociale
Una nazione allo sbando / E. Aga Rossi. – Il Mulino, 2003
Storia della Resistenza italiana / R. Battaglia. – Einaudi, 1964
Storia dell’Italia partigiana / G. Bocca. – Laterza, 1966
Una guerra civile: saggio storico sulla moralità nella Resistenza / C. Pavone. – Bollati Boringhieri, 1991
La Resistenza in Italia / S. Peli. – Einaudi, 2004
Storia della Repubblica di Salò / F. W. Deakin. – Einaudi, 1963
La repubblica di Mussolini / G. Bocca. – Laterza, 1977
La repubblica delle camicie nere / L. Ganapini. – Garzanti, 1999
Cap. 23. Il mondo diviso
Parola chiave. Nucleare
L’energia nucleare – o, meno propriamente, “atomica” – è quella contenuta nel nucleo dell’atomo e liberata mediante processi di reazione (scissione o fusione) provocati artificialmente.
Le prime applicazioni dell’energia nucleare furono indirizzate a fini bellici.
Furono le “bombe atomiche” (basate sulla scissione del nucleo di materiali radioattivi come l’uranio o il plutonio) fatte esplodere dagli americani a Hiroshima e Nagasaki nell’agosto 1945 a porre fine al secondo conflitto mondiale.
Pochi anni più tardi (1952) sarebbero state sperimentate le più potenti bombe all’idrogeno o dei suoi isotopi (deuterio e tritio).
L’apparizione delle bombe nucleari – col loro enorme potenziale distruttivo e con i loro disastrosi effetti di lungo periodo sugli equilibri naturali – aprì uan nuova fase nella storia delle relazioni internazionali, portò un elemento di sconvolgente novità nella strategia militare e influì profondamente sugli stessi modi di pensare dei contemporanei.
Espressioni come “era nucleare” (o “era atomica”), “logica nucleare”, “equilibrio nucleare”, “rischio nucleare” sono entrate stabilmente nel linguaggio politico e militare.
Da un lato, l’affermarsi di due superpotenze nucleari, ciascuna delle quali dotata di arsenali nucleari capaci di distruggere l’avversario, ha dato una notevole stabilità al quadro internazionale e ha fatto apparire più remota l’eventualità di un conflitto generale.
D’altro canto, l’affermarsi di due superpotenze nucleari, ciascuna delle quali dotata di arsenali nucleari capaci di distruggere l’avversario, ha dato una notevole stabilità al quadro internazionale e ha fatto apparire più remota l’eventualità di un conflitto generale.
D’altro canto, la stessa esistenza di armi capaci di alterare in modo irrimediabile gli equilibri naturali, di compromettere la salute delle generazioni future e, al limite, di distruggere ogni forma di vita sul pianeta ha introdotto un fattore di angoscia permanente che è tipico della nostra epoca (ed è sostanzialmente diverso dalla semplice paura della guerra e della morte).
L’incubo della morte nucleare ha dato argomenti e spazio alle tematiche pacifiste e, successivamente, ha costituito uno degli argomenti centrali delle campagne dei movimenti ecologisti, che dell’energia nucleare hanno contestato anche gli usi pacifici.
Le numerose centrali nucleari, costruite a partire dagli anni ’50 in molti paesi industrializzati per assicurare la produzione di energia elettrica a costi inferiori a quelli delle centrali “termiche” (alimentate da derivati del petrolio), presentano infatti alcune inquietanti incognite, legate sia al problema dell’eliminazione delle scorie radioattive sia al rischio di guasti o di errori umani.
Incidenti come quello accaduto nel ’79 nella centrale statunitense di Three Mile Island o quello, più grave, verificatosi nell’86 nella centrale sovietica di Chernobyl destarono allarme in tutto il mondo e determinarono la rinuncia alla tecnologia nucleare da parte id alcuni paesi, fra cui l’Italia.
Sommario.
La Seconda guerra mondiale sancì la crisi definitiva della supremazia europea e l’emergere di due superpotenze, Usa e Urss.
Nasceva così un nuovo equilibrio internazionale di tipo bipolare.
Gli orrori della guerra, le rivelazioni sullo sterminio degli ebrei, lo spaventoso potere distruttivo della bomba atomica colpirono profondamente l’opinione pubblica e spinsero le potenze vincitrici a cercare basi più stabili e regole nuove per i rapporti internazionali.
La creazione dell’Onu (1945) rappresentò il risultato più importante del tentativo di dare vita a un nuovo ordine internazionale capace di scongiurare nuovi conflitti.
La creazione del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale (1944), gli accordi commerciali Gatt (1947), il primato del dollaro come valuta internazionale furono gli strumenti della ripresa economica internazionale.
La “grande alleanza” fra le potenze vincitrici aveva cominciato a incrinarsi già prima della fine della guerra, in relazione al problema del futuro della Germania e al controllo dell’Urss sui paesi dell’Europa orientale.
La conferenza della pace (Parigi, luglio-ottobre 1946) lasciò irrisolto il problema tedesco.
Nel ’46-47 i contrasti fra le due superpotenze si accentuarono dando inizio a quella contrapposizione tra due blocchi che fu definita “guerra fredda”.
La maggior tensione si ebbe nel 1948-49, quando i sovietici chiusero gli accessi a Berlino; questa crisi si risolse nella nascita della Repubblica federale tedesca (che inglobava le zone sotto il controllo di americani, inglesi e francesi), cui l’Urss rispose con la creazione della Repubblica democratica tedesca.
Il Patto Atlantico (1949) e il Patto di Varsavia (1955) completarono la divisione dell’Europa in due blocchi.
In Urss si ebbe nel dopoguerra un’accentuazione dei caratteri autoritari del regime.
La ricostruzione economica avvenne rapidamente, privilegiando l’industria pesante e comprimendo i consumi della popolazione.
L’Urss diventò una grande potenza militare, dotandosi anch’essa della bomba atomica.
La ricostruzione del paese avvenne anche grazie a massicce riparazioni imposte ai paesi dell’Est, ex nemici.
Tutti questi paesi furono trasformati, nella seconda metà degli anni ’40, in “satelliti” dell’Urss, politicamente ed economicamente dipendenti dalle decisioni della potenza egemone e modellati secondo il sistema sovietico.
Un’eccezione fu la Jugoslavia di Tito, la cui autonomia dai sovietici portò nel ’48 a una vera e propria rottura.
Negli Stati Uniti si esaurì, durante la presidenza Truman, la spinta progressista del New Deal e si diffuse, nei primi anni ’50, una campagna anticomunista il cui protagonista fu il senatore McCarthy.
L’Europa occidentale, nell’immediato dopoguerra, fu attraversata da una forte spinta riformista.
Il caso più emblematico fu quello dell’Inghilterra, dove nel ’45-52 i laburisti attuarono un vasto programma di riforme sociali che segnava la nascita del Welfare State.
In Francia – dove nel ’46 fu varata una nuova costituzione democratico-parlamentare (Quarta Repubblica) – la coalizione fr ai partiti di massa resse fino al 1947, quando i comunisti furono esclusi dal governo.
Grazia anche agli aiuti americani, la Germania federale si risollevò rapidamente dalle disastrose condizioni della fine della guerra e fu protagonista di un vero “miracolo economico”.
Un altro miracolo economico fu quello del Giappone, dove gli Stati Uniti imposero una trasformazione in senso democratico-parlamentare senza tuttavia intaccare il potere delle grandi concentrazioni industriali.
Negli anni successivi il Giappone si affermò come una delle maggiori potenze economiche mondiali.
La vittoria dei comunisti sui nazionalisti e la fondazione della Repubblica popolare cinese (1949) segnarono la rinascita della Cina come Stato indipendente e, insieme, un allargamento del “campo socialista”.
L’anno successivo la dimensione mondiale del confronto tra i due blocchi si manifestò con la guerra di Corea, originata dall’invasione del Sud del paese da parte delle truppe del Nord comunista appoggiate dai sovietici.
All’intervento americano contro l’invasione rispose quello cinese, finché la crisi coreana si concluse nel ’53 col ritorno alla situazione precedente alla guerra.
Negli anni successivi alla fine della presidenza Truman (1952) e alla morte di Stalin (1953) si affermò progressivamente un nuovo rapporto meno conflittuale tra le sue superpotenze.
L’equilibrio tra i due blocchi si basava essenzialmente sul reciproco riconoscimento delle rispettive sfere id influenza.
Nel febbraio ’56, nel corso del Ventesimo Congresso del Pcus, il leader sovietico Kruscev fece una clamorosa denuncia dei crimini di Stalin.
Il processo di “destalinizzazione” avviato in Urss alimentò nei paesi dell’Europa dell’Est la speranza di un allentamento del controllo sovietico.
Diffusi movimenti di protesta si verificarono in Polonia (giugno-ottobre 1956) e in Ungheria (ottobre-novembre).
Mentre le agitazioni polacche portarono a una cauta liberalizzazione, l’insurrezione ungherese fu stroncata dall’intervento dell’Armata rossa.
Negli anni ’50 e ’60, mentre l’economia britannica visse un prolungato ristagno, in tutti i paesi dell’Europa occidentale si verificò una crescita economica sostenuta.
Rapida fu soprattutto la ripresa della Germania favorita anche da una notevole stabilità politica.
Il definitivo ridimensionamento politico dell’Europa, conseguenza del conflitto mondiale, favorì l’integrazione economica dei vari Stati, dapprima con la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) e poi con l’istituzione, nel 1957, della Comunità economica europea (Cee).
La Francia attraversò negli anni ’50 una grave crisi istituzionale, legata al problema algerino.
Nel ’58 De Gaulle assunse la guida del governo, varando una nuova costituzione (con cui nasceva la Quinta Repubblica) e concedendo l’indipendenza all’Algeria.
In politica estera De Gaulle seguì una politica finalizzata alla creazione di un’Europa indipendente dai due blocchi ed egemonizzata dalla Francia.
Bibliografia.
Sulla guerra fredda
Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: l’Europa da Yalta a Praga / A. Gambino. – Laterza, 1972
Storia della guerra fredda / A. Fontaine. – Il Saggiatore, 1968
Cinquant’anni di guerra fredda / R. Crockatt. – Salerno, 1997
La guerra fredda / M. Del Pero. – Carocci, 2001
Sul dibattito storiografico
Gli Stati Uniti e le origini della guerra fredda / a c. di E. Aga Rossi. – Il Mulino, 1984
Per un inquadramento generale dei problemi del dopoguerra
Il mondo contemporaneo, 1945-1980 / E. Galli Della Loggia. – Il Mulino, 1982
Sui problemi delle superpotenze, considerati in una prospettiva di lungo periodo
Ascesa e declino delle grandi potenze / P. Kennedy. – Garzanti, 1989
Sugli Stati Uniti
L’America da Roosevelt a Reagan / G. Mammarella. – Laterza, 1984
Sull’Europa
Storia d’Europa dal 1945 a oggi / G. Mammarella. – Laterza, 2000
Dopoguerra: come è cambiata l’Europa dal 1945 ad oggi / T. Judt. – Mondadori, 2007
Sulle due Germanie
Grande storia della Germania / H. A. Winkler. – Donzelli, 2004
Sulla Francia
De Gaulle e il gollismo / G. Quagliariello. – Il Mulino, 2003
Sui rapporti economici fra le due sponde dell’Atlantico
L’Europa ricostruita / D. W. Ellwood. – Il Mulino, 1994
Sull’Urss
Storia dell’Unione Sovietica / G. Boffa. – Mondadori, 1979
Sulle democrazie popolari
Storia delle democrazie popolari / F. Fejto. – Bompiani, 1977
Sulla Rivoluzione cinese
La Cina dal 1949 ai nostri giorni / M.-C. Bergere. – Il Mulino, 2003
Sulla guerra di Corea
La guerra di Corea / S. H. Lee. – Il Mulino, 2003
Cap. 24. La decolonizzazione e il Terzo Mondo
Parola chiave. Neocolonialismo
Di “neocolonialismo” si cominciò a parlare intorno alla metà del ‘900, parallelamente al processo di decolonizzazione.
Numerosi osservatori sostennero che all’acquisita indipendenza politica delle ex colonie asiatiche e africane non corrispondeva una piena autonomia economica: la fine del dominio “formale” era accompagnata dal persistere, con nuove modalità, di rapporti di dipendenza e di alcuni aspetti caratteristici del vecchio colonialismo.
Secondo le teorie sul neocolonialismo, le ricchezze nazionali delle ex colonie continuavano a essere sfruttate a vantaggio del capitale estero in collusione con le classi dirigenti locali, spesso corrotte e prive di reale autonomia, in quanto dipendenti dal sostegno diplomatico, militare e finanziario dei governi occidentali e delle grandi multinazionali dell’industria e della finanza.
Anche lo sfruttamento dei lavoratori (bassi salari e scarse tutele) poteva essere perseguito più facilmente e in misura maggiore nelle aree arretrate, dove non esistevano forze in grado di opporsi e dove lo Stato sosteneva i capitalisti stranieri.
L’iniqua distribuzione delle risorse e il più elevato sfruttamento dei lavoratori sarebbero a loro volta stati sorretti da una visione eurocentrica del mondo, fondata sulla convinzione della superiorità economico-culturale dell’Occidente.
Molte teorie sul neocolonialismo si basavano sul concetto di scambio ineguale: da un lato, l’arretratezza economica e tecnologica, le marcate disuguaglianze, la diffusa povertà e l’accentuata preminenza della produzione di materie prime o di racconti poco remunerativi portava gli Stati di nuova indipendenza a indirizzare l’economia verso l’esportazione e non alla creazione di un mercato interno; dall’altro, la netta predominanza economica, tecnologica, diplomatica e militare avrebbe permesso alle economie occidentali di imporre rapporti contrattuali a loro molto più favorevoli, riuscendo così a determinare l’andamento degli scambi commerciali e a ottenere prezzi più bassi.
Ciò avrebbe comportato un trasferimento di ricchezza dai paesi poveri a quelli ricchi.
Elaborate da studiosi marxisti e da movimenti indipendentisti asiatici e africani negli anni ’50 e ’60, le teorie sul neocolonialismo esprimevano la delusione per le difficoltà incontrate dal processo di decolonizzazione e per il fatto che la nascita di nuovi Stati non si traduceva in piena indipendenza politica né dava luogo a uno sviluppo economico.
All’accusa rivolta alle imprese multinazionali e ai governi occidentali di attuare politiche finalizzate a perpetuare le diseguaglianze e la subordinazione dei paesi sottosviluppati si saldò la denuncia del ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali (soprattutto il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale), considerate uan diretta emanazione degli interessi delle economie più avanzate, in particolare di quella statunitense.
A partire dagli anni ’70 la crescita dell’economia e dell’autonomia politica di alcuni paesi sottosviluppati ha prodotto una forte differenziazione all’interno del Terzo Mondo, modificando pure il rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri; ciò ha indotto a una profonda revisione delle teorie e delle analisi elaborate sin allora.
Sommario.
La Seconda guerra mondiale sancì la definitiva crisi del colonialismo e l’affermazione, a livello internazionale, del principio di autodeterminazione.
La decolonizzazione avvenne in forme relativamente indolori nei possedimenti inglesi, mentre la Francia applicò nelle sue colonie una politica di forte resistenza nei confronti dei movimenti indipendentisti.
Solo assai di rado i nuovi Stati indipendenti avrebbero avuto regimi democratici, prevalendo in generale governi autoritari o militari.
L’Asia precedette di quasi dieci anni il continente africano nella liberazione dal dominio coloniale.
La prima e più importante tappa fu l’indipendenza dell’India (1947).
Al raggiungimento dell’indipendenza seguirono spesso aspri contrasti entro i nuovi Stati, come quello fra indù e musulmani in India e quello fra nazionalisti e comunisti in vada paesi del Sud-Est asiatico.
Particolarmente lungo il processo di emancipazione del Vietnam, ove la lotta contro i francesi si concluse nel ’56 con la divisione del paese in due Stati, l’uno comunista e l’altro filo-occidentale.
In Medio Oriente, già all’inizio del secolo si era sviluppato un movimento nazionalista arabo: la Seconda guerra mondiale accelerò il processo di emancipazione.
Nel 1948, con il ritiro degli inglesi dalla Palestina e la nascita dello Stato d’Israele (cui seguiva immediatamente la prima guerra arabo-israeliana) nasceva il problema palestinese.
Il regime di Nasser in Egitto, nato dopo che una rivolta di ufficiali rovesciò la monarchia (1952), diede a quel paese una posizione di preminenza nella regione, soprattutto dopo la crisi di Suez del ’56 (quando inglesi e francesi, che avevano occupato il Canale, furono costretti a ritirarsi dalle pressioni di Usa e Urss).
In Libia, nel 1969, una rivoluzione portò al potere il colonnello Gheddafi, artefice di un esperimento di “socialismo islamico” e, sul piano internazionale, di una politica che avrebbe alimentato le tensioni nell’area mediorientale.
Particolarmente drammatico e cruento fu il processo di emancipazione in Algeria, per la presenza di oltre un milione di coloni francesi tenacemente avversi all’indipendenza.
Fu De Gaulle a capire l’inevitabilità della rinuncia all’Algeria, che ottenne nel ’62 l’indipendenza.
A sud del Sahara, nell’Africa nera, il processo di decolonizzazione si compì fra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60.
Fu un processo generalmente pacifico tranne in casi come quelli della Rhodesia del Sud o del Congo.
Le vicende del Congo furono particolarmente rappresentative dei conflitti intestini che agitavano spesso le ex colonie, costituitesi in Stati secondo gli artificiali confini della dominazione europea.
Le stesse istituzioni politiche, ricalcate sui modelli europei, avrebbero mostrato una particolare fragilità, lasciando spesso il posto a regimi militari.
Un caso a sé fu quello del Sud Africa, dove la consistente minoranza bianca (presente nel paese da tre secoli) riuscì a conservare il potere praticando una politica di discriminazione (apartheid) ai danni della maggioranza nera.
Sul piano della politica internazionale, i paesi di nuova indipendenza cercarono una piattaforma comune (a partire dalla Conferenza di Bandung del ’55) nel “non allineamento”.
Progressivamente, però, tale neutralismo rispetto al contrasto Est-Ovest lasciò il campo, nella realtà, allo schieramento di molti paesi non allineati in senso filo-comunista o filo-occidentale.
Sul piano economico, il Terzo Mondo era accomunato dalla realtà del sottosviluppo, ovvero dall’incapacità a risolvere i problemi dell’arretratezza economica resi ancor più gravi dall’aumento assai rapido della popolazione.
I paesi dell’America Latina godevano da tempo dell’indipendenza politica ma si trovavano tuttavia in condizioni di dipendenza economica dagli Stati Uniti (che esercitavano uan sorta di tutela su tutto il continente).
L’instabilità politica dell’America centrale e meridionale si caratterizzò nell’oscillazione fra liberalismo, populismo e autoritarismo.
Fra le esperienze più significative, quella del regime populista-autoritario stabilito da Peron in Argentina.
Di grande rilievo, per l’attrazione che esercitò in tutta l’America Latina, du la rivoluzione cubana guidata da Castro (1959) che diede al nuovo regime un orientamento comunista.
Bibliografia.
Sulla decolonizzazione
Decolonizzazione e Terzo Mondo / G. Calchi Novati. – Laterza, 1979
La decolonizzazione / R. Betts. – Il Mulino, 2003
Sull’India
Storia dell’India / P. Spear. – Rizzoli, 1970
Storia dell’India / M. Torri. – Laterza, 2000
Sulla guerra di indipendenza algerina
La rivoluzione algerina / G. Calchi Novati. –Dall’Oglio, 1969
Storia della guerra d’Algeria, 1954-1962 & A. Horne. – Rizzoli, 1980
Sul Medio Oriente e la nascita di Israele
Israele e il rifiuto arabo / M. Rodinson. – Einaudi, 1969
La costruzione del Medio Oriente / B. Lewis. – Laterza, 1998
Il settimo milione: come l’olocausto ha segnato la stori adi Israele / T. Segev. – Mondadori, 2001
Vittime / B. Morris. – Rizzoli, 2001
Sull’Africa
Storia dell’Africa nera / J. Ki-Zerbo. – Einaudi, 1977
L’Africa nera dal 1800 ai nostri giorni / C. Coquery-Vidrovitch, H. Moniot. – Mursia, 1977
Storia dell’Africa / J. Fage. – Sei, 1995
Sull’America Latina
Capitalismo e sottosviluppo in America Latina / A. Gunder Frank. – Einaudi, 1969
Sociologia delle modernizzazione / G. Germani. – Laterza, 1971
Storia dell’America Latina / T. Halperin Donghi. – Einaudi, 1972
Militari e potere in America Latina nel Ventesimo Secolo / G. Pasquino. – Il Mulino, 1974
L’America Latina nel Ventesimo Secolo / M. Plana, A. Trento. – Ponte alle Grazie, 1992
Su Cuba
Storia di Cuba, 1762-1970 / H. Thomas. – Einaudi, 1973
Cap. 25. L’Italia dopo il fascismo.
Parola chiave. Qualunquismo.
Il “qualunquismo”, come atteggiamento di diffidenza nei confronti dei partiti e in genere della politica (che si vorrebbe risolta nella buona amministrazione), come esaltazione dei valori dell’individuo e della tradizione contro le tendenze stataliste, come protesta contro la fiscalità, esiste da molto prima che qualcuno pensasse di dargli un nome, o addirittura di fondare su di esso un vero e proprio partito.
In questo senso, tendenze qualunquiste sono sempre state presenti nei regimi parlamentari, anche se non avevano un’espressione politica autonoma, in quanto si risolvevano nell’adesione ai partiti conservatori o, più coerentemente, nell’astensione dal voto.
Nel periodo fra le due guerre mondiali, queste tendenze confluirono in larga parte nei movimenti fascisti o parafascisti, che proclamavano la loro avversione nei confronti della politica tradizionale e ne proponevano una nuova, basata sul drastico accentramento dei processi decisionali.
Solo nel secondo dopoguerra, alcuni abili quanto improvvisati leader pensarono di isolare e di coltivare il virus della sfiducia nella politica, per farne la base di inediti movimenti di massa.
Il primo di questi movimenti fu quello fondato in Italia nell’immediato dopoguerra dal commediografo Guglielmo Giannini, col nome di “Fronte dell’Uomo qualunque” (donde il termine “qualunquismo”).
Una vicenda molto simile fu quella dell’”Unione per la difesa dei commercianti e degli artigiani”, fondata in Francia nel ’53 dal cartolaio Pierre Poujade (in francese il termine poujadisme corrisponde all’italiano “qualunquismo”).
Nata come gruppo di pressione extrapartitico e poi trasformatasi in movimento politico vero e proprio, sull’onda del rigurgito nazionalista seguito alla crisi dell’impero coloniale francese, l’Unione ebbe il 10% dei voti nelle elezioni del ’56 e mandò cinquanta deputati alla Camera.
Ma, due anni dopo, la sua base era stata già erosa dalla crescita del movimento gollista.
Negli ultimi decenni, quasi tutte le democrazie industriali dell’Occidente hanno conosciuto fenomeni che, pur non potendosi definire qualunquisti in senso stretto, hanno non pochi punti di contatto col qualunquismo “storico”.
Dai gruppi che si richiamavano alla cosiddetta “maggioranza silenziosa” (termine coniato negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60) e che esprimevano le esigenze della “legge e ordine” delle classi medie spaventate dalle agitazioni operaie o studentesche, ai movimenti “antitasse”, nati nella seconda metà degli anni ’70 in Europa e negli Stati Uniti, nel quadro del rilancio delle ideologie liberiste e della crisi dello “Stato assistenziale”.
Anche in Italia si è assistito in questi ultimi anni al crescere di nuove e diffuse forme di protesta contro un fisco ritenuto troppo esoso, ma anche contro una classe politica accusata in blocco di eccessiva invadenza nei confronti della società civile.
Se queste forme di protesta si possano o meno definire “qualunquiste” (termine che, nel linguaggio della classe politica, porta con sé una certa connotazione spregiativa), è un tema di discussione ancora aperto.
Sommario.
Le condizioni in cui versava l’Italia alla fine della guerra erano gravissimi: se le industrie non erano state eccessivamente danneggiate, era però stata fortemente colpita l’agricoltura; ingenti anche i danni subiti dall’edilizia e dai trasporti; elevatissima l’inflazione.
La maggioranza della popolazione risentiva della scarsità di cibo e abitazioni e dell’alta disoccupazione.
I problemi dell’ordine pubblico erano gravi: difficoltà nella smobilitazione dei partigiani, occupazione delle terre, borsa nera, separatismo e banditismo in Sicilia.
Il ritorno della democrazia determinò una crescita della partecipazione politica.
La Democrazia Cristiana si presentava come perno del fronte moderato, in quanto era l’unico partito in grado di competere con socialisti e comunisti sul piano dell’organizzazione di massa.
Molto minor seguito avevano i liberali, i repubblicani e il Partito d’Azione.
A destra il movimento dell’”Uomo qualunque” ebbe, per breve tempo, notevole successo.
La Confederazione generale italiana del lavoro fu ricostituita nel ’44 su basi unitarie.
Il primo governo dell’Italia liberata, basato sulla coalizione fra i partiti del Cln, fu presieduto da Ferruccio Parri, capo partigiano e esponente del Partito d’Azione.
Nel novembre ’45 la guida del governo passò al democristiano De Gasperi.
L’avvento di De Gasperi segnò una svolta moderata nella politica italiana e la fine delle prospettive di radicale rinnovamento sociale.
Il 2 giugno 1946 un referendum popolare sancì la vittoria della repubblica e la caduta della monarchia.
Nello stesso giorno si tennero le elezioni per l’Assemblea costituente, che videro il successo dei tre partiti di massa, e soprattutto della DC che divenne il partito di maggioranza relativa.
Nel ’46-47 i contrasti fra i partiti della coalizione antifascista si approfondirono.
Le accresciute tensioni interne e internazionali provocarono, nel gennaio ’47, la scissione del Partito socialista: l’ala guidata da Saragat, contraria alla stretta alleanza col Pci, fondò il Partito socialista dei lavoratori italiani (poi Partito socialdemocratico).
Nel maggio, De Gasperi estromise i socialisti e comunisti dal governo e formò un ministero “monocolore”.
I contrasti tra i partiti non impedirono il varo di una nuova Costituzione repubblicana (che entrò in vigore dal 1° gennaio 1948).
La Costituzione affiancava agli istituti tipici di un sistema democratico-parlamentare alcuni importanti principi di tipo sociale (diritto al lavoro, libertà sindacale, ecc.).
La campagna per le elezioni del 18 aprile ’48 – dalle quali doveva uscire il primo Parlamento – vide una forte contrapposizione tra socialisti e comunisti (uniti nel Fronte popolare), da un lato, e DC e partiti laici minori, dall’altro.
I democristiani ottennero un grande successo, anche grazie all’appoggio della Chiesa e degli Stati Uniti.
Dopo le elezioni De Gasperi diede vita ad una coalizione “centrista” che vedeva la DC alleata con liberali, repubblicani e socialdemocratici.
Sul piano della politica economica, ebbero sempre il sopravvento le forze moderate, che seguirono una politica di “restaurazione liberista”, rifuggendo da un uso incisivo degli strumenti di intervento statale nell’economia.
Tale politica si affermò pienamente, dopo l’estromissione delle sinistre dal governo, ad opera del ministro del bilancio Einaudi: il successo della sua linea di risanamento finanziario ebbe comunque forti costi sociali, soprattutto in termini di disoccupazione.
Il trattato di pace, che comportava la rinuncia alle colonie e secondarie ratifiche di confine a favore della Francia, fu firmato dall’Italia nel ’47.
Restava aperta con la Jugoslavia la questione di Trieste, riunita all’Italia solo nel ’54.
L’appartenenza dell’Italia al blocco occidentale ottenne una sanzione sul piano militare con l’adesione, nel 1949, al Patto atlantico.
Negli anni del “centrismo” (’48-53) la politica dei governi De Gasperi non fu priva di importanti interventi sociali, come la riforma agraria e l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.
La politica di austerità finanziaria e contenimento dei consumi perseguita dal governo suscitò numerose proteste di piazza cui le forze dell’ordine risposero con durezza,
In questa situazione la DC cercò di rendere più stabile la propria maggioranza con una riforma del meccanismo elettorale (“legge truffa”), la cui approvazione suscitò vivaci proteste a sinistra e fu comunque priva di risultati pratici nelle elezioni del ’53.
Gli anni ’53-58 furono un periodo di transizione.
Alle novità sul piano economico (“piano Vanoni”, ministero delle Partecipazioni statali) e istituzionale (insediamento della Corte costituzionale) si affiancarono mutamenti entro i partiti che avrebbero poi reso possibile l’allargamento della maggioranza ai socialisti.
Nella DC si affermò con la segreteria Fanfani (1954) una nuova generazione, più attenta all’intervento dello Stato nell’economia e più sensibile ai problemi sociali.
Il Psi, soprattutto a partire dal ’56, andava allontanandosi dai socialisti.
Bibliografia
Sull’Italia del dopoguerra
Storia del dopoguerra: dalla liberazione al potere DC / A. Gambino. - Laterza, 1978
Storia dell’Italia moderna. Vol. 11. / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1986
Le paure e le speranze degli italiani, 1943-1953 / E. Di Nolfo. – Mondadori, 1986
Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi / P. Ginsborg. – Einaudi, 1989
La repubblica dei partiti / P. Scoppola. – Il Mulino, 1991
Storia dell’Italia repubblicana: l’economia, la politica, la cultura, la società dal dopoguerra agli anni ’90 / S. Lanaro. – Marsilio, 2001
L’Italia contemporanea, 1943-1992 / G. Mammarella. – Il Mulino, 1993
Storia della prima repubblica / A. Lepre. – Il Mulino, 1995
Storia d’Italia. Vol. 5. / Sabbatucci-Vidotto. – Laterza, 1997
Storia dell’Italia repubblicana /coordinata da F. Barbagallo. – Einaudi, 1993-97
Sull’economia
La politica economica della ricostruzione, 1945-1949 / C. Daneo. – Einaudi, 1975
Stato e industria dell’Italia repubblicana / M. Salvati. – Feltrinelli, 1982
Per gli aspetti istituzionali
Storia costituzionale della Repubblica / F. Bonini. – Nis, 1993
La Costituente: un problema storico-politico / P. Pombeni. – Il Mulino, 1995
Sui partiti
Storia dei partiti nell’Italia repubblicana / S. Colarizi. – Laterza, 1994
Partito e antipartito: una storia politica della prima Repubblica, 1946-1978 / S. Lupo. – Donzelli, 2004
Sul qualunquismo
L’Uomo qualunque, 1944-1948 / S. Setta. – Laterza, 1975
Sul Partito d’Azione
Storia del Partito d’Azione / G. De Luna. – Feltrinelli, 1982
Sulla DC
Il Partito cristiano al potere / G. Baget-Bozzo. – Vallecchi, 1974
Il partito italiano: la Democrazia Cristiana dal 1942 al 1994 / A. Giovagnoli. – Laterza, 1996
Su De Gasperi
De Gasperi / P. Craveri. – Il Mulino, 2006
Sul Pci
Storia del Partito comunista italiano / R. Martinelli. – Einaudi, 1995
Storia del Partito comunista italiano / R. Martinelli, G. Gozzini. – Einaudi, 1998
Sul Psi
Storia del Psi / M. Degl’innocenti. – Laterza, 1993
Sulla politica estera
L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992 / A. Varsori. – Laterza, 1998
L’Italia e il Trattato di pace del 1947 / S. Lorenzini. – Il Mulino, 2007
Cap. 26. La società del benessere
Parola chiave. Multinazionali
Si dicono “multinazionali” quelle grandi imprese che posseggono stabilimenti e reti di distribuzione commerciale in diversi paesi e che, pur conservando il quartier generale (ossia gli uffici direttivi), nel paese d’origine, trasferiscono all’estero quote importanti delle loro attività.
Diversi sono i motivi che possono spingere le imprese a dislocare la propria produzione fuori dai confini nazionali, anziché limitarsi a esportare i loro prodotti: tagliare i costi per il trasporto delle merci nei paesi di destinazione, aggirare eventuali restrizioni al commercio o limiti all’importazione, penetrare stabilmente in un mercato per imporvi il proprio marchio, ma soprattutto risparmiare sul costo del lavoro, che è in genere più basso nei paesi poveri, tanto più se sprovvisti di tutele sindacali.
Da tempo, dunque, le grandi imprese (e a volte anche le medie) tendono a “delocalizzare” il grosso della loto produzione, concentrando nei paesi avanzati solo le lavorazioni a più alto contenuto tecnologico.
La crescita delle multinazionali, in numero, dimensione e peso, ebbe inizio negli anni ’60 del ‘900, per poi diventare uno dei dati caratterizzanti dell’”età della globalizzazione”.
Ma il fenomeno aveva origini più antiche.
Giù alla fine dell’800 alcune grandi imprese avevano cominciato a trasferire all’estero parti importanti della loro produzione.
Si trattava, all’inizio, soprattutto di imprese britanniche, cui si aggiunsero (e in parte si sostituirono) quelle statunitensi (celebre il caso della United Fruit Company, che possedeva immense piantagioni di frutta in tutta l’America Latina) e, in una fase successiva, quelle giapponesi.
Presenza e attive sui mercati vastissimi, le multinazionali sono giunte a gestire bilanci, e ad accumulare poteri, pari o superiori a quelli di Stati di media grandezza.
Nel 1999, ad esempio, l’americana General Motors superava, in termini di dimensioni di bilancio, la Grecia (o la Norvegia o il Sudafrica).
Con i loro enormi profitti, le multinazionali rappresentano una fonte di ricchezza per gli Stati di origine, che spesso sono impegnati a difenderne gli interessi, ma anche un’occasione di sviluppo per i paesi che le ospitano e in qualche caso ne subiscono il condizionamento.
Per questo rapporto squilibrato con i paesi del Terzo Mondo, ma anche per la loro capacità di sottrarsi alle decisioni politiche degli Stati o di influenzarle pesantemente, le multinazionali sono state oggetto di aspre contestazioni, rilanciate in anni recenti dai movimenti “no global”.
Sommario.
Negli anni ’50 e ’60 l’economia dei paesi industrializzati attraversò una fase di intenso sviluppo, che ebbe tra le sue cause: crescita della popolazione (da cui un aumento della domanda); innovazione tecnologica e razionalizzazione produttiva; espansione del commercio mondiale ; politiche statali della crescita.
L’applicazione delle scoperte scientifiche divenne velocissima.
Nel campo della chimica si svilupparono le materie plastiche e le fibre sintetiche.
In medicina c’è da segnalare la produzione di nuovi farmaci (antibiotici, ormoni, psicofarmaci, anticoncezionali, ecc.) e i grandi progressi della chirurgia.
Le conseguenze dello sviluppo tecnologico si fecero sentire in modo decisivo nel campo dei trasporti (motorizzazione privata, sviluppo dell’aviazione civile), contribuendo a modificare radicalmente le abitudini di vita.
Nel 1957, col lancio del primo satellite artificiale sovietico, iniziava la conquista dello spazio (del ’69 è il primo sbarco dell’uomo sulla Luna), che avrebbe determinato la “ricaduta” di tecnologia in tutti i settori produttivi.
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa (anzitutto della televisione) ha rappresentato, tra i prodotti dello sviluppo tecnologico, quello che più di ogni altro ha condizionato la vita quotidiana e i modelli di comportamento delle società industrializzate (e in parte anche di quelle meno sviluppate).
Una caratteristica dei decenni del dopoguerra è il forte aumento della popolazione, concentrato però soprattutto nel Terzo Mondo, dove al calo della mortalità si è accompagnato un tasso di natalità notevolmente elevato.
Nei paesi industrializzati l’aumento demografico è stato invece molto contenuto e in alcuni di essi si è giunti ormai alla “crescita zero” della popolazione.
La notevole espansione del consumi “superflui” è ormai caratteristica fondamentale delle società avanzate, ove ha suscitato fenomeni estesi di rifiuto ideologico, nonché di critica da parte di alcune correnti intellettuali (anzitutto quella che si richiama alla “Scuola di Francoforte”).
Alla fine degli anni ’60 si verificò un’esplosione della protesta giovanile contro la “società del benessere”: protesta iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi nell’Europa occidentale e in Giappone.
L’episodio più clamoroso della contestazione studentesca fu la rivolta parigina del maggio ’68.
La fase della ribellione giovanile lasciò un segno profondo nelle società industriali, soprattutto nel campo dei valori e dei modelli di comportamento.
Negli stessi anni si sviluppava un nuovo femminismo che – raggiunta ormai la parità trai sessi sul piano dei diritti politici – criticava la divisione dei ruoli tra uomo e donna nella famiglia e nel lavoro e più in generale rifiutava i valori “maschilisti” dominanti nelle società industrializzate.
Di fronte alla nuova realtà delle società del benessere, la Chiesa cattolica – pur ribadendo la sua critica al diffondersi di valori materialistici e di comportamenti contrari alle sue dottrine – tentò un proprio rinnovamento interno e un’apertura ai problemi del mondo contemporaneo.
Tale nuovo corso iniziò col pontificato di Giovanni Ventitreesimo (1958-63) e proseguì con il Concilio Vaticano Secondo.
Bibliografia.
Per gli aspetti economici e sociali
Storia economica e sociale del mondo / a c. di Po'. Leon. – Laterza, 1979
La società opulenta / J. K. Galbraith. – Comunità, 1963
Il nuovo Stato industriale / J. K. Galbraith. – Einaudi, 1968
Il secolo breve / E. J. Hobsbawm. – Rizzoli, 1995
Sui mass media
I persuasori occulti / V. Packard. – Einaudi, 1958
Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teoria della cultura di massa / U. Eco. – Bompiani, 1964
Gli strumenti del comunicare / M. McLuhan. – Il Saggiatore, 1971
Sulla mentalità e costume del nostro tempo
La vita privata: il Novecento / P. Aries, G. Duby. – Laterza, 1988
Sulla contestazione giovanile
Storia delle nuove sinistre in Europa, 1956-1976 / M. Teodori. – Il Mulino, 1976
Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America / P. Ortoleva. – Ed. Riuniti, 1988
Il Sessantotto / M. Flores, A. De Bernardi. – Il Mulino, 1988
Sul femminismo
Esclusa dalla storia / S. Rowbotham. – Ed. Riuniti, 1977
Sulle trasformazioni della Chiesa
Fra mito della cristianità e secolarizzazione: studi sul rapporto Chiesa-società nell’era contemporanea / G. Miccoli. – Marietti, 1985
La Chiesa nella società contemporanea / G. Verucci. – Laterza, 1988
Cap. 27. Distensione e confronto
Parola chiave. Dissenso.
In senso generico, il termine “dissenso” indica semplicemente l’espressione di un disaccordo: dunque un fenomeno del tutto normale, in politica come nella vita quotidiana.
Il dissenso diventa un problema politico solo nei regimi autoritari, dove il consenso sulle scelte dei vertici è obbligatorio e in qualche misura scontato e in qualsiasi organizzazione (per esempio militare o religiosa) basata sulla gerarchia e sull’obbedienza.
A partire dagli anni ’60, il termine è stato usato soprattutto in riferimento a due realtà fra loro molto diverse: l’atteggiamento di quei gruppi cattolici (detti appunto “del dissenso”) che, pur rimanendo all’interno della Chiesa, ne contestavano l’organizzazione interna e in qualche caso la stessa dottrina; e l’attività di quei gruppi minoritari, formati per lo più da scrittori, scienziati e in genere intellettuali, che alimentavano, in Urss e nelle “democrazie popolari” dell’Europa orientale, una corrente di critica dei regimi comunisti, sfruttando gli scarsi spazi di libertà che di tanto in tanto si aprivano e usando soprattutto canali di comunicazione clandestini per tenersi in contatto fra loro e per far giungere i loro iscritti in Occidente: il principale di questi canali era il Samiszdat (in russo, “autoedizione”), ovvero il dattiloscritto fatto passare di mano in mano.
Fu in relazione in questi gruppi che, a partire dagli anni ’60, si parlò di un “dissenso nei paesi dell’Est”, di “intellettuali del dissenso”, di “repressione del dissenso” e così via.
Inizialmente, l’emersione dei fermenti critici fu favorita dalla parziali aperture tipiche della fase di destalinizzazione: il primo romanzo di Aleksandr Solzenicyn (Una giornata di Ivan Denisovic, del 1962, che descriveva l’esperienza dei campi di concentramento) fu pubblicato col consenso delle autorità sovietiche.
Ma il successivo blocco di ogni evoluzione in senso liberale del sistema – già negli ultimi anni di Kruscev e poi con i suoi successori – ricacciò quei fermenti nell’area della clandestinità.
Un punto di svolta in questo senso fu, nel 1966, il processo ai due scrittori dissidenti Andrej Sinjavskij e Julij Daniel, entrambi condannati a sei anni di carcere.
A volte tollerati, più spesso sottoposti a misure restrittive (dal carcere all’esilio in manicomio), sempre rigidamente controllati dagli apparati di regime, i dissenzienti dell’Est si rifacevano a diverse correnti di pensiero: dal tradizionalismo a sfondo religioso alla liberal-democrazia di modello occidentale, dalla critica “si sinistra” di marca trotzkista che denunciava il tradimento degli ideali rivoluzionari al riformismo di chi si batteva per una democratizzazione del sistema all’interno (come quella tentata invano con la “primavera di Praga”).
Nell’insieme essi svolsero un ruolo importante nel tenere viva in Occidente l’attenzione nei confronti degli aspetti più oppressivi del sistema sovietico e di quello dei paesi satelliti.
Basti pensare all’eco suscitata in Europa e negli Stati Uniti dalla pubblicazione, nel 1973, di Arcipelago Gulag di Solzenicyn (espulso dall’Urss nel 1974) o dall’instancabile campagna per i diritti civili condotta dal fisico Andrej Sacharov (insignito del premio Nobel per la pace nel 1975).
Fu anche grazie alle loro denunce, e a quelle di tanti altri dissidenti, se il comunismo sovietico non poté più godere, nella fase del suo tramonto, di quei diffusi consensi, soprattutto negli ambienti intellettuali, che lo avevano circondato (e indubbiamente aiutato) sia nelle fasi più buie dello stalinismo, sia negli anni del “disgelo” krusceviano.
Sommario.
Negli Usa la presidenza Kennedy (durata dal ’60 al ’63, quando Kennedy fu assassinato) fu improntata a un indirizzo riformistico.
In politica estera, la grave crisi legata alla presenza di missili nucleari sovietici a Cuba (1962) si risolse infine con un successo americano e non compromise la distensione (nel ’63 Usa e Urss firmarono un trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari nell’atmosfera).
In Urss Kruscev accentuò i caratteri pacifici del confronto con l’Occidente.
Ma nel 1964 fu destituito anche per il fallimento dei suoi piani economici.
In Cina, l’insuccesso della politica di sviluppo agricolo lanciata nel ’58 (“grande balzo in avanti”) favorì sul piano internazionale la definitiva rottura con l’Urss, mentre sul piano interno diede spazio alle componenti “moderate” del gruppo dirigente comunista.
Fra il ’65 e il ’68, per scalzare il potere di queste ultime, Mao stimolò un movimento di contestazione giovanile (la rivoluzione culturale) che portò alla defenestrazione di molti dirigenti, finché fu frenato dallo stesso Mao.
In politica estera, soprattutto per opera del primo ministro Chou En-lai, la Cina attuò, all’inizio degli anni ’70, un clamoroso avvicinamento agli Stati Uniti.
A partire dalla metà degli anni ’60 si sviluppò progressivamente l’intervento militare americano nel Vietnam del Sud, dove era attivo un movimento di guerriglia che godeva del diretto appoggio dei nordvietnamiti.
Dopo il ritiro delle truppe americane (1973), avvenuto anche in seguito alla forte opposizione che quella guerra aveva suscitato negli Stati Uniti, il governo sudvietnamita fu sconfitto nel 1975.
Nello stesso anno si ebbe la vittoria dei partigiani comunisti in Cambogia e Laos.
La segreteria Breznev (1964-82) mutò più lo stile che la sostanza della politica sovietica; si accentuò, in particolare, la repressione dei dissidenti.
In politica estera l’Urss, se accettò la moderata autonomia conquistata dai rumeni, represse duramente il tentativo riformatore dei comunisti cecoslovacchi (“primavera di Praga”), intervenendo militarmente nell’estate del ’68.
Per le democrazie dell’Europa occidentale gli anni ’60 e i primi anni ’70 furono un periodo di stabilità economica e di mutamenti politici.
In Italia, Germania federale e Gran Bretagna entrarono nel governo i socialisti.
In Germania il socialdemocratico Brandt inaugurò una politica estera di conciliazione con i paesi dell’Est.
Nel 1972 la Cee si allargò con l’ingresso di Inghilterra, Irlanda e Danimarca.
Il Medio Oriente fu teatro in questi anni di due successive guerre: la “guerra dei sei giorni” del ’67 e la “guerra del Kippur” del ’73.
In seguito alla guerra del ’67 Israele occupò nuovi territori arabi, riacutizzando il problema palestinese.
La guerra del ’73 fu all’origine del blocco petrolifero proclamato dai paesi arabi e del successivo aumento del prezzo del petrolio.
L’aumento del prezzo del petrolio nel ’73 (che si inseriva in una fase di instabilità monetaria internazionale inaugurata nel ’71 dalla sospensione della convertibilità del dollaro) generò una crisi economica internazionale di vaste proporzioni.
A differenza delle crisi del passato, la crescita della disoccupazione si sommava a un elevato tasso di inflazione.
La gravità della crisi indusse ad interrogarsi sui fondamenti stessi della civiltà nata con la rivoluzione industriale.
Bibliografia
La Germania da Adenauer a oggi / G. Mammarella. – Laterza, 1979
Storia d’Europa: l’Europa oggi. – Einaudi, 1993
Sulla guerra del Vietnam
Storia della Guerra del Vietnam / S. Karnow. – Rizzoli, 1985
La Guerra del Vietnam / M. K. Hall. - Il Mulino, 2003
Sul conflitto arabo-israeliano e la questione palestinese
Storia del conflitto arabo israeliano palestinese / G. Codovini. – Bruno Mondadori, 1999
Storia della Palestina moderna / I. Pappe. – Einaudi, 2005
Cap. 28. Anni di crisi
Parola chiave. Monetarismo
Il monetarismo è una corrente di pensiero economico sviluppatasi a partire dagli anni ’60 del ‘900 e legata soprattutto al nome dell’economista statunitense Milton Friedman e alla cosiddetta Scuola di Chicago, la sede universitaria in cui Friedman insegnò.
Alla base delle teorie monetariste c’è l’importanza attribuita alla quantità di moneta come elemento regolatore dell’attività economica.
Secondo i monetaristi, è l’ammontare di moneta resa disponibile dalla banca centrale a determinare, almeno nel lungo periodo, il livello dei prezzi e della produzione.
Regolando il quantitativo di moneta in circolazione, soprattutto attraverso la manovra del tasso di sconto (il tasso di interesse richiesto dalla banca centrale alle altre banche), le autorità pubbliche di uno Stato possono intervenire efficacemente sull’andamento generale dell’economia.
Infatti un’espansione della moneta determina un aumento della domanda complessiva, che a sua volta stimola un incremento della produzione e dei prezzi.
Una riduzione, naturalmente, produce l’effetto opposto.
Se il governo e la banca centrale limitano la quantità di moneta in circolazione, i datori di lavoro ne hanno di meno a disposizione per acquistare nuovi macchinari, per assumere nuovi lavoratori o per aumentare i salari: la produzione e i consumi ne soffrono, ma l’inflazione viene bloccata.
L’equilibrio si ottiene con una politica che commisuri l’offerta di moneta al tasso di crescita dell’economia.
Secondo i monetaristi l’intervento sulla moneta non è solo il più efficace, ma anche l’unico compatibile con politiche che riducano al minimo l’ingerenza dello Stato nell’economia e interferiscano il meno possibile col funzionamento del mercato.
La concezione monetaristica si contrappone dunque frontalmente alle teorie di John Maynard Keynes – che prevedono interventi mirati dello Stato per ridurre la disoccupazione e per stimolare il ciclo produttivo – e alle politiche ad essa ispirate, largamente praticate da molti governi nel secondo dopoguerra.
Il monetarismo si è perciò di fatto identificato con le posizioni neoliberiste, favorevoli a una maggiore libertà del mercato e dell’iniziativa privata.
Negli anni ’70 e ’80, di fronte alla difficoltà di controllare una spesa pubblica in continua crescita, molti governi occidentali adottarono politiche monetaristiche; e una prospettiva analoga fu fatta propria dalle organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, che la imposero ai paesi che fruivano dei loro aiuti.
Ne nacque un acceso dibattito, sia perché quelle politiche non furono coronate da un pieno successo (non sempre si riuscì a controllare la quantità di moneta in circolazione), sia per i costi sociali derivanti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dalla riduzione dell’intervento dello Stato.
Sommario.
L’aumento del prezzo del petrolio nel ’73 (che si inseriva in una fase di instabilità monetaria internazionale inaugurata nel ’71 dalla sospensione della convertibilità del dollaro) generò una crisi economica internazionale di vaste proporzioni.
A differenza delle crisi del passato, la crescita della disoccupazione si sommava a un elevato tasso di inflazione.
La gravità della crisi indusse ad interrogarsi sui fondamenti stessi della civiltà nata con la rivoluzione industriale.
Nei paesi occidentali si manifestò nei tardi anni ’70 una crisi delle ideologie di sinistra, sia riformiste sia rivoluzionarie, e la tendenza all’abbandono dell’impegno politico per un ritorno al privato o i valori tradizionali (il cosiddetto “grande riflusso”).
Nello stesso periodo esplose il fenomeno del terrorismo politico.
Dopo un periodo di incertezza politica ed economica, gli Stati Uniti inaugurarono, con la presidenza Reagan (1980-1988) e poi di Bush, un nuovo corso basato sulla scelta liberista in economia e su una politica estera più dura nei confronti dell’Urss e dei regimi integralisti del Medio Oriente (Iran, Libia).
Negli ultimi anni dell’età di Breznev, l’Urss, pur non avendo risolto i suoi problemi interni, allargò la sua sfera di influenza mondiale.
Particolarmente costoso, anche da un punto di vista umano, fu l’intervento militare in Afghanistan (’79).
Con l’avvento di Gorbacev (1985) fu avviata una radicale svolta sia in politica estera sia in politica interna (riforme economiche e istituzionali, maggiore libertà di informazione): svolta che suscitò, però, non poche difficoltà all’interno dell’Urss.
In seguito a una serie di incontri fra i leader sovietici e statunitensi, si instaurò dopo il 1985 un nuovo clima di distensione internazionale che consentì alcuni accordi fra le superpotenze sulla limitazione degli armamenti e si riflesse positivamente anche sulle prospettive di soluzione dei conflitti locali.
Sul piano dell’economia, l’Europa perse terreno, negli anni ’70 e ’80, rispetto a Usa e Giappone, e il processo di unificazione non fece grandi passi avanti.
Sul piano politico le principali novità furono: la vittoria dei conservatori di Margaret Thatcher in Gran Bretagna; il ritorno al potere dei cristiano-democratici in Germania federale; la vittoria del socialista Mitterrand in Francia; il ritorno alla democrazia in Portogallo, Grecia e Spagna (entrati poi a far parte della Cee).
In America Latina gli anni ’70 e ’80 videro la massima espansione delle politiche militari (come quelle affermatisi in Cile nel ’73 e in Argentina nel ’76), poi il graduale ritorno alla democrazia politica.
Il processo di democratizzazione fu però ostacolato quasi ovunque da gravi problemi economici.
Il Sud-Est asiatico, dopo la partenza degli americani, vide l’esplodere di conflitti tra i paesi comunisti.
Nel ’78, dopo essere stata teatro del sanguinoso esperimento rivoluzionario di Pol Pot, la Cambogia fu invasa dal Vietnam.
Il Cina l’ascesa di Deng Xiaoping portò a un processo di riforme interne e liberalizzazione economica, che diede buoni risultati in termini di sviluppo produttivo, ma non si accompagnò alla democratizzazione.
Il Giappone, già protagonista nel secondo dopoguerra di un “miracolo economico”, divenne, all’inizio degli anni ’80, la seconda potenza industriale e finanziaria del mondo, senza peraltro svolgere in campo internazionale un ruolo adeguato alla sua forza economica.
Bibliografia
Sul miracolo giapponese
Storia del Giappone contemporaneo / J. M. Bouissou. – Il Mulino, 2003
Sul terrorismo
L’età del terrorismo / W. Lacqueur. – Rizzoli, 1987
Cap. 29. L’Italia dal miracolo economico alla crisi della Prima repubblica.
Parola chiave. Mafia.
La parola “mafia” (o “maffia”), termine dall’etimologia incerta, fece la sua comparsa nel dialetto siciliano, e poi nella lingua italiana, intorno alla metà dell’800, per indicare una rete di associazioni legate da stretti vincoli gerarchici e da un codice d’onore fondato sull’omertà, che praticavano la violenza e l’intimidazione per trarne guadagni e vantaggi per i propri membri, ma anche per imporre, a livello locale, un proprio ordine, alternativo a quello dello Stato.
In questo senso la parola ha poi goduto di larghissima fortuna, ben al di là dei confini nazionali (si è parlato, fra l’altro, di mafia russa e turca, cinese e giapponese), e viene oggi comunemente usata, assieme al derivato “mafioso”, per indicare la tendenza a prevaricare, a sostituire il proprio potere a quelli istituzionali, valendosi di una rete di amicizie e di complicità inconfessabili.
Storicamente, le radici del fenomeno sono state individuate nella Sicilia semifeudale del ‘700-800: nelle “compagnie d’armi” al servizio dei signori, ma anche nelle corporazioni artigiane di Palermo e soprattutto nell’azione dei grandi affittuari (gabellotti) per il controllo del mondo contadino nella parte centro-occidentale dell’isola.
Dopo l’unità d’Italia, l’associazionismo mafioso si estese e si rafforzò anche come reazione alla più forte presenza dello Stato, diventando subito oggetto di studi e inchieste.
Ma fu soprattutto dopo il 1893, con l’assassinio del direttore del Banco di Sicilia Emanuele Notarbartolo e il successivo processo che vide imputato come mandante il deputato Raffaele Palizzolo (sospettato di legami con la mafia), che il fenomeno assunse rilevanza nazionale, svelando i suoi stretti intrecci con la politica.
Questi legami si intensificarono all’inizio del ‘900, mentre la mafia cercava l’oceano inserendosi, tramite le comunità integrate, nel “gangsterismo” nordamericano.
Nel 1926 il nascente regime fascista affrontò la questione, inviando a Palermo il prefetto Cesare Mori e investendolo di poteri straordinari per debellare la rete mafiosa, che fu in effetti colpita e decapitata, ma non del tutto estirpata.
Quando molti esponenti della mafia italo-americana sbarcarono in Sicilia nel luglio 1943 assieme alle truppe statunitensi (e forse con l’appoggio delle autorità alleate), la rete fu rapidamente ricostituita e, nell’immediato dopoguerra, fu largamente usata come strumento della reazione padronale contro il movimento contadino.
Un ulteriore “salto di qualità” si ebbe a partire dagli anni ’60, quando la mafia, originariamente espressione di una società contadina, si inserì, sfruttando anche i suoi collegamenti politici, nella speculazione edilizia per poi applicarsi con profitto al traffico internazionale degli stupefacenti, senza per questo rinunciare alle attività tradizionali, come il taglieggiamento delle attività commerciali (il “pizzo”) richiesto come contropartita a una protezione imposta con la forza.
L’estendersi degli interessi mafiosi scatenò una serie di lotte interne all’organizzazione, da cui uscì vincitore il gruppo ei “corleonesi” (così chiamati dal loro paese d’origine), guidato da Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.
Questi, a partire dalla fine degli anni ’70, di fronte ai primi segnali di reazione da parte dei poteri pubblici, dopo anni di interventi scarsamente incisivi, reagirono scatenando una autentica guerra allo Stato che provocò molte vittime illustri, culminando, nel 1982, nell’uccisione del prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa e, dieci anni dopo, nell’assassinio dei magistrati Giovanni Falcine e Paolo Borsellino.
Da allora l’azione repressiva della polizia e magistratura ha fatto registrare non pochi successi, a cominciare dall’arresto di Riina (1993) e di Provenzano (2006).
Ma la mafia, in quando fenomeno radicato nel territorio e dotato di estesi collegamenti internazionali, è ancora ben lontana dall’essere definitivamente estirpata.
Sommario.
Lo sviluppo dell’economia italiana si fece particolarmente intenso negli anni 1958-63.
Fu questo il cosiddetto “miracolo economico” che – nonostante il tasso di sviluppo si riducesse dopo la crisi del ’63-64 – mutò definitivamente in senso industriale il volto del paese.
Al boom nell’industria si accompagnarono due importanti fenomeni sociali: l’esodo dal Sud al Nord e la crescita dell’urbanizzazione.
Entrambi si svolsero in modo caotico, creando notevoli problemi.
In quegli anni, con la televisione si ebbe per la prima volta l’unificazione linguistica e nei modelli di comportamento.
Altro simbolo dell’Italia del miracolo fu l’automobile, che ebbe una diffusione di massa.
I mutamenti economici e sociali si accompagnarono, all’inizio degli anni ’60, a una svolta politica, con l’ingresso dei socialisti nell’area della maggioranza.
L’inserimento fu graduale e molto contrastato.
Nell’estate ’60, dopo la crisi del ministero Tambroni (che aveva tentato, suscitando violente proteste, di governare con l’appoggio determinante del Msi), si formò un governo Fanfani che si reggeva grazie all’astensione (poi trasformata in appoggio parlamentare) dei socialisti.
Nel ’63 si formò il primo governo di centro-sinistra “organico”, presieduto dal leader della DC Aldo Moro.
In questa fase furono varati due importanti provvedimenti: la nazionalizzazione dell’industria elettrica e l’istituzione della scuola media unica.
A partire dal ’63 il centro-sinistra venne esaurendo la sua spinta riformatrice, anche per le preoccupazioni suscitate nella DC dal peggioramento della congiuntura economica e dall’ostilità dei gruppi moderati.
Nelle elezioni del ’63 e in quelle del ’68, sia la DC sia il PSI ottennero risultati deludenti.
Nel ’68 esplose anche in Italia la contestazione studentesca, con caratteri di particolare radicalità dovuti alla forte tradizione marxista presente nella cultura italiana.
Nacquero, tra il ’68 e il ’70, gruppi extraparlamentari.
Il ’69 fu segnato da acute agitazioni operaie (l’”autunno caldo”), protagonisti delle quali furono soprattutto i lavoratori immigrati al Nord.
Le lotte operaie si conclusero con forti aumenti salariali e con un rafforzamento delle confederazioni sindacali.
A queste agitazioni la classe dirigente non seppe rispondere in modo adeguato.
Furono approvati tuttavia alcuni importanti provvedimenti (Statuto dei lavoratori, istituzione delle regioni, divorzio).
Gli anni ’70 furono segnati dalle manifestazioni del terrorismo di destra e di sinistra, cui il governo non seppe reagire adeguatamente.
Gli equilibri politici cominciarono a modificarsi dopo il successo del referendum (1974) che confermò il divorzio contro le posizioni della Chiesa e della DC, testimoniando i profondi cambiamenti della società.
La nuova politica del compromesso storico, annunciata dal segretario del PCI Berlinguer (1973), favorì le vittorie elettorali dei comunisti (1975-76).
Dopo il distacco dei socialisti dal governo (’75) si giunse – di fronte alla necessità di affrontare i problemi suscitati dalla crisi economica e dall’accentuarsi del terrorismo di sinistra – al governo di “solidarietà nazionale”, nel 1978.
Proprio allora le Brigate Rosse compirono la loro azione più clamorosa: il rapimento e l’assassinio di Moro.
Nonostante alcune leggi di contenuto sociale (equo canone e riforma sanitaria) il programma riformatore del governo di solidarietà nazionale non riuscì a realizzarsi, mentre si accentuarono le divisioni tra le forze politiche.
Negli anni ’80, esauritasi l’esperienza della solidarietà nazionale, si ebbero per la prima volta governi a guida non democristiana (con Spadolini e poi con Craxi).
Tra i problemi maggiori affrontati dall’esecutivo vi furono quelli dell’espansione abnorme della spesa pubblica e della malavita organizzata (mentre il terrorismo, dopo la legge sui “pentiti”, risultava sostanzialmente sconfitto).
I contrasti interni alla maggioranza “pentapartita” portarono, nel ’87, alla crisi del governo Craxi e a nuove elezioni anticipate, che segnarono un progresso del PSI e un calo del PCI.
Dopo le elezioni, la coalizione si ricostituiva, dando vita a tre successivi governi a guida democristiana (Goria, De Mita, Andreotti).
Si accentuavano frattanto nell’opinione pubblica la critica alle disfunzioni del sistema politico e l’attesa delle riforme istituzionali.
Bibliografia
In generale
Storia d’Italia. Vol. 6. / Sabbatucci-Vidotto. – Laterza, 1999
Sull’Italia del miracolo economico
Storia del miracolo italiano / G. Crainz. – Donzelli, 1996
Sui problemi dei decenni successivi
Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta / G. Crainz. – Donzelli, 2003
Sulle trasformazioni sociali
Le classi sociali negli anni ’80 / P. Sylos Labini. - Laterza, 1986
Italiani/e: dal miracolo economico a oggi / V. Vidotto. – Laterza, 2005
Sulla storia politica
Il potere dei partiti: la politica in Italia dagli anni Sessanta a oggi / P. Ignazi. – Laterza, 2002
Sul centro-sinistra
Storia e cronaca del centro-sinistra / G. Tamburrano. – Feltrinelli, 1973
Su Craxi e il PSI
La cruna dell’ago: Craxi, il Partito socialista e la crisi della Repubblica / S. Colarizi, M. Gervasoni. – Laterza, 2005
Craxi / L. Musella. – Salerno, 2007
Sul delitto Moro
Il caso Moro: una tragedia repubblicana / A. Giovagnoli. – Il Mulino, 2005
Sui caratteri del sistema politico italiano
Il sistema politico italiano / a c. di P. Farneti. – Il Mulino, 1973
Il sistema politico italiano / a c. di G. Pasquino. – Laterza, 1985
Il sistema politico italiano / C. Guarnieri. – Il Mulino, 2006
Sul fenomeno del terrorismo
Il terrorismo italiano, 1970-1980 / G. Bocca. – Rizzoli, 1981
Terrorismi italiani / D. Della Porta. – Il Mulino, 1984
Il terrorismo di sinistra / D. Della Porta. – Il Mulino, 1990
Cap. 30. Società postindustriale e globalizzazione
Parola chiave. Ecologia.
Si chiama “ecologia” (dal greco oikos, dimora) la scienza che studia i rapporti fra gli esseri viventi e l’ambiente fisico in cui vivono.
Pur essendo da sempre una componente importante di tutte le scienze naturali, solo di recente l’ecologia – chiamata così per la prima volta dallo scienziato e filosofo positivista Ernst Haeckel in un libro del 1866 – ha acquistato uno status di disciplina autonoma.
E’ stata soprattutto la crisi petrolifera del 1973-74 a far riflettere sui pericoli che potrebbero derivare all’umanità da un uso indiscriminato delle risorse naturali.
Ma, più in generale, sono stati gli sviluppi della civiltà dei consumi che, portando all’estremo alcuni fenomeni tipici delle società industrializzate, hanno costretto l’opinione pubblica e i governi a preoccuparsi dei problemi ambientali più di quanto non fosse mai avvenuto in passato.
L’estensione spesso enorme dei centri urbani; la motorizzazione di massa; la moltiplicazione dei consumi, con conseguente accumulo di rifiuti solidi; l’uso crescente di prodotti non biodegradabili (ossia non riassorbibili nel ciclo naturale), come i contenitori di plastica o alcuni detersivi; gli scarichi delle industria chimiche nell’atmosfera o nei corsi d’acqua: questi e altri fenomeni hanno non solo contribuito al degrado ambientale dei grandi agglomerati urbani, ma hanno anche influito sugli equilibri ecologici delle aree non industrializzate.
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha richiamato l’attenzione su altri e ancor più inquietanti fenomeni, anch’essi riconducibili agli effetti dello sviluppo industriale: come l’assottigliarsi dello strato di ozono che protegge la terra dalle radiazioni ultraviolette; o come il formarsi di una cappa di anidride carbonica che, provocando un innalzamento della temperatura (“effetto serra”), rischierebbe, secondo molti scienziati, di compromettere gli equilibri ecologici dell’intero pianeta.
I temi dell’ecologia sono diventati così oggetto di discussione e di mobilitazione in tutti i paesi industriali.
Soprattutto negli anni ’70 sono sorti un po’ ovunque associazioni e gruppi – ricordiamo in particolare l’associazione internazionale Greenpeace, e ecologista e pacifista, nata nel ’71, mentre il WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mondiale per la Natura) era attivo già negli anni ’60 – che si propongono di lottare contro l’inquinamento atmosferico e marino, per la tutela degli spazi versi e del territorio in generale, per la difesa delle specie animali minacciate di estinzione.
Oggi l’esigenza di una più attenta tutela dell’ambiente è riconosciuta da tutti.
Ma esiste ancora una profonda spaccatura fra gli ecologisti “puri”, spesso attivi in movimenti “verdi”, e quelli che potremmo definire gli “industrialisti”.
I primi ritengono la difesa dell’ambiente naturale un obiettivo assolutamente prioritario, , contestano il principio dello sviluppo ad ogni costo e mettono sotto accusa la logica stessa della società industriale.
Gli altri non intendono sacrificare alla causa dell’ecologia le ragioni del progresso economico e tecnologico e affidano proprio a questo progresso la speranza di risolvere in modo equilibrato il problema del rapporto fra l’uomo e il suo ambiente.
Sommario.
Dopo la crisi petrolifera la prospettiva di una crescita illimitata cominciò ad apparire a molto non solo irreale, ma anche dannosa, in quanto portava con sé la tendenza allo spreco energetico e alla dissipazione delle risorse naturali.
Del resto il degrado dell’ambiente aveva assunto i caratteri di una vera e propria emergenza e già alla metà degli anni ’70 appariva necessario utilizzare fonti energetiche alternative ai combustibili fossili.
I governi promossero politiche di risparmio energetico e cominciò ad affermarsi il concetto di “sviluppo sostenibile”.
Gli ultimi decenni del ‘900 hanno segnato nuove trasformazioni nell’economia, che hanno avuto il loro centro propulsore nelle crescenti applicazioni dell’elettronica (computer) e delle scienze ad essa collegate (informatica, cibernetica, robotica, telematica).
La rivoluzione elettronica ha trasformato il sistema delle comunicazioni di massa: da una parte sono aumentati i mezzi di trasmissione, dall’altra è cresciuta l’integrazione tra i diversi canali.
La digitalizzazione ha consentito di unificare i linguaggi e di far circolare informazioni di diversa natura sugli stessi canali di comunicazione.
Una delle più importanti novità dell’ultimo decennio del ‘900 è stato lo sviluppo di Internet: la rete ha contribuito a modificare i modi di espressione e gli orizzonti culturali di milioni di persone.
Gli sviluppi della rivoluzione elettronica hanno avuto effetti anche sull’industria culturale: si sono moltiplicate le imprese multimediali e si è accentuata la tendenza alla standardizzazione dei prodotti culturali di massa.
Gli sviluppi dell’elettronica e dell’informatica hanno accelerato la transizione verso una società “postindustriale”, caratterizzata dal terziario, dalla fine della centralità della fabbrica, dal ruolo crescente dell’informazione.
Cambia anche la natura dei conflitti, meno coordinati dai sistemi di produzione e più legati alle differenze di cultura, di età, di genere.
L’accresciuta velocità delle comunicazioni e la maggiore facilità di spostamento sono all’origine di una sempre maggiore integrazione economica e finanziaria a livello planetario.
Questa tendenza ha provocato da un lato il tentativo degli Stati più ricchi di coordinare meglio le loro economie, dall’altro un moto di protesta mondiale contro gli effetti della globalizzazione, in nome della difesa delle identità locali e di una più equa distribuzione delle ricchezze.
Nell’ultimo trentennio del ‘900 la popolazione mondiale ha continuato ad aumentare ma il ritmo di crescita si sta lentamente riducendo.
Il tasso di fertilità è sceso sotto la soglia della “crescita zero” in Europa e ha cominciato a diminuire anche negli altri continenti: più lentamente in Africa, più rapidamente in America Latina e in Asia.
Questa tendenza è dovuta a volte a politiche demografiche attuate dai governi centrali, altre volte a fenomeni spontanei (benessere, nuovi modelli culturali, urbanizzazione).
In Europa occidentale la “crescita zero” ha creato non pochi problemi proprio in relazione al mantenimento dei livelli di benessere raggiunti.
Alla fine del ‘900 c’è stato un considerevole incremento dei flussi migratori.
Si cominciò a emigrare da tutte le aree povere del mondo verso tutte quelle ricche e la scelta delle destinazioni seguiva una complessa rete di itinerari.
All’inizio del Ventunesimo Secolo la portata di questo flusso imponente non è facilmente quantificabile: anche perché in parte considerevole le migrazioni si svolgono in forma clandestina.
Lo sviluppo di una società multietnica ha dato luogo a reazioni di diverso segno.
Da un lato si è manifestata la tendenza a cogliere gli aspetti positivi dell’immigrazione, dall’altro ci sono state reazioni di ansia e di ripulsa.
Solo all’inizio degli anni ’80 in tutti i paesi occidentali fu legalmente sancita l’uguaglianza civile tra uomini e donne.
Per quanto riguarda l’emancipazione economica, invece, i progressi furono evidenti già negli anni ’50: il tasso di attività tra le donne cominciò a crescere rapidamente e, dalla fine degli anni ’60, iniziò progressivamente a ridursi la differenza salariale fra i sessi.
Ancora oggi, però, permangono ritardi e disparità tra i sessi.
Limitati, invece, sono stati i progressi nelle condizioni di vita della popolazione femminile in molti paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina.
Al di là della mancanza di un riconoscimento legale dell’uguaglianza tra i sessi, risulta poco diffusa l’idea di un diritto della donna all’autorealizzazione personale.
All’inizio del Ventunesimo Secolo la religione resta ancora il riferimento culturale fondamentale per buona parte dei popoli del pianeta.
La Chiesa di Roma, in particolare, ha guadagnato posizioni nelle tradizionali terre di missione, Africa e Asia, compensando così quella tendenza all’abbandono della pratica dei sacramenti che si registra in molti paesi europei.
Un ruolo importante nel rilancio planetario del cattolicesimo è stato svolto dal papa polacco Karol Woytila, salito al soglio pontificio nel 1978 col nome di Giovanni Paolo Secondo.
Un altro fenomeno caratteristico di questo periodo è l’espansione della religione musulmana al di là delle sue aree tradizionali di insediamento.
Questo rilancio dell’Islam ha spesso preso forme dell’integralismo, che ha assunto un notevole peso dopo la rivoluzione iraniana del 1979.
L’integralismo, peraltro, rappresenta solo una componente minoritaria del mondo musulmano e non è uan prerogativa esclusiva dell’Islam: correnti fondamentaliste sono attive da sempre nell’ambito delle Chiese cristiane e nel mondo ebraico.
Ai progressi della medicina nella cura delle più diffuse malattie, ha fatto riscontro negli ultimi decenni la comparsa di nuovi virus, fra cui quello che provoca la Sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).
Gli sviluppi della medicina e della genetica hanno aperto nuovi problemi nei rapporti fra scienza ed etica.
I limiti degli interventi sulla natura e sulla vita costituiscono il campo di riflessione della bioetica.
Bibliografia.
Sull’ambiente e i problemi energetici
Storia verde del mondo / C. Ponting. – Sei, 1992
Energia: storia e scenari / U. Colombo. – Donzelli, 1996
Qualcosa di nuovo sotto il sole: storia dell’ambiente nel Ventesimo Secolo / J. R. Neill. – Einaudi, 2002
Su Internet e sui nuovi media.
Internet: viaggio nel cyberspazio / J. C. Guédon. – Universale Electa-Gallimard, 1996
Il mondo digitale: introduzione ai nuovi media / F. Ciotti, G. Roncaglia. – Laterza, 2000
Sui problemi del lavoro
La fine del lavoro / J. Rifkin. – Baldini & Castoldi, 1995
Sulla globalizzazione
Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone / Z. Bauman. – Laterza, 2001
Globalizzazione dal basso: economia mondiale e movimenti sociali / M. Pianta. – Manifestolibri, 2001
Globalizzazione e disuguaglianze / L. Gallino. – Laterza, 2007
La globalizzazione e i suoi oppositori / J. E. Stiglitz. – Einaudi, 2003
Sulle migrazioni
Migranti, coloni, rifugiati: dall’emigrazione di massa alla fortezza Europa / S. Sassen. – Feltrinelli, 2000
Sulla condizione delle donne nel ‘900
Storia delle donne / a c. di G. Duby, M. Perrot. – Laterza, 1992
Sul rilancio del proselitismo religioso e sull’integralismo
La rinascita islamica / B. Lewis. – Il Mulino, 1991
La rivincita di Dio: cristiani, ebrei, musulmani alla riconquista del mondo / G. Kepel. – Rizzoli, 1991
Intransigenza e modernità: la Chiesa cattolica verso il terzo millennio / A. Riccardi. – Laterza, 1996
Sulle biotecnologie
Il secolo biotech: il commercio genetico e l’inizio di una nuova era / J. Rifkin. – Baldini & Castoldi, 2000
Cap. 31. La caduta dei comunismi
Parola chiave. Pulizia etnica.
Di “pulizia etnica” si cominciò a parlare in Europa a proposito dei conflitti interetnici seguiti alla dissoluzione della Jugoslavia e protrattisi per tutti gli anni ’90 del secolo scorso.
L’espressione serve a designare una pratica di persecuzione o di violenza fisica compiuta da una popolazione ai danni di un’altra per terrorizzarla e costringerla ad abbandonare un territorio conteso.
In questo senso, quindi, “pulire” un’area geografica significa renderla forzatamente omogenea, eliminandone tutti gli appartenenti alle etnie minoritarie.
In Jugoslavia, per esempio, il leader Slobodan Milosevic tentò di allontanare in questo modo gli albanesi che risiedevano nel Kosovo (e lo stesso fecero, in quegli anni, i serbi contro i croati e i croati contro i serbi nelle aree miste da essi controllate).
L’espressione è stata utilizzata anche a proposito degli scontri tra hutu e tutsi in Ruanda.
Ma può essere usata anche in riferimento a moltissimi episodi del passato, che videro intere popolazioni costrette ad abbandonare le loro terre.
E oggi viene utilizzata dai mass-media per denunciare casi di politiche discriminatorie contro minoranze etniche indesiderate all’interno di una nazione.
In questo senso la “pulizia etnica” si distingue dal genocidio propriamente detto: in quest’ultimo, infatti, il fine che si si propone è l’annientamento fisico di un popolo, mentre la pulizia etnica ha come obiettivo il suo allontanamento, indipendentemente dai mezzi usati per ottenerlo.
In realtà la giurisprudenza internazionale non ha ancora trovato uan soluzione chiara riguardo all’eventuale corrispondenza tra genocidio e pulizia etnica.
Alcuni studiosi hanno suggerito una versione molto ristretta del concetto di genocidio: in questa prospettiva solo la Shoah potrebbe essere considerata in questi termini, poiché rimane l’unico caso in cui risulta evidente l’intenzione di distruggere completamente un gruppo, gli ebrei, indipendentemente dal luogo dove vivevano.
Uan definizione simile distinguerebbe dunque automaticamente la pulizia etnica dagli atti di genocidio.
Ciò non esclude, tuttavia, che un’accezione più ampia di genocidio possa ricomprendere anche episodi di pulizia etnica.
E’ importante comunque sottolineare che la definizione di genocidio, contenuta nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) e ripresa nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998), pone come requisito l’esistenza di un progetto per distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo.
Sommario.
Il declino dell’Urss, e in generale dei sistemi comunisti, manifestatosi già negli anni ’70, conobbe una brusca accelerazione nel decennio successivo.
Decisivo, nel determinare la crisi, fu il fallimento del tentativo di Gorbacev di avviare un processo di parziale liberalizzazione aprendo limitati spazi di pluralismo nel sistema sovietico e nei rapporti con i paesi satelliti.
La Polonia aveva anticipato questi mutamenti già all’inizio degli anni ’80, con la nascita del sindacato indipendente Solidarnosc.
Il processo, interrotto nel 1981 da un colpo di Stato militar-comunista, riprese dopo l’avvento di Gorbacev, portando, nell’89, alle prime elezioni libere in un regime di “democrazia popolare”.
I mutamenti in Unione Sovietica ebbero immediati riflessi sui paesi dell’Europa orientale, provocando la crisi dell’intero blocco comunista.
Processi di liberalizzazione furono avviati prima in Polonia – dove già all’inizio degli anni ’80 si era affermato il sindacato indipendente Solidarnosc – e in Ungheria, poi in Germania orientale, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania – l’unico paese in cui il trapasso di regime avvenne in forma violenta.
Mentre in Romania e in Serbia i gruppi “neocomunisti” riuscirono a mantenere il potere, negli altri Stati i partiti comunisti furono completamente travolti.
Nella Repubblica democratica tedesca la caduta del muro di Berlino e la vittoria dei cristiano-democratici aprirono la strada alla riunificazione con la Repubblica federale, che fu portata a termine nell’ottobre 1990.
Fra il 1989 e il 1991 gli equilibri mondiali subirono un radicale sconvolgimento.
Nel vuoto aperto dalla crisi dell’Urss e dall’assenza di un nuovo ordine internazionale, si inserì una generale ripresa dei movimenti nazionalisti.
L’evento centrale di questa nuova fase fu la crisi dell’Urss.
Il processo di disgregazione avviato con le riforme di Gorbacev si accelerò dopo un fallito colpo di Stato tentato, nell’agosto 1991, dai rappresentanti del vecchio regime.
Alla fine del 1991 l’Unione Sovietica cessò di esistere e Gorbacev diede le dimissioni.
Negli anni ’90 l’Europa ex comunista attraversò momenti difficili dal punto di vista economico e politico.
La Jugoslavia si divise in diversi Stati – Federazione jugoslava, comprendente Serbia e Montenegro, Croazia, Slovenia, Bosnia e Macedonia – e, dal 1991, fu teatro di una spietata guerra fra le nazionalità: particolarmente sanguinoso il conflitto in Bosnia, concluso con un precario accorso solo nel 1995.
Fra il ’98 e il ’99 esplose la crisi del Kosovo, dove la repressione attuata dai serbi neo confronti della popolazione albanese venne bloccata dall’intervento militare della Nato.
Nel ’97 anche l’Albania conobbe una drammatica crisi interna, risolta solo con l’intervento dell’Onu.
Bibliografia.
Sulla crisi dei regimi comunisti
1989: riflessioni sulla rivoluzione in Europa / R. Dahrendorf. – Laterza, 1990
Le rovine dell’impero: Europa centrale, 1980-1990 / T. Garton Ash. – Mondadori, 1992
La fine delle democrazie popolari / F. Fejto. – Mondadori, 1994
La caduta dei comunismi / B. Bongiovanni. – Garzanti, 1995
Dall’Urss alla Russia: storia di una crisi non finita / G. Boffa. – Laterza, 1995
Le guerre jugoslave, 1991-1999 / J. Pirjevec. – Einaudi, 2001
Sulla riunificazione tedesca
Capire la Germania / G. E. Rusconi. – Il Mulino, 1990
Diario berlinese, 1989-1990 / R. Darnton. – Einaudi, 1992
Il crollo: la crisi del comunismo e la fine della Germania Est / C. S. Maier. – Il Mulino, 1999
Grande storia della Germania / H. A. Winkler. – Donzelli, 2004. – 2 voll.
Cap. 32. Il nodo del Medio Oriente.
Parola chiave. Fondamentalismo.
Si definisce “fondamentalismo” l’atteggiamento di chi si batte per un ritorno ai “fondamenti” della religione: dunque per una interpretazione letterale dei testi sacri posti alla base della propria confessione (si tratti della Bibbia, del Vangelo o del Corano) e per un’applicazione integrale dei precetti in essi contenuti, che dovrebbero informare di sé le leggi dello Stato, e dunque la politica, la vita sociale e l’economia (in questo caso si parla anche di integralismo: un termine che però ha un significato più vago e un campo di applicazione più ampio).
I movimenti fondamentalisti si considerano i legittimi detentori delle verità religiose originarie, inquinate dai processi di modernizzazione.
Per imporsi, si inseriscono nelle fasi di crisi, offrendone una spiegazione unica e al tempo stesso una soluzione semplice e immediata: il ritorno, appunto, alle antiche tradizioni e alle certezze del credo religioso.
Essi forniscono, inoltre, ai propri aderenti un’organizzazione e una comunità da cui sono esclusi i non credenti e i dissidenti, considerati come nemici da abbattere.
Se l’atteggiamento fondamentalista è antico quanto le religioni, il termine si è imposto soprattutto nel Ventesimo Secolo.
I primi ad usarlo furono quei gruppi di protestanti conservatori americani che si riconoscevano nei Fundamentals, una raccolta di testi ricavata dalla Bibbia che doveva costituire la base per il rinnovamento spirituale della società.
In ambito islamico, le origini del fondamentalismo contemporaneo vanno fatte risalire al movimento dei Fratelli musulmani, nato in Egitto alla fine degli anni ’20 del ‘900 per iniziativa di un insegnante, Hasan al-Banna, con lo scopo di reagire all’occidentalizzazione della società in nome di una totale adesione ai precetti coranici.
Ma la diffusione del fenomeno su vasta scala risale alla fine degli anni ’70, in coincidenza con la rivoluzione khomeinista in Iran e con la resistenza dei combattenti afghani all’occupazione sovietica.
Il carattere militante e aggressivo di un certo islamismo radicale – manifestatosi in forma emblematica soprattutto con gli attentati dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New York – ha fatto sì che il fondamentalismo islamico venisse avvertito in occidente (e in molti degli stessi paesi musulmani) come una minaccia permanente e come l’emergenza prioritaria del nostro tempo.
Ciò non deve tuttavia far dimenticare che il fondamentalismo in quanto tale non è un carattere esclusivo dell’islamismo.
Esiste un fondamentalismo evangelico, forte soprattutto negli Stati Uniti, legato alla destra conservatrice e impegnato nella battaglia contro le teorie evoluzioniste e contro la pratica dell’aborto.
Esiste un fondamentalismo cattolico, che si batte contro le innovazioni del Concilio Vaticano Secondo.
Esistono gruppi fondamentalisti ebraici, diffusi sia in Israele sia negli Stati Uniti.
Esiste un fondamentalismo induista, che in India si è spesso scontrato con la minoranza musulmana.
Si tratta, in ognuno di questi casi, di fenomeni minoritari e non necessariamente violenti, che però testimoniano la presenza di vaste aree di disagio e di reazione tradizionalista, che i processi di modernizzazione hanno allargato e acuito.
Sommario.
Negli ultimi decenni del ‘900 la centralità strategica del Medio Oriente si accentuò per l’intrecciarsi di tre fattori di tensione: l’accresciuto interesse per il petrolio, il prolungarsi del conflitto arabo-israeliano, la diffusione del fondamentalismo islamico.
La pace fra Egitto e Israele stipulata nel 1978 da Sadat e Begin con la mediazione degli Stati Uniti non bastò a favorire un accordo globale nella regione.
In Iran, nel 1979, una rivoluzione rovesciò la monarchia e instaurò una repubblica di stampo teocratico e fondamentalista guidata dall’ayatollah Khomeini.
Violentemente antioccidentale, il nuovo regime entrò subito in contrasto con gli Stati Uniti.
Nel 1980 l’Iran fu attaccato dall’Iraq: la guerra durò otto anni e si risolse in un’inutile carneficina.
Negli anni ’80 si accentuò il conflitto fra Israele e i palestinesi sulla sorte dei territori occupati nel 1967.
A partire dall’87 i palestinesi dei territori diedero vita a uan rivolta (intifada) contro Israele, che reagì duramente.
I riflessi dell’irrisolto nodo palestinese si erano intatto fatti sentire anche in Libano che, dalla metà degli anni ’70, era entrato in uno stato di cronica guerra civile.
La situazione si aggravò dopo che l’esercito israeliano invase il paese per cacciarne le basi dell’Olp.
L’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq si Saddam Hussein nel 1990 provocò, nel 091, la risposta di una coalizione militare guidata dagli Stati Uniti che agiva sotto la bandiera dell’Onu.
La campagna fu rapida e vittoriosa, ma il regime di Saddam rimase in piedi.
La sconfitta dell’Iraq favorì il rilancio del processo di pace, che portò nel 1993 a un accordo tra Israele e i palestinesi dell’Olp.
L’accordo era tuttavia minacciato sia dall’affermazione delle forze nazionaliste in Israele, dopo l’attentato che nel 1995 costò la vita al premier laburista Rabin, sia dalla recrudescenza del terrorismo palestinese in versione fondamentalista.
Nel 2000, dopo un fallito tentativo di giungere a un accordo generale, gli scontri e gli attentati ripresero con rinnovata violenza.
Nemmeno il ritiro israeliano da Gaza, nel 2005, servì a riportare la pace, mentre cresceva l’influenza del movimento integralista Hamas.
Sull’onda della rivoluzione iraniana, le correnti fondamentaliste si diffusero in tutto il mondo islamico e, nel ’96-97, trovarono una base in Afghanistan sotto il regime dei talebani.
L’ondata fondamentalista toccò anche paesi di tradizione laica, come la Turchia e soprattutto l’Algeria.
Qui la reazione dei gruppi fondamentalisti all’annullamento delle elezioni del ’92 provocò una serie di spaventosi massacri.
Bibliografia
Sulla storia del Medio Oriente
Storia del Medio Oriente, 1798-2005 / Il Mulino, 2006
Cap. 33. L’Unione europea
Parola chiave. Europeismo.
L’europeismo è un movimento politico e di idee che tende a promuovere l’avvicinamento tra gli Stati nazionali europei, fino alla costruzione di un’Europa politicamente unita.
Essi si richiama alle fondamentali affinità culturali e storiche che legano tra loro i popoli d’Europa, al di là dei mutevoli e controversi confini geografici che dividono il continente, e al sentimento di appartenenza a un destino comune.
Richiami a una civiltà europea intesa come unità culturale erano già presenti in epoca pre-rinascimentale, soprattutto in riferimento al lascito della tradizione cristiana medievale.
Il tema dell’unicità della civiltà europea ritornò in auge nel ‘700 (con Voltaire e Kant) e nell’800 (con Mazzini), non più inteso soltanto nei suoi aspetti culturali ma declinato anche come concreta opzione politica.
Il tema, però, rimase per decenni patrimonio di una ristretta élite.
Spazi per un movimento politico sembrarono aprirsi dopo la fine della prima guerra mondiale: le tragiche conseguenze cui aveva condotto il nazionalismo dei diversi Stati e la crisi del tradizionale equilibrio confermavano le ragioni di chi poneva l’obiettivo di un superamento delle divisioni interne al continente.
Negli anni ’20 del ‘900, un politico austriaco, Richard Coudenhove-Kalergi, fondò l’Unione paneuropea, finalizzata alla promozione dell’unione politica fra gli Stati del vecchio continente (escluse Russia e Inghilterra); furono anche elaborate alcune proposte federaliste, come il progetto del ministro francese Aristide Briand di istituire gli Stati Uniti d’Europa.
L’ascesa al potere dei nazisti, le tensioni e i conflitti degli anni ’30 e poi la seconda guerra mondiale dimostrarono che i tempi non erano ancora maturi.
La fine della guerra ebbe come risultato la divisione politica dell’Europa tra Est e Ovest e, con l’emergere delle superpotenze Usa e Urss, il ridimensionamento del continente nello scenario mondiale.
Fu in questo contesto che l’idea di un’Europa unita – rilanciata durante la guerra da varie forze antifasciste – divenne un tema all’ordine del giorno del dibattito politico e culturale.
Essa fu sostenuta da politici di diverso orientamento: socialisti come il francese Léon Blum e il belga Paul-Henri Spaak, cattolici come il tedesco Konrad Adenauer, l’italiano Alcide de Gasperi e il francese Robert Schuman, conservatori come Winston Churchill.
Importante fu poi l’azione di alcuni gruppi europeisti, il principale dei quali fu il Movimento federalista europeo (ispirato al Manifesto per l’Europa libera e unita, redatto nel 1941 dagli antifascisti italiani Ernesto Rossi e Altiero Spinelli durante il confino a Ventotene, e guidato dallo stesso Spinelli), sorto intorno all’obiettivo della costituzione degli Stati Uniti d’Europa.
Se l’idea di un avvicinamento tra le nazioni del continente fu largamente condivisa, profonde divergenze si registrarono – e in parte continuano a registrarsi – sulle forme che avrebbe dovuto assumere il processo d’integrazione.
L’europeismo assunse diverse declinazioni: al modello federalista si contrapposero quello confederalista (basato sulla cooperazione tra i governi e sulla conservazione delle sovranità statali), di cui si fece assertore, tra gli altri, Charles de Gaulle con la sua “Europa delle patrie”, e quello funzionalista, cioè che puntava al superamento della sovranità statale assoluta attraverso accordi settoriali, portato avanti in particolare dal politico francese Jean Monnet.
Le idee europeiste, nel loro insieme, diedero un notevole impulso all’avvio del processo di integrazione.
Il percorso seguito a partire dalla costituzione della Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 1951) e, soprattutto, della Cee (Comunità economica europea, 1957), sino ai più recenti sviluppi, è stato contrassegnato da un prevalere del modello funzionalista, evidente soprattutto nella scelta di far precedere l’integrazione economica a quella politica, nel tentativo di aggirare le forti resistenze degli Stati nazionali.
Sommario
Dopo i trattati di Roma del 1957, il cammino verso l’integrazione politica dell’Europa si arrestò.
Solo nella seconda metà degli anni ’70 si ebbero due novità importanti: l’elezione a suffragio diretto del Parlamento europeo e l’istituzione dello Sme, un sistema di cambi fissi fra le monete dei paesi membri.
Nel decennio successivo, il processo di integrazione fu rilanciato dalla firma dell’Atto unico europeo (1985) e del Trattato di Maastricht (1992), che diede vita all’Unione europea e stabilì condizioni per entrarvi.
I firmatari si impegnarono fra l’altro a realizzare entro il 1999 il progetto du una Unione monetaria europea, con una moneta unica (euro) e una Banca centrale europea (Bce).
A partire dal gennaio 2002 l’euro sostituì le monete nazionali (tranne che in Gran Bretagna).
Il dibattito sull’Unione europea (e sui vincoli che essa poneva alle politiche nazionali) si intrecciò con le vicende dei singoli paesi, che videro in questi anni una regolare alternanza tra forze moderate e forze di orientamento socialista.
All’inizio del nuovo secolo, l’Unione accolse le richieste di adesione di quasi tutti i paesi ex comunisti dell’Europa orientale.
Fu così cancellata la frattura creata con la guerra fredda.
Segnò invece il passo il processo di integrazione politica, soprattutto dopo la bocciatura, nel 2005, da parte dell’elettorato francese e olandese, del progetto di Costituzione europea elaborato, tra il 2001 e il 2003, da un’apposita convenzione.
Bibliografia
Sull’idea di Europa
Storia dell’idea di Europa / F. Chabod. – Laterza, 2001
Europa: storia di un’idea e di un’identità / H. Mikkeli. – Il Mulino, 2002
Sulle vicende dell’integrazione europea
Storia d’Europa dal 1945 a oggi / G. Mammarella. – Laterza, 2000
L’Europa difficile: storia politica dell’integrazione europea, 1948-2000 / B. Olivi. – Il Mulino, 2000
Storia dell’integrazione europea / L. Rapone. – Carocci, 2002
Sugli aspetti economici
Sull’integrazione economica europea, 1947-2006 / F. Fauri. – Il Mulino, 2006
Sugli aspetti giuridici
La costituzione dell’Europa / J. H. H. Weiler. – Il Mulino, 2003
Cap. 34. Sviluppo e disuguaglianza
Parola chiave. Debito estero.
Si intende per “debito estero” un debito pubblico a scadenza pluriennale contratto da uno Stato con creditori privati, governi ed enti pubblici di altri paesi e rimborsabile in valuta straniera, merci o servizi.
Il debito estero di un paese si forma se il fabbisogno di fondi per finanziare la spesa privata in investimenti e la spesa pubblica è maggiore dei capitali disponibili all’interno dello Stato.
Prendere a prestito fondi dalle economie più avanzate, o semplicemente più ricche di capitali, è pratica normale per quegli Stati che debbano affrontare speciali emergenze (guerre, ricostruzioni, opere di modernizzazione) e in genere per ogni paese che intenda scommettere sulla propria crescita.
In particolare, negli anni ’70 del ‘900, i paesi in via di sviluppo acquisirono ingenti prestiti dall’estero al fine di avviare la propria industrializzazione.
E’ dunque in quel periodo che si registrò un rilevante aumento del volume di debito.
Già nel decennio successivo, per molti paesi in via di sviluppo, il debito estero divenne un problema drammatico.
Infatti, alla fine degli anni ’70, la rivalutazione del dollaro, provocata dalla necessità di contrastare gli effetti del caro petrolio, determinò un brusco aumento dei tassi di interesse sui prestiti internazionali e una crescita dello stesso ammontare dei debiti.
Molti paesi debitori entrarono allora in difficoltà: è stato calcolato che tra il 1978 e il 1981 il peso reale degli interessi, al netto dell’inflazione, passò da un valore negativo (-20%) a uno positivo (+20%).
Questo incremento innescò una seria crisi economica nelle aree meno sviluppate del pianeta.
Nel 1982 il Messico dichiarò una moratoria sul debito estero, ovvero una sospensione temporanea dei pagamenti, e successivamente, molti altri Stati presentarono richieste di rinvio delle scadenze e appelli per una rinegoziazione.
Il debito estero, infatti, si rivelò un peso insostenibile per le fragili economie di molti paesi, soprattutto dell’Africa e dell’America Latina.
Intervenne allora il Fondo monetario internazionale come garante di nuovi accordi di rinegoziazione tra paesi debitori e paesi creditori.
Questo coinvolgimento del principale organismo finanziario internazionale inaugurò una nuova politica dei prestiti, che vennero sempre più vincolati a riforme economiche da realizzare nei paesi beneficiari.
Lo scopo era quello di cercare di stabilizzare la situazione economica negli Stati debitori al fine sia di ridurre i rischi di insolvenza sia di promuovere l’espansione del mercato mondiale.
Ma questa strategia, che provocò una severa compressione dei consumi in paesi già poveri, divenne oggetto di molte critiche.
Alla fine degli anni ’80 il Fondo monetario internazionale cambiò approccio e divenne promotore di interventi di rilancio economico nei paesi in via di sviluppo, appoggiando l’avvio di una riduzione volontaria del debito e di una serie di significativi condoni.
Il che non impedì il prolungarsi dello stato di crisi in molti paesi e il verificarsi di casi di insolvenza, come quello di cui fu protagonista l’Argentina nel 2001.
Sommario
Nonostante i grandi mutamenti verificatisi in alcune aree del Terzo Mondo – fra i produttori di petrolio, nei paesi di nuova industrializzazione del Sud-Est asiatico, in India e in Cina – alla fine del ‘900 il divario fra i paesi ricchi e i paesi poveri complessivamente si approfondì.
In Africa si registrarono vere e proprie tragedie della fame, mentre il problema del debito estero si faceva sempre più pressante.
In Asia, negli anni ’80 e ’90, lo straordinario sviluppo economico non fu accompagnato da un significativo progresso della democrazia.
In Cina gli eredi di Deng riuscirono a inserire il paese in un mercato internazionale da cui era rimasto isolato per decenni.
In Giappone, dopo un lungo periodo di sviluppo economico sostenuto, esplose negli anni ’90 una crisi economica aggravata da una serie di difficoltà politiche.
In India ci fu un consolidamento delle istituzioni rappresentative, mentre in Pakistan tornarono al potere i militari.
In Indonesia finì la dittatura di Suharto, ma il paese rimase instabile per una proliferazione dei conflitti etnico religiosi.
Alla fine del ‘900 il modello di sviluppo asiatico, fondato sulla flessibilità e sui bassi salari, fu in parte incrinato da una grave crisi finanziaria.
Non si interruppe però la crescita della Cina, cui si aggiunse quella dell’India.
Negli anni ’90 l’Africa nera vide i suoi mali aggravati da una lunga serie di colpi di Stato e di guerre civili che, in alcuni paesi, giunsero a distruggere ogni autorità centrale.
Le note incoraggianti vennero soprattutto dal Sudafrica, dove si concluse la lunga stagione dell’apartheid.
Un conflitto che trovò soluzione fu anche quello tra gli indipendentisti eritrei e lo Stato etiopico: nel 1993, infatti, nacque lo Stato indipendente dell’Eritrea.
La Somalia divenne teatro di una spietata guerra tra clan e bande rivali, che non venne arrestata nemmeno da una missione di pace dell’Onu.
Più tardi fu il Ruanda a essere dilaniato da una crudelissima guerra, fra le etnie degli hutu e dei tutsi, che ebbe tragiche conseguenze anche in Zaire.
In America Latina, negli anni ’80, si assisté alla caduta delle dittature militari e al conseguente ritorno a una sia pur precaria vita democratica.
Questo processo di democratizzazione, però, incontrò numerosi ostacoli di natura economica, politica e sociale.
Quasi tutti i paesi furono travagliati dall’inflazione e da un pesantissimo carico di debiti con l’estero.
Gli inizi degli anni ’90 segnarono l’inizio di una ripresa e la tendenza alla creazione di aree economicamente integrate (Nafta, Mercosur).
Per i maggiori paesi del Sud America uan nuova crisi si profilò a partire dal 1998: il Brasile riuscì a superare il momento difficile, mentre l’Argentina precipitò in una gravissima crisi finanziaria.
Negli anni successivi, in alcuni paesi latino-americani (Venezuela, Bolivia, Ecuador), si alternarono regimi populisti di sinistra.
Bibliografia
Sul tema delle disuguaglianze
Globalizzazione e disuguaglianze / L. Gallino. – Laterza, 2007
Sull’Africa
Il leone e il cacciatore: storia dell’Africa subsahariana / A. M. Gentili. – Il Mulino, 1995
Sulla Cina
Il secolo cinese / F. Rampini. – Mondadori, 2005
Cap. 35. Nuovi equilibri e nuovi conflitti
Parola chiave. Multiculturalismo
Questo termine, elaborato originariamente nell’ambito delle discipline antropologiche, indica il riconoscimento della pari dignità delle espressioni culturali di tutti i gruppi e comunità che convivono in una società.
E’ un concetto che si fonda sull’idea che ciascun essere umano ha diritto a crescere dentro la propria cultura e la propria tradizione e non deve essere costretto ad assimilarsi a quella della maggioranza.
La parola “multiculturalismo” cominciò a circolare con insistenza negli Stati Uniti e in Canada durante gli anni ’70 del ‘900, per poi diffondersi altrove nel decennio successivo.
Inizialmente, il termine faceva riferimento soprattutto alla convivenza all’interno della società di etnie e culture diverse.
Decisiva, al riguardo, era stata, negli Stati Uniti, la mobilitazione degli afro-americani per il riconoscimento dei diritti civili negli anni ’60.
E altrettanto importante era stata la decisione del governo canadese di avviare, all’inizio degli anni ’70, una politica federale multiculturale per soddisfare le richieste delle minoranze, soprattutto quella francofona.
Ma presto si affermò anche un’accezione più ampia del concetto di multiculturalismo, che faceva riferimento a tutte le differenze presenti in una società.
A ispirarla fu soprattutto l’esperienza dei movimenti collettivi degli anni ’60, in particolare del femminismo, che rivendicava il riconoscimento della differenza di “genere”.
A quest’ultima si aggiunsero poi le differenze di preferenze sessuali, di stili di vita, di credenze spirituali.
Oggi il tema del multiculturalismo è al centro dei dibattito politico nelle società occidentali, non solo in quelle profondamente trasformate dall’immigrazione.
E costituisce il principio legittimante di tutte le politiche di affirmative action (azione affermativa), destinate cioè a garantire pari opportunità e quote di presenze (nelle università, in politica o negli uffici pubblici) a donne e minoranze culturali.
La questione risulta strettamente intrecciata all’idea che lo Stato debba trattare con rispetto non solo il cittadino in quanto entità astratta, ma anche la persona col suo patrimonio di esperienze e di culture: ovvero che le istituzioni pubbliche debbano valorizzare anche ciò che rende diversi gli individui.
Questa idea, però, pone a sua volta problemi nuovi, resi evidenti negli ultimi decenni soprattutto dalla crescita e dalla riscossa identitaria delle comunità islamiche immigrate in Occidente.
Ci si chiede in particolare se l’ideale del rispetto per l’identità culturale di ogni singola comunità (comunitarismo) possa entrare in contrasto con i valori dello Stato di diritto e della stessa democrazia basata sull’uguaglianza dei cittadini, o quantomeno rendere più difficile il funzionamento di leggi e istituzioni che dovrebbero valere per tutti, al di là dei confini comunitari.
Sommario
Dopo il crollo dell’Urss gli equilibri mondiali subirono un radicale sconvolgimento.
Nel vuoto aperto dalla crisi dell’Urss e dall’assenza di un nuovo ordine internazionale, si inserì una generale ripresa dei movimenti nazionalisti e fu lanciata la sfida del fondamentalismo islamico.
Negli Stati Uniti, le difficoltà economiche provocarono, nel ’92, la sconfitta del presidente repubblicano Bush, che pure aveva riportato notevoli successi in politica internazionale e l’elezione del democratico Clinton.
Dopo le iniziali incertezze (dovute anche alle difficoltà inerenti al nuovo ruolo degli Usa, diventati l’unica super potenza mondiale), Clinton accrebbe la sua popolarità grazie soprattutto alla favorevole congiuntura economica e fu rieletto nel ’96.
Nonostante i buoni risultati ottenuti da Clinton nel suo secondo mandato, le presidenziali del 2000 furono vinte di strettissima misura dal repubblicano George W. Bush.
La Federazione russa, sotto la guida di Eltsin, cercò di ereditare il ruolo dell’Urss, ma si trovò in condizioni di grave dissesto economico e di cronica instabilità politica, aggravata dal conflitto con i separatisti della Cecenia.
Una parziale stabilizzazione fu avviata a partire dal 2000, con l’elezione di Putin alla presidenza.
Questi rilanciò la guerra in Cecenia e avviò uan nuova politica estera con l’obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale della Russia.
L’11 settembre 2001 il terrorismo integralista mise a segno un clamoroso attentato contro le Twin Towers a New York e contro il Pentagono a Washington.
L’intero Occidente ne fu sconvolto.
La reazione degli Stati Uniti e dei loro alleati si indirizzò contro l’Afghanistan, che ospitava il presunto capo dei terroristi, Osama bin Laden: l’oppressivo regime dei talebani fu spazzato via dai bombardamenti americani e dall’offensiva delle forze di opposizione.
Dopo l’Afghanistan gli Stati Uniti volsero la loro attenzione all’Iraq di Saddam Hussein, accusato di nascondere armi di distruzione di massa.
Dopo un infruttuoso negoziato tra Onu e Iraq, gli Stati Uniti e Gran Bretagna cominciarono a preparare un’operazione militare.
Su questa decisione la comunità internazionale si divise: da una parte Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna, determinati all’uso della forza; dall’altra Francia, Germania, Russia, Cina e Stati arabi, favorevoli a una soluzione diplomatica.
Il 20 marzo 2003 i primi missili statunitensi colpirono Baghdad.
Nei giorni seguenti le truppe anglo-americane cominciarono ad avanzare in Iraq.
Il regime di Saddam Hussein si sfaldò all’istante, ma la pacificazione del paese si rivelò lenta e difficile.
Bibliografia
Sui nuovi scenari mondiali
L’impero riluttante / a c. di S. Romano. – Il mulino, 1992
Verso il Ventunesimo Secolo / P. Kennedy. – Garzanti, 1993
America senza rivali? / G. J. Ikenberry. – Il Mulino, 2004
Colossus: ascesa e declino dell’impero americano / N. Ferguson. – Mondadori, 2006
Sullo scontro fra islam e Occidente
Occidentalismo: l’Occidente agli occhi dei suoi nemici / I. Buruma, A. Margalit. – Einaudi, 2004
Cap. 36. La Seconda Repubblica
Parola chiave. Proporzionale/Maggioritario
A partire dalle elezioni per l’Assemblea costituente e fino ai due referendum del 9-10 giugno 1991 e del 18 aprile 1993, gli italiani hanno eletto i loro rappresentanti politici in Parlamento con un sistema proporzionale plurinominale basato sullo scrutinio di lista: nei collegi elettorali venivano presentate liste di partiti, ciascuna contrassegnata da un simbolo e composta da un numero di candidati pari ai seggi in palio; gli elettori esprimevano la loro opzione per una lista ed eventualmente per uno o più candidati (voto di preferenza).
Ad ogni partito veniva assegnato un numero di seggi proporzionale ai voti raccolti.
Il sistema proporzionale assicura un’esatta raffigurazione delle scelte dell’elettorato, ma spesso indebolisce la stabilità del governo.
Viene infatti incoraggiata e moltiplicata la frammentazione politica, garantendo rappresentanti in Parlamento a piccoli gruppi o partiti con basse percentuali di voti: tutti sono così incoraggiati a partecipare alla corsa elettorale, anche se la differenza tra formazioni affini è limitata.
Perciò difficilmente in un sistema proporzionale un partito conquista la maggioranza assoluta: per formare un governo è spesso necessaria una vasta coalizione di partiti, dove ogni forza tende a sottolineare le differenze rispetto agli alleati per accrescere il proprio consenso, indebolendo l’attività del governo.
Inoltre, in un regime parlamentare privo di altre cariche direttamente elette dal popolo (come il capo dello Stato o il capo del governo), questo sistema elettorale contribuisce ad assegnare ai partito un ruolo determinante nelle decisioni politico-istituzionali, a scapito degli elettori: con il voto nell’urna viene infatti indicato soltanto il partito preferito, mentre la formazione del governo, l’elaborazione del programma, la scelta dei ministri sono il risultato di trattative tra le forze politiche dopo le elezioni.
Per questo, in alcuni casi, il metodo proporzionale viene corretto con l’introduzione di un premio di maggioranza, ovvero di una quota supplementare di seggi, allo scopo di favorire la stabilità.
In altri casi (come quello della Repubblica federale tedesca dopo la Seconda guerra mondiale) lo stesso obiettivo viene perseguito attraverso una soglia di sbarramento (in Germania è del 5%): chi non la supera viene escluso dalla rappresentanza parlamentare.
Con il sistema maggioritario uninominale, invece, il territorio elettorale è diviso in un numero di collegi pari ai rappresentanti da eleggere (dunque molto più piccoli rispetto a quelli del sistema proporzionale, e tali da favorire un contatto più diretto tra eletto ed elettori), dove si affrontano i candidati, uno per ciascun partito o coalizione di partiti (da cui “uninominale”): chi ottiene il maggior numero di voti (anche se non necessariamente la maggioranza assoluta) ha diritto al seggio.
Esistono molte versioni del sistema uninominale: le più note sono l’inglese e la francese.
Nel primo caso la votazione avviene in un unico turno: è così possibile conquistare il seggio anche con una maggioranza relativa molto bassa di voti.
Nel secondo caso, invece, qualora nessun candidato si sia aggiudicata la maggioranza assoluta al primo turno, viene svolto un secondo turno elettorale (detto ballottaggio) tr ai candidati più votati, consentendo eventualmente agli elettori dei candidato esclusi di votare per l’esponente politicamente più vicino tra quelli rimasti in gara.
Il sistema maggioritario uninominale elimina la corrispondenza proporzionale tra voti e seggi: generalmente chi ottiene la maggioranza relativa di voti conquista un numero di seggi superiore a quanto gliene spetterebbero in proporzione.
Viene così garantita uan semplificazione del panorama politico, che tende ad evolvere verso il bipartitismo (nel caso del turno unico) o verso il bipolarismo (nel caso del doppio turno), poiché i piccoli gruppi con un consenso limitato sono incoraggiati a fondersi o allearsi con le formazioni più vicine.
In Italia la legge elettorale per il Parlamento, approvata dopo il referendum del 1993, era diversa dai modelli descritti: per evitare gli effetti traumatici del maggioritario puro su un sistema politico abituato al proporzionale, era previsto un unico turno maggioritario per i tre quarti dei seggi, mentre era mantenuto il proporzionale per il restante quarto.
Le conseguenze furono contradditorie: per un verso i partiti erano incoraggiati ad integrarsi in cartelli elettorali per conquistare i seggi uninominali, per l’altro tendevano a differenziarsi per ottenere consensi nella quota proporzionale.
Alla fine del 2005, la maggioranza di centro-destra attuò uan nuova riforma, che reintroduceva il criterio proporzionale con liste bloccate (ossia decide sei partiti, senza voto di preferenza), correggendolo con un premio di maggioranza per la coalizione vincente (su base nazionale alla Camera, regionale al Senato) e con uan clausola di sbarramento fissato al 4%.
Il risultato ambiguo delle elezioni del 2006 e la difficile governabilità che ne seguì convinsero le maggiori forze politiche (compresi alcuni fra i promotori della riforma) dell’opportunità di un ulteriore intervento legislativo, sollecitato anche da una nuova proposta referendaria che mirava a semplificare il sistema attribuendo il premio alla lista, anziché alla coalizione vincente.
Il tema della riforma elettorale tornava così ancora una volta al centro del dibattito politico.
Sommario
Nel linguaggio corrente è ormai consuetudine indicare con l’espressione “Seconda Repubblica” il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli anni 1992-94.
I primi anni ’90 vedevano aggravarsi i fattori di crisi, sia sul terreno dell’economia (aumento del deficit pubblico, rallentamento della produzione, svalutazione della lira), sua su quello della convivenza civile (ripresa dell’offensiva mafiosa, dilagare della corruzione).
Sul piano politico, le maggiori novità furono la trasformazione del Pci in Partito democratico della sinistra e l’emergere di nuovi movimenti ostili al sistema dei partiti (verdi, leghe, rete).
Dopo le elezioni del 5 aprile 1992, che segnavano la sconfitta delle forze tradizionali e mettevano in crisi i vecchi equilibri, il governo presieduto da Giuliano Amato ottenne alcuni successi nell’affrontare l’emergenza economica e quella dell’ordine pubblico.
Ma il ceto politico, delegittimato dalle inchieste della magistratura, non riusciva a trovare un accordo sulle riforme istituzionali.
Il referendum dell’aprile 1993 imponeva il passaggio al sistema maggioritario uninominale, passaggio confermato dalle nuove leggi elettorali.
Dopo le dimissioni di Amato (aprile) il governo Ciampi affrontava la crisi economica e occupazionale del paese, mentre le forze politiche si preparavano a un nuovo confronto elettorale.
Le elezioni del marzo ’94, tenutesi col nuovo sistema maggioritario uninominale (che poneva le premesse per instaurare un meccanismo di alternanza tra maggioranza e opposizione), portarono al governo una precaria maggioranza di centro-destra guidata dall’imprenditore Silvio Berlusconi.
Costretto solo dopo sette mesi a dimettersi peri contrasti sopraggiunti all’interno della maggioranza gli succedeva un ministero di tecnici guidato da Lamberto Dini e sostenuto da uno schieramento di forze di centro-sinistra.
Nuove elezioni anticipate (aprile ’96), vinte dalla coalizione di centro-sinistra, inauguravano una nuova fase di governo diretta dal leader dell’Ulivo Romano Prodi.
Il governo di centro-sinistra affrontò il problema del deficit di bilancio riuscendo a ridurlo nel corso del 1997 e quindi a rientrare nei parametri indicati dal Trattato di Maastricht per l’ingresso nell’Unione monetaria.
Fra i problemi politici del paese rimanevano aperti quello dei correttivi al Welfare e quello relativo alle riforme istituzionali, in presenza di una perdurante instabilità politica.
Nel 1998 il governo Prodi cadde e fu sostituito da un nuovo governo di centro-sinistra guidato da D’Alema.
Nel 1999 l’Italia partecipò con gli altri paesi della Nato all’intervento militare in Kosovo.
Nel 2000, dopo la sconfitta elettorale nelle regionali, a D’Alema succedette un altro governo di centro-sinistra presieduto da Amato.
Alla fine della legislatura la maggioranza approvò un’importante legge costituzionale che ampliava i poteri degli enti locali.
Le trasformazioni sociali dell’Italia si misuravano ormai con i comportamenti demografici che registravano una spiccata denatalità e un invecchiamento della popolazione.
L’omologazione dei consumi non riusciva a nascondere differenze sociali, basate soprattutto sulla disuguaglianza dei redditi e dei livelli culturali.
Le elezioni politiche del maggio 2001 diedero una netta vittoria alla Casa delle libertà, la coalizione guidata da Berlusconi, che nel giugno successivo formò il nuovo governo di centro-destra.
La grande ridorma costituzionale voluta dalla maggioranza e approvata nel 2005 fu respinta dal successivo referendum di conferma.
Le elezioni dell’aprile 2006, tenute con una nuova legge elettorale, segnarono la sconfitta, con stretto margine, del centro-destra.
Dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, il diessino Giorgio Napolitano, Romano Prodi formò, in maggio, il nuovo governo di centro-sinistra.
Ma, due anni dopo, le divisioni interne alla maggioranza provocarono una nuova crisi di governo.
Alle elezioni anticipate dell’aprile 2008 si presentarono schieramenti largamente rinnovati: il Popolo delle libertà, la nuova formazione politica creata da Berlusconi, prevalse nettamente sul Partito democratico, guidato da Walter Veltroni.
E Berlusconi riassunse la guida del governo.
Bibliografia.
Sui mutamenti politici dei primi anni ‘90
La grande slavina / L. Cafagna. – Marsilio, 1993
Terra incognita: le radici geopolitiche della crisi italiana / L. Caracciolo. – Laterza, 2001
Sulle nuove forze politiche
Dal Pci al Pds / P. Ignazi. – Il Mulino, 1992
La Lega / I. Diamanti. – Donzelli, 1993
Sulla società italiana
La popolazione italiana: dall’espansione al contenimento / E. Sonnino. – In: Storia dell’Italia repubblicana, vol. 2, t. 1. – Einaudi, 1995
I mutamenti della stratificazione sociale / M. Paci. - Storia dell’Italia repubblicana, vol. 3, t. 1. – Einaudi, 1996
L’Italia del tempo presente / P. Ginsborg. – Einaudi, 1998
Italiani/e: dal miracolo economico a oggi / V. Vidotto. – Laterza, 2005
Introduzione alla storia contemporanea / a cura di Stefano Cavazza e Paolo Pombeni
- Visite: 134
Cap. 1. L’età contemporanea: spazio, tempo, atmosfera / di Paolo Pombeni
Per comprendere come possano stare assieme due concetti in apparenza opposti come “contemporaneo “storia” è necessario osservare che il confine della storia contemporanea non solo è 2mobile” ma varia anche da caso a caso e persino da studioso a studioso. Tra i parametri adottati dagli storici nell’affrontare la questione della “periodizzazione” vi sono il distacco di più generazioni, il concetto di “distanza storica” e infine il principio oggettivo della disponibilità delle fonti. Come criterio di massima, si può allora affermare che un evento è storicamente comprensibile quando, pur non avendo perso tutte le connessioni col presente, è leggibile in un quadro di riferimenti compiuti.
La storia contemporanea? Ecco quella che sembrerebbe una contraddizione in termini, cioè il bisticcio di parole che non possono stare assieme. “Contemporaneo” significa “che accade nello stesso tempo”; “storia” è un concetto che rinvia a qualcosa che è “passato”, anzi di più, che è passato in modo così definitivo da imporsi agli uomini del presente come un qualcosa di concluso su cui si può addirittura riflettere per trarne degli insegnamenti.
Come potrà dunque aversi una storia che sia contemporanea? Il mistero potrebbe essere svelato in modo banale dicendo che la definizione è occasionale e per di più legata al contesto culturale italiano. Infatti la grande partizione originaria della storia distingueva tra la storia “antica” – quella delle civiltà classiche sviluppatesi prima dell’evento che la storia dell’Occidente giudica ancora come oggi come centrale, la nascita di Gesù di Nazareth da cui ebbe origine il cristianesimo – e la storia “moderna” ovvero quella “incominciata da poco”. Il concetto fu introdotto con l’Umanesimo nel 15. secolo, quando la civiltà occidentale iniziò a percepirsi come un rifiorire in forma nuova dei valori che avevano fatto grandi gli antichi. Un rifiorire ricco di innovazioni (culturali, ma anche tecniche e scientifiche) che chiudeva un’epoca descritta fra il crollo dell’antichità classica con la presa di Roma da parte dei barbari e quello che era allora percepito come il ritrovamento della vera dimensione dell’uomo: dunque un’”età di mezzo”, une vo medio che si sarebbe collocato tra evo antico e appunto un nuovo evo, quello moderno.
P. 17
Conclusioni
Si potrebbero concludere queste brevi considerazioni introduttive notando che sino a oggi l’interpretazione dell’età contemporanea si è svolta sotto il segno dei grandi eventi dominati dalle relazioni internazionali e dalla lettura delle loro crisi, individuando in essi i grandi eventi “apocalittici” che segnavano le svolte storiche. Se teniamo presenti le due guerre mondiali, questa lettura acquista una forte plausibilità: in questo caso le relazioni internazionali hanno creato eventi con ripercussioni profonde e durature sul piano economico, sociale, politico, culturale, ecc. In altri casi si può essere di fronte a fenomeni facilmente comprensibili in questo ampio livello di implicazioni: il Congresso di Vienna o la guerra fredda sono già aventi che hanno avuto ripercussioni ampie, ma non così coinvolgenti a livello generale.
Naturalmente sono i fatti “politici” a poter essere più chiaramente identificati con una data e questo spinge a riferirsi a essi come “segnali” dei tornanti storici. In altri casi le mutazioni, per quanto profonde, non si prestano ad essere identificate con una data. Pensiamo per esempio a due fatti che hanno cambiato moltissimo la vita degli uomini nell’età contemporanea come la radio (e poi la televisione) o il computer. Anche se è possibile fissare il momento della loro invenzione, questo non è significativo, perché ci sono voluti decenni perché queste “macchine” raggiungessero un livello di diffusione e di perfezione tale da cambiare significativamente i connotati di una certa forma di civiltà. In più questi fenomeni difficilmente “finiscono” nel medio periodo: l’introduzione generalizzata dell’energia elettrica ha cambiato totalmente la vita dell’umanità, ma essa non ha mai avuto “fine”, anche se oggi la si considera solo la “base” per altre e più impegnative innovazioni.
Ciò spiega la ragione per cui è ancora prevalente a livello di convenzione storiografica la periodizzazione fondata sul riferimento ai grandi eventi politici (l’età delle grandi dittature a base di massa, l’età d’oro del liberalismo, l’imperialismo ecc.). Poiché la periodizzazione è, come abbiamo rilevato all’inizio, un semplice strumento per l’organizzazione logica del discorso storico, non vi sono particolari problemi nello scegliere un metodo o un altro. Quello che bisogna evitare assolutamente la drammatizzazione forzata: leggere tutto attraverso la categoria dei “giorni che hanno cambiato il mondo” è fuorviante. Solo a conclusione dei cicli o col passar del tempo si prende distacco e si “capisce” quel che è successo: il giorno della marcia su Roma non “iniziò” veramente il fascismo, perché non era ancora certo “come sarebbero andate a finire” le cose, perché in molte zone del mondo l’evento passò del tutto inosservato, persino in varie regioni d’Italia e presso molte parti della popolazione. Naturalmente gli uomini che misero ine essere quell’impresa avevano vagamente in testa l’idea di instaurare un regime, ma che esso 1) fosse in grado di affermarsi; 2) fosse configurato in quella determinata maniera; 3) avesse la forza di durare e di imporsi come un modello di soluzione della crisi dello stato moderno; 4) mostrasse la dimensione fallimentare di questa velleità al prezzo di distruggere la forza di una nazione e di precipitarla nell’avventura dei totalitarismi e nella catastrofe della Seconda guerra mondiale, lo si vide solo progressivamente e in maniera completa dopo la conclusione del fenomeno. Quindi la “marcia su Roma” come evento storico non è quel semplice fatto materiale che ebbe luogo il 28 ottobre 1922, ma è la lettura che di quell’evento è divenuta possibile in seguito, applicando a esso una prospettiva di indagine e di valutazione che non era disponibile a nessuno degli uomini coinvolti in esso o suoi spettatori diretti,
Lo stesso, come abbiamo già detto, si può ripetere a maggior ragione per quello che è accaduto fra gli anni Settanta e Ottanta del 20. secolo: considerarli come un ambito di ricerca storica non solo è giusto, ma necessario; pensare che su di essi sia possibile un inquadramento storico in senso appropriato è piuttosto rischioso. Bisogna dunque essere molto cauti con la passione per la storia come “dramma” o come grande sfilata di “eventi decisivi”. Bisogna tenere a mente che la scienza ha fatto un grande e decisivo passo avanti quando ha abbandonato le teorie “catastrofiche” per spiegare il modo di formazione della superficie terrestre. Per un certo periodo si era pensato chela formazione di una montagna o di una valle, di un mare o di un deserto fosse dovuta a un grande e terribile evento: l’eruzione di un vulcano, , una glaciazione, una straordinaria siccità concentrata, un maremoto o un terremoto. Poi invece gli scienziati hanno capito che nel passato non è successo nulla che non succeda anche ora: anche ora le coste lentamente si sgretolano, le montagne si erodono, le terre si inaridiscono o diventano fertili, ecc. Tutto avviene però attraverso fenomeni impercettibili al nostro occhio e al nostro modo di misurare il tempo: se ne vedono i risultati solo quando alla fine di periodi lunghissimi le mutazioni prendono una forma decisiva e avvertibile.
Qualcosa di simile accade per la storia. Essa continua anche oggi e tutti ne siamo partecipi e testimoni: solo che per lo più non sappiamo di “cosa” siamo testimoni, né riusciamo a percepire, nell’apparente banalità della maggior parte degli eventi che si susseguono, il costruirsi di quella che, a distanza di anni, si presenterà agli uomini come la storia del nostro tempo. Certo rimarrà sempre per la storia contemporanea una questione che non si pone per nessun’altra epoca. Ci si deve chiedere dove dobbiamo smettere di “fare storia” per entrare semplicemente o nel campo della cronaca (la descrizione degli eventi fatta da una persona che ne parla con un certo coinvolgimento in essi e senza presumere di darne una ricostruzione completa) o, se si preferisce un approccio più scientifico, nel campo di altre discipline che si misurano con gli eventi loro contemporanei, giudicandoli con propri parametri scientifici (come la politologia per gli eventi politici, la sociologia per le vicende sociali, ecc.). Sono state date varie risposte a questa domanda, nessuna veramente soddisfacente: si è parlato della necessità di un certo distacco di generazioni (già ma quante?), di un problema di “distanza storica” che consentirebbe una “serenità” di giudizio (già, ma quale?), di un criterio oggettivo di disponibilità delle fonti per la ricerca in misura relativamente completa. Tutti criteri accettabili, ma che non rispondono realmente alla nostra questione.
Il fatto vero è che il confine della storia contemporanea è non solo “mobile” (si ridefinisce continuamente), ma varia anche da caso a caso e persino da studioso a studioso. Ci sono autori che, scrivendo di cose a loro molto vicine, sono riusciti fare opera di storia (cioè a scrivere analisi che hanno retto nel tempo alla successiva conoscenza che si rendeva disponibile con nuove fonti e con maggior distacco dai fatti) e autori che, studiando cose più lontane e con ampia documentazione disponibile, non sono riusciti in questo intento. Tuttavia, ciò non significa ancora molto: se sono possibili delle eccezioni, non bisogna pensare che non esistano regole. Come criterio di massima si può dire che un evento è storicamente comprensibile quando esso sia in una certa misura “concluso”, cioè non che abbia perso tutte le connessioni col presente (poiché in questo caso non interesserebbe più a nessuno), ma che si a leggibile in un quadro di riferimenti compiuti senza che ci debba ancora chiedere “come andrà a finire”.
Per chi vuole misurarsi con la fase dell’età contemporanea che ci vede direttamente coinvolti, il primo, e più arduo, compito da affrontare è dimostrare la possibilità di dare un senso scientifico alla sua investigazione. Bisogna sapere che è un esercizio molto difficile che richiede una buona base documentaria e un’adeguata preparazione per affrontarlo.
P. 31-33
Bibliografia
Guida alla storia contemporanea / C. Barraclough. – Laterza, 2009
Prima lezione di storia contemporanea / C. Pavone. – Laterza, 2007
Ottocento: lezione di storia contemporanea / R. Romanelli. – Il Mulino, 2011
I caratteri dell’età contemporanea / R. Vivarelli. – Il mulino, 2005
Cap. 2. La società di massa / di Stefano Cavazza
La Rivoluzione francese, sancendo i diritti fondamentali degli individui e il principio dell’uguaglianza e aprendo la strada al suffragio universale, contribuì al processo storico che portò alla moderna società di massa. La rivoluzione industriale, se da una parte mise in moto un incremento costante della ricchezza, offrendo così le basi materiali per una diffusione generalizzata dei consumi, fu anche all’origine della formazione del proletariato urbano e in seguito di un nuovo ceto medio, parti di un’unica struttura sociale. La dimensione di massa assunta dalla politica, da un lato, portò alla nascita di organizzazioni permanenti come i partiti; dall’altro favorì nuove forme di comunicazione e nuovi media.
- Dall’Antico regime alla società di massa
Nel film M il mostro di Düsseldorf, girato nel 1931 dal regista Fritz Lang, una folla proveniente dai bassifondi della città insegue un assassino di bambine, lo cattura e lo sottopone a un processo per condannarlo a morte. La trama del film fa leva su alcuni temi ricorrenti nell’immaginario legato al concetto di massa. Da un lato l’idea del bassofondo, manifestazione delle viscere della società urbana e ricettacolo del crimine, ma anche espressione di un proprio codice di condotta; dall’altro l’immagine della folla che cerca di farsi giustizia da sola mossa da un istinto primordiale. L’immagine della folla inferocita fu al centro delle analisi sui comportamenti collettivi a fine Ottocento ed è, anche grazie alla letteratura, una delle fonti principali che ha dato corpo al concetto a noi familiare dell’irrazionalità delle masse contrapposta al comportamento razionale dell’individuo. Eppure, noi viviamo quotidianamente in una società di massa nella quale il nostro agire come liberi individui è garantito anche dall’esistenza delle masse di cui noi, volenti o nolenti, facciamo parte. Non solo: la società attuale è una configurazione sociale in cui ogni aspetto ha una potenziale dimensione di massa. Per esempio, la stessa fruizione individuale di un determinato bene sotto forma di consumo presuppone che quell’oggetto sia stato prodotto in serie per essere acquistato da un certo numero di persone. La dimensione di massa assunta dalla nostra quotidianità è il punto di arrivo di un lungo cammino, in cui la liberazione dell’individuo dai suoi vincoli corporativi d’Ancien regime ha prodotto le masse come soggetti sociali e politici in grado di riempire piazze, stadi, grandi magazzini, teatri, facendo di questi aggregati di volta in volta cortei di protesta, curve di tifo di osannanti, schiere di consumatori in cerca dei regali di Natale, ascoltatori entusiasti di concerti. Se la massa può essere considerata la cifra politico-sociale dell’età contemporanea, la sua comparsa come soggetto sociale e politico ha generato fin dall’inizio timori nelle classi dirigenti. Del resto, se guardiamo all’etimologia della parola “massa” la faremo risalire al greco “maza”, termine che definiva l’impasto necessario per fare il pane. Il lemma “massa” fu dunque usato principalmente per indicare un ammasso indistinto i cui elementi costitutivi scomparivano nell’insieme. Trasferito alla realtà politico-sociale, il concetto poteva facilmente assumere connotazioni negative per designare uno stato sociale nel quale il singolo perdeva la sua individualità confondendosi nell’indistinto aggregato della massa. Questa iniziale connotazione negativa si ritrova spesso nei termini derivati, come “massificazione” o “massificato”. Sentirsi attribuire l’etichetta di “massificato” non equivale certo a ricevere un complimento.
P. 35-36
In precedenza, un tessitore esperto con anni di preparazione alle spalle era in grado di dettare le sue condizioni al commerciante che gli procurava il lavoro e poteva lavorare a casa propria organizzando il lavoro come voleva.
P. 40
La classe è in sostanza una massa di persone circoscritta dall’elemento di omogeneità costituita dal fatto di essere un lavoratore manuale, di vivere di un salario e di lavorare in grandi fabbriche.
P. 41
Il sistema dei sussidi, in vigore in alcune contee, alla fine fu abolito perché ostacolava lo sviluppo del mercato del lavoro. Proprio perché garantiva comunque il minimo vitale al lavoratore non spingeva i poveri a uscire dalla loro condizione.
P. 42
Per quanto veloci gli artigiani potevano produrre solo un limitato numero di pezzi e dal momento che dettavano loro le condizioni al mercante, potevano produrre non tanto in funzione delle esigenze del mercato quanto delle proprie.
P. 44
Bibliografia
Le origini del totalitarismo / H. Arendt. – Bompiani,1978
Culture del consumo / P. Capuzzo. – Il mulino, 2006
Dimensione di massa: individui, folle, consumi, 1830-1945 / S. Cavazza. – Il mulino, 2004
La rivoluzione dei consumi: società di massa e benessere in Europa / S. Cavazza. – Il mulino, 2010
Tempo e denaro: la nascita della cultura del consumo / G. Cross. – Il mulino, 1998
La rivoluzione dell’uguaglianza: storia del suffragio universale in Francia / P. Ronsavallon. – Anabasi, 1994
Cap. 3. Globalizzazione dello sviluppo economico e delle crisi: un percorso economico / di Carlo Taviani
L’economia contemporanea è caratterizzata da tendenze contrapposte: nuove potenze, come la Cina e l’India, fanno la parte del leone nelle piazze commerciali e finanziarie di tutto il mondo mentre il vecchio continente europeo subisce i contraccolpi di una grave crisi. Queste pagine guardano al passato e si soffermano su un periodo che va dall’apogeo dell’Europa nel tardo Ottocento alla supremazia novecentesca degli Stati Uniti. La globalizzazione segnò i decenni successivi alla rivoluzione industriale, poi un lungo periodo di guerre mondiali e di crisi ha progressivamente indotto gli stati ad accentuare il proprio ruolo in campo economico. I decenni successivi alla Seconda guerra mondiale sono stati caratterizzati da una forte ripresa fino alla crisi degli anni Settanta. Gli ultimi paragrafi di questa storia restano però ancora da scrivere, poiché siamo tuttora immersi in un profondo processo di transizione.
- L’eredità della Rivoluzione industriale: la globalizzazione, 1870-1913
All’alba dell’Ottocento l’Europa si trovava alle soglie di una profonda trasformazione economica: solo pochi anni prima in Gran Bretagna erano state create nuove tecnologie che ora potevano essere applicate in diversi settori. La rivoluzione industriale di fine Settecento aveva infatti permesso di produrre elevate quantità di beni, attingendo a una nuova fonte di energia, il carbone. Fino ad allora gran parte del lavoro era stata svolta grazie all’impiego di energie con un modesto impatto sull’ambiente, quali quelle eoliche, idriche, quelle ricavate dagli animali o dalle popolazioni rese schiave. Dal tardo Settecento furono le macchine a svolgerlo, con risultati più elevati in termini quantitativi. Gli effetti positivi erano sotto gli occhi di tutto, quelli negativi furono percepibili più lentamente, a distanza di molti anni, Oggi, che si è sviluppata una maggiore attenzione agli effetti della trasformazione dell’energia non rinnovabile, prodotta da fonti fossili, sappiamo che tali innovazioni ebbero un costo ambientale molto elevato.
Il tardo Ottocento fu un periodo caratterizzato dalla forza economica dell’Europa. Il suo prodotto interno lordo (Pil), cioè il valore dei beni e dei servizi, costituiva il 46% di quello mondiale nel 1870 e il 47% nel 1913. Nel mondo, però, cominciavano ad emergere nuove economie, che progredivano a tassi di crescita molto elevati: il Pil del Nord e del Sud America, dell’Australia e della Nuova Zelanda incideva su quello mondiale per il 13% nel 1870 e per il 26% nel 1913.
Nel corso dello stesso secolo, la Rivoluzione industriale non solo fece sentire i suoi effetti nel campo della produzione dei beni, ma ebbe un impatto sulla vita delle popolazioni a molteplici livelli. Tra i fenomeni sociali di grande rilievo, si annovera l’inurbamento di grandi masse di lavoratori che si spostarono dalle campagne alle città per trovare un impiego nelle industrie. Fu questo un fenomeno migratorio interno, che anticipò in scala più ridotta un processo di ben più vaste proporzioni, che caratterizzò l’Ottocento e il primo decennio del Novecento. Gli economisti lo definiscono con il termine globalizzazione e con esso si riferiscono alla circolazione oltre i confini nazionali non solo delle persone, ma anche dei beni, dei capitali e delle idee. Per spiegarlo hanno misurato direttamente questi quattro elementi, oltre che altri parametri che indirettamente forniscono una prova della loro circolazione. Lo scambio dei beni aumentò del 16,1% all’anno tra il 1830 e il 1870 e del 4,1% dal 1870 al 1913. Anche la differenza dei prezzi tra un luogo e l’altro subì una grande variazione: essa si ridusse notevolmente, segno che le merci si spostavano di più e più velocemente rispetto al passato. Tra il 1870 e il 1913, ad esempio, la differenza del prezzo del grano tra Liverpool e Chicago si ridusse del 42%. In secondo luogo, anche i capitali circolarono di più: tra il 1870 e il 1913 l’Europa finanziò in misura maggiore rispetto al passato soprattutto gli Stati Uniti, il Canada, l’Argentina e l’Australia e nel 1914 i paesi europei più ricchi, cioè la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e la Svizzera, finanziavano da soli l’87% degli investimenti mondiali. Sappiamo inoltre che i capitali si muovevano di più, perché diminuì il legame diretto tra risparmi locali e investimenti locali. Ciò significa che nel corso dell’Ottocento sempre più attività economiche e in misura maggiore vennero finanziate con denaro che proveniva dall’estero e non dal paese dove esse avevano sede. Esiste infine un ultimo elemento che fornisce un’indicazione dell’integrazione dei capitali, cioè la variazione del differenziale di rendimento di due titoli di stato di paesi diversi. Ogni paese emetteva, come accade anche oggi, delle cedole che rappresentavano una frazione del suo debito pubblico, i titoli di Stato, e dopo averle vendute ai propri cittadini, o agli investitori stranieri, pagava periodicamente gli interessi fino a una cifra che superava il capitale investito. Tanto più l’interesse era alto, tanto meno valeva il titolo di debito: in pratica, quanto più l’economia di un paese era in cattiva salute, Tanti più interessi doveva pagare ai suoi creditori. La differenza tra il rendimento di due titoli di paesi diversi è detta spread. Se nel 1870 lo spread tra i titoli della Germania, la Francia e la Gran Bretagna, da un lato, e quello dei paesi meno ricchi dell’Europa, dall’altro, si attestava al 5%, nel 1914 scese fino all’1%, segno che ormai a questa data i capitali erano molto integrati, perché gli investitori dei paesi più ricchi avevano fiducia e investivano anche nelle economie più povere. Come terzo importante fattore che indica quanto il processo di globalizzazione fosse esteso consideriamo le migrazioni di persone. Esse aumentarono notevolmente, raggiungendo cifre che nemmeno nei tempi più recenti sono state mai toccate: l’immigrazione europea nelle Americhe (del Nord e del Sud, complessivamente) negli anni Venti era intorno alle 15380 unità per anno. Tra gli anni Quaranta e Cinquanta del secolo raggiunse le 178530 unità e nel 1900 si attestava a più di un milione di persone. L’Italia raggiunse delle cifre molto elevate a partire dai primi anni del Novecento, quando circa il 10,77 della popolazione emigrò per cercare fortuna. Come ultimo elemento, consideriamo ora la circolazione delle idee e delle tecnologie, le persone e dunque altri fattori, quali la riduzione del costo dei viaggi e le politiche di immigrazione, furono responsabili della loro diffusione. Inoltre, in misura molto più rilevante rispetto al passato, le idee circolavano anche attraverso le macchine. Queste ultime, infatti, non erano soltanto delle merci, ma anche un concentrato di nuove tecnologie: esse potevano inizialmente essere acquistate dai paesi che non le possedevano solo al fine di produrre beni. In un secondo momento, però, venivano studiate per essere replicate o trasformate. Come conseguenza, molte imprese non sentirono tutelata la proprietà intellettuale dei loro prodotti e cominciarono a stabilire delle sedi all’estero per produrli e venderli sul posto. Esse persero così il loro carattere locale e divennero delle multinazionali.
Il processo di globalizzazione secondo alcuni studiosi fu reso possibile da un sistema di regolazione delle monete definito “gold standard”. Esso viene fatto convenzionalmente fatto iniziare nel 1717 in Gran Bretagna, quando Isaac Newton stabilì ilc ambio fisso dell’oro (un’oncia per 3 sterline, 17 scellini e 10,5 pence). Si tratta di un sistema inizialmente entrato in vigore solo in Gran Bretagna, poi via via in altri stati, in base al quale ogni paese decideva di mantenere fisso il cambio tra la propria moneta e l’oro. Il gold standard si basava sull’adesione ad alcune “buone regole”: un paese non poteva stampare più carta moneta dell’oro che possedeva, né avrebbe dovuto deliberatamente importare oro. Quando si rispettavano queste regole, entrava automaticamente in azione una serie di meccanismi che avviavano un processo di stabilizzazione dell’economia, principalmente equilibrando i prezzi e la differenza dei capitali tra i paesi. Vediamo come funzionava il caso della stabilizzazione dei prezzi in due paesi. Se accadeva che la bilancia dei pagamenti di un paese era in deficit, cioè se il paese avesse speso più di quanto guadagnava, si sarebbe ridotto naturalmente la quantità di oro. Esso infatti veniva richiesto all’estero come pagamento delle merci, perché era preferibile essere pagati in oro che in carte moneta. Fino a questo punto si trattava di una normale dinamica economica. Per rispettare le “regole del gold standard” e cioè la parità del cambio con l’oro, il paese in deficit doveva ritirare artificialmente anche la carta moneta circolante. La contrazione della quantità di carta moneta induceva il ribasso dei prezzi. Di conseguenza, venivano esportate le esportazioni, perché altri paesi erano interessati a comprare merci meno costose. Viceversa, un paese nel quale entrava più oro, perché la bilancia dei pagamenti era in attivo, doveva stampare più carta moneta (seguendo le regole) e ciò causava un innalzamento dei prezzi. Conseguentemente, le esportazioni diminuivano, perché gli altri paesi non avevano convenienza a comprare beni che costavano di più, e le importazioni aumentavano.
L’efficacia del gold standard è stata largamente enfatizzata, soprattutto a partire dalla fine della Prima guerra mondiale che, con le sue tragedie, segnò a lungo l’immaginario europeo. In questo periodo si tese a idealizzare gli anni precedenti e si identificarono le cause della crescita nel rispetto delle “buone regole” economiche del patto moneta-denaro. In realtà, gli studi attuali tendono a rivedere questa interpretazione, mettendo in luce come le speculazioni finanziarie e i piccoli dissesti fossero all’ordine del giorno. Il sistema non funzionò perfettamente per diversi motivi. Oltre al basarsi sul rispetto delle regole del gioco, il gold standard si fondava sull’assunto che la quantità di oro nel mondo fosse sempre la stessa. Senza il rispetto di questi due parametri non sarebbero potuti entrare in azione i meccanismi di aggiustamento automatico. La realtà fu diversa, sia a causa della scoperta di nuove miniere d’oro (in California, nel 1848), sia perché alcuni paesi (ad esempio la Francia ed il Belgio) non rispettarono le regole e variarono deliberatamente il rapporto oro-moneta, acquistando appositamente più metallo prezioso.
Nel complesso, gli anni che vanno dal 1870 al 1914 furono caratterizzati da un aumento del Pil in molti paesi. Non è possibile delineare un quadro omogeneo europeo, perché i paesi dell’area settentrionale crebbero di più, mentre quelli dell’area mediterranea subirono profondi rallentamenti. Questo stesso periodo fu però attraversato da momenti di debolezza e ripresa, che alcuni economisti definirono “cicli economici”. Tra il 1873 e il 1895 i prezzi subirono una flessione considerevole, tanto che questi anni sono conosciuti con il nome forse un po’ improprio di “Grande depressione”. Ad esso seguirono alcuni anni di ripresa e innalzamento dei prezzi, grossomodo dal 1895 al 1914, e proprio questo fu il periodo poi eccessivamente enfatizzato, tanto da prendere il nome di Belle époque.
P. 55-58
Bibliografia
Storia economica del mondo / R. Cameron e L. Neal. – Il mulino, 2005
Storia dell’economia internazionale dal 1850 ad oggi / J. Foreman-Peck. – Il mulino, 1999
Prometeo liberato: trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell’Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri / D. S. Landes. – Einaudi, 1978
Storia economica del Novecento / S. Pollard (a cura di). – Il mulino, 2005
Dalla rivoluzione industriale all’integrazione europea: breve storia economica dell’Europa contemporanea / V. Zamagni. – Il mulino
Cap. 4. L’età delle ideologie
Il concetto di “ideologia”, di origine filosofica, costituisce uno strumento conoscitivo composto di elementi teorici che prendono la forma di un sistema destinato all’interpretazione della realtà e alla sua valutazione. Gli ambiti concettuali fondamentali entro i quali si muovono le ideologie sono la questione del mutamento, la reciproca influenza fra Stato e società, il rapporto tra individuo e collettività. All’interno di queste relazioni si sviluppano le principali “famiglie” ideologiche – reazionarismo, conservatorismo, liberalismo, socialismo – che vengono qui descritte attraverso la loro origine.
- Che cos’è una ideologia
Il termine “ideologia” è di provenienza filosofica. Fu utilizzato per la prima volta in modo chiaro e sistematico da un gruppo di filosofi, il più importante dei quali fu A. L. C. Destutt de Tracy, che vissero e operarono in Francia tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi dell’Ottocento. Il termine, nell’uso che ne facevano gli “ideologi”, stava ad indicare lo studio delle sensazioni e delle idee che si producono nella coscienza umana. Di provenienza illuministica e di fede politica liberale, gli ideologi assunsero una posizione critica nei confronti tanto di Robespierre e del terrore rivoluzionario quanto di Napoleone. L’imperatore, in polemica con loro, diede alla parola ideologia un significato negativo, utilizzandola per definire un tipo di pensiero politico del tutto astratto e dottrinario, privo di contatto con la realtà e di alcun valore o riflesso pratico.
Qualche decennio più tardi, in un momento del tutto diverso e con ben altra motivazione intellettuale, la parola fu nuovamente utilizzata, ancora con una connotazione negativa, da Karl Marx. Il materialismo storico e dialettico del filosofo tedesco attribuisce un’importanza centrale, sul piano si a economico, sia sociale, sia politico, alle classi – aristocrazia feudale, borghesia, proletariato – e allo scontro in atto fra di esse. La vicenda umana è fatta di lotta tra le classi, lotta dalla quale una sola classe – diversa a seconda dei momenti storici – riesce ad emergere vincitrice, trovandosi così nelle condizioni di dominare sulle altre. Il dominio di classe, unica autentica realtà dei rapporti sociali, economici e politici, non è tuttavia esplicito e sfacciato, ma si nasconde dietro a teorie, idee, principi, finalizzati da un alto a legittimarlo, dall’altro a occultarne la spietata durezza. Questo paravento teorico è per Marx l’ideologia. Le caratteristiche della definizione marxiana di ideologia sono dunque due: in primo luogo l’ideologia ha un’origine sociale, ovvero è prodotta, ovvero è prodotta dalla classe dominante; in secondo luogo essa è falsa, ossia consiste di idee e dottrine prive di corrispondenza con la realtà e anzi finalizzate soltanto a nasconderne la sostanza – che, lo ripetiamo, è fatta di lotta e dominio di classe.
Dopo la Seconda guerra mondiale il concetto di “ideologia2 si è trasferito dalla filosofia alle scienze sociali: In questo nuovo ambito esso ha perduto qualsiasi connotazione positiva o negativa e si è trasformato in uno strumento conoscitivo neutro, utilizzato al fine di riunire in un’unica categoria analitica diversi fenomeni storici – il liberalismo, il socialismo, il conservatorismo, ecc. – stabilendone la natura e le caratteristiche comuni. Di definizioni del concetto di ideologia, assunto in questo nuovo significato, gli scienziati sociali ne hanno date numerose. Esse condividono tuttavia alcune caratteristiche:
a) le componenti di base di un’ideologia sono elementi teorici e astratti, idee, principi, valori, credenze quali la libertà, la giustizia, l’eguaglianza, la tutela della proprietà privata
b) l’ideologia non si basa su un solo di questi elementi, ma assume le caratteristiche di un sistema, ovvero include al proprio interno numerosi elementi, li fa interagire e li coordina, così da trasformarsi in un insieme di parti integrate dotato di un sufficiente grado di coerenza. Il liberalismo, ad esempio, non si fonda soltanto sul valore della libertà, ma anche sulla convinzione che l’uomo sia razionale e perfettibile, su una moderata fede nel progresso, sulla pace e cooperazione internazionale, sull’eguaglianza davanti alla legge, sull’idea che la concorrenza promuova il benessere sociale, ecc.
c) Questo sistema di credenze comprende al proprio interno elementi sia descrittivi sia prescrittivi. In altre parole: da un lato esso pretende di fornire strumenti utili a interpretare la realtà, a comprendere in che modo funzionino l’economia, la società, la politica e quindi i motivi per i quali accadono determinati eventi, a prevedere che cosa avverrà nel futuro. Dall’altro, esso intende fornire una guida per l’azione politica, ossia indicare agli individui in quale modo sia opportuno e giusto comportarsi, quali siano i fini che devono essere perseguiti e con quali mezzi. Ad esempio: davanti all’avvento del fascismo, nell’Italia del 1922, chi aderisce all’ideologia comunista, da un lato, potrà interpretare l’evento come il prodotto politico di un sistema economico capitalistico vicino al collasso, e prevederne la non lontana crisi mortale (elemento descrittivo o giudizio di fatto); dall’altro saprà che deve opporsi recisamente al nuovo regime e affrettarne la fine (elemento prescrittivo, o giudizio di valore).
d) Infine, l’ideologia svolge un’importante funzione di legittimazione, ovvero dà agli attori politici, siano essi al potere o all’opposizione, la possibilità di giustificare il proprio operato facendo ricorso a una visione globale del mondo, a principi e concetti di portata ampia e generale.
P. 69-70
Bibliografia
Ideologie e teoria politica / M. Freeden. – Il mulino, 2000
Manuale di storia del pensiero politico / a cura di C. Galli. – Il mulino, 2011
Ideologia: per l’interpretazione di un operare sociale e la ricostruzione di un concetto / F. Rossi-Landi. – Meltemi, 2005
Cap. 5. La trasformazione della politica e le costituzioni
Elemento caratterizzante della disamina dell’evoluzione costituzionale all’interno dell’ordine politico occidentale tra la fine del 17. secolo e la fine del 20. è la centralità del “modello inglese”, dominato dal principio della balance of power, dal government by discussion e successivamente dall’introduzione del partito politico extraparlamentare. La modernità di tale modello e soprattutto la sua capacità di adattamento emergono nel confronto con le differenti esperienze europee (italiana, francese, tedesca, ma anche sovietica), in particolare nel momento in cui queste ultime mostrano tutta la loro incapacità di autodifesa di fronte al demone totalitario.
- I modelli originari: tra Francia e Inghilterra
Nel 19. Secolo il dibattito sui sistemi politici che si svolse tra uomini politici e intellettuali ruotò prevalentemente intorno al cosiddetto “modello inglese”. Con questa espressione veniva comunemente indicata la realtà politico-istituzionale della Gran Bretagna. Si trattava di un sistema che affondava le sue radici nel mondo medievale e che, perfezionatosi nel tempo, assicurava alla nazione che lo aveva plasmato stabilità e progresso: condizioni per la sua indiscussa egemonia sullo scenario mondiale.
A questo sistema politico la gran parte del liberalismo continentale guardava con ammirazione e favore. Nella convinzione che l’esportazione della formula che nell’isola aveva dato magnifici frutti avrebbe garantito, pure in mutate condizioni ambientali, crescita ed equilibrio.
Se le radici del sistema politico inglese possono rintracciarsi in epoche antichissime, la matrice della sua configurazione ottocentesca veniva comunemente indicata nella Gloriosa rivoluzione del 1688. Essa era interpretata dai suoi estimatori in contrapposizione con la Rivoluzione francese, che circa un secolo dopo, nel 1789, avrebbe infiammato la Francia. Mentre quest’ultima era vissuta e concepita come un momento di rottura radicale all’interno della storia politica francese, la Rivoluzione del 1688 era piuttosto letta come un momento di risanamento: il tentativo di chiudere la ferita che si era aperta negli anni Quaranta del 16. secolo con la “grande ribellione” di Oliver Cromwell e con il regicidio del 1649. Essa, dunque, giunse a negare la frattura tra Ancien Regime e mondo moderno, che si sarebbe invece affermata un secolo più tardi con la Rivoluzione francese. Tale implicita affermazione di continuità depotenziava all’origine il conflitto tra i fautori della rivoluzione e quelli della controrivoluzione.
La circostanza, in realtà, evidenziava un aspetto che contribuiva ad acuire le differenze tra l’isola e il continente: nella Rivoluzione inglese del 1688 la passione politica aveva svolto una funzione. Fra le cause principali della rivoluzione vi erano motivazioni religiose: il conflitto fra anglicani e cattolici. La sua rivoluzione aveva dato luogo ad un potere politico tollerante e rispettoso degli equilibri sociali. In altre parole, il potere pubblico rinunciava alla pretesa d’imporsi sulla società, e le divisioni politiche si fermavano in superficie non affondando nel corpo sociale della nazione.
La filosofia della storia, che si trovava alla base della Gloriosa rivoluzione, avrebbe ricevuto una sua traduzione anche in ambito politico-istituzionale. Essa si incarnava in una forma di stato monarchico-costituzionale che lasciava ampi spazi di autonomia e autodecisione alle comunità locali.
In origine il re era titolare del potere esecutivo, ma la prassi istituzionale portò sempre più la corona a rappresentare l’unità superiore della nazione e a proporsi come potere di controllo e di garanzia. Il potere legislativo era invece detenuto da due camere: quella elettiva (Camera dei Comuni) riuniva i rappresentanti delle diverse parti della nazione; quella ereditaria (Camera dei Lord) costituiva la principale espressione della parte nobile del sistema e aveva il ruolo di preservare le tradizioni immodificabili del costume nazionale. Le due anime erano animate da un bipartitismo tendenziale, in grado di garantire al meglio il collegamento tra il potere legislativo e l’esecutivo, nonché un forte ricambio alla guida del paese.
I due partiti “storici” erano il Whigh e il Tory e fino al 1870 essi mantennero una struttura eminentemente parlamentare, potendo contare nel paese solo su un embrione organizzativo.
Il primo ministro veniva scelto tra ranghi di una maggioranza parlamentare più o meno stabile e dopo al seconda grande riforma elettorale del 1867 a tale carica sarebbe assurto il leader del partito vittorioso alle elezioni. Il primo ministro avrebbe poi raccolto i membri più autorevoli della compagine del gabinetto, vero centro del potere esecutivo e garante della parte efficiente del sistema. Le riunioni di questo organismo ristretto erano segrete e la leggenda vuole che non di rado fossero burrascose. Il gabinetto, però, davanti al paese si sarebbe sempre presentato con le decisioni unanimi, condivise, e difese da tutti i suoi membri.
Il leader del partito soccombente diveniva il capo dell’opposizione e presiedeva il governo-ombra con il compito di contrastare le decisioni del governo effettivo, preparandosi così alla successione. Il governo aveva bisogno della fiducia della Camera dei Comuni. Ma il legame tra legislativo ed esecutivo era reso ancor più stretto dalla possibilità concessa al primo ministro di decretare lo scioglimento della Camera dei Comuni. Si creavano così le condizioni per un sistema di contrappesi che faceva dipendere l’esecutivo dal legislativo, attraverso la previsione del rapporto di fiducia, e il legislativo dall’esecutivo, in quanto quest’ultimo avrebbe potuto in ogni momento utilizzare il suo potere di sciogliere la camera elettiva. La moderazione del sistema si fondava su questo complesso equilibrio interno alla dinamica istituzionale. All’esterno, essa riceveva il contributo di un suffragio assai limitato che avrebbe allargato i suoi confini gradualmente, con grande riluttanza, respingendo il precetto illuministico per il quale ogni uomo doveva avere pari diritti. Infine, anche il sistema elettorale maggioritario a turno unico contribuiva a forgiare la peculiarità del “modello inglese”. Questo tipo di scrutinio metteva in luce le radici medievali e “corporative” del sistema politico inglese: originariamente il deputato non era il rappresentante di una corrente ideologica né della “volontà nazionale” bensì della comunità locale dalla quale veniva eletto. In questa maniera l’asprezza del conflitto politico veniva limitata e non arrivava mai a intaccare la trama unitaria della società civile.
Il “modello inglese” non fu estraneo alle dinamiche istituzionali attivate dagli eventi rivoluzionari che introdussero il 19. secolo. Fu l’esempio che più di ogni altro ispirò l’esperimento statunitense che prese avvio con la rivoluzione del 1776 e fu tenuto in gran conto nel dibattito istituzionale che seguì la Rivoluzione francese del 1789. In particolare, i national builders americani cercarono di adattare quel “miracolo della storia”, che erano state le istituzioni della Gran Bretagna a un paese privo di passato nazionale e che si trovava in una condizione geopolitica completamente diversa. Tale tentativo di empirico adattamento del “modello inglese” portò alla nascita di un sistema politico che esasperava la tendenza all’autogoverno delle istanze locali giungendo a prevedere una struttura statale federale.
Per quanto riguarda la forma di governo diede invece vita a un sistema presidenziale con un presidente della repubblica eletto a suffragio universale alla testa dell’esecutivo dallo Stato centrale e dunque un sostituto “laico” del re d’Inghilterra. Il suo potere sarebbe stato contrastato a livello diffuso dalle istituzioni dei diversi stati federati, oltre che, a livello centrale, dalla forza “concorrente2 del potere legislativo. In luogo del collegamento tra esecutivo e legislativo previsto dal sistema inglese, nel sistema americano i poteri si presentavano divisi a garanzia di un più efficace bilanciamento. Grande importanza era infine concessa ai cosiddetti organi di garanzia, primi tra tutti la Corse Suprema federale che si ergeva a guardiano del rispetto dei limiti imposti ai differenti poteri.
Nella Francia della Rivoluzione, invece, il tentativo di giungere all’edificazione di un sistema politico costruito sull’esempio che proveniva da oltre Manica uscì sconfitto. La Rivoluzione, però, non riuscì nel compito di edificare un sistema alternativo ugualmente solido. In ambito istituzionale il suo lascito fu una situazione di instabilità endemica. Nei primi cinquant’anni del secolo, nel tentativo di condurre in porto la rivoluzione, la Francia conobbe l’impero, la monarchia “restaurata”, alla monarchia costituzionale, la repubblica presidenziale: un vero e proprio catalogo dei regimi politici possibili. Questa grande incertezza permise agli anglofili francesi di presentare il “modello inglese” alla stregua di una grande occasione mancata.
Del resto, nel corso dell’Ottocento la ricezione del “modello inglese” – quanto meno nei suoi tratti più evidenti ed esteriori – caratterizzò la maggior parte delle monarchie europee, le quali diedero vita a regimi costituzionali e bicamerali. Seppure a diversi gradi d’approssimazione (e con differenze non secondarie riguardo alla natura e alla composizione della seconda camera), le istituzioni dell’isola ispirarono le monarchie belga, olandese, italiana, spagnola, portoghese. In Francia un ritorno al “modello inglese” si concretizzò attraverso la cosiddetta Monarchia di luglio, frutto della rivoluzione del 1830, dopo aver cacciato la famiglia “legittima” regnante dei Borbone, mise sul trono Luigi Filippo d’Orléans. In luogo della mitica stabilità inglese, però, i francesi conobbero un regime che progressivamente si piegava su sé stesso, assumendo un volto oligarchico e corrotto. Tale deriva causò nel 1848 l’esplosione di una nuova fiammata rivoluzionaria, che tornò a incendiare l’Europa e che in Francia, dal punto di vista istituzionale, portò alla nascita della Seconda Repubblica: un regime presidenziale che prevedeva l’elezione del presidente a suffragio universale. Anche questo esperimento, tuttavia, non fu coronato da successo. Nel dicembre del 1848 l’elezione di Luigi Napoleone Bonaparte a presidente della repubblica rappresentò il prodromo della fine della seconda repubblica. Tre anni più tardi, il 2 dicembre 1851, un colpo di Stato metteva fine alla Seconda repubblica e il successivo 21 dicembre un plebiscito ratificava la restaurazione dell’impero. Nel dibattito sui sistemi politici la svolta del 2 dicembre 1851 ha avuto, tra l’altro, due effetti: uno di lunga durata, l’altro più immediato. Nel lungo periodo consolidò la diffidenza nei riguardi dei sistemi che avrebbero previsto l’elezione del vertice dell’esecutivo da parte del popolo e, più generalmente, nei riguardi degli strumenti di democrazia diretta. La degenerazione plebiscitaria ha ostacolato le richieste di rafforzamento del potere esecutivo e, indirettamente, ha agevolato l’identificazione tra regime democratico e sistemi fondati sulla centralità del parlamento. Solo le vicende della Quinta Repubblica francese voluta nel 1958 dal generale Charles De Gaulle avrebbero, in parte, cancellato tali pregiudizi. Eppure, se si presta attenzione al dibattito istituzionale che seguì l’avvento di Napoleone 3., sarà facile notare che il giudizio dei contemporanei sul sistema politico del Secondo impero e le previsioni sulle sue possibili evoluzioni non erano affatto scontati. Basti pensare che Walter Bagehot – l’autore di La costituzione inglese, il libro destinato a divenire il classico per antonomasia sul “modello inglese” – nutrì una spiccata simpatia per Napoleone 3. e, soprattutto, era convinto che il sistema politico da lui edificato potesse approssimarsi al sistema di gabinetto vigente in Gran Bretagna assai più di quanto non era riuscita a fare la Monarchia di Luglio che, pure, si era richiamata esplicitamente all’esperienza d’oltre Manica. L’evoluzione in senso liberale dell’impero nella primavera del 1870 sembrò per un attimo confermare le sue previsioni. Quel che però è più importante notare è che, in quei frangenti, la propensione di Bagehot era il sintomo di un fenomeno più generale che il dibattito sui sistemi politici del tempo mise bene in evidenza: l’equilibrio e la dinamica dei poteri proposti dal “modello inglese” iniziavano ad autonomizzarsi dalla soluzione monarchica e si rendevano utilizzabili anche per esperienze istituzionali differenti. Se ne ebbe la prova effettiva in Francia, una volta caduto il Secondo impero a Sedan, nelle tribolate vicende che portarono alla nascita della Terza Repubblica. Quest’ultima fu una soluzione di compromesso tra monarchici e repubblicani. Alla ripresa della vita politica, dopo la sanguinosa parentesi della Comune, i primi potevano contare sulla maggioranza ma non avevano una concreta soluzione dinastica da proporre al paese. Ciò portò i secondi, più deboli dal punto di vista elettorale, a trovarsi in una posizione di indiscutibile vantaggio sul terreno della proposta politica. La crisi istituzionale venne così empiricamente risolta adattando a una soluzione repubblicana lo schema formale della monarchia costituzionale inglese. La maggioranza dei repubblicani accettò il conveniente compromesso che li obbligava a rinunciare al patrimonio assembleare, retaggio dell’eredità rivoluzionaria, in cambio della repubblica. I monarchici, dal canto loro, nutrivano la segreta speranza di poter un giorno sostituire alla testa dello Stato il presidente della repubblica con il re, senza stravolgere le istituzioni.
Il sistema politico del nuovo regime fu definito da una serie dileggi “fondamentali” approvate nel 1875. E qui può già scorgersi un evidente “cedimento” verso la tradizione anglosassone. Con questa scelta, infatti, la Francia rinunciava a darsi una “costituzione di programma” che prevedesse precise finalità. Si accontentava più empiricamente di una serie di leggi che avrebbero regolato il funzionamento delle principali istituzioni. Il sistema politico della Terza repubblica, così come la monarchia inglese, sarebbe stato bicamerale. Anche in questo caso l’azione della Camera bassa, eletta a suffragio universale diretto, avrebbe dovuto essere bilanciata dal ruolo di freno e conservazione svolto dalla camera alta. In luogo della Camera dei Lord, era infatti previsto un senato, la cui composizione sarebbe scaturita da elezioni di secondo grado. Nello spirito del compromesso istituzionale, questa istituzione avrebbe dovuto rappresentare la Francia profonda; la concretezza della provincia francese legata alla monarchia, naturalmente diffidente nei riguardi dell’innovazione e diga naturale verso gli “astrati” furori rivoluzionari della capitale. Come in Gran Bretagna, anche nella Francia della Terza repubblica esecutivo e legislativo erano uniti dal rapporto di fiducia. Inoltre, per prevenire possibili derive assemblearistiche era attribuito al presidente della repubblica di sciogliere la camera bassa, previo parere conforme del senato. Tale schema istituzionale si allontanava sensibilmente dalle speranze di quanti si sentivano eredi della tradizione della rivoluzione e avrebbero voluto una repubblica costruita sulla centralità assoluta del parlamento. Ma d’altro canto, esso si innestava su una premessa che non poteva dispiacere agli estimatori del 1789: la conferma del suffragio universale, che nell’immaginario collettivo assurgeva al ruolo di vera e propria “arca santa” del nuovo sistema.
P. 93-99
La nascita delle “macchine” politiche aveva portato a una revisione di costumi e strumenti consolidati, ma non aveva stravolto i postulati di fondo della teoria rappresentativa. Questi furono invece radicalmente negati dall’incontro tra il partito e la rivoluzione. Tale connubio aveva infatti lo scopo di affermare una precisa concezione ideologica e una specifica organizzazione statuale attraverso l’annientamento di tutte le posizioni contrastanti.
P. 105
Bibliografia
Le costituzioni anglosassoni e l’Europa / a cura di E. Capozzi. – Rubbettino, 2002
Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee / a cura di P. Grilli di Cortona e G. Pasquino. – Il mulino, 2007
Il potere, lo Stato, la libertà: la gracile costituzione della società libera / a. Panebianco. – Il mulino, 2004
L’Europa dei partiti: per una sociologia dei partiti politici nel processo di integrazione europea / L. Viviani. – Firenze University Press, 2009
Cap. 6. Religioni ed età contemporanea
Con l’incedere della modernità, le religioni dovettero far fronte a una serie di nuove sfide poste in essere da cambiamenti economici e politici che investirono le società occidentali dopo le rivoluzioni americana e francese. L’avvento dello Stato liberal, la diffusione dell’idea di tolleranza religiosa, di nuove forme di individualismo e gli straordinari risultati delle scoperte scientifiche, furono tra i fattori più rilevanti che incisero sulla formazione della società moderna. Cristianesimi, ebraismo, islam e induismo cercarono di reagire a queste sfide in diversi modi. Le risposte che elaborarono nel corso dell’Ottocento permettono di comprendere molti fenomeni attuali che riflettono tensioni tra società moderna e sfera del religioso.
In questi ultimi decenni la religione sembra aver recuperato un rinnovato ruolo pubblico e per svariati motivi è tornata al centro del dibattito mediatico. A catturare l’attenzione degli osservatori politici e dei commentatori, ovviamente, sono fatti legati alle vicende dell’islam politico e in particolare del fondamentalismo religioso. Più in generale, la religione sembra ricoprire un ruolo molto rilevante anche in altri contesti culturali, intercettando questioni politiche di natura diversa, come ad esempio il nazionalismo etnico. Negli Stati Uniti, così come in alcuni paesi europei, i rappresentanti ufficiali delle religioni organizzate prendono parola per indirizzare le scelte dei governi e dei cittadini su temi molto importanti come aborto, fecondazione artificiale, diritti civili, fino a incidere sul rapporto tra scienza e fede, questione quest’ultima che sembrava del tutto superata, almeno nel mondo occidentale.
Molti osservatori si sono posti quindi nuove domande relative a quel processo di secolarizzazione che sembrava essere destinato ad affermarsi con la diffusione della modernità. Che cos’è accaduto in questi ultimi decenni? Quali sono le caratteristiche specifiche della secolarizzazione? Che ruolo ha la religione nella società contemporanea? Quale è stato il suo ruolo storico a partire dalla Rivoluzione francese? Si può ora parlare di ritorno del religioso o il religioso non è mai scomparso dall’orizzonte del contemporaneo?
Per rispondere ad alcune di queste domande è necessario definire alcune questioni preliminari. L’età contemporanea si apre con due rivoluzioni, quella americana e quella francese. Entrambe contribuirono a definire i caratteri di un nuovo assetto politico, lo stato liberale, in cui il ruolo della chiesa e delle chiese nella sfera pubblica subiva un netto ridimensionamento. È su questo snodo centrale che si inserisce il dibattito circa il rapporto tra religioni e secolarizzazione. Con quest’ultimo termine si indica un processo di svuotamento e ridimensionamento della sfera religiosa a vantaggio di quella profana (o secolare, utilizzando un termine che deriva dal latino e indica lo spazio di azione esterno agli interessi della chiesa). La secolarizzazione descriverebbe quindi quel processo culturale, connesso alla diffusione della modernità, in cui il ruolo delle chiese istituzionali viene lentamente eroso all’interno delle istituzioni pubbliche sia nella società. Il ridimensionamento delle religioni istituzionali permette di costruire un ideale spazio neutro a cui hanno idealmente accesso tutti i membri della collettività, indistintamente dalla loro fede religiosa.
I due modelli politici, quello francese e quello statunitense, danno vita però a forme molto diverse di secolarizzazione e a rapporti quasi opposti fra religioso e non religioso. Nel caso del modello francese è possibile parlare di una separazione tra stato e chiesa tendente a proteggere lo stato dall’ingerenza del sistema religioso. Nel caso del modello statunitense, invece, si può affermare l’opposto, che il principio di separazione tra stato e chiesa serve a proteggere le comunità religiose (sempre al plurale) dall’ingerenza dello stato.
1) Una definizione di modernità
Per comprendere la storia delle religioni in età contemporanea occorre prima di tutto far luce su alcune questioni preliminari e presentare alcune definizioni atte ad indirizzare la lettura di queste problematiche. Innanzitutto possiamo cercare di circoscrivere la nozione di modernità, un termine centrale nella riflessione storiografica ed epistemologica, ma sempre più sottoposto a critica in questi ultimi decenni di 2post-modernità” o “sur-modernità”.
La modernità può essere definita in termini politici, filosofici, economici, sociali, religiosi e culturali. Per semplificare possiamo cercare di abbozzare una sorta di modello ideale per capire che cosa si intenda quando utilizziamo questo termine, che ci possa inoltre guidare nella lettura dei fenomeni religiosi in età contemporanea.
1. Da una prospettiva economica, la modernità è l’esito di un processo connesso alla nascita e alla diffusione del capitalismo industriale, che, a sua volta, ha inciso sui processi di inurbamento mutando radicalmente il paesaggio tradizionale. Grandi flussi migratori dai villaggi verso la città, dalle zone dell’Europa orientale o mediterranea verso le metropoli dei paesi industrializzati, caratterizzarono la storia europea nel corso dell’Ottocento, così come quella di altri continenti nel secolo successivo. Questi massicci flussi migratori cambiarono radicalmente il tessuto culturale delle città europee e americane, contribuendo in modo determinante alla nascita di società multireligiose. Ma, soprattutto, questo processo contribuì ad affievolire i sistemi religiosi tradizionali.
2. Un ruolo centrale assunse nel corso dell’Ottocento la scienza moderna, i cui risultati si posero, talvolta, in netta contrapposizione con la verità e le certezze di molte tradizioni religiose. A questo livello le ortodossie religiose furono chiamate a un confronto che spesso si trasformò in uno scontro. Il risultato di tale incontro produsse, in certi contesti, una radicalizzazione dei comportamenti culturali, rafforzando le posizioni di difesa religiose o quelle antireligiose.
3. La modernità è caratterizzata inoltre dalla diffusione di una nuova forma politica, lo stato liberale, il quale si fonda su una nuova concezione di cittadinanza e sull’applicazione del principio di separazione tra stato e chiesa. All’interno di questo contesto, si diffonde la teoria della tolleranza religiosa, che assume, a partire dalla riflessione ottocentesca, una rilevanza e centralità inedite.
4. Corollario di questi diversi aspetti fu l’intensificarsi della moderna concezione dell’individuo e della sua autonomia, che aumentò il senso della libertà di coscienza, in una prospettiva sia esistenziale sia religiosa. Questa condizione fu bilanciata, nel corso del 20. secolo, dalla centralità assunta dai movimenti politici di massa e da una rinnovata rilevanza assunta dalla dimensione collettiva.
I processi che produssero questi cambiamenti ebbero origine a partire dalla prima età moderna, in particolar modo nel corso del Seicento. E’ in questo secolo che si manifestarono i primi conflitti tra libertà religiosa e di coscienza, tra scienza e fede. Questi problemi però trovarono una loro più ampia diffusione nel corso dell’Ottocento, per riproporsi, con modalità e sfumature diverse, anche nel corso del Novecento.
Per comprendere quindi il ruolo delle religioni in età contemporanea occorre tenere ben presente questi punti che definiscono alcuni aspetti centrali della modernità. Ogni sistema religioso rispose in tempi e modi diversi alle sfide poste in essere dall’avvento della modernità, che fosse politica, filosofica, economica, sociale o culturale. I tipi di reazioni furono ovviamente definiti anche dal ruolo della tradizione religiosa e dalle decisioni che i rappresentanti dei sistemi religiosi posero in essere. Molto spesso, le leadership religiose non furono coerenti e si divisero al loro interno, dando vita a fratture che percorsero, e percorrono tutt’oggi, il sistema religioso nel suo complesso.
P. 115-17
A titolo indicativo si può fin da subito affermare che i sistemi religiosi ebbero tre tipi differenziati di reazione rispetto all’avvento della modernità: a) reazione positiva che cercò fin da subito di conciliare tutte le scoperte e le richieste della società moderna con la tradizione religiosa; b) una seconda reazione che invece rifiutò nettamente molti degli aspetti della modernità e che si pose quindi in una posizione di netta opposizione, antagonista rispetto alla modernità; c) infine una terza, meno nota, opzione, che mostrò un netto disinteresse nei confronti della modernità, continuando al vivere al di fuori di essa, come se nulla fosse cambiato.
Occorre sin da subito sottolineare che queste reazioni non si presentano in forma distinta, ma possono essere diversificate in relazione alle questioni di volta in volta presentate. Inoltre, anche le posizioni più intransigenti dovettero, ad un certo punto, trovare una forma di compromesso con le esigenze provenienti dalla società moderna.
P. 119
- Conclusioni
Come abbiamo cercato di mostrare, i sistemi religiosi hanno reagito in modi diversi alle sfide che la modernità ha posto loro a partire dall’età contemporanea.
Nel corso del 20. secolo le religioni hanno mostrato una straordinaria vitalità anche in società decisamente secolarizzate o post-secolari, dove accanto alle tradizioni consolidate sono apparse nuove forme del sacro. Le religioni hanno costituito una fonte straordinaria per i movimenti di liberazione o di resistenza a regimi oppressivi (come nel caso della Polonia) o a drammatiche pratiche di ingiustizia (come nel caso di Martin Luther King). Anche la Chiesa cattolica, con il Concilio Vaticano 2., abbracciò, negli anni Sessanta del 20. secolo, una visione positiva nei confronti della cultura moderna e dei suoi principi liberali e democratici.
Se, da un lato, è possibile osservare come le tradizioni più vicine al centro di irradiazione della cultura moderna abbiamo reagito in modo più dinamico e positivo – come nel caso delle tradizioni di matrice protestante - sono altresì riscontrabili orientamenti che vi si oppongono. Tra questi il fondamentalismo evangelico, che riappare sulla scena politica a partire dalla fine degli anni Settanta del 20. secolo, per assurgere a movimento relativamente visibile nel contesto culturale attuale. I fondamentalismi religiosi apparsi sulla scena internazionale in questi ultimi decenni si sono manifestati in tutte le tradizioni religiose, dall’islam all’ebraismo, dall’induismo al protestantesimo, fino ad alcune correnti del cattolicesimo. La loro genesi è riscontrabile e comprensibile entro il quadro storico che abbiamo cercato di descrivere, come una forma o reazione religiosa alla cultura moderna, che si esprime nel rifiuto di alcuni suoi principi e spesso si combina con le istanze del nazionalismo politico.
Bibliografia
Religioni forti: l’avanzata dei fondamentalismi sulla scena mondiale / G. A. Almond … et al. – Il mulino, 2006
Le religioni e il mondo moderno / a cura di G. Filoramo. – Einaudi, 2008
L’Islam oggi / W. Ende … et al. – Edb, 1991
Induismo / G. Flood. – Einaudi, 2000
Storia del cristianesimo / G. L. Potesta, G. Vian. – Il mulino, 2012
Cristiani e musulmani / W. M. Watt. – Il mulino, 1994
Breve storia dell’Islam / W. M. Watt. – Il mulino, 2001
Cap. 7. Le relazioni internazionali / di Guido Formigoni
Il sistema internazionale contemporaneo è nato da quello tradizionale europeo sorto in età moderna. Dopo lo sconvolgimento delle guerre rivoluzionarie e napoleoniche prese corpo il modello del cosiddetto “concerto europeo”, imperniato su una stabilità negoziata, rotto poi dalla dinamica sempre più unilaterale dei comportamenti delle grandi potenze, che portò alla Prima guerra mondiale. Seguì una stabilizzazione fondata sulal spontaneità del mercato, crollata però con la crisi del ’29. Le conseguenti competizioni imperiali spiazzarono definitivamente la centralità europea: il mondo venne a essere governato da un meccanismo bipolare (Stati Uniti e Unione Sovietica). Durante la Guerra Fredda il blocco occidentale conobbe la coesistenza di regolazioni statali forti e di una progressiva integrazione economica.
- La “società internazionale” europea e le grandi potenze
Le grandi rivoluzioni economiche, ideologiche e politiche che contrassegnarono l’ingresso nella contemporaneità non ebbero un’evidente manifestazione parallela nelle relazioni internazionali. Il mondo internazionale dell’Ottocento era frutto di una precedente evoluzione lenta e plurisecolare. L’Europa era sicuramente il suo centro, per la posizione globale ormai dominante del suo sistema economico e militare (non sempre era stato così nei secoli precedenti) e poteva quindi esportare le sue regole a livello globale. Si era sedimentato nei secoli sul continente europeo un “sistema” di rapporti tra entità politiche diverse, che si concepivano come “sovrane”: gli stati moderni, nati dalla dissoluzione di quell’universo medievale concepito come fortemente unitario e ani tendenzialmente universale (ancorché pluralistico e frammentato al suo interno), nella duplice ma interconnessa matrice di un impero sacrale e di una chiesa cristiana diffusa su tutto il continente.
La nascita degli stati moderni implicava la decisione di un principe di assumere la propria autonomia dall’impero e dal papato (superiorem non recognoscens) e al tempo stesso la volontà di centralizzare l’autorità in un ben definito territorio (rex in regno suo et imperator). Questo processo era ormai molto avanzato alla metà del Seicento. E’ decisivo notare come questo sistema contemplasse contemporaneamente logiche particolaristiche e tendenze universalistiche. Da una parte infatti la “ragion di stato” portava ogni principe a voler mantenere, tutelare e rafforzare il proprio dominio politico come primo obiettivo. D’altra parte, continuava a operare la visione pregnante di una sorta di “comunità” tra gli stati: Edmund Burke parlava alla fine del Settecento di una £repubblica diplomatica d’Europa”. Proprio l’affermazione della sovranità aveva infatti come risvolto necessario il riconoscimento reciproco degli stati in un rapporto teoricamente paritario. Da qui si sviluppò un insieme di regole di relazione (il diritto internazionale), di mezzi di comunicazione e scambio (la diplomazia), che configurò lentamente una vera e propria “società internazionale” di stati d’Europa.
Certo, nella misura in cui questa rete di rapporti non fosse bastata a soddisfare le esigenze di un sovrano, il ricorso allo strumento militare era frequentissimo. Lo ius belli (il diritto di fare guerra) era del resto parallelo alla capacità degli stati di imporre l’ordine e la sicurezza all’interno del proprio territorio. I monarchi europei, che concepivano lo stato come proprietà personale (patrimonialismo), cercarono anche di organizzare le economie al servizio della sua potenza. La concezione mercantilistica esprimeva questa visione, anche se una rete di iniziative imprenditoriali e commerciali indipendenti aveva posto le basi della ricchezza e della capacità tecnologica europee. Le diversità strutturali tra gli stati diventarono quindi un elemento importantissimo per comprendere il funzionamento del “sistema”. All’inizio dell’Ottocento venne formalizzato il concetto di “grande potenza”: cioè gli stati territorialmente estesi, con interessi generali e capacità di gestione del “sistema” complessivo delle relazioni europee. Questi stati erano a quel punto cinque (Inghilterra, Franci, Impero asburgico, Russia e Prussia). Altre grandi monarchie erano ormai in decadenza (prime fra tutte la Spagna o la meteora Svezia), mentre declinarono anche le repubbliche marinare come Venezia oi Paesi Bassi. Tra questi attori maggiori, il gioco della ricerca di “egemonia” si era intrecciato con la visione di un “equilibrio” pluralistico (“balance of power”), codificata già con il trattato di Utrecht de 1713. La visione meccanicistica dell’equilibrio era in realtà solo teorica: se contro i tentativi egemonici fossero nati spesso alleanze contrapposte, tale regola non avrebbe avuto alcuna efficacia quando una grande potenza si rapportava ai soggetti minori del sistema: la spartizione dello stato polacco tra Russia, Austria e Prussia nei decenni finali del Settecento fu solo il caso più eclatante in questo senso.
Il sistema europeo era da secoli in rapporto (non sempre pacifico) con altri sistemi di entità politiche confinanti o lontani: dalla catena dei potentati islamici che si estendeva dal Maghreb all’Indonesia e dal Caucaso all’Africa nera, in cui era centrale l’Impero ottomano, fino al lontano sistema imperiale cinese. Dal 1500 in poi, le potenze europee avevano cominciato ad espandere lentamente la propria influenza mondiale, ma alle soglie della contemporaneità non si poteva ancora parlare di un controllo esteso. Una rete di rapporti commerciali – di dimensioni quantitative ridotte ma di valore crescente – allargava e sosteneva il quadro dell’influsso europeo in una caratteristica competizione tra i diversi nuclei del pluralistico sistema di stati.
P. 131-32
Bibliografia
La nascita del mondo moderno, 1780-1914 / C. A. Bayly. – Einaudi, 2007
La guerra ineguale: pace e violenza nel tramonto della società internazionale / A. Colombo. – Il mulino, 2006
Dagli imperi militari agli imperi tecnologici: la politica internazionale del 20. secolo / E. Di Nolfo. – Laterza, 2007
Storia della politica internazionale in età contemporanea / G. Formigoni. – Il mulino, 2006
Ascesa e declino delle grandi potenze / P. Kennedy. – Garzanti, 1989
Storia della guerra fredda: l’ultimo conflitto per l’Europa / F. Romero. – Einaudi, 2009
Cap. 8. I movimenti delle donne in Europa e negli Stati Uniti d’America
I movimenti attraverso i quali le donne hanno conquistato i diritti di cittadinanza – diritti politici, sociali e civili – e hanno affermato la loro soggettività sul piano della sfera pubblica, come pure quella privata e familiare, avevano preso avvio già All'epoca delle grandi rivoluzioni e sono giunti a conclusione nel 20º secolo, per dare vita a nuove forme di partecipazione politica femminile. Si è trattato di un processo lungo e conflittuale che ha investito tutti i settori della vita politica, economica e sociale e che ha conosciuto fasi differenti a seconda dei diversi paesi e delle diverse situazioni giuridiche e politiche, e che è tutt’altro che concluso. Il cammino compiuto dai movimenti delle donne è dunque particolarmente degno di nota in quanto ha segnato, in maniera critica, la costruzione della modernità politica occidentale sia in Europa sia negli Stati Uniti.
Il Novecento è stato spesso definito il “secolo delle donne”. Nel 20. secolo , infatti, sono giunti – nel contesto europeo e statunitense a cui qui ci riferiamo in modo specifico – a una prima conclusione quei processi, avviati già all’epoca delle grandi rivoluzioni della fine del Settecento (quella americana del 1776 e quella francese del 1789), attraverso i quali le donne (con i movimenti suffragisti e femministi in primo luogo) hanno conquistato i diritti di cittadinanza – diritti politici, sociali e civili – e hanno affermato la loro soggettività sul piano della sfera pubblica come pure di quella privata e familiare; vale a dire si sono costituite come individui autonomi, titolari di diritti propri e non, come tradizionalmente erano state considerate, soggetti il cui ruolo e la cui identità si definivano in funzione di qualcuno (figlie, mogli, madri).
Le ragioni del ruolo subordinato della donna nella sfera politica devono essere rintracciate in quella divisione, che si trovava già nel pensiero greco classico, fra la “casa”, la famiglia e la vita privata, e l’agorà, la sfera pubblica. Aristotele distingueva l’oikos, la casa, ciò che doveva rimanere nascosto, e la polis, la politica, ciò che doveva essere visibile a tutti. Oltre alla differenziazione tra una sfera pubblica e una privata, che con accenti diversi si è tramandata fino ad oggi, al pensiero classico va fatta risalire un’altra distinzione altrettanto importante per comprendere la specificità della subalternità delle donne: quella fra il logos, la ragione e il corpo. Secondo i filosofi greci, il cui pensiero fu ripreso in questo senso anche dai teorici contrattualisti e liberali, le donne, a causa della differenza biologica e delle loro funzioni riproduttive, svolgevano un ruolo separato e opposto a quello dell’uomo. La donna, cioè, in virtù della sua “natura” non era in grado di trascendere il proprio corpo e le passioni, di sviluppare un ordine morale razionale e quindi di costituirsi come soggetto autonomo nella polis. Il suo ruolo non poteva che essere legato alla sfera affettiva, familiare, alla procreazione e alla cura dei figli e della casa. Questa idea di una separazione fra il corpo (la donna) e la ragione (l’uomo) fu alla base della divisione tra una sfera pubblica – razionale (quindi maschile) – e una sfera privata – affettiva (femminile) – che nell’Ottocento definì il contesto politico e culturale europeo-occidentale e statunitense. La teoria delle “sfere separate”, come questa distinzione fu allora definita, se significava l’esclusione della donna dalla sfera politica, nell’ambito della sfera privata invece poteva far intravvedere spazi imprevisti per l’azione delle donne. Soprattutto in area angloamericana, proprio in virtù della sua specificità biologica e della sua funzione riproduttiva ed educativa, si riconosceva alla donna uno status morale superiore a quello dell’uomo, necessario per crescere ed educare i futuri cittadini della nazione.
Se l’esclusione dalla politica non si coniugava logicamente alla completa subordinazione, era questa però la condizione della donna che si poteva osservare nella sfera privata e familiare. Le donne erano soggette all’autorità del padre o del marito e, come si vedrà in seguito, la loro condizione giuridica era assimilabile a quella dei bambini e degli idioti, come fecero osservare le prime suffragiste. Secondo le teorie più recenti, questa minorità era conseguenza di una struttura fondata sul potere patriarcale (il potere dei padri sui figli, ma anche del marito sulla moglie) che sopravvisse anche quando i contrattualisti prima e i teorici della democrazia liberale poi elaborarono un modello politico basato sul contratto e sulla relazione fra individui liberi e autonomi. Ma in questa definizione di individui liberi e autonomi non furono ricomprese le donne, considerate parte integrante della sfera privata e quindi separata da quella pubblica, fondata sui principi di uguaglianza, di libertà, di diritti o di cittadinanza.
Questa contraddizione ha segnato il percorso politico dei moderni stati occidentali ed è stata, altresì, la scintilla che nel corso dell’Ottocento e del Novecento ha provocato la formazione dei primi movimenti suffragisti e femministi per il riconoscimento e la rivendicazione dei diritti di cittadinanza. Si è trattato di un processo lungo e conflittuale che ha investito tutti i settori della vita politica, economica e sociale e che ha avuto fasi e tappe differenti a seconda dei diversi paesi e delle diverse tradizioni giuridiche e politiche. Ad esempio, il diritto di voto è stato a volte preceduto dalla conquista di alcuni diritti sociali e civili: altre volte l’acquisizione della cittadinanza politica non ha significato il riconoscimento di una piena e autonoma uguaglianza giuridica e sociale.
Fin dall’inizio i movimenti delle donne si sono mossi, inoltre, su un duplice piano: da un lato la rivendicazione dell’uguaglianza e del riconoscimento dei diritti universali che sono il fondamento della modernità politica e delle democrazie liberali; dall’altro la rivendicazione e la difesa di una specificità femminile, di una differenza. Vale a dire la richiesta di accesso ai diritti universali in quanto individui, ma soprattutto in quanto donne. Tale duplicità ha caratterizzato tutto il percorso del movimento suffragista e femminista e ha costituito però anche il segno più evidente della possibilità, proclamata dalle donne, di rivendicare l’acquisizione si adi un’identità individuale (che alle donne era sempre stata negata) si adi un’identità collettiva sulla base id un’affermazione della differenza femminile vista come valore positivo invece che come espressione di inferiorità.
Bibliografia
Il femminismo degli anni Settanta / a cura di T. Bertilotti e A. Scattigno. – Viella, 2005
Una democrazia incompiuta: donne e politica in Italia dall’Ottocento ai nostri giorni / N. M. Filippini e A. Scattigno. – Angeli, 2007
Storia e cultura politica delle donne / E. Guerra. – Archetipolibri, 2008
Femminismo senza frontiere: teoria, differenze, conflitti / C. T. Mohanty. – Ombre corte, 2012
Diritti delle donne e multiculturalismo / S. Moller Okin. – Cortina
Cap. 9. Mass media e politica: dal telegrafo a internet
A partire dalla fine dell’Ottocento l’estensione della Rivoluzione industriale al campo delle comunicazioni ha decretato l’inizio dell’”età dell’oro” della stampa, primo mezzo di comunicazione di massa dell’età contemporanea. La Grande guerra ha visto l’emergere della radio. Con gli anni Cinquanta e l’avvento dell’”era televisiva” i mass media hanno acquisito una crescente centralità, modificando logiche e linguaggi della comunicazione e contribuendo all’affermazione di una legittimità “mediatica” senza tuttavia impedire che si registrasse una progressiva presa di distanza dell’opinione pubblica rispetto alla politica. Il recente sviluppo di internet, pur caratterizzato da una progressiva democratizzazione del dibattito pubblico, non sembra in grado di arginare il discredito crescente della politica che si registra nelle democrazie occidentali e pare piuttosto favorire l’emergere di una contro-sfera pubblica”.
Quando si riflette sul ruolo e sull’impatto politico dei mass media i ricordi affollano la mente, carichi di significato. E’ difficile, in effetti, evocare qualche avvenimento della nostra epoca spogliandolo della dimensione radiofonica, di quella televisiva o, da ultimo, delle immagini acquisite attraverso internet. Hitler e Mussolini senza il suono delle loro urla isteriche trasmesse attraverso le onde dell’etere sono quasi inconcepibili. Lo studente di piazza Tian’an men che affronta coraggiosamente il carro armato o i giovani “a cavalcioni” sul muro di Berlino dopo che ne era stata disposta la demolizione, sono ormai nella memoria collettiva grazie alle immagini televisive. Allo stesso modo gran parte delle immagini degli attentati dell’11 settembre 2001 è stata resa disponibile grazie a filmati amatoriali trasmessi attraverso la rete.
P. 177
Il contratto fiduciario tra produttore e acquirente non si fonda più sul concetto di verità ma su quello di plausibilità, dalla realtà si slitta lentamente verso l’opinione e il discorso diventa inevitabilmente persuasivo.
P. 179
Bibliografia
Storia sociale dei media / A. Briggs e P. Burke. – Il mulino, 2010
Media e società nel mondo contemporaneo / L. gorman e D. McLean. – Il mulino, 2011
Storia dei media / J.-N. Jeanneney. – Ed. Riuniti, 2003
Obama.net: new media, new politics? Politica e comunciazione al tempo del networking / a cura di M. Mezza. – Morlacchi, 2009
Il secolo dei media: riti, abitudini, metodologie / P. Ortoleva. – Il Saggiatore, 2009
La comunicazione politica negli Usa / C. Vaccari. – Carocci, 2007
La politica online: internet, partiti e cittadini nelle democrazie occidentali / C. Vaccari. – Il mulino, 2012
Twitter factor: come i nuovi media cambiano la politica internazionale / A. Valeriani. – Laterza, 2011
Cap. 10. Ambiente, società e politica
Il problema di un corretto rapporto tra uomo e ambiente accompagna l'intera storia dell'umanità, ma è diventato centrale dopò la rivoluzione industriale quando l'uomo ha aumentato in misura significativa la capacità di modificare il proprio habitat. Negli ultimi decenni la politica si è misurata con le sfide poste da partiti, movimenti ambientalisti e opinione pubblica in tema di ambiente, inquinamento e impoverimento delle risorse. Il rapporto del Mit sui limiti dello sviluppo ha rappresentato un punto di svolta nel dibattito sulla natura della crescita economica.
Nel film di fantascienza Soylent Green (1973) , in una terra sovrappopolata e priva di risorse, la popolazione è costretta a nutrirsi con sostanze prodotte dai cadaveri. In quel periodo anche Hollywood risentiva della tendenza a interrogarsi sul futuro della specie umana, a fronte di un uso delle risorse per lo sviluppo considerato già allora da alcuni indiscriminato. L'uscita del film seguiva di un anno la pubblicazione del rapporto del Mit (Massachusetts institute of Technology) sui limiti dello sviluppo (1972), di cui parleremo più avanti. Se gli anni '60 sono stato il punto più alto della fiducia per le possibilità dischiuse dal progresso, di cui la conquista della luna appariva l'emblema, già in quel periodo e ancor più nel decennio successivo cominciò a farsi strada nell’opinione pubblica la presa di coscienza dei problemi connessi alla crescita economica. Lo choc petrolifero del 1973 sembrò confermare le previsioni negative mettendo in luce lo stretto legame che intercorreva fra disponibilità di risorse energetiche e benessere. La ricezione di questi temi nella letteratura e poi nel sistema hollywoodiano era dunque il punto di arrivo di studi e riflessioni che si erano manifestate già durante gli anni '60. Se già nel 1962 il libro di Rachell Carson, Primavera silenziosa, aveva richiamato l'attenzione sui rischi dell’abuso di pesticidi in agricoltura (in particolare del ddt, nel 1968 il libro di Paul Ehrlich, The population bomb (la bomba demografica, aveva ammonito sui rischi della espansione demografica. Negli anni '70, Barry Commoner con il testo Il cerchio da chiudere diede una svolta alla riflessione ecologista. La letteratura critica sullo sviluppo non si limitava a mettere in discussione la possibilità di aumentare le risorse in corrispondenza dell’aumento demografico, riprendendo in parte le t. esi di Thomas Robert Malthus, ma sollevava anche il problema di un corretto rapporto fra uomo e ambiente e poneva l'accento sulla necessità di garantire un equilibrio tra uso e reintegro di risorse. Il già citato rapporto del mit del 1972, con le scioccanti conclusioni sull’impossibilità di garantire indefinitamente uno sviluppo economico autosostenuto, trovava dunque un terreno già fertile. Nella premessa firmata dai membri del club di Roma si sintetizzava il rapporto con la convinzione che “l'umanità non può continuare a proliferare a ritmo accelerato, considerando lo sviluppo materiale come scopo principale, senza scontrarsi con i limiti naturali del progresso” (I limiti dello sviluppo, 1972). Nel 1973 la riduzione delle forniture petrolifere da parte dei paesi dell'opec costrinse i paesi occidentali a introdurre restrizioni ai consumi energetici. In Italia fu persino vietata la circolazione delle auto la domenica, toccando così uno dei feticci e lo sviluppo dei consumi italiano. Negli anni che seguirono quella stagione di studi e indubbio che la sensibilità per i temi ambientali sì è andata crescendo nell’opinione pubblica dei paesi economicamente più sviluppati e sia diventata un tema imprescindibile di ogni agenda politica. In tempi recenti, anche nei paesi economicamente emergenti in rapido sviluppo la questione ambientale ha cominciato a farsi strada, anche se spesso mi sono resistenze da parte di chi vede in essa uno strumento attraverso il quale le classi politiche dei paesi di più antica industrializzazione cercano di frenare l'espansione economica dei nuovi arrivati. Il termine ecologia, parola coniata dal biologo tedesco Ernst Haeckel Nel 1886 e utilizzata per indicare la branca della scienza che studia l'interazione tra esseri viventi e ambiente, e diventato un termine familiare presso l'opinione pubblica e uno dei temi più trattati nelle scuole.
La riflessione sulle conseguenze della crescita economica ha influenzato anche la storiografia generando un settore di studi specifici denominato environment history. Le radici di questo filone di ricerca storica sono molteplici e legate a tradizioni culturali preesistenti. Negli Stati Uniti, gli studi di storia ambientale sono, in parte, alimentati alla cultura della frontiera sei bella wilderness contrapposta alla civilizzazione, in cui l'opera storiografica di Turner e le opere di Sora Thoreau sono antesignane nei rispettivi campi. In Germania, la sensibilità per l'ambiente affonda le sue radici nella stessa tradizione culturale del paese e nella reazione a appuntamento del paesaggio provocata dall' industrializzazione che diede vita , tra le altre cose, nel 1907, al movimento per la protezione dell'ambiente e del paesaggio. In Italia, l'interesse per il paesaggio e i monumenti portò, soprattutto a cavallo tra 8 e 900, alla costituzione di associazioni che si preoccupavano della tela di questi aspetti in vari modi, in alcuni casi assumendo la come fine statutario principale o all’interno di finalità di tipo escursionistico. In questa direzione si muovevano il Club alpino italiano (1863), il Touring Club (1894), La Pro montibus et silvis (1898) che l'associazione per i paesaggi e momenti italici (1906). la storia dell'ambiente ha le sue radici principalmente negli studi di storia dell’agricoltura , in particolare nelle opere di Piero Bevilacqua e Diego Moreno, e si è poi arricchita dell'incontro con le suggestioni provenienti dalla tradizione anglosassone. Prima di tutto, interesse per l'ambiente come tema di ricerca storica è spesso nato in concomitanza con lo sviluppo di movimenti ambientalisti e ne ha recepito sensibilità e istanze. Pertanto, spesso tali studi tendono a leggere la questione ambientale all’interno di una critica al capitalismo e/o al modello di sviluppo basato sull'industria. In secondo luogo, nelle fasi iniziali, nella environment history ha talvolta prevalso un approccio molto critico nei confronti dell’intervento umano e che contrapponeva la natura, intesa come fattore positivo, all'uomo, percepito come elemento di alterazione del processo naturale. Negli ultimi anni si sono diffuse sempre più concezioni diverse che hanno analizzato l'evoluzione naturale mettendola in relazione allo sviluppo antropico, sviluppo che veniva ora considerato parte del processo di evoluzione in veste di elemento co evolutivo (Armiero e Barca). Con l'approfondimento degli studi, la storia ambientale ha quindi sviluppato filoni diversi di specializzazione: alcuni riporti a indagare le cause dei processi di trasformazione ecologica, altri indirizzati ad approfondire le cause di carattere sociale (Neri Serneri). In questo capitolo non ricostruiremo, però, i complessi percorsi della storia ambientale, né analizzeremo il problema ecologico in tutti i suoi molteplici aspetti, ma cercheremo di focalizzare alcuni snodi del rapporto tra ambiente e società che sono necessari per la comprensione della vicenda storica contemporanea, tenendo conto sia delle acquisizioni della storia dell'ambiente sia della dimensione globale oggi indispensabile per l'analisi storica.
Bibliografia
Storia dell’ambiente / M. Armiero e S.Barca. – Carocci, 2008
La Terra è finita: breve storia del’ambiente / P. Bevilacqua. – Laterza, 2006
Primavera silenziosa / R. Carson. – Feltrinelli, 1999
Il cerchio da chiudere / B.Commoner. – Garzanti, 1987
I limiti dello sviluppo / D. H. Meadows. – Mondadori, 1972
Incorporare la natura: storie ambientali del Novecento / S. Neri Serneri. – Carocci, 2005
Breve storia dell’ambiente nel Novecento / F. Paolini. – Carocci, 2009
La società a somma zero / L. Thurow. – Il mulino, 1980
Cap. 11. L’emergere dell’Asia nella storia contemporanea / di Antonio Fiori
Alla conclusione della seconda guerra mondiale L'Asia che era poco più di una mera espressione geografica. Oggi, al contrario, guardiamo il continente asiatico come a una delle regioni più vibranti ed energiche del mondo, completamente trasformata dalla condizione di povertà e frammentazione in cui versava. La trasformazione e stato il prodotto di due fattori chiave che hanno dominato le relazioni internazionali dell'asia dal 1945: da una parte la competizione tra l'unione sovietica e gli Stati Uniti, volta a porre sotto il rispettivo ombrello i singoli stati all’interno della regione; dall'altra la lotta condotta da leader nazionalisti per lo sviluppo del sostegno necessario al mantenimento del potere e dell'indipendenza in un contesto internazionale estremamente instabile.
La Seconda guerra mondiale, da una prospettiva generale, costituì un fondamentale punto di svolta che modifica ho profondamente la struttura delle relazioni internazionali rispetto al periodo precedente. Nel contesto della guerra fredda, l'area divenne una delle arene principali di scontro tra le due superpotenze e su di essa ebbe un notevole impatto, sagomando le relazioni tra gli Stati asiatici e le interazioni tra questi e il resto del mondo.
Da una prospettiva regionale, la Seconda guerra mondiale impose un ri posizionamento dei paesi asiatici nell’ordine internazionale. Al principio di questo periodo le potenze imperiali che avevano colonizzato quasi interamente l'Asia nel corso dei quattro decenni precedenti - Gran Bretagna, Francia, Olanda, Giappone e Stati Uniti - Persero i loro possedimenti coloniali: Ciao Benny sia per effetto dell' indebolimento delle potenze coloniali seguito alla guerra, sia in seguito all’esplosione del sentimento nazionalistico all’interno delle colonie che alimenti i movimenti indipendentisti.
I leader degli stati postcoloniali della regione Asia, nell’immediato dopoguerra, si sforzarono di sfruttare il sentimento nazionalista e di trovare ricette economiche che potessero favorire lo sviluppo nazionale. In ambito internazionale Era necessario definire delle politiche che avrebbero consentito di difendere le appena conquistata sovranità, in un quadro che andava rapidamente polarizzando si in una lotta per il potere tra gli Stati Uniti e loro alleati occidentali da un lato e l'unione sovietica e il suo blocco dall'altro. Nello sforzo di scendere a patti con la pressione imposta dal bipolarismo , i nuovi stati asiatici seguiranno percorsi diversi : in alcuni casi - Corea, Cina e Vietnam - l'allineamento con una delle due superpotenze trasformò la linea di confronto ideologica in una separazione territoriale dei paesi. In altri casi, come quello indiano, si scelse la via della neutralità. In altri ancora, come nel caso della Repubblica popolare cinese, ci si schierò con un polo, per poi - dopo un periodo di lungo isolamento - avvicinarsi all'altro e infine liberarsi dai legami, perseguendo una linea di apertura all'economia globale.
Nella maggior parte dei casi i benefici della cooperazione nei campi della sicurezza e dell'economia attraverso l'allineamento con una delle due superpotenze fecero sì che la politica interna e quella estera dei nuovi stati asiatici fossero intimamente interdipendenti. La maggior parte dei regimi nei nuovi stati erano relativamente deboli e necessitavano di un supporto esterno di tipo economico e militare. Allo stesso tempo, in molti casi, i leader dei nuovi stati dovettero confrontarsi con una posizione politica che complicava e a volte minacciava il loro controllo sul potere. In tali circostanze, le lotte indipendentistiche divennero potenti strumenti politici nelle mani dei leader e dei loro oppositori virgola e le questioni di politica estera ebbero delle profonde ricadute sulle lotte politiche interne. Inoltre, la guerra fredda condiziona la politica internazionale della regione asiatica e fu influenzata dalle priorità ed alle politiche degli stessi paesi della regione. Nei paesi divisi - Corea, Cina e Vietnam -, alla fine di massimizzare la propria influenza , ognuna delle due superpotenze individuò e sostenne un contendente al potere nazionale emerso dalle élite nazionaliste locali. Il risultato fu che le lotte per il potere che la guerra civili tra i contendenti in questi paesi si intrecciarono con le esigenze della guerra fredda.
La fine della guerra fredda e il successivo crollo del comunismo nel 1991 che usano la lotta bipolare archiviando le dinamiche che avevano plasmato le relazioni internazionali dei paesi asiatici nei 10 anni precedenti. Tra i cambiamenti più degni di nota che anticipavano la fine dello scontro fra le superpotenze americana e sovietica mi furono il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese, l’emersione del Giappone, la fine della guerra del Vietnam, il decollo della Corea del Sud, di Taiwan, delle tigri del sud-est asiatico, l'ascesa della Cina di Deng e dei suoi successori.
Le relazioni internazionali nell’Asia a partire dalla seconda guerra mondiale derivano quindi le proprie dinamiche dall' intricata interazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica in lotta per l'influenza e il potere all’interno della regione, da un lato, e dai conflitti dei neonati stati nazione per il loro consolidamento e per l'affermazione della propria sovranità, dall'altro. Tuttavia, è bene ricordare che proprio dagli effetti di questa interazione sono derivate anche alcune rilevanti trasformazioni - il successo economico su tutti - che hanno caratterizzato la fase successiva dell'ascesa Asiatica.
Mentre le elezioni del ’56 furono bloccate dal timore che Ho potesse stravincere. Il principio delle elezioni libere perdeva qualsiasi significato a Washington nel caso in cui si sospettasse che a vincere potessero essere i comunisti.
P. 221
La Cina era e continua a essere intimorita dalla possibilità che una pressione troppo forte possa determinare la caduta del regime e il successivo incontrollabile caos sul confine. E inutile dire che anche i sudcoreani non torno un certo timore nei confronti di un cambiamento, soprattutto se repentino nell’assetto politico della Corea del Nord: nel loro caso, infatti, ciò potrebbe significare accollarsi la gran parte dei costi sociali, condannando Seoul a una regressione significativa nella scala della ricchezza mondiale.
P. 233
Bibliografia
Storia del Giappone contemporaneo / J. Bouissou. – Il Mulino, 2003
Storia del Giappone / R. Caroli e F. Gatti. – Laterza, 2004
L’Asia orientale: dal 1945 ai giorni nostri / A. Fiori. – Il mulino,2010
Parte seconda: cesure e tornanti
Cap. 12. 1789-1815: la nascita dell’età contemporanea / di Emilie Delivré
Fine di un’epoca o inizio di una nuova era, il periodo 1789-1815 costituisce una fase di transizione in cui si compie il passaggio dall'età moderna qualità contemporanea, momento di transizione tra 18º e 19. Secolo, a cavallo tra illuminismo e romanticismo. Le rivoluzioni americana e francese, le agitazioni politiche , le guerre napoleoniche e la fine Ehi sacro romano impero ridisegnarono in meno di tre decenni la mappa politica europea e trasformarono anche all'orizzonte di aspettativa di gran parte della popolazione occidentale. La politica dei sovrani, la legittimità dei governi e i modelli sociali che ne dipendevano vennero rimessi in discussione, mentre gli inizi dell’industrializzazione in Gran Bretagna mostrarono già tutte le caratteristiche di un processo che avrebbe buttato definitivamente l'economia mondiale.
1. L’età delle rivoluzioni
Per capire come uno stato centralizzato e ben articolato come quello francese virgola che godeva del sostegno di istituzioni molteplici nonché della chiesa, possa essere stato scosso in pochi mesi occorre considerare una lunga serie di avvenimenti durante il 700, circostanze eccezionali ma anche lenti processi appunto uno di questi è la guerra dei 7 anni (1756 -63) che oppose i Borboni (Francia e Spagna) e la Gran Bretagna, e che avrebbe lasciato la Francia indebolita e la Gran Bretagna ben decisa ad approfittare delle nuove terre americane conquistata dai francesi per mandare nuovi emigranti. Già nel 1770, però, cominciarono azioni di protesta da parte degli insorgenti americani. Dal 1775 al 1783, la Rivoluzione americana Oppose le 13 colonie inglesi dell'America del nord alla loro madrepatria. il 4 luglio 1776 (l’indipendence Day, oggi ricordato come festa nazionale) la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, redatta da Thomas Jefferson con Benjamin Franklin, Roger Livingston e John Adams, sei programmata imposta come pietra fondante della creazione di un nuovo stato federale, gli Stati Uniti d'America. i capi della ribellione erano infatti riusciti a dare un fondamento universalistico alla loro resistenza, ottenendo così un appoggio (spesso interessato) In Europa. È così che, prima ancora del trattato di Parigi del 1783 che vedeva la Gran Bretagna riconoscere l'indipendenza nella sua colonia, parole come libertà, diritti o costituzione attraversarono l'Atlantico insieme ha un corpo di spedizione francese nel quale si trovava la vista pratico francese liberale La Fayette, venuto a raggiungere l'esercito continentale condotto da George Washington (che diventerà il primo presidente degli Stati Uniti nel 1789). da questa rivincita contro la Gran Bretagna La Francia , però, non trasse vantaggi economici piccola al contrario: lo stato era indebitato e non riuscì a compiere riforme effettive, ritrovandosi intrappolato fra una struttura sociale fondata sui privilegi e sul funzionamento sempre più liberale dell’economia.
Nel frattempo, il mondo occidentale continuava ad essere turbato da una serie di moti rivoluzionari: contemporaneamente ci furono agitazioni politiche e popolari In Irlanda e Gran Bretagna , movimenti democratici a Ginevra nel 1768 e nel 1782, Rivendicazioni democratiche nelle province unite negli anni 1783 - 83 Ehi soluzioni nei Paesi Bassi austriaci (il futuro Belgio) alla fine degli anni '80. In un ambiente politico , sociale ed economico particolarmente difficile (i raccolti erano stati scarsissimi dopo un inverno molto duro che nel 1788 provocò una carestia), il re Luigi 16º convoco eccezionalmente gli Stati generali Del Regno francese, che rappresentavano i tre ordini (nobiltà, clero, terzo stato), innescando tutta quella serie di avvenimenti rivoluzionari che avrebbero posto fine all’antico regime.
Bibliografia
La rivoluzione industriale inglese / R. C. Allen. – Il mulino, 2011
L’Italia di Bonaparte: politica, statualità e nazione nella penisola tra due rivoluzioni, 1796-1812 / A. De Francesco. – Utet, 2011
Critica della Rivoluzione francese / F. Furet. – Laterza, 1989
La Rivoluzione francese: politica, cultura, classi sociali / L. Hunt. – Il Mulino, 2001
Napoleone e gli italiani / A. Pillepich. – Il mulino, 2005
Rivoluzione e controrivoluzione: la Francia dal 1789 al 1815 / D. Sutherland. – Il mulino, 2000
Cap. 13. 1848: Costituzioni, diritti, nazionalità
Guerra e diplomazia, nazionalismo e costituzionalismo, furono gli ingredienti dell’esperienza rivoluzionaria del 1848. Da Parigi a Vienna, da Berlino a Palermo i popoli reclamarono, negli scontri di piazza, quella libertà (di stampa, di riunione, di associazione, di autodeterminazione9 e quei diritti fondamentali (in primis, il diritto di voto) sconfessati nel 1815 dal Congresso di Vienna. Pur uniti dal desiderio di chiudere l’esperienza del governo d’Ancien régime, operai, artigiani e borghesi si divisero ben presto tra sostenitori di una rivoluzione liberal-moderata e fautori di un repubblicanesimo avanzato, determinando nell’immediato il fallimento dei moti, senza però disperderne il patrimonio di conoscenza ed esperienze, come la storia successiva avrebbe dimostrato.
- Origini e protagonisti di una svolta
La terza ondata rivoluzionaria del 20° secolo ebbe tutte le caratteristiche di una vera e propria rivoluzione europea. Nella primavera del 1848 la sollevazione all’unisono dei popoli oppressi manifestò una carica collettiva di lotta e una volontà di emancipazione politica dallo straniero e dai regimi autoritari tanto matura e consapevole che i primi incerti tentativi insurrezionali degli anni Venti e Trenta sembravano appartenere ad un’altra epoca. A scatenare una contestazione così radicale all’ordine costituito fu la pericolosa miscela creata dal concomitante manifestarsi in più punti del vecchio continente di crisi economica e difficoltà politiche, di fame e repressione. Impossibile, per i governi usciti dalla Restaurazione, trovare la formula con cui conciliare le crescenti richieste di aiuto provenienti dagli strati più poveri della popolazione e il rigido mantenimento dell’ordine pubblico, la reiterata richiesta di diritti (in primo luogo, quello del voto) e la censura, la tutela delle libertà di pensiero e d’impresa e la totale mancanza di fiducia nei cittadini. Da qui una mobilitazione sociale che assunse i connotati di una vera e propria rivoluzione, nel momento in cui alla crescita demografica e a l manifestarsi dei segni di una prima industrializzazione non priva di contraddizioni (gli operai erano mal pagati e per nulla tutelati, il loro potere d’acquisto irrisorio) si venne sovrapponendo, nel biennio 1845-46, una crisi agricola dagli effetti devastanti.
Tuttavia non sarebbe bastata la miseria in sé ad alimentare un’ondata di tumulti di piazza così vasta se il malcontento non avesse trovato un proprio punto di riferimento politico in quel nucleo ci intellettualità e borghesia urbana illuminata che sosteneva da tempo gli ideali di libertà e di modernizzazione esportati in ogni angolo d’Europa dalle truppe napoleoniche. Nel volgere poi lo sguardo oltre Manica, gli esponenti di questa classe sociale emergente mostravano di voler porre un freno ai regimi arbitrari usciti dal Congresso di Vienna del 1815: riducendo il potere della monarchia e della chiesa, ampliando il potere dei cittadini nella gestione del bene pubblico attraverso i sistemi costituzionali parlamentari fondati sulla legalità e la divisione dei poteri. Al contempo, però, questi sostenitori del pensiero liberale rifiutavano l’idea di democrazia, di sovranità popolare in senso pieno, poiché giudicata foriera di disordini, di pulsioni anarchiche. A guidare il cambiamento potevano essere destinati solo gli esponenti di quelle classi medie agiate che, pagando le tasse e dimostrandosi culturalmente preparate, apparivano come le uniche in grado di attuare progetti politici più avanzati, senza però rischiare “salti nel buio”. In altri termini, i rappresentanti di questa borghesia moderata (avvocati, professori, medici, ingegneri, giornalisti, uomini d’affari e dell’alta burocrazia) non intendevano mettere a repentaglio quelli che giudicavano essere i capisaldi della convivenza civile: dal diritto di proprietà alla rappresentanza dei migliori. Al fine di scongiurare tale pericolo, i riformisti europei appartenenti alle fasce più agiate e istruite della popolazione cercarono di creare un “ponte” con la gran massa di diseredati delle città e delle campagne attraverso quella piccola borghesia fatta di artigiani, commercianti e operai specializzati che nutriva sì progetti di cambiamento, ma al pari delle classi inferiori temeva il montare dell’insicurezza economica. A questi soggetti andò sempre più indirizzandosi la pubblicistica moderata, nel tentativo di creare un ampio movimento d’opinione capace d’immaginare soluzioni alternative all’Ancien Regime che non sfociassero per forza in un bagno di sangue. Ma il traguardo della mobilitazione senza rivoluzione non era ciò cui aspiravano i democratici, ossia quel cenacolo d’intellettuali, custodi di una tradizione repubblicana e socialisteggiante ( si pensi a Saint-Simon, Fourier, Blanc, Blanqui, solo per citarne alcuni) che affondava le proprie radici nel 1789 e dintorni, il cui solidarismo ed egualitarismo apparivano agli antipodi rispetto alla politica dei “piccoli passi” propugnata dalla borghesia. Il loro obiettivo rimaneva, infatti, quello di creare una netta cesura tra l’Europa delle monarchie “di diritto divino e l’”Europa dei popoli” liberi e uguali (secondo la definizione coniata da Mazzini) e di dare alle strutture dello Stato una legittimazione “dal basso” e lineamenti tali da rendere significativa la partecipazione popolare alla gestione delle risorse pubbliche. Una metamorfosi che, proprio alla vigilia dei moti del 1848, trovò la propria espressione più avanzata nel manifesto del Partito comunista di Marx ed Engels, pamphlet al quale si deve la prima compiuta teorizzazione della lotta di classe e della funzione rivoluzionaria del proletariato.
Tuttavia, mentre i paesi che già possedevano un ordinamento liberal-moderato, come la Francia, furono interessati da lotte democratiche guidate in larga parte da repubblicani e socialisti, nei paesi politicamente divisi o soggetti a regimi assolutistici (gli stati tedeschi e quelli italiani, l’Ungheria, la Polonia, l’Austria) le tensioni sociali si tradussero in un abbraccio tra liberalismo e nazionalismo, cioè in una combinata rivendicazione di libertà e regimi costituzionali fondati sullo statuto, che tutti, dal sovrano al più umile cittadino, dovevano rispettare, oltre che sulla piena indipendenza dallo straniero.
P. 245-47
- Limiti ed eredità del ‘48
Indubbiamente, la “primavera dei popoli” fu alla prova dei fatti un totale fallimento. Se si esclude l’esperimento costituzionale piemontese, nessuno dei regimi nati in Europa dai moti del 1848 sopravvisse all’ondata restauratrice. Una disfatta la cui causa principale va identificata nell’inconciliabile frattura tra due opposte visoni del concetto di riformismo e di libertà: quella liberal-moderata e quella democratica-radicale. Mentre la prima mirava a scardinare l’Ancien regime attraverso un moderato costituzionalismo, la seconda ambiva a realizzare un progetto avanzato di repubblicanesimo col quale, da un lato, far tabula rasa delle case regnanti e dei loro privilegi, dall’altro accentuare l’interventismo sociale dello Stato. La borghesia europea, allarmata dagli esiti di quest’ultima opzione, dopo gli entusiasmi iniziali, tornò celermente su posizioni conservatrici, abbandonando i democratici al loro destino. Lasciati soli a sostenere lo scontro politico e militare con le forze della restaurazione, i democratici furono fatalmente sconfitti.
Inoltre, l’idea di “guerra di popolo” dei patrioti italiani, capace di coniugare il progetto di liberazione della penisola dallo straniero con quello di emancipazione politica e sociale delle plebi, si scontrò con l’immobilismo delle masse contadine, estranee, se non apertamente refrattarie, alle lotte organizzate nei centri urbani della piccola e media borghesia. Ciò si tradusse nella benevola concessione da parte dei sovrani di statuti molto simili tra loro che contemplavano una camera bassa elettiva (secondo un sistema fortemente censitario), una camera alta di nomina regia e un governo responsabile del proprio operato solo davanti al re. Leggi fondamentali che riconoscevano l’emergente ruolo economico e politico della borghesia, ignorando invece il “popolo minuto”.
Ma il fallimento della rivoluzione europea si spiega anche nell’intreccio tra questioni politiche e questioni nazionali. Inizialmente, le lotte per i diritti e la democrazia andarono a braccetto con quelle per l’indipendenza, ma poi queste ultime prevalsero, scagliando i popoli gli uni contro gli altri e soffocando definitivamente qualsiasi aspirazione alla libertà e alla democrazia, a tutto vantaggio delle autocrazie. Si pensi al caso ungherese, che vide aprirsi una competizione tra la popolazione magiara e quella slava. Si pensi al caso tedesco, dove liberali, pur di veder realizzata l’unità degli stati tedeschi, furono disposti a offrire la corona imperiale ad un sovrano dispotico come Federico Guglielmo 4.
Ma l’insuccesso della strategia rivoluzionaria del ’48 non bastò a cancellare alcune importanti novità dalle quali, , nei decenni successivi, non sarà più possibile prescindere. La “seconda” restaurazione non mise fine alle aspirazioni nazionaliste dei popoli che componevano l’impero asburgico, né quelle degli stati italiani e tedeschi. Anche le monarchie più conservatrici cominciarono a riconoscere la necessità di riforme costituzionali. Inoltre, si venne registrando una sensibile crescita della partecipazione politica prodotta da un movimento d’opinione che poté giovarsi dal rapido sviluppo della stampa. Movimenti, sindacati, associazioni professionali assunsero un primordiale ruolo di collettore e sintesi degli interessi espressi da diverse fasce della popolazione, mentre il panorama politico si andò arricchendo di maggiori sfumature, anche estreme (dal socialismo al nazionalismo di stampo sciovinista, passando per il liberalismo, il radicalismo e il conservatorismo), che avrebbero influito sulla storia d’Europa per il resto del 19° secolo.
Bibliografia
La Francia della Seconda Repubblica, 1848-1852 / M. Aghulon. – Ed. riuniti, 1979
Con lealtà di Re e con affetto di padre: Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello Statuto albertino / P. Colombo. – Il mulino, 2003
Nazione e controrivoluzione nell’Europa contemporanea, 1788-1848 / a cura di E. DI Rienzo. – Guerrini, 2004
Tra idealità e ideologia: il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l’inverno 1848 / R. Ferrari Zumbini. – Giappichelli, 2008
1848: la rivoluzione del Risorgimento / E. Francia. – Il mulino
Dall’Antico regime al 1848: le origini costituzionali dell’Italia moderna / C. Ghisalberti. – Laterza, 1999
Daniele Manin e la rivoluzione veneziana del 1848-49 / P. Ginsborg. – Einaudi, 2007
Le rivoluzioni del 1848 / R. Price. – Il mulino, 2004
1848: l’anno della rivoluzione / M. rapport. – Laterza, 2009
Lo Statuto albertino / G. Rebuffa / Il mulino, 2011
Cap. 14. 1860: la guerra civile americana / di Tiziano Bonazzi
Se la guerra civile rappresenta per tutti gli americani la va bene con la marmellata di occhi “grande tragedia nazionale” tragedia nazionale - con oltre mezzo milione di morti e un lungo strascico di ostilità che al dramma della schiavitù sostituirono la segregazione razziale -, essa tuttavia si comprende solo inserita in un contesto storico e geografico più ampio. Il conflitto che iniziò nel 1861, infatti, rientra nel quadro della grande Europa meglio di metà 800 nell'ambito del quale giunsero a un primo consuntivo le profonde trasformazioni degli assetti politici e costituzionali dell'epoca e iniziò a farsi largo la “questione sociale”.
- Gli Stati Uniti e l’Europa
Nell'immaginario collettivo del popolo americano la guerra civile del 1861-65 occupa un posto particolare, anche un secolo e mezzo di storia non è riuscito a scalfire. Centinaia di musei, un fiume di pubblicazioni, dct internet, di ricostruzioni storiche che si ripetono annualmente indicano un continuo rinnovarsi della sua memoria.
Italiano in una storia come quella degli Stati Uniti virgola che sembra il prototipo delle storie di successo - un gruppo di lontane, oscure colonie che diventa un modello politico ed economico e la prima potenza al mondo - la guerra civile è l'evento che più di ogni altro dà agli americani il senso di una grande tragedia nazionale, con 630.000 morti, la distruzione di intere aree del paese, il lungo strascico di ostilità che si lasciò dietro e il dramma della schiavitù che fu abolita, ma a cui si sostituì la segregazione razziale, mentre il razzismo restava immutato. tuttavia se sull'onda di una memoria così intensamente americana sì guarda alla guerra civile come a un evento soltanto statunitense , si rischia di restare intrappolati in una visione parziale e di cedere all'idea che la storia degli Stati Uniti sia qualcosa di autoreferenziale.
La storia americana e invece parte integrante di quella europea Gli Stati Uniti appartengono - fino alla seconda guerra mondiale virgola dopo la quale tutto è cambiato - al sistema della grande Europa, nato dall’ampliarsi del sistema degli stati europei agli stati sorti dalle ex colonie e inglesi, spagnole, portoghesi e francesi nel nuovo mondo.
Fin dalla loro nascita infatti Gli Stati Uniti si integrarono perfettamente nel sistema economico Atlantico e nella prima metà dell'Ottocento divennero grandi esportatori di prodotti agricoli , forti importatori di prodotti industriali che con la loro moderna flotta mercantile vettori commerciali di rilievo. lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la politica internazionale, anche se nella prima metà dell'800 erano un paese estraneo ai grandi giochi di potenza europea. sapevano però diffondere bene i loro interessi nazionali come indicano la famosa dichiarazione di Monroe del 1823, l’abile politica di trattati con Francia, Spagna e Gran Bretagna con cui ampliarono il proprio territorio fino al pacifico, nonché la guerra vittoriosa del 1846-48 contro il Messico, che costò a quest'ultimo quasi la metà del proprio territorio e nella quale si mostrarono in grado immettere in campo un esercito a migliaia di chilometri di distanza dalle basi di partenza.
E’ infine un segnale di appartenenza all'Europa il fatto che la rivoluzione americana del 1776 si fondò sui diritti naturali dell'individuo, la sovranità popolare, la separazione stato chiesa - cioè sulla libertà per cui lottava illuminismo - e che proprio negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni '20 dell’Ottocento, ma quella moderna democrazia politica fondata sul suffragio universale maschile e sui partiti.
P. 253-54
Bibliografia
Storia della guerra civile americana / R. Luraghi. – Rizzoli, 2009
La guerra civile americana / R. Mitchell. – Il mulino, 2009
Cap. 15. 1870: il nuovo equilibrio europeo / di Maria Serena Piretti
Vent’anni dopo la “primavera dei popoli”, fallita nel 1848, l’equilibrio europeo fu segnato da processi di mutamento che l’avrebbero accompagnato fino alle soglie della Prima guerra mondiale. La Francia, gli stati di lingua tedesca e la penisola italiana furono i paesi maggiormente interessati da questi mutamenti. La carta dei mutamenti geopolitici, tracciata all’inizio del secolo, fu sostituita da un nuovo assetto che vide fortemente ridimensionato il potere esercitato dall’Impero austroungarico.
Passati circa vent’anni dagli eventi del 1848, l’equilibrio politico europeo, che il fallimento della “primavera dei popoli” aveva prodotto, riceve una nuova scossa e registra, quasi in sordina, una serie di trasformazioni destinate a durare fino allo scoppio della Prima guerra mondiale.
I paesi maggiormente interessati a questi mutamenti sono la Francia, gli stati di lingua tedesca e la penisola italiana, mentre la Gran Bretagna, che è solo indirettamente toccata dalla parziale risistemazione della carta geopolitica dell’Europa, procede, secondo lo stesso modulo che già l’aveva accompagnata in un riformismo senza rivoluzione negli anni del ’48, a un riequilibrio della “balance of power” che caratterizza il suo sistema politico.
La causa congiunturale che sta all’origine di questi eventi è il fatto che sul trono nel Regno di Spagna si sia esaurita una dinastia, senza che sia chiaro a chi tocchi la successione nello stesso: ciò scatena gli appetiti delle monarchie europee, ingenerando contemporaneamente i logici timori derivanti da n possibile disequilibrio nella distribuzione del potere politico fra le diverse case regnanti. Come è naturale, gli interrogativi più pressanti circa la risoluzione di questa diatriba sono quelli della Francia che, per la posizione geografica confinante con la Spagna, sarebbe sottoposta al pericolo più immediato di un ipotetico assedio psicologico, se a regnare sullo stato al di là dei Pirenei venisse posta una monarchia che già esercita il suo potere in un paese posto ai suoi confini orientali (cioè se si trattasse di una casata tedesca).
In realtà la crisi congiunturale della successione spagnola non rende piena ragione della trasformazione in atto e lo sbocco di questa crisi non sarebbe comprensibile se non si considerassero gli sviluppi che lo scenario europeo presenta nell’intervallo tra il 1848 e il 1870. E’ per questo che, per spiegare gli eventi, è necessario fare un passo indietro rispetto agli avvenimenti del 70.
Il ’48, come peraltro già il 1815, aveva negato risoluzione ai problemi delle “nazionalità” e il tentativo esperito dai popoli di lingua tedesca di darsi una propria struttura, indipendentemente dal controllo della Confederazione germanica e quindi dell’Austria, era abortito di fronte al rifiuto espresso da Federico Guglielmo 4° all’offerta del titolo di imperatore, che gli veniva presentata dall’Assemblea di Francoforte, liberamente eletta, all’indomani dello scoppio della rivoluzione, per coronare i sogni di un’unificazione dei territori tedeschi.
Questo diniego opposto dalla monarchia degli Hohenzollern è legato, tuttavia, non alla volontà prussiana di mantenere inalterati i rapporti di potere sanzionati nel Congresso di Vienna (e quindi all’accettazione di un ruolo non così paritario rispetto all’Austria) bensì al rifiuto di un impianto costituzionale che, provenendo dal basso, avrebbe per sua stessa natura sottolineato la debolezza della forma statuale che corrispondeva al “principio monarchico” (il sovrano che non derivava il suo potere da alcuno). Conforta questa linea interpretativa l’abile mossa di Federico Guglielmo 4., posta in essere all’indomani della stessa Rivoluzione del ’48, quando, per affermare il ruolo preminente della Prussia rispetto agli altri stati membri della Confederazione, tenta di avviare, d’accordo con i Regni di Sassonia e dell’Hannover, un movimento di unificazione nazionale degli stati tedeschi del Nord. Tentativo subito sventato dall’Austria che, con il trattato di Olmutz nel novembre 1859, riafferma il suo ruolo guida all’interno della Confederazione e vieta qualsiasi alleanza strutturale ai paesi posti all’interno della stessa.
P. 261-62
Bibliografia
Storia della Francia nell’Ottocento / P. Barjot … et al. – Il mulino, 2003
Storia della Gran Bretagna, 1789-1990 / M. D. Pugh. – Carocci, 2002
Ottocento: lezioni di storia contemporanea / R. Romanelli. – Il mulino, 2011
Bismarck: l’uomo e lo statista / A. J. P. Taylor
Cap. 16. 1898: La guerra ispano-americana e l’impero statunitense
Nel 1898 gli Stati Uniti dichiararono guerra all’Impero spagnolo. Il conflitto scoppiò in risposta alle azioni spagnole a Cuba, che all’epoca faceva ancora parte dell’Impero e dove si era sviluppato un movimento nazionalista che rivendicava l’indipendenza dell’isola. La guerra durò pochi mesi e si concluse con un facile successo per gli Stati Uniti, che li portò ad acquisire il controllo diretto delle Filippine, di Portorico e dell’isola di Guam nel Pacifico. Cuba, per la cui indipendenza si era combattuto, venne rapidamente trasformata in un protettorato degli Stati Uniti. La guerra sanzionò l’affermazione nordamericana nell’arena internazionale e la nascita dell’impero statunitense.
E’ consuetudine tra gli storici della politica estera americana considerare la guerra del 1898 tra gli Stati Uniti e la Spagna come uno spartiacque cruciale. Un momento di svolta che segnerebbe l’inarrestabile ascesa degli Usa a indiscussa potenza globale. Secondo tale lettura, la guerra del 1898 inaugurerebbe, con solo due anni di anticipo, quello che quattro decenni più tardi il magnate dell’editoria Henry Luce avrebbe definito il “secolo americano”.
Questa interpretazione offre molti vantaggi, anche sul piano didattico e divulgativo. Su tutti quello di fornire una periodizzazione, semplice e conveniente, che usa il 20° secolo come propria unità di misura. Non di meno, una sovra-enfatizzazione della portata della rottura del 1898 nella storia statunitense non permette di comprendere il legame che vi fu tra la guerra con la Spagna e precedenti processi politici, diplomatici ed economici che avevano qualificato l’espansionismo statunitense durante tutto l’Ottocento e concorso alla formazione di un impero continentale in Nord America. Processi la cui continuità non trovava certo una soluzione in occasione della guerra con la Spagna. La guerra del 1898 rappresentò pertanto un salto di qualità, più che un momento di rottura dell’espansionismo statunitense. Tale tradizione necessitava infatti di una rimodulazione, resa necessaria sia dal completamento dell’espansione continentale sia dalla progressiva globalizzazione degli interessi strategici ed economici, degli Stati Uniti. In tal senso l’annessione delle Hawaii, anch’essa del 1898, e preceduta da un’intensa discussione politica e pubblica, rappresentò un viatico e un segnale importante. Per la loro collocazione, le Hawaii rappresentavano un’importante base, militare e commerciale, in direzione del continente asiatico, verso cui s’indirizzavano le attenzioni crescenti del mondo politico ed economico statunitense.
P. 269-70
Bibliografia
Libertà ed Impero: gli Stati Uniti ed il mondo, 1776-2011 / M. Del Pero. – Laterza, 2011
L’impero americano: gli Usa potenza mondiale / F. Romero. – Giunti, 2001
Il secolo degli Stati Uniti / A. testi. – Il Mulino, 2008
Cap. 17. Fine secolo / di Fulvio Cammarano
Nei principali paesi europei – Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania – si riproposero in modo conflittuale, negli ultimi anni dell’Ottocento, le tensioni riguardanti il funzionamento delle istituzioni rappresentative che avevano percorso la storia politica europea a partire dalla Rivoluzione francese. La radicalizzazione fu il risultato di diversi fattori – declino della proprietà terriera, ascesa del movimento operaio e crisi economiche – che amplificarono la percezione di precarietà del sistema politico-istituzionale liberale. Tale processo, in particolare per Italia, Francia e Gran Bretagna, si risolse con l’affermazione di un modello più liberal-democratico.
Gli ultimo anni del 19° secolo e i primi del 20° rappresentarono per molti paesi europei un momento di travagliato trapasso politico-istituzionale, spesso associato a forti contrasti d’ordine sociale. Nella fase finale del suo lento tramonto l’Ottocento ripropose in modo concentrato e conflittuale quell’impasto di ansie e speranze circa il funzionamento delle istituzioni rappresentative che aveva accompagnato, con diverse sfumature, la storia di questo secolo, a partire dalla Rivoluzione francese. Molti fattori avevano contribuito a radicalizzare questi anni di “frontiera”, già di per sé simbolicamente evocativi di mutamenti epocali, a cominciare dal declino della proprietà terriera e dei suoi valori negli anni Settanta, e dalla rapid ascesa del movimento operaio organizzato. Tali aspetti ebbero modo di alimentare l’espressione di precarietà della civiltà liberale, anche perché amplificati da una delle prime grandi depressioni economiche mondiali del sistema capitalistico che, in alcuni paesi, estese le sue propaggini sino alla seconda metà degli anni Novanta. Di fronte a tale scenario iniziò ad incrinarsi la fiducia di una parte delle classi dirigenti liberali in una possibile, sebbene cauta, integrazione delle grandi masse nei regimi politici di tipo parlamentare. Alcuni settori delle élites cominciarono a percepire i parlamenti come luoghi in cui venivano messe in discussione le gerarchie tradizionali e in cui si affaccendavano demagoghi impegnati solamente a soddisfare interessi di parte e a solleticare gli appetiti delle masse in funzione elettorale. Con modalità e pathos differenti a seconda dei paesi, si affrontarono dunque per la prima volta in modo aperto i difensori del sistema politico basato sullo sviluppo del sistema parlamentare e del suffragio universale e i propugnatori di un sistema incentrato su un esecutivo quanto più possibile sganciato dalla volontà dell’elettorato. Nel complesso si possono intravvedere i tratti di un’unica grande crisi in cui due diverse visioni dei sistemi politici si batterono duramente per una posta che in gran parte d’Europa era la definizione dell’assetto costituzionale in senso liberal-parlamentare o conservatore-autoritario.
P. 275-76
- Italia
In Sicilia, in particolare, le agitazioni ebbero vaste ripercussioni e si svolsero sotto la guida dei cosiddetti “Fasci dei lavoratori” (in seguito definiti Fasci siciliani), unioni sindacali dirette dai socialisti
…..
Crispi fece approvare delle leggi che aggravavano le pene per i reati di opinione a mezzo stampa e vietavano le organizzazioni con finalità socialiste.
…..
Nel frattempo usciva, anonimo, l’articolo di Sidney Sonnino “Torniamo allo Statuto”, che focalizzava le ragioni del disappunto del liberalismo più moderato nei confronti del ruolo assunto dal parlamento, attaccando un “potere nuovo, parassita e ibrido, dallo statuto non contemplato, il quale facendo si strumento e sgabello delle pretese dottrinarie e delle crescenti usurpazioni della Camera dei deputati, che vorrebbe arrogare a sé sola il diritto di parlare come interprete della volontà della nazione”, era riuscito a usurpare “quasi tutte le funzioni normali della Corona”. Per tale motivo Sonnino invocava, in difesa delle istituzioni liberali minacciate dall’invadenza socialista e clericale, un ritorno alla “lettera” dello Statuto albertino, che affidava esclusivamente al sovrano la gestione del potere esecutivo, anziché a un presidente del Consiglio sorretto da una maggioranza parlamentare. Il 1898 si apriva con un ulteriore aggravamento delle tensioni nelle piazze italiane.
….
In realtà il nuovo presidente del consiglio intendeva portare avanti un progetto politico di più ampio respiro incentrato sulla limitazione del ruolo del parlamento e sulla repressione delle libertà d’opinione e d’associazione.
P. 276-77
Bibliografia
Storia dell’Italia liberale / F. Cammarano. – Laterza, 2011
Fine secolo: gli intellettuali italiani e inglesi e la crisi tra Otto e Novecento / G. Guazzaloca. – Il mulino, 2004
Crisi, consenso, legittimazione / a cura di G. Pombeni. – Il mulino, 2003
L’impero inquieto: la Germania dal 1866 al 1918 / M. Sturmer. – Il mulino, 1993
Cap.18. La Prima guerra mondiale / di Marco Mondini
Il 28 giugno 1914 l’erede al trono austriaco venne assassinato. L’attentato di Sarajevo fu la scintilla che alimentò una conflagrazione europea, motivata da cause politiche profonde (le rivalità tra le grandi potenze), da cause culturali (il radicarsi dei nazionalismi) e dalla rigidità dei sistemi di alleanze. La guerra non fi breve, come tutte le parti coinvolte avevano creduto, ma si trasformò in una logorante guerra di trincea. L’Italia intervenne nel 1915 a fianco della Francia, Gran Bretagna e Russia. Nel 1917 la Russia si arrese, mentre gli Stati Uniti entrarono in guerra contro la Germania. La Prima guerra mondiale terminò nel novembre 1918 con al resa degli imperi centrali (Germania, Austria-Ungheria e Turchia) e l’apertura della conferenza di pace di Parigi (1919-21).
- Perché scoppiò la Prima guerra mondiale?
Le origini del conflitto possono schematicamente essere ricondotte a tre ordini di cause: cause di natura politica, cause di natura culturale, cause di natura militare.
Le cause politiche profonde della guerra vanno cercate nel contesto competitivo e conflittuale delle relazioni tra le principali potenze europee. Semplificando un quadro estremamente complesso, si può sostenere che la crisi del 1914 sia dipesa dalla rottura dell’equilibrio internazionale raggiunto alla fine degli anni Settanta dell’Ottocento, dopo che la guerra franco-prussiana (1870-71) e l’ascesa del Secondo Reich tedesco avevano radicalmente mutato i rapporti di forza sul continente. Il Congresso di Berlino del 1878 aveva ratificato un nuovo ordine europeo ma non aveva eliminato le tensioni esistenti. Uno dei primi fattori di instabilità nel sistema internazionale fu la persistenza del conflitto franco-tedesco. La Francia perseguiva con forza una politica “revanchista”, che la spinse ad accantonare la tradizionale rivalità con il Regno Unito (trattato dall’Entente cordiale, 1904) e a riavvicinarsi alla Russia zarista, con cui venne siglata nel 1894 un’alleanza antitedesca che nel 1907, integrata da un accordo anglo-russo, diventò la “Triplice Intesa”. A questo “accerchiamento (come lo definì il cancelliere Bulow nel 1904) la Germania rispose con una politica estera e militare sempre più aggressiva: gli effettivi dell’esercito e della marina vennero aumentati e le dimostrazioni di forza nei confronti della Francia spinsero le relazioni dei due paesi al punto di rottura. Nel 1950 e ancora nel 1911 (crisi di Agadir) il tentativo tedesco di impedire l’estensione del protettorato francese al Marocco giunse a un passo dallo scatenare una guerra aperta. Berlino ra tuttavia sempre più isolata diplomaticamente, mentre il riarmo navale lanciato dal kaiser Guglielmo 2° all’inizio del secolo si rivelò un insuccesso: la Germania non aveva le risorse per dotarsi in tempi rapidi di una marina da guerra in grado di competere con la Royal Navy britannica. Al contrario, la sfida al suo tradizionale dominio dei mari spinse la Gran Bretagna ad aderire al blocco antitedesco. Altro elemento di destabilizzazione fu la rivalità russo-austriaca, catalizzatore delle molte tensioni nazionali che agitavano la “polveriera balcanica”. Ergendosi a tutore dell’aggressivo regno serbo e proponendosi quale paladino di una politica panslava, la Russia minacciava direttamente l’Austria-Ungheria, sia perché indeboliva il suo ruolo come principale potenza regionale dell’area balcanica sia perché, fomentando il nazionalismo slavo, metteva in forse la stessa esistenza del multinazionale Impero asburgico. Di conseguenza, nel 1879, Austria-Ungheria e Germania strinsero un’alleanza difensiva antirussa nota come “Duplice Alleanza”, a cui avrebbe aderito di lì a poco anche il Regno d’Italia (Triplice Alleanza, 1882). Questo complesso delle alleanze venne alla fine messo in crisi dal crollo dell’Impero ottomano: aggredito dall’Italia (guerra di Libia) e poi sconfitto dalla coalizione di Serbia, Montenegro, Bulgaria e Grecia nel corso della Prima guerra balcanica (1912), il vecchio impero fu ridotto alla Turchia e ai possedimenti mediorientali, mentre gli ex alleati si scontravano tra di loro per la suddivisione dei territori conquistati nella Seconda guerra balcanica (1913). Una situazione di instabilità che esacerbò i timori per l’imminente fine della convivenza pacifica tra le nazioni, in un clima di generalizzata corsa agli armamenti.
Tra le cause culturali del conflitto, la più importante si ritrova nella convinzione, comune trai contemporanei, che la lotta per la sopravvivenza e la supremazia delle potenze fosse inevitabile. Il radicalizzarsi dei nazionalismi e un malinteso darwinismo diffuso, che sosteneva la visione della guerra come banco di prova delle nazioni e occasione per “migliorare i popoli”, alimentarono l’immagine, familiare nella cultura europea all’inizio del 20° secolo, di un imminente “grande guerra”. Certo, si trattava di sentimenti condivisi da segmenti minoritari delle popolazioni europee, soprattutto politici, intellettuali, artisti e mondo studentesco; d’altra parte, la maggioranza (particolarmente i contadini) si rassegnava alla guerra come un evento sventurato, oltre che fatale. L’antimilitarismo internazionalista e il pacifismo di matrice cristiana non avevano infatti fatto breccia nelle masse europee.
Infine, non vanno trascurate alcune cause tecniche militari, riconducibili all’autonomia concessa agli Stati maggiori (soprattutto in Germania) e alla rigidità dei piani di mobilitazione. La convinzione che la guerra sarebbe stata breve e che fosse necessario attaccare per primi portò entrambi gli schieramenti ad avviare con la massima celerità possibile le disposizioni per la mobilitazione generale. Eserciti di milioni di coscritti vennero chiamati alle armi, equipaggiati e avviati al fronte prima che la diplomazia avesse esaurito le sue opzioni: un atto collettivo di ostilità che pregiudicò l’esito della crisi nelle sue ore cruciali.
P. 285-86
Bibliografia
La violenza, la crociata, il lutto / S. Audoin. – Einaudi, 2002
La Grande Guerra e la memoria moderna / P. Fussell. – Il mulino, 2000
La Grande Guerra degli italiani, 1915-1918 / A. Gibelli. – Sansoni, 1998
Il mito della Grande Guerra / M. Isnenghi. – Il mulino, 2007
La grande Guerra, 1914.1918 / M. Isnenghi, G. rochat. – Il mulino, 2008
Le origini della Prima guerra mondiale / J. Joll. – Laterza, 1985
Terra di nessuno / E. J. Leed. – Il mulino, 2004
Cap. 19. 1917: lo spartiacque della Rivoluzione bolscevica
Come la Rivoluzione francese inaugura il “lungo 800”, quella russa si colloca all'inizio del secolo breve, il 900, la cui periodizzazione (1914 -89) Coincide in larga misura con la parabola dell'Unione Sovietica. La prima fase rivoluzionaria (la rivoluzione di Febbraio) sfocia nel crollo dello zarismo e nell’instaurazione di un dualismo di potere fra i soviet, egemonizzato dai socialisti menscevichi, trudoviki e Rivoluzionari, e il governo provvisorio, guidato dal liberale L’vov. Nel corso dell'estate, rivoluzione agraria e diserzioni di massa minano il potere del governo provvisorio e la capacità di portare avanti la guerra contro i tedeschi. I bolscevichi guadagno poi consensi e per iniziativa del loro leader Lenin prendono il potere con la rivoluzione di ottobre. Nei primi mesi del 1918 sciolgono l’Assemblea costituente che firmano con i tedeschi la pace di Brest-Litovsk.
Nel 1917 Il corso della prima guerra mondiale fu mutato da eventi che ebbero per protagonisti due paesi di cultura europea ma di dimensione continentale, destinati a subentrare, dopo la seconda guerra mondiale, all'Europa nell’egemonia mondiale: l'intervento nel conflitto degli Stati Uniti, sollecitato dal nuovo impulso dato dalla Germania alla guerra sottomarina; gli succede si nell'impero russo di due rivoluzioni, di Febbraio e di ottobre, che provocarono prima l’indebolimento della resistenza antitedesca sul fronte orientale, e poi l'uscita della Russia dal conflitto con l’onerosa pace di Brest-Litovsk
- La Rivoluzione russa nella storia europea e mondiale
Alla Rivoluzione russa e stata attribuita un’importanza epocale, tale da paragonarla, per dimensioni e durevolezza di impatto, alla Rivoluzione francese del 1789. Così come questa ha inaugurato il “lungo 800 “, Quella ha dato inizio, assieme alla Prima guerra mondiale, al secolo breve, il 900, la cui periodizzazione (1914 – 89) coincide in larga misura con la parabola di vita dell'Unione Sovietica. Anche al 1917, non diversamente dal 1789, si può attribuire la duplice valenza di rivoluzione nazionale, in quanto momento di Fondazione di un nuovo stato, con una nuova legittimazione popolare e un nuovo senso di appartenenza collettiva, e di rivoluzione di portata internazionale, nella misura in cui i suoi principi gli ordinamenti che vengono modelli e punti di riferimento per i rivoluzionari di altri paesi, o sono esportati con gli strumenti della diplomazia, della propaganda, della conquista militare. la rilevanza dell’impatto mondiale del 1917 si comprende anche tenendo conto della natura bifronte dell'impero russo, esteso tra Europa e Asia, anello arretrato del sistema devi potenze occidentali via avamposto dell’occidente in Oriente, metropoli imperiale e periferia semi coloniale.
Nel breve termine la rivoluzione produsse In Russia una drammatica accelerazione del mutamento storico: alla disgregazione delle istituzioni e al sovvertimento dei rapporti sociali, alla ricostruzione di un nuovo stato e di un nuovo sistema di potere, si accompagna una guerra civile brutale e devastante (1918 – 20), destinata a coinvolgere, in modo diretto o indiretto, la maggioranza della popolazione. Ma l'interpretazione di questi eventi e stata di volta in volta condizionata dalle circostanze storiche e politiche. Innanzitutto, bisogna ricordare che furono i protagonisti della rivoluzione a fornire l'immagine di rottura radicale nella storia dell'umanità. La storiografia sovietica poi ha consolidato quella rappresentazione, in modo funzionale alla legittimazione del regime, attribuendo rilievo preponderante all'ottobre, descritto come una rivoluzione di massa quale in realtà non fu. Dopo il 1989 si è assistito a un ridimensionamento del 1917 come spartiacque epocale, e alla riconsiderazione dell’ottobre nei termini di una sorta di “colpo di stato” che coinvolse direttamente poche migliaia di persone. Al tempo stesso è stata approfondita la riflessione sulla connessione tra guerra, mobilitazione totale e rivoluzione, al punto che alcuni storici hanno proposto di collocare nel 1914 il vero spartiacque della storia russa contemporanea e di interpretare la sequenza “guerra-rivoluzione-guerra civile” (1914-21) come un unico “continuum di crisi” del quale il 1917 è stato il fulcro.
Sul piano della collocazione geopolitica e dei rapporti internazionali, conseguenza immediata della Rivoluzione bolscevica e degli accordi di Brest-Litovsk fu il ridimensionamento consistente del versante occidentale dell’ex Impero zarista, ricondotto nei confini della Moscovia seicentesca (almeno fino al 1920, quando l’Ucraina fu riconquistata dai bolscevichi). Ciò comportò la fine temporanea per la Russia del ruolo di grande potenza europea e lo spostamento del suo baricentro verso Oriente e l’Asia, tanto più che l’isolamento politico e ideologico del regime fu ratificato dall’adesione delle potenze vincitrici all’idea del “cordone sanitario” attorno all’”infezione” rivoluzionaria, concretizzatasi durante la conferenza di Parigi nel consolidamento dei neo costituiti stati dell'Europa centro orientale. Nelle regioni dell'Asia centrale la combinazione leninista di socialismo e autodeterminazione nazionale sembrò, almeno inizialmente, inaugurare per quelle popolazioni una stagione inedita di riscatto ed emancipazione. In generale, esempio russo divenne il punto di riferimento per le lotte di riscatto sociale e di liberazione nazionale dal dominio imperialistico portate avanti nel terzo mondo, anche se i tentativi rivoluzionari compiuti dai comunisti in diversi paesi (Cina, Indonesia, Brasile) non ebbero successo.
In Europa, l’esempio della rivoluzione bolscevica, del suo immediato ripudio della guerra unito agli ambiziosi programmi di giustizia sociale, infiamma le masse popolari negli anni 1918-20: divamparono rivoluzioni, poi represse, in Europa centro-orientale, e massicce rivoluzioni sociali e politiche in Europa occidentale. In questo contesto nacquero i partiti comunisti, destinati a raccogliere il consenso di intellettuali e operai che erano rimasti delusi dalle ambiguità e dai compromessi delle socialdemocrazie nell’epoca della Prima guerra mondiale. In generale, la risonanza dell’evento nell’opinione pubblica mondiale fu amplissima, e il mito che fu costruito intorno ad esso, e alla realtà sovietica che ne era scaturita, risultò tanto più durevole e credibile alla luce della crisi nella quale i paesi dell’Occidente capitalistico erano stati precipitati dalla guerra e successivamente dalla catastrofe economica del ’29 e dall’involuzione autoritaria dei regimi politici.
E’ frequente nella storiografia recente il ricorso a concetti quali “guerra dei trent’anni” del 20° secolo oppure “guerra civile europea” per definire il periodo 1914-15, caratterizzato dalla contrapposizione tra sistemi politici e sociali alternativi (democrazia, fascismo, comunismo), dallo scontro tra ideologie e fedi contrapposte, dalla trasformazione della politica interna dei singoli paesi in una sorta di guerra civile permanente, di volta in volta latente o aperta. Il 1917 russo riveste evidentemente, rispetto a questo periodo a questo periodo, un ruolo fondante, che deve però essere precisato e circoscritto: ci appaiono infatti scarsamente fondate quelle interpretazioni che, considerando il fascismo e il nazismo come fenomeni prodotti dalla reazione al comunismo, giungono ad attribuire alla nascita del regime bolscevico in Russia un ruolo del tutto spropositato nello spiegare vicende europee complesse e dalle molteplici radici.
Bibliografia
La Russia contemporanea: un profilo storico, 1855-2005 / G. Cigliano. – Carocci, 2005
La tragedia di un popolo: la Rivoluzione russa, 1891-1924 / O. Figes. – Tea, 2000
L’Unione Sovietica, 1914-1991 / A. Graziosi. – Il mulino, 2011
La Rivoluzione russa: dall’agonia dell’ancien regime al terrore rosso / R. Pipes. – Mondadori, 1995
La Rivoluzione russa / A. Wood. – Il mulino, 1999
Cap. 20. 1929: il grande crollo dell’economia
La grande depressione, sopraggiunta alla fine degli anni Venti a seguito di un’inversione nel ciclo economico americano e aggravata dal crollo della borsa, rappresentò un fenomeno drammatico che coinvolse quasi tutti i paesi del mondo. Fra le varie conseguenze, furono notevoli il calo della produzione e il forte aumento del tasso di disoccupazione; la crisi del ’29 pose fine all’egemonia della teoria economica del laissez-faire e il ruolo dello Stato nella vita economica divenne più attivo proprio allo scopo di evitare l’insorgere di altri squilibri di tale portata. Le varie strategie di politica economica tese a contrastare gli effetti della crisi si concretizzarono negli anni Trenta nel New Deal, il programma di ripresa attuato da Roosevelt.
La profonda recessione economica che, a partire dal 1929, investì quasi tutti i paesi del mondo è nota come Grande depressione. La stessa data – il 1929 – è divenuta il modo sintetico per indicare quella grave crisi; in particolare nominando il 199 ci si vuole riferire all’autunno di quell’anno, quando il mercato azionario di New York subì un violento crollo e tutte le conseguenze che ne derivarono.
Gli sconvolgimenti determinati dalla crisi del 1929 negli equilibri nazionali e internazionali furono di portata epocale, confrontabili soltanto con quelli di una guerra mondiale. Le difficoltà economiche rafforzarono in Italia i poteri della dittatura, resero più profondo il rancore dei tedeschi verso i paesi vincitori della Grande guerra e favorirono l’ascesa di Hitler al potere, inducendo anche i paesi non totalitari ad adottare politiche protezionistiche ostili. L’assetto internazionale che ne emerse conteneva ormai in sé tutti quei fattori che avrebbero determinato poco tempo dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale.
- La smania speculativa
Durante la Prima guerra mondiale gli Stati Uniti avevano fornito ai paesi dell’Europa beni e risorse finanziarie necessari a sostenere i bisogni delle loro economie di guerra. Alla fine del conflitto la America del nord si trova pertanto nella vantaggiosa posizione di paese creditore netto, che l'avrebbe in breve portata al ruolo la guida dell’economia mondiale. Oltre a godere di condizioni favorevoli in fatto di materie prime (tra le quali il petrolio, che in quegli anni cominciava a diventare una risorsa chiave per lo sviluppo dei trasporti) e al rapido progresso tecnologico, Gli Stati Uniti adottarono negli anni 20 politiche economiche che favorirono il loro sviluppo. Gli aumenti dei dazi sulle importazioni i beni stranieri che mirava a proteggere i beni americani dalla concorrenza mondiale, la sospensione delle leggi antitrust che incoraggiarono le concentrazioni industriali e lo sviluppo di grandi società finanziarie, la creazione all'estero di imprese di proprietà americana furono tutti elementi che consentiranno agli imprenditori statunitensi di realizzare profitti molto più elevati che in passato; inoltre, le autorità politiche americane del dopoguerra, d'accordo con i sindacati, imposta sono restrizioni all'immigrazione, limitando le quote di lavoratori in entrata; questo fattore, unito alla convinzione degli imprenditori che percependo salari più elevati i lavoratori sarebbero stati più produttivi e più fedeli, consente anche agli operai di godere di condizioni economiche più favorevoli. Gli anni '20 furono quindi per gli Stati Uniti un periodo di espansione produttiva, il progresso tecnologico e di prosperità. Va detto però che diversi settori della popolazione americana rimasero esclusi dai benefici dell’espansione economica: gli agricoltori, per esempio, dopo la caduta della domanda dei loro beni da parte dell'Europa dovuta alla fine della guerra virgola non riusciranno a risollevarsi. Anche lo stato di degrado delle periferie urbane rivelava che la nuova ricchezza non si era distribuita equamente e chi ampi strati della popolazione erano rimasti in una situazione di grande povertà. Durante tutto il decennio le fluttuazioni economiche non mancarono, ma furono tanto lievi e di breve durata da fargli tenere che gli Stati Uniti fossero entrati definitivamente in una nuova era di progresso e di benessere.
Questa convinzione si diffuse e si radicò talmente nella popolazione che i cittadini americani cominciarono a credere che arricchirsi fosse un’attività semplice e veloce. Si verificò un boom degli investimenti immobiliari, si acquistarono terreni specialmente in Florida perché si riteneva che, grazie al suo clima e alle nuove vie di comunicazione, sarebbe diventata la meta di un continuo e crescente turismo annuale. Ma non si compravano terreni per edificare, si compravano per rivenderli, quindi con intenzioni speculative, e più si comprava più i prezzi dei lotti di terra aumentavano, fornendo profitti facili rapidi e rafforzando la convinzione che arricchirsi fosse alla portata di tutti. Queste stesse motivazioni e questo stesso meccanismo caratterizzarono il boom della borsa che precedette il crollo dell’autunno del 1929. Il mercato azionario cominciò la sua lunga scesa nel 1927: gli investitori americani avevano cominciato a comprare azioni alla borsa di New York in vista del rialzo del loro prezzo, che inevitabilmente si verificava perché altri investitori desideravano comprare con lo stesso obiettivo , quindi chi aveva comprato titoli a un certo prezzo trovava sempre gli acquirenti a cui venderli a prezzi più elevati. Com'era venuto per la speculazione immobiliare, si organizzarono sistemi di finanziamento, a riporto, grazie ai quali era possibile acquistare azioni senza pagare interamente il prezzo e così non sono i ricchi, ma, in tutta l’America, strati di popolazione più diversi furono contagiati da questa febbre virgola che dalla borsa di New York e si era estesa alle borse americane più periferiche; si organizzò la possibilità di operare in borsa persino dai transatlantici. Quella della fine degli anni '20 fu una vera e propria smania speculativa, dovuto all euforia che si alimentava che il fatto che le aspettative più facile guadagni puntualmente si realizzavano.
- Conclusioni
La crisi del 1929 inferse un colpo molto duro, anche se non definitivo, alla fede nel laissez-faire. il tipo di capitalismo che mersa della ripresa non era più quello che era stato fino agli anni '20 perché il ruolo dello Stato nella vita economica era diventato più attivo e responsabile. Anche la percezione delle forze economiche da parte della gente comune ne uscì profondamente modificata. Negli anni Venti i cittadini di tutto il mondo o avevano speculato in borsa, o tenevano i loro risparmi depositati in banca, ricevevano un reddito lavorando in proprio o presso qualche impresa. Con la grande depressione ognuno di essi capi che cos'è una crisi finanziaria, valutaria che devi economica perdendo i risparmi investiti in borsa, occorrendo a recuperare quelli depositati in una banca che stava per fallire, vedendo scendere i prezzi dei propri prodotti, o perdendo il posto di lavoro nelle imprese che chiudevano i battenti. Non solo i gli esperti di problemi economici e finanziari, ma anche la gente Comune di ogni paese si rese conto che l'economia ha un fondamento ciclico con fasi depressive che possono durare anche molto a lungo EI cui effetti negativi ricadono su tutti. Dopo quella crisi virgola che sembrava senza confini nello spazio e nel tempio, anche il modo di pensare diffuso subì una svolta, si rivede più attenti a fenomeni che prima arrivano distanti e innocui per la maggior parte dei cittadini e si livella infine più coinvolti nel giudicare le azioni di politica economica adottate dai governi.
Bibliografia
Il dollaro: una storia monetaria degli Stati Uniti, 1867-1960 / M. Friedman … et al. – Utet, 1979
Il grande crollo / J. K. Galbraith. – Bur, 2009
Industria e banca nella grande crisi, 1929-1934 / a cura di G. Toniolo. – Etas, 1978
Cap. 21. 1936: la guerra civile spagnola e lo scontro tra fascismo e antifascismo / di Alfonso Botti
La guerra civile che ebbe inizio nel luglio del 1936 e che insanguinò la Spagna per quasi tre anni fu la conseguenza di un colpo militare che riuscì solo in parte per le resistenze incontrate in circa la metà del territorio nazionale. Scoppiata per motivi prossimi e remoti che affondano le radici nella storia del paese iberico, essa si internazionalizzò immediatamente per gli aiuti che i ribelli ottennero dapprima da Mussolini e Hitler, poi dall’Unione Sovietica e dai volontari antifascisti accorsi da tutto il mondo per difendere la repubblica. Per tre anni il paese iberico fu teatro di uno scontro tra fascismo ed antifascismo che allora apparve decisivo, ma che in realtà ebbe soluzione solo alcuni ani dopo con la vittoria degli alleati nella Seconda guerra mondiale.
I generali che provocarono l’alzamiento dal 17-18 luglio 1936 non pensavano che esso si sarebbe trasformato in una lunga e sanguinosa guerra civile. Il loro piano era quello di agire con la massima tempestività e violenza proprio per stroncare sul nascere la possibilità di risposta e reazione popolare. Tra di loro vi erano monarchici e repubblicani, privi entrambi di un progetto condiviso su che cosa fare dopo. Li accomunava la volontà di mettere fine ai conflitti sociali, sventare la minaccia di un progressivo scivolamento del paese verso il comunismo (spauracchio con il quale erano avvezzi indicare qualunque cambiamento in senso democratico o a favore dei lavoratori), difendere l’unità territoriale che consideravano minacciata dalle spinte autonomiste di catalani e baschi, ristabilire, in definitiva, l’ordine e con esso l’assetto sociale precedente il 1931. Puntavano a instaurare una dittatura militare come quella che il generale Miguel Primo de Rivera aveva imposto al paese nel 1923. La Spagna del 1936, però, non era più quella dell’inizio degli anni Venti e, dopo il consolidamento del fascismo in Italia e l’avvento al potere di Hitler, neppure l’Europa era più la stessa. Con lo scoppio della guerra civile, così, la Spagna divenne la frontiera più avanzata dello scontro tra fascismo e antifascismo.
P. 317
Bibliografia
La guerra civile spagnola / A. Beevor. – Rizzoli, 2006
La guerra di Spagna: uan tragedia nazionale / B. Bennassar. – Einaudi, 2006
La guerra civile spagnola / H. Browne. – Il Mulino, 2000
L’eclissi della democrazia: la guerra civile spagnola e le sue origini, 1931-1939 / G. Ranzato. – Bollati Boringhieri, 2004
Storia della guerra civile spagnola / H. Thomas. – Einaudi, 1963
Cap. 22. La Seconda guerra mondiale
La Seconda guerra mondiale inizia nel 1939, con l’aggressione della Germania alla Polonia. Nel 1940 la Germania sembra vicina alla vittoria: l’Italia si schiera al suo fianco, la Francia è costretta alla resa e la Gran Bretagna rimane da sola a combattere. Nel 1941 la Germania invade l’Unione Sovietica ma viene sconfitta: il Giappone, alleato di Italia e Germania, attacca gli Stati Uniti a Pearl Harbor. Tra 1942 e 1945 i paesi dell’Asse vengono sconfitti: l’Italia si arrende nel 1943, la Francia è liberata nel 1944. Nel maggio 1945 i russi conquistano Berlino, Hitler si uccide e in Europa la guerra ha termine. Il Giappone resisterà fino al settembre successivo, quando si arrenderà dopo essere stato colpito dalle prime bombe atomiche.
- Le origini e l’inizio della guerra
Il secondo conflitto mondiale viene convenzionalmente fatto iniziare alle 4.45 del 1° settembre 1939, quando le armate tedesche invasero la Polonia provocando la reazione di Gran Bretagna e Francia, che dichiararono guerra alla Germania. Ma l’aggressione alla Polonia fu solo l’ultimo atto della politica revisionistica condotta da Adolf Hitler al fine di rivoluzinare l’ordinamento europeo stabilito dai trattati di pace del 1919. Fin dal 1933 Hitler aveva sistematicamente violato i limiti imposti alla forze armate tedesche, ripristinando la coscrizione obbligatoria e avviando un imponente programma di riarmo (fondazione della Wehrmacht, 1935). Nel marzo 1936 truppe tedesche occuparono la Renania, provincia demilitarizzata amministrata dalla Società delle Nazioni. Nel marzo 1938 l’Austria venne annessa alla “Grande Germania” (Anschluss), unione espressamente proibita dal trattato di Versailles. Infine, nell’estate 1938, Hitler proclamò la sua volontà di incorporare nel nuovo “Terzo Reich” il territorio dei Sudeti, regione di confine della Repubblica cecoslovacca a prevalenza germanofona. La Cecoslovacchia era una creatura di Versailles: pensata dalle potenze vincitrici come stato cuscinetto da opporre a un eventuale riarmo tedesco, faceva parte anche del “cordone sanitario” antisovietico (con la Polonia e gli stati baltici) e la sua sicurezza era garantita da Francia e Gran Bretagna. Tuttavia, nel corso della Conferenza di Monaco (settembre 1938) queste e l’Italia acconsentirono alle richieste di Hitler. La Cecoslovacchia cessò di esistere come stato indipendente, dopo aver ceduto i Sudeti, nel marzo 1939 venne smembrata in un “governatorato di Boemia e Moravia” (amministrato da Berlino) e in una Slovacchia formalmente autonoma. Le democrazie occidentali furono accusate di aver sacrificato la Cecoslovacchia nel tentativo di arrivare a un compromesso con Hitler (politica dell’appeasement). Va sottolineato che l’opinione pubblica e gli ambienti politici a Parigi e a Londra erano in maggioranza contrari alla guerra. Inoltre, benché il regno Unito e la Francia si stessero riarmando fin dal 1936, era convinzione comune che non fossero ancora in grado di sfidare la Wermacht, le cui potenzialità erano sopravvalutate. In ogni caso, la distruzione della Cecoslovacchia dimostrò il fallimento della politica di mediazione. Nel marzo 1939 venne sottoscritto un accordo militare anglo-polacco, mentre gli Stati maggiori francese e inglese iniziarono a coordinare una difesa comune. La possibilità che tali iniziative potessero intimidire Hitler venne però meno con la stipula di un patto di non aggressione russo-tedesco (patto Ribbentrop-Molotov) mediante il quale la Germania si assicurava ka benevolenza dell’URSS in cambio della cessione della Polonia orientale.
P. 325-26
Bibliografia
Fronte orientale / O. Bartov. – Il mulino, 2003
La Seconda guerra mondiale / J. Bourke. – Il mulino, 2005
Storia della Seconda guerra mondiale / A. Hilgruber. – Laterza, 1989
La strada della vittoria: perché gli alleati hanno vinto la Seconda guerra mondiale / R. Overy. – Il mulino, 2002
Le origini della Seconda guerra mondiale / R. Overy. – Il mulino, 2009
La Seconda guerra mondiale / G. Schreiber. – Il Mulino, 004
Cap. 23. 1949: la Rivoluzione cinese
Dopo una lunga guerra civile tra i nazionalisti e i comunisti, inframmezzata dalla ricomposizione il fronte in chiave antinipponica, il 1° ottobre 1949 viene proclamata, dal leader comunista Mao Zedong, la nascita della Repubblica popolare cinese. Da questo momento inizia un processo di ricostruzione del paese che passa attraverso l'attuazione di una serie di importanti riforme già lì, economiche e politiche. Oltretutto, la polarizzazione provocata dalla guerra fredda non risparmierà la neonata Repubblica popolare cinese piccola che dovrà decidere al fianco di chi sia schierarsi.
- Alle origini della Rivoluzione
Il partito comunista cinese (Pcc) nacque il 1° luglio 1921 a Shanghai, allorché 12 delegati si incontrarono Dimmi rappresentanza di oltre 50 membri dei gruppi locali il primo congresso nazionale. Molto probabilmente, pochi tra questi delegati avrebbero scommesso che, documento di trent'anni, quella stessa formazione sarebbe arrivata a dominare la scena politica cinese. il partito comunista cinese era virgola in un certo senso, figlio delle aspettative originatesi in Cina in seguito alla rivoluzione di ottobre che traeva forza da una generazione di studenti, attivisti e professori che desideravano fortemente sanare le profondissime diseguaglianze sociali presenti nel paese.
Il secondo congresso del partito comunista cinese si tende di nuovo a Shanghai nel luglio del 1922 che segnò una svolta e Levante per la vita del giovane partito: base alle indicazioni del Comintern, ai quali il partito comunista cinese si era iscritto formalmente, ho deciso che i comunisti avrebbero dovuto cercare un’alleanza politica con i rappresentanti del “movimento democratico borgese illuminato”. Solo attraverso questa strada, infatti, il partito comunista cinese avrebbe potuto sperare di diventare un attore rilevante nello scenario politico cinese. così che si andò verso la composizione di un “fronte unito” con il Guomindang, il partito nazionalista guidato dall’autorevole Sun Yatsen. L’alleanza tra l’ala destra e quella sinistra del partito. Però, diventò sempre più instabile in seguito alla morte di Sun, nel marzo 1925, e peggiorò quando il controllo del movimento nazionalista passò nelle mani dell’ambizioso Jiang Jieshi (Chiang Kai-Shek), comandante dell’Accademia militare di Huangpu. Quest’ultimo, infatti, fece di tutto per marginalizzare i comunisti, imponendo loro delle restrizioni nella partecipazione alla vita del partito nazionalista.
Diventato comandante in capo dell'esercito rivoluzionario nazionale, Jiang Lanciò alla fine di luglio 1926 la cosiddetta “spedizione settentrionale”, il cui obiettivo era quello di porre sotto controllo i signori della guerra, cioè coloro che al crollo della dinastia Qing, del 1911, si erano divisi potere nella maggior parte della Cina settentrionale: l'obiettivo dichiarato era quello di riunificare il paese sotto l'egida del Guomindang. La campagna riscosse un enorme successo che, dopo aver conquistato Shanghai in marzo, Young deciso di approfittarne per regolare i conti con i comunisti colpendoli a tradimento e passando per le armi gran parte del nucleo originario del partito comunista cinese. Dopo sfasciato di fatto l'alleanza con i comunisti, Jiang venne nominato presidente del nuovo governo nazionale nel 1928: si trattava in effetti di una dittatura militare con una limitatissima base di potere popolare. La sconfitta dei signori della guerra e la riunificazione gran parte del paese non avevano comunque risolto i grandi problemi che affliggevano la Cina: un sistema economico precario, una diffusa povertà che tormentava le zone rurali, l’esteso problema della corruzione. Più che di occuparsi di dare una soluzione a tali questioni, Jiang spendeva le sue energie nella lotta al partito comunista cinese che, nonostante fosse ormai un organizzazione clandestina, aveva fatto breccia tra gli agricoltori e gli allevatori impoveriti. alcune grandi basi rivoluzionarie comuniste immerso nella Cina centrale e meridionale: una di quelle grandi in assoluto, quella dello Jiangxi - una delle zone più remote e povere dell’intero paese - era comandata da un giovane leader di nome Mao Zedong. In antitesi all’impero sovietico, ma ho prevedeva che la spina dorsale della rivoluzione comunista cinese dovesse essere costituita dagli agricoltori che non dai lavoratori delle zone urbane o dagli intellettuali.
La lotta alle basi comuniste divenne una delle priorità assolute delle campagne militari dei nazionalisti. Nel corso delle 5 campagne di “accerchiamento e ambientamento” le truppe di Jiang minacciarono seriamente la stabilità della base nello Jiangxi. i leader comunisti, allora, deciso di sfuggire alla minaccia nazionalista dando inizio nell'autunno del 1934 alla lunga marcia, durata fino alla fine del 1935. I comunisti attraversando il paese da sud a nord, percorrendo migliaia di chilometri e pagando un tributo enorme in termini di vite umane. Nel gennaio del 1935 , nel corso della lunga marcia, sei una storica riunione allargata dell'ufficio politico del comitato centrale piccolo nota come conferenza di Zunyi: In seguito a questo incontro, l'influenza del Comintern sul partito comunista cinese risultò significativamente ridotta e virgola al contempo, la figura di Mao cominciò ad assumere sempre maggiore centralità nell’organizzazione.
Il periodo che va dal 1936 al 1945, indicato anche come periodo di Yan’an (cioè il luogo in cui Mao stabilì la capitale dell’esercito comunista), Fu di centrale importanza per una molteplicità di ragioni. In primis i comunisti EI nazionalisti dettero vita a un secondo fronte unito per cercare di arginare l'invasione dei giapponesi, avvia tesi in grande stile nel 1936. dopo un decennio di lotta ai comunisti, Jiang Costretto dai suoi generali ad accettare la decomposizione di fronte come l'unica possibilità per contrastare i giapponesi. Nonostante ciò, il conflitto tra comunisti e nazionalisti non si risolse completamente , con le due parti che continuare a combattersi a vicenda. Gradualmente, però, furono i comunisti a ottenere un maggiore vantaggio, dotandosi di un contingente militare sempre più nutrito e ampliando progressivamente le zone sottoposti al loro controllo. Questa espansione coincise con la maturazione di tutta una serie di esperienze in campo amministrativo che organizzativo che vennero portati avanti nelle basi e rivoluzionarie in particolare nella roccaforte di Yan’an, E che entrarono a far parte di quel bagaglio culturale che avrebbe accompagnato il partito dopo il 1949. Non bisogna scordare, inoltre, la profonda opera di riorganizzazione e consolidamento messa in atto da Mao in quel periodo, che consente al partito di passare da 40.000 iscritti nel 1937 a circa 1.200.000 nel 1945.
L’invasione su larga scala della Cina da parte dei giapponesi nel 1937 spinse Jiang e il suo governo a fronteggiare gli invasori, i quali avevano utilizzato la base in Manciuria per espandere il loro controllo nelle contee a Nord della grande muraglia e nella Mongolia interna. I primi passi dell’invasione giapponese cominciarono il 7 luglio 1937, nei pressi di Pechino; un secondo fronte si aprì quasi immediatamente a Shanghai. L’avanzata sembrava inarrestabile e, sul finire della stagione estiva, le città a Nord del Fiume Giallo erano ormai cadute nelle mani dei nipponici. Nel dicembre di quell’anno i giapponesi avevano occupato con successo Shanghai e attaccato in maniera brutale Nanchino, costringendo Jiang e il suo governo a rifugiarsi nell’entroterra, a Chongqing. Intrappolato all’interno del paese, senza poter contare sulla produttività o sule finanze delle industrie dell’Est, il governo nazionalista – nelle aree da esso controllate – dovette fare ricorso all’imposizione di una pressione fiscale insostenibile, subito seguita dalla coscrizione coatta. Queste vessazioni furono mal sopportate e generarono una crescente ostilità verso il governo di Jiang in tutti i settori della popolazione. Solo la sconfitta giapponese da parte degli alleati, nel 1945, mise Jiang nelle condizioni di riguadagnare il controllo del suo paese.
La fine della Seconda guerra mondiale, tuttavia, non consegnò la pace alla Cina. Al contrario, i comunisti cominciarono a far pesantemente leva sulla propaganda per contrastare i nazionalisti: Essi furono involontariamente aiutati dagli insufficienti risultati dell’azione del governo nazionalista nei mesi immediatamente successivi alla vittoria alleata nella Seconda guerra mondiale. La ripresa del controllo sulla Cina orientale fu caratterizzata da molteplici episodi di corruzione da parte dei funzionari nazionalisti, che ammassarono ingenti fortune a spese della popolazione che aveva dovuto sopportare la dominazione giapponese per otto lunghi anni.
L’animosità tra i comunisti e i nazionalisti riemerse prepotentemente nonostante gli sforzi volti alla mediazione fatta dagli americani. Nel 1946, infatti, la Cina entrò in una brutale guerra civile (1946-49), in cui il confronto tra le due parti fu eminentemente militare. I nazionalisti di Jiang, fruendo dei cospicui aiuti – finanziari e militari – degli americani, erano numericamente di gran lunga superiori alle forze dell’Armata di liberazione popolare dei comunisti. Dopo che i nazionalisti si furono aggiudicati una serie di rapide vittorie, tutto lasciava presagire che Jiang e i suoi avrebbero avuto la meglio sui loro oppositori. L’inadeguata leadership militare e il bassissimo morale tra le truppe nazionaliste, intimamente connesso alla capacità di conquistare la fiducia e la collaborazione delle masse sa parte dei comunisti, sovvertirono le sorti del conflitto. Tra il 1947 e il 1948 una serie di significative sconfitte in Manciuria mostrarono la superiorità dei comunisti. Jiang fu costretto a indietreggiare e, come ultima ratio, non poté far altro se non sfuggire sull’isola di Taiwan aspettando, con le sue truppe, un attacco finale che non arrivò mai. Al contrario, nell’estate del 1949, il Pcc cercò di consolidare il suo potere all’intero territorio continentale, distogliendo la sua attenzione dalla colonia britannica di Hong Kong, da quella portoghese di Macao e, par l’appunto, di Taiwan, ove i nazionalisti sconfitti avevano trovato rifugio.
In qualità di nuovo leader, Mao Zedong proclamò la nascita della Repubblica popolare cinese il 1° ottobre 1949 a Pechino, da un podio da cui dominava Tian’an men, la “Porta della pace celeste”. La “Cina si è rialzata”, dichiarò il “grande timoniere”, inseguendo in tal modo una nuova era della storia cinese.
P. 333-336
Bibliografia
La Cina dal 1949 ai giorni nostri / M. Bergère. – Il mulino, 2003
Storia della Cina / J. A. G. Roberts. – Il mulino
La Cina del Novecento / G. Samarami. – Einaudi, 2004
Storia della Repubblica popolare cinese / L Tomba. – B. Mondadori, 2002
Cap. 24. 1950: La guerra di Corea / di Antonio Fiori
La guerra di Corea, ancora poco studiato in occidente, costituì il primo grande conflitto internazionale dopo la fine della seconda guerra mondiale punto fisso rappresenta o uno snodo fondamentale per lo sviluppo della guerra fredda , mostrando chiaramente come nel secondo dopoguerra il mondo fosse diviso in due sfere di influenza rigide e in conflitto tra di loro. Lo studio del conflitto coreano evidenza il destino di un paese distrutto e tragicamente separata virgola che ancora oggi soffre le conseguenze della guerra fredda.
- Alle origini del conflitto
Il 15 agosto del 1945 virgola non appena si diffuse la notizia della dichiarazione di resa pronunciata dall’imperatore giapponese Hirohito, i cittadini coreani Corte erano liberare tutta la loro gioia Ehi e l'intera penisola prodotti in festeggiamenti. L'occupazione nipponica, cominciato ha formalmente nel 1910, era giunta al termine, anche se il prezzo della colonizzazione era stato estremamente alto per la Corea, che ne uscì molto provata. Nessuno, in quel preciso istante, avrebbe potuto immaginare il quale terribile sorte il destino aveva in serbo per la penisola coreana.
Già molto tempo prima della fine della guerra si era cominciato a discutere sulle modalità attraverso le quali disporre dei possedimenti coloniali nipponici. Alla conferenza del Cairo, nel novembre del 1943 com'è il presidente americano Roosevelt, il p rimo ministro inglese Churchill e il leader del partito nazionalista cinese Jiang Jieshi (Chain Kai-shek) Si incontrarono per coordinare l'azione degli alleati contro l'impero giapponese e stabilire le successive mosse da intraprendere in Asia nel dopoguerra. I tre , oltre a ribadire la loro ferma convinzione di continuare a combattere contro il Giappone fino alla sua resa incondizionata, conclusero che le colonie nipponiche, a inclusione della Corea, avrebbero guadagnato la loro libertà e indipendenza a tempo debito, dopo un periodo più o meno lungo di amministrazione fiduciaria da parte delle grandi potenze. Successivamente, nel Febbraio del 1945, Roosevelt e Churchill Incontrarono Stalin alla conferenza di Yalta; Il leader sovietico accettò l'idea di una amministrazione fiduciaria per la Corea , anche se questo avrebbe dovuto essere di breve durata. In quella sede si decise, inoltre, l'unione sovietica, alla fine del conflitto in Europa, sarebbe intervenuta contro i giapponesi in Manciuria e Corea, in modo da alleggerire la pressione sugli Stati Uniti, ti avrebbero così potuto concentrarsi sul Giappone. I sovietici, infatti, dichiararono guerra al Giappone lotta agosto 1945 e virgola quasi contestualmente, cominciarono a penetrare in territorio coreano dal confine di nord est.
Gli americani cominciarono ben presto a tenere i sovietici avrebbero finito per occupare l'intera penisola: Eh sì non erano ancora pronti a partecipare all'occupazione della Corea né tantomeno potevano a quel punto combattere contro i sovietici per scacciarli dal territorio coreano. Si pensò, quindi dietro di arrestare l'avanzata sovietica in Corea proponendo a Stalin, da una parte preoccupato per la superiorità militare degli americani e virgola dall'altra, desiderosa di giocare un ruolo nell’occupazione del Giappone, non si oppose la proposta degli statunitensi, avallando così la creazione di due aree di occupazione sul suolo coreano.
All'inizio di settembre del 1945, quando le truppe statunitensi comandate dal generale John R. Hodge giunsero sulla penisola trovare una situazione politica intricata e orientata a sinistra. Per arginare questa deriva, gli americani deciso di appoggiare, come futuro leader, Syngman Rhee, Acceso nazionalista e fervente anticomunista. Al nord, invece, la scelta dei sovietici cambia su un giovane uomo, Kimi il Song virgola che si era particolarmente contraddistinto in Manciuria negli anni '30 nella nelle fila della resistenza coreana in funzione antigiapponese.
Sin dai primi mesi dell’amministrazione controllata divenne chiaro che nella penisola coreana stavano nascendo due entità statuale nettamente distinte e separate. Nonostante ciò, ancora nel dicembre del 1945, quando le potenze alleate si incontrarono la conferenza dei ministri degli esteri a Mosca, non solo si convenne sul carattere di transitorietà della fase di occupazione della Corea, ma anche sulla necessità di dar vita a una commissione congiunta, sovietico americana virgola che avrebbe dovuto gettare le basi per la formazione di un governo coreano unificato appunto tale soluzione, tuttavia, oltre a non soddisfare le legittime aspirazioni di autogoverno dei coreani, non poteva prevedere l'imminente e netto peggioramento delle relazioni tra Unione Sovietica e Stati Uniti virgola che sfociò nel 1947 nell’inizio della guerra fredda.
Nel novembre del 1947, vista la situazione di stallo in cui versava la commissione congiunta, venne creata dalle Nazioni Unite, peraltro largamente controllate dagli Stati Uniti, la Commissione temporanea delle Nazioni unite sulla Corea.
Tale organismo avrebbe dovuto accompagnare il paese a elezioni generali, facilitando in questa maniera la nascita di un governo coreano indipendente e, di conseguenza, di un Parlamento unico. il trasferimento di potere a questa istituzione avrebbe determinato conseguente abbandono della penisola da parte degli occupanti americani e sovietici, lasciando ai coreani la piena sovranità sul proprio territorio. Sperare che una delle due superpotenze potesse fare delle concessioni all'altra in questo frangente era tuttavia in realistico, e infatti i sovietici si rifiutarono di riconoscere qualsivoglia autorità alla neonata commissione, prendendo così di fatto impossibile l indizione di elezioni al nord.
le elezioni volte a dar vita a un assemblea nazionale si tenero nella sola parte meridionale nel maggio 1948, e videro la definitiva consacrazione politica di Syngman Rhee. Quest'ultimo, infatti, venne nominato presidente il 20 luglio di quell'anno, mentre il 15 agosto fu proclamata formalmente la nascita della repubblica di Corea. L'assemblea generale delle Nazioni unite preso atto della validità delle elezioni tenutesi al sud, dichiarando quello appena eletto il solo doverne legittimo della Corea. Le autorità del nord risposero proclamando a loro volta le edizioni virgola che sanciranno, il 9 settembre 1948, la nascita della Repubblica democratica Popolare di Corea in cui Kim Hill Song assume la carica di primo ministro. La penisola coreana era ormai inesorabilmente spaccata in due.
La repubblica di Corea dovette confrontarsi con una serie innumerevole di difficoltà nei suoi primi anni di vita. la cronica instabilità politica del periodo immediatamente successivo alla liberazione si era evoluta in insurrezione aperta, sotto forma di guerriglia, nell’estate del 1948. Rhee Non aveva sostanzialmente alcuna opposizione nel paese, sia per il limitato spazio di manovra assegnato all’assemblea nazionale, sia per l'uso sfrenato che egli fece della legge di sicurezza nazionale, ricorrendo alla quale poteva mettere a tacere i suoi oppositori senza ostacoli. Alcune settimane prima dello scoppio della guerra, Rhee Incontrò a Seul il futuro segretario di Stato americano John Foster Dulles , con il quale ebbe un colloquio in cui non si parlò solo di un impegno americano nella difesa della parte meridionale della Corea birra ma probabilmente anche della possibilità di sferrare un attacco sul nord.
Anche Kim il sung aveva cominciato a prendere in considerazione la possibilità di procedere alla riunificazione della penisola; per questo motivo, alla fine di Febbraio del 1949 egli si recò a mosca virgola dovrebbe un incontro con Stalin, con il quale discusse dell’opportunità di lanciare un attacco sulla parte meridionale della Corea. Stalin, inizialmente poco favorevole a un’azione di questo tipo, fu convinto dalle rassicurazioni di Kim, secondo cui l'attacco avrebbe comportato scarsi rischi e successo assicurato e, soprattutto, dalla mutata situazione in Cina, dove i comunisti avevano ormai raggiunto il potere. In aggiunta, la dichiarazione fatta nel gennaio 1950 dal segretario di Stato americano, Dean Acheson, secondo cui la linea difesa statunitense avrebbe incluso il Giappone e le Filippine, lasciando fuori la Corea e Taiwan, potrebbe avere acceso le speranze di successo di Stalin, Kim e mouse.
Bibliografia
La guerra di Corea / S. Hugh Lee. – Il Mulino, 2003
Cap. 25. 1956: una svolta del secolo? / di Stefano Bottoni
Idealmente iniziato a febbraio, con il 20º congresso del Pcus e la denuncia dei crimini di Stalin pronunciata da Cheuscev, il 1956 si chiude simbolicamente a inizio novembre con la sanguinosa repressione della rivolta ungherese da parte dei carri armati sovietici. Fu un anno di crisi internazionali anche al di fuori del blocco sovietico, con l'aggressione anglo francese dell'Egitto e la crisi di Suez. Il rafforzamento dell'egemonia americana e sovietica all’interno delle rispettive sfere di influenza Apri la strada a forme di convivenza più o meno pacifica tra i blocchi politico militari della guerra fredda, metti la capacità dimostrata da Mosca di bloccare ogni spinta centrifuga garantì per decenni la sopravvivenza dell'impero sovietico.
- Il 20° congresso del Pcus e il suo impatto in Europa orientale
Il 1956 fu un anno di rinnovamento e di crisi, che chiuse la fase di più aspro confronto della guerra fredda per aprirne una più aperta e dinamica, sebbene non meno conflittuale. In realtà, i meccanismi che avrebbero portato ai conflitti esplosi quell’anno si erano già innescati in seguito alla morte di Stalin, avvenuta il 5 marzo 1953. Alla destalinizzazione avviata in Unione Sovietica e nel blocco orientale (il “disgelo” nelle parole dello scrittore Il’ja Grigorievic Erenburg), si accompagnò la graduale ripresa di rapporti tra l’URSS e la Jugoslavia di Tito e la fondazione, nel 1955, del movimento dei paesi non allineati, guidati dal primo ministro indiano Nehru e dal presidente egiziano Nasser. Nello stesso 1955 i paesi del blocco sovietico avevano formalizzato la propria cooperazione militare mediante la costituzione del Patto di Varsavia, un’alleanza dell’assetto strategico offensivo contrapposta alla Nato.
Fu tuttavia il 20° Congresso del Pcus a dare avvio a un’ondata di cambiamenti che avrebbe presto sconvolto equilibri ritenuti consolidati non solo all’interno del blocco sovietico, ma nell’intera rete delle relazioni internazionali. Il rapporto sui crimini e gli errori di Stalin, letto nella notte del 24-25 febbraio 1956 dal segretario del Pcus Nikita Krushev, gettò nel panico i partiti comunisti europei, i cui leader provenivano senza eccezione dall’esperienza politica e culturale dello stalinismo, e provocò nel blocco sovietico una grave crisi di legittimità. In aprile fu sciolto il Cominform, ormai svuotato di ogni funzione dopo la riconciliazione con Tito. In polonia e in Ungheria l’ammissione degli errori e delle illegalità rafforzò le correnti riformiste e contribuì a delegittimare le forze al potere. A Varsavia il rapporto “segreto” divenne di pubblico dominio pochi giorni dopo la morte del segretario comunista Bierut. Nei dibattiti pubblici organizzati durante la primavera il partito polacco si divise fra coloro che intendevano riformare le istituzioni dello stalinismo ei conservatori, con il nuovo segretario Edward Ochab nel ruolo di mediatore. La censura fu allentata, il parlamento riacquistò un più alto profilo pubblico, molti oppositori furono rilasciati, mentre Wladislaw Gomulka si riaffacciava alla vita politica dopo anni di ostracismo. Nella primavera-estate del 1956 molti polacchi non respingevano il sistema comunista in quanto tale, ma ne chiedevano una declinazione più umana e “nazionale”.
L’illusione di una liberalizzazione controllata si spezzò con la rivolta scoppiata nel centro industriale di Poznan il 28 giugno. Nata come un conflitto sindacale di carattere economico, la protesta degli operai del complesso metallurgico intitolato a Stalin si trasformò, il 29-30 giugno, in un’insurrezione repressa nel sangue dalle forze speciali polacche, sostenute da contingenti sovietici. La rivolta destò impressione a Varsavia come a Mosca. Il 18 luglio, il 7° Plenum del CC del partito polacco fissò norme per il ripristino della “legalità”, mentre l’interpretazione ufficiale della rivolta di Poznan si premurò di distinguere fra i pochi provocativi e la moltitudine degli onesti, che rivendicavano migliori condizioni di lavoro e la rimozione dei dirigenti compromessi.
In autunno lo stato di agitazione si allargò a tutto il paese, coinvolgendo non solo operai (questi ultimi riuniti in consigli elettivi), Ma anche contadini e studenti. I manifestanti chiedevano enorme di lavoro sostenibili, più attenzione ai beni di consumo e la fine della collettivizzazione agricola. i conservatori moscoviti prospettarono concessioni simboliche o demagogiche: la cooptazione di Gomulka nell‘ufficio politico, il rilancio del cardinale Wyszynski, Un aumento dei salari e la purga dei numerosi ebrei dagli apparati statali. La pressione della piazza si esprimeva ormai in assemblee e manifestazioni spontanee convocate in tutto il paese, nelle quali trovava sfogo una posizione diffusa al regime e virgola soprattutto, alla dipendenza del paese dall’Unione Sovietica. L’8° Plenum del CC, convocato per il 19 ottobre in presenza di Gomulka e di una delegazione sovietica al massimo livello si svolse in un clima di recriminazioni reciproche e intimidazioni, mentre le truppe sovietiche avanzavano su Varsavia. Il giorno, 20, all’insaputa dei sovietici, appena tornati a Mosca, Ochab lasciò la carica di segretario generale a Gomulka, mentre diversi “stalinisti” guidati dal ministro della difesa Rokosovskij, furono allontanati dai vertici del partito. La manovra fece infuriare Kruscev, il quale, dopo aver ponderato un intervento militare per reprimere l’insubordinazione di Varsavia, optò per una soluzione politica della crisi in cambio della garanzia della permanenza della Polonia nel Patto di Varsavia. Il 24 ottobre 1956 Gomulka chiese all’immensa folla riunitasi nelal capitale per acclamarlo come un eroe nazionale di sospendere ogni manifestazione e di riprendere il lavoro.
L’ottobre polacco si chiuse dunque con un compromesso politico su tre punti essenziali: la decollettivizzazione della terra e il mantenimento della piccola proprietà contadina; la fine del controllo sovietico sulle strutture militari polacche, con il richiamo dei consiglieri militari sovietici e le dimissioni del ministro della difesa Rokosovskij; e, infine, il rafforzamento dei rapporti con la Chiesa cattolica che implicò il rilancio di Wyszynski, il 28 ottobre. Nei mesi successici alla crisi, le energie sprigionatesi nei dibattiti e nelle manifestazioni dell’autunno si incanalarono in una liberalizzazione controllata. Alle elezioni del maggio 1957, oltre un terzo dei mandati fu assegnato agli alleati contadini e democratici, molti altri a candidati indipendenti e una dozzina al movimento cattolico Znak (simbolo), tollerato dalle autorità e appoggiato dalle gerarchie ecclesiastiche. Ciò avrebbe rappresentato sino al 1989 il massimo di pluralismo politico concesso in Europa orientale da un regime comunista. Nonostante gli spazi di autonomia permessi alla società si restrinsero sin dal 1957-58, l’impatto della destalinizzazione fu così profondo da trasformare la Polonia di Gomulka e dei suoi successori in un sistema politico autoritario ma non più totalitario, dotato di una società vitale e assertiva.
P. 349-51
Bibliografia
Un altro Novecento: l’Europa orientale dal 1919 ad oggi / S. Bottoni. – Carocci, 2011
1956 / M. Flores. – Il Mulino, 1996
L’Europa orientale dal 1945 al 1970 / B. Fowkes. – Il Mulino, 2004
Cap. 26. 1957: i trattati di Roma e le origini dell’integrazione europea
I trattati di Roma (1957) rappresentano il risultato di un cammino decennale compiuto dai paesi dell’Europa occidentale alla ricerca di strumenti di integrazione economica e politica capaci di garantire, nella complessa fase della ripresa postbellica, un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e delle relazioni fra gli stati. Intimamente legata alle evoluzioni della guerra fredda, la prima fase del processo di integrazione europea ha seguito uno svolgimento complesso e a tratti imprevisto. A prevalere nel progetto di costituzione di un’unità politica europea è stata l’ottica funzionalista, orientata a uno sviluppo graduale dell’integrazione, da perseguire attraverso la fusione progressiva di singole nazioni.
- Le origini dell’integrazione e il contesto internazionale
La firma dei trattati di Roma con cui, il 25 marzo 1957, fu sancita l’istituzione della Comunità economica europea (Cee) e della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) costituisce una delle tappe fondamentali del processo di integrazione europea avviatosi nel secondo dopoguerra. Ogni inizio è al tempo stesso un approdo, tanto più se in gioco ci sono fenomeni complessi come la costruzione di ordini economici e politici sovranazionali. Vale dunque la pena richiamare le principali tappe che, non senza sorprese e svolte impreviste, hanno condotto alla definizione, nella seconda metà degli anni Cinquanta, delle basi istituzionali intorno a cui si sarebbe in seguito edificata l’unità europea.
E’ necessario tornare al periodo immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale, poiché è nel panorama di distruzione e desolazione dell’Europa postbellica che hanno preso le mosse i primi tentativi di dare forma a un ordine mondiale capace di evitare nuove cadute nella catastrofe. La vicenda europeista va dunque inquadrata nel più generale contesto politico del dopoguerra, segnato dalla rottura dell’alleanza antihitleriana e da una progressiva polarizzazione del campo ideologico. In seguito all’enunciazione della “dottrina Truman”, in base alla quale gli Stati Uniti si impegnavano a “sostenere i popoli liberi che si oppongono ai tentativi di oppressione da parte di minoranze armate o di pressioni esterne”, e in conseguenza del definitivo fallimento delle trattative tra alleati occidentali e Unione Sovietica per la definizione di un possibile trattato di pace con la Germania, una cortina di ferro calò sull’Europa.
La contrapposizione fra il costituendo blocco occidentale e l’area di influenza sovietica, giocata in buona parte intorno al destino della Germania e alla conseguente ridefinizione degli assetti europei, andò assumendo contorni sempre più accesi. Il varo del piano Marshall, promosso dagli Stati Uniti a sostegno della ricostruzione e della ripresa economica europea, sancì l’inconciliabilità tra i disegni politici americani e quelli sovietici. La successiva costituzione del Cominform (1947), l’organismo che riuniva i partiti comunisti e attraverso il quale l’Unione Sovietica reagiva alla dottrina Truman promuovendo la propria egemonia sui paesi dell’Est, non fece che rendere ancora più esplicita la divisione dello scacchiere internazionale in due blocchi contrapposti, sancendo l’avvio della guerra fredda.
Il colpo di Stato comunista a Praga (25 febbraio 1948), l’avvio del blocco di Berlino imposto da Mosca agli alleati occidentali (20 giugno 1948), la firma a Bruxelles del trattato di difesa collettiva stipulato tra Francia, Gran Bretagna e paesi del Benelux (17 marzo 1948) furono manifestazioni della rapida accelerazione del conflitto, rispetto al quale il braccio di ferro sugli assetti della Germania e la ricerca di nuovi equilibri europei ebbero una rilevanza sostanziale. Nell’ottica di un contenimento della minaccia comunista, la rinascita economica e politica della Germania costituiva infatti per gli Stati Uniti un obiettivo fondamentale, per il perseguimento del quale si rendeva necessaria un’intesa di concertazione a livello sovranazionale. Per il governo americano il rilancio dell’Europa doveva passare dalla ricostruzione della Germania, ma questa non era perseguibile fuori di un’integrazione delle differenti politiche nazionali.
L’instabile fase della ricostruzione postbellica costituiva un terreno fertile per lo sviluppo di ideologie di marca europeista, che iniziarono a confrontarsi sui possibili assetti futuri del vecchio continente. Che non fosse un fronte ideale omogeneo lo dimostrò il Congresso dell’Aja (maggio 1948), che raccolse numerosi delegati da tutta Europa e in seno al quale vennero a confronto tre differenti modi di intendere il processo di integrazione. I “confederalisti” (o “unionisti”), che si richiamavano al progetto paneuropeo promosso nei primi anni Venti da Richard Coudenhove-Kalergi, si spesero per promuovere forme di cooperazione rispettose della piena sovranità dei singoli ordinamenti nazionali. Su un piano diverso si mossero le correnti “federaliste”, orientate al superamento degli stati nazionali in nome di un’architettura istituzionale sovraordinata e dotata di organi legislativi, esecutivi e giudiziari. Una terza via era perseguita dai rappresentanti del cosiddetto “funzionalismo”, prospettiva che mirava a un modello di integrazione graduale ed evolutivo, da esercitare anzitutto nei settori economico-commerciali, cui sarebbe seguita nel tempo una progressiva trasmissione di poteri e funzioni indipendenti di carattere sovranazionale.
La conferenza, promossa e presieduta da Churchill, non giunse a risultati concreti significativi, ma definì i contorni delle prospettive politiche che nel corso degli anni seguenti si sarebbero contese la guida del progetto di riordino della comunità politica ed economica europea. Fu altresì l’occasione in cui si manifestarono in termini evidenti i differenti approcci nazionali all’integrazione: più sensibili a un disegno europeista le delegazioni d Francia, Belgio e Italia, maggiormente vicine a forme più tradizionali di cooperazione intergovernativa le prospettive di Gran Bretagna, Orlanda e paesi scandinavi.
Un primo risultato dell’interazione che nei mesi seguenti si produsse tra movimenti europeisti e governi fu la nascita, il 5 maggio 1949, del Consiglio d’Europa, un organo consultivo nato dall’intesa tra dieci paesi (Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia) con l’obiettivo di definire azioni comuni in ambito economico, sociale, scientifico e culturale. Pur dotato di due organi quali il Comitato dei ministri – composto da rappresentanti dei vari governi – e l’Assemblea consultiva – formata da membri eletti nei parlamenti nazionali – il Consiglio d’Europa ebbe margini di intervento limitati, per via della mancata devoluzione di poteri effettivi dei vari paesi.
Forme di cooperazione economica erano state sperimentate l’anno precedente con l’istituzione dell’Organizzazione europea per la cooperazione economica (Ocse), sorta per organizzare la ricostruzione postbellica resa possibile dagli aiuti del piano Marshall varato nel giugno del 1947. La mancanza di strumenti idonei a dare efficacia alle deliberazioni dell’organizzazione e le azioni di resistenza opposte dalla Gran Bretagna non consentirono peraltro all’Oece di svolgere una funzione di integrazione realmente propulsiva. A fornire uno spunto decisivo all’azione di condivisione delle politiche economiche furono piuttosto, ancora una volta, gli sviluppi della guerra fredda.
Raggiunto un accordo sulle sorti della Ruhr, nodo storico della contrapposizione tra francesi e tedeschi, gli alleati occidentali diedero impulso alla nascita della Repubblica federale tedesca, che venne proclamata nel maggio 1949. Poche settimane prima era stato varato il patto atlantico, l’organizzazione di difesa europea promossa dagli Stati Uniti e realizzata grazie alla mediazione della Gran Bretagna con l’obiettivo di legare i destini militari dei principali paesi dell’Europa occidentale, Italia compresa. Se per gli Stati Uniti si trattava del superamento della tradizionale politica “isolazionista”, per i paesi europei che vi aderirono costituiva un importante passo verso forme di alleanza politica sempre più strutturate.
Bibliografia
Storia politica dell’Unione europea, 1926-2003 / G. Mammarella, P. Cacace. – Laterza, 2003
Storia dell’integrazione europea: dalla guerra fredda alla costituzione dell’Unione / B. Olivi e R. Santaniello. – Il Mulino, 2010
Il rilancio dell’Europa e i trattati di Roma / a cura di E. Serra. – Giuffrè, 1987
Cap. 27. 1960: la decolonizzazione in Africa: un processo incompiuto? / di Mario Zamponi
I processi di decolonizzazione che prendono avvio dopo la Seconda guerra mondiale trovano tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta l’apice della loro realizzazione. In quel periodo la maggior parte dei paesi ex coloniali – ci si sofferma qui in particolare sulla liberazione in Africa delle colonie francesi e britanniche – diventa indipendente ed entra nel consesso internazionale delle nazioni libere e sovrane e il 1960 viene scelto ad emblema del processo storico che pone fine agli imperi coloniali. Proprio nel 1960, ad esempio, ottiene l’indipendenza il Congo belga, simbolo di una decolonizzazione traumatica che investe le stesse Nazioni Unite e che evidenzia la difficoltà della costruzione politica degli stati-nazione postcoloniali.
Le idee e le rivendicazioni di emancipazione politica e sociale che nei territori coloniali di Africa e Asia si erano andate sempre iù rafforzando durante la fase coloniale, dopo le grandi trasformazioni degli assetti mondiali originati dalla fine della Seconda guerra mondiale giungono a compimento. Il processo di decolonizzazione è il risultato congiunto di trasformazioni e di decisioni a livello internazionale unite a processi di riforma degli stati coloniali stessi e alle rivendicazioni politiche e sociali di gruppi e movimenti interni alle colonie (che diverranno poi i movimenti nazionalisti e i partiti al potere nel periodo post indipendenza).
In Asia il processo di decolonizzazione prende l’avvio nell’immediato periodo postbellico: nel 1946 diventano indipendenti le Filippine e, in Medio Oriente, Siria, Libano e Giordania, nel 1947 l’India (anche se con il trauma della spartizione tra India e Pakistan), nel 1947 Birmania (Myanmar) e Ceylon (Sri Lanka), nel 1949 l’Indonesia, mentre nel 1954, con la sconfitta francese in Indocina, si formano gli stati del Laos, Cambogia e il Vietnam viene diviso in due. Nel 1948, inoltre, nasce lo Stato di Israele, mentre si apre la non ancora risolta questione palestinese.
In Africa, dove alla fine della Seconda guerra mondiale soltanto due paesi erano formalmente indipendenti (Liberia e Etiopia) – oltre all’anomali caso del Sudafrica che nel 1948 istituzionalizza il regime dell’apartheid – il secondo dopoguerra produce grandi trasformazioni soprattutto nelle colonie delle due grandi potenze coloniali (Gran Bretagna e Francia), cui si aggiunge il Belgio in una frettolosa decolonizzazione, mentre l’Italia aveva perso le sue colonie a seguito degli eventi bellici (la Somalia nel 1950 viene assegnata all’Italia in amministrazione fiduciaria dalle Nazioni Unite). Il Portogallo, invece, resta irriducibile nelle sue mire coloniali, contribuendo a creare in Africa australe il cosiddetto “bastione bianco”, ossia un sistema regionale incentrato sul controllo delle comunità bianche, composto dalle colonie portoghesi del Mozambico e Angola, dal Sudafrica dell’Apartheid, che amministra anche come propria provincia interna l’Africa del Sud-Ovest (Namibia) – formalmente un mandato assegnato dalla Società delle Nazioni al Sudafrica dopo la Prima guerra mondiale - , cui nel 1965 si aggiunge la Rhodesia (Zimbabwe) con la dichiarazione unilaterale di indipendenza della piccola comunità di coloni bianchi. Una situazione che darà origine a quella che sarà definita la “seconda decolonizzazione” in Africa caratterizzata da movimenti armati di liberazione nazionale.
P. 365-66
Bibliografia
La decolonizzazione / R. F. Betts. – Il Mulino, 2007
Breve storia dell’Africa / C. Coquery-Vidrovitch. – Il Mulino, 2012
Il leone e il cacciatore: storia dell’Africa sub-sahariana / A. M. Gentili. – Carocci, 2008
La guerra d’’Algeria / B. Stora. – Il Mulino, 2009
Cap. 28. Gli anni Sessanta / di Michele Marchi
Gli anni Sessanta sono di solito descritti come un “decennio felice”. La crescita economica e il consolidarsi di un avanzato sistema di welfare sono tratti determinanti della golden age. Non bisogna però sottostimare le fratture e le discontinuità che fanno degli anni Sessanta un “decennio ponte”, dominato dal concetto di affluent society, ma anche anticipatore di alcune difficoltà che caratterizzeranno gli anni Settanta. Dal punto di vista delle relazioni internazionali le due figure chiave sono quelle di Kennedy e De Gaulle. Sul fronte italiano, con il centro-sinistra di Moro, il nostro paese tenta una via particolare al riformismo, evidenziando nuovamente le peculiarità del suo bipartitismo imperfetto, in particolare l’impossibilità dell’alternanza di governo.
Gli anni Sessanta sono spesso ricordati, perlomeno nell’immaginario collettivo, come un “decennio felice. Tale immagine convenzionale è soprattutto legata alla prosperità dell’Occidente industrializzato. Secondo questo approccio gli anni Sessanta diventano sinonimo del trionfo della “civiltà del benessere”. Non vi è dubbio che nella maggior parte dei paesi dell’Europa occidentale, distrutti dagli eventi bellici, il prodotto interno lordo raggiunse in maniera più rapida del previsto i livelli degli anni Trenta del Novecento. Già dunque alla metà degli anni Cinquanta l’obiettivo della ricostruzione era stato centrato. Gli anni Sessanta diventavano così il fulcro della cosiddetta golden age o dei trentes glorieuses, per utilizzare il termine francese. Accanto alla crescita economia vera e propria, l’altro indicatore caratteristico del decennio fu l’aumento della spesa pubblica. Il decennio segnò il consolidamento del welfare state, vero e proprio simbolo della diffusione capillare dei diritti sociali (sanità, previdenza, sussidi), contemporaneamente espressione e strumento della modernizzazione, del progresso sociale, ma anche veicolo di strutturazione del consenso politico all’interno delle principali democrazie liberali. L’immagine probabilmente più adatta per descrivere questa società dominata dal progresso e dai consumi privati fu quella offerta dall’economista John Kenneth Galbraith nel suo libro del 1958 intitolato La società opulenta. Ciò di cui parlava Galbraith, relativamente al caso statunitense, al netto delle specificità nazionali, stava avvenendo anche nei principali paesi dell’Europa occidentale. Si stava infatti strutturando un affluent society, cioè una società nella quale una quota sempre più ampia della popolazione era “libera” dai meri problemi di sussistenza. Di conseguenza, da un lato, il consumo poteva rivolgersi verso beni non di primaria necessità. D’altra parte, lo sviluppo economico avrebbe dovuto concentrarsi in quegli ambiti necessari a combattere le residue forme di ineguaglianza, con l’obiettivo di allargare sempre più le basi di tael “società del benessere”.
Eppure sia dal punto di vista degli equilibri politico-sociali interni, sia da quello delle relazioni internazionali, il decennio non mancò di alcune significative turbolenze. Lo stesso sviluppo economico non spense in molti frangenti i conflitti sociali, anzi in alcuni casi (come per gli eventi del 1968) finì per aumentarli. Inoltre, la coesistenza tra i due blocchi Est-Ovest certamente si consolidò e si confermò, ma questo avvenne anche attraverso momenti di duro scontro (come la crisi dei missili di Cuba) e comunque, nella seconda parte del decennio, fu rimessa in grave crisi dall’acuirsi del conflitto in Vietnam e dal riacutizzarsi di quello arabo-israeliano in occasione della guerra dei sei giorni. Il tutto si innestava poi sul non ancora completato movimento di decolonizzazione, che visse una fase particolarmente traumatica nella conclusione del conflitto algerino, e infine su una decisiva e rivoluzionaria svolta all’interno della Chiesa cattolica, impegnata nel periodo 1962-65 nel Concilio Vaticano 2°.
Bibliografia
Il secolo mondo: storia del Novecento / M. Flores. – Il Mulino, 2002
La società opulenta / J. K. Galbraith. – Boringhieri, 1976
L’Italia e la nuova frontiera, 1958-1965 / U. Gentiloni Silveri. – Il Mulino, 1998
Il continente diviso / W. I. Hitchcock. – Carocci, 2003
Storia della guerra fredda / F. Romero. – Einaudi, 2009
La repubblica dei partiti / P. Scoppola. – Il Mulino, 1991
Cap. 29. 1967: la svolta della “questione mediorientale” / di Marcella Emiliani
La guerra dei Sei giorni ha determinato la nascita di un nuovo Medio Oriente, sull’onda della bruciante sconfitta inflitta da Israele ai paesi arabi. Sulla genesi del conflitto e delle sue finalità ancor oggi si assiste a un acceso di battito storiografico che investe anche il ruolo svolto dalla due superpotenze dell’epoca, Stati Uniti e Unione Sovietica. Di fatto la guerra del ’67 segnò il declino irreversibile della presidenza di Nasser in Egitto, accelerò il colpo di stato in Iraq del ’68 che porto al potere il partito Ba’th di Saddam Hussein e favorì il golpe con cui nel ’70 Hafez al-Assad andò al potere in Siria. Infine, nessun paese arabo accettò la proposta di Israele di vedersi restituiti i territori persi in cambio di una pace duratura.
- La guerra dei Sei giorni
Quando, la mattina del 5 giugno 1967, 183 aerei dell’aviazione israeliana si alzarono in volo dando inizio a quella che sarebbe stata chiamata la “guerra dei Sei giorni”, nessuno, ma proprio nessuno, immaginava le conseguenze che il terzo episodio del conflitto arabo-israeliano, dopo il 1948 e il 1956, avrebbe avuto sugli equilibri del Medio Oriente e – più in generale – sull’insieme delle relazioni internazionali. La “Guerra dei Sei giorni” come la chiamavano gli israeliani, o la “guerra di giugno” come la chiamavano gli arabi, è entrata subito di prepotenza nel mito e ancor oggi il suo racconto è oggetto di accaniti dibattiti tra scuole storiografiche. Tale dibattito si può brevemente riassumere come segue: per la storiografia araba, la guerra non è stata altro che l’ennesima manifestazione della natura imperialista dello stato di Israele, pedina degli interessi occidentali in Medio Oriente e loro braccio armato nella guerra fredda. Il conflitto, dunque, sarebbe stato scatenato per acquisire territori con la forza, con la complicità degli Stati Uniti, interessati ad umiliare l’altra superpotenza, l’Unione Sovietica, attraverso i paesi arabi suoi alleati nell’area. Per parte israeliana, l’attacco preventivo con le Idf (Israeli Defence Forces) sorpresero gli eserciti arabi si giustifica come risposta a una serie di “atti ostili” da parte di Siria ed Egitto. Nella fattispecie: il moltiplicarsi di incursioni terroristiche di guerriglieri palestinesi a partire dalla Siria, dal Libano e dalla Giordania; il bombardamento da parte dell’artiglieria siriana degli insediamenti ebraici sottostanti le alture del Golan; ma soprattutto l’allontanamento dal confine israelo-egiziano dei caschi blu dell’Onu, ivi insediati al termine della guerra di Suez del 1956, e la successiva chiusura da parte dell’Egitto degli stretti di Tiran alle navi battenti bandiera israeliana.
Per Israele nel 1967, come già nel 1948, si trattava insomma di sopravvivere in un contesto estremamente ostile, coi paesi arabi impegnati a coordinare un attacco congiunto contro il suo territorio col pieno appoggio dell’Unione Sovietica. E l’URSS un ruolo nello scatenarsi della guerra lo ha avuto indubbiamente. Mosca era uscita sconfitta dal braccio di ferro con gli Usa sulla “crisi dei missili” a Cuba dall’inizio degli anni Sessanta e il confronto continuava più aspro che mai nella guerra del Vietnam. Per questo cercava una sorta di rivincita in Medio Oriente, dove aveva fatto affluire dal 1956 aiuti militari per 2 miliardi di collari, andati per il 43% al solo Egitto di Gamal Abdel Nasser. Dal ’66 era entrata pienamente nell’orbita anche la Siria a seguito dell’ennesimo golpe militare, che questa volta aveva portato al potere Nureddin al-Atassi, ma soprattutto quella parte del partito Ba’th che, pur dicendosi campione dell’unione araba tanto quanto Nasser, intendeva rafforzare l’appello nazionalista siriano e, a differenza di Nasser – che di comunisti riempiva le prigioni patrie – era più ligio all’ortodossia ideologica di Mosca. Il nuovo governo di Damasco non solo intensificò gli atti di aggressione lungo il confine con Israele, ma accelerò il programma di sbarramento sul fiume Banias, affluente del Giordano, minacciando in tal modo il regime delle acque del lago di Tiberiade, la maggiore riserva idrica israeliana, e intensificò anche il proprio aiuto alla guerriglia palestinese. Tra il gennaio ’66 e il giugno ’67 si registrarono 122 incursioni palestinesi in Israele provenienti soprattutto da Giordania e Libano, ma era noto che proprio dal febbraio 1966 al-Fatah, la formazione principale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), era addestrata e armata dalla Siria che, in questo appoggio militante, tentava di scalzare l’Egitto, sponsor tradizionale e privilegiato della causa palestinese. In questo modo Damasco non solo aspirava alla leadership del mondo arabo, ma “dirottava” la puntuale rappresaglia israeliana contro altri stati arabi che gravitavano nell’orbita occidentale, Giordania e Libano appunto, evitando di essere colpita direttamente dalle Idf. Detto in parole povere, il nuovo regime del Ba’th, che al ministero della difesa aveva insediato Hafez al-Assad, faceva di tutto per trascinare Israele, ma anche i paesi arabi “fratelli”, in un nuovo conflitto
P. 381-82
Bibliografia
Storia del Medio Oriente / M. Campanini. – Il Mulino, 2010
La terra ci chi? Geografia del conflitto arabo-israeliano-palestinese / M. emiliani, Il Ponte, 2008
Medio Oriente: una storia dal 1918 al 1991 / M. Emiliani. – Laterza, 2012
Il conflitto arabo-israeliano / T. G. Fraser. – Il Mulino, 2009
Le molte identità del Medio Oriente / B. Lewis. – Il Mulino, 2011
Cap. 30. 1968: i giovani al potere / di Michele Marchi
È difficile parlare di un solo ’68. Il movimento di rivolta e protesta studentesca affonda le radici nel movimento giovanile americano degli anni Sessanta. In Europa i focolai di maggiore attivismo sono sicuramente, sul fronte occidentale, quello tedesco, quello francese e quello italiano, senza dimenticare naturalmente quello oltre cortina della “primavera di Praga”. Sollevamento senza una regia comune, il ’68 rappresenta l’ingresso sulla scena politico-sociale della prima generazione post-bellica. Se i mutamenti politici innescati non sono stati particolarmente significativi, il ’68 deve essere ricordato soprattutto come rivoluzione delle mentalità, dei costumi e dei linguaggi.
E’ possibile parlare di un unico ’68 o è più opportuno distinguere la mobilitazione studentesca a seconda del contesto nazionale nel quale vide la luce? Senza dubbio il dato nazionale non può essere trascurato. Senza nulla togliere al carattere di sovra-nazionalità delle parole d’ordine del movimento studentesco, si deve dunque parlare di molti ’68. Bisogna fare attenzione a non eccedere in senso contrario e di conseguenza si possono individuare almeno due elementi costitutivi comuni a tutti i contesti di rivolta studentesca e giovanile.
Il primo è di natura ideale e riguarda l’orizzonte politico-culturale all’interno del quale si dipanavano le riflessioni dei differenti movimenti studenteschi. E’ possibile affermare che il trait d’union fosse costituito dal pensiero della cosiddetta “nuova sinistra”. Alla base di questa elaborazione vi era una critica forte nei confronti di una società accusata di sostituire allo sfruttamento economico una nuova forma di dominio, attraverso pubblicità e mass media, una nuova tirannia tecnologica, una nuova forma di “assopimento” degli individui basata su un benessere giudicato illusorio. Lo strumento classico per sostanziare questa critica fu la ripresa dell’ideologia rivoluzionaria di matrice marxista. Ma, a questa, si accostò anche la riscoperta della cosiddetta Scuola di Francoforte (attiva negli anni Venti nella Germania di Weimar) e in particolare delle opere di Herbert Marcuse, dominate dalla critica all’etica borghese del successo, alla cosiddetta società opulenta caratterizzata dal culto dei consumi.
D’altra parte è possibile riscontrare anche un elemento comune di natura più propriamente congiunturale, individuabile nella comune opposizione alla guerra del Vietnam. Dagli Stati Uniti alla Germania, passando per la Francia e l’Italia, il contrasto alla cosiddetta “sporca guerra” che, non bisogna dimenticare, negli Usa coinvolgeva in prima persona anche i giovani studenti universitari, si tramutò nel catalizzatore di una più ampia riflessione e protesta da rivolgere contro l’imperialismo e a sostegno dell’ampio movimento di lotta anticoloniale in atto su scala globale.
Bibliografia
La rivoluzione introvabile? / R. Aron. – Rubbettino, 2008
1968: l’anno che ha fatto saltare il mondo / M. Flores e A. De Bernardi. – Mondadori, 2004
Sul Sessantotto / N. Matteucci. – Rubbettino, 2008
Il Sessantotto: una breve storia / M. Tolomelli. – Carocci, 2008
Cap. 31. 1973: la crisi petrolifera e la fine dell’età del benessere / di Riccardo Brizzi
Il 1973 rappresenta un anno di cesura storica, per molteplici aspetti. Sul fronte delle relazioni internazionali la fase di distensione tra le due superpotenze proseguì nonostante la fine traumatica del conflitto vietnamita e l’esplodere della guerra del Kippur. Ma il fattore che ha caratterizzato in misura maggiore il 1973 è probabilmente da ricondurre all’ambito economico con la traumatica presa di coscienza dell’esaurimento della fase di crescita postbellica, cui si sostituirono anni di incertezza, dovuta sia motivi strutturali (la delicata transizione verso un’economia postindustriale) sia a ragioni di ordine congiunturale (la crisi petrolifera e l’impennata dei costi delle materie prime).
Il 1973 ha rappresentato un importante momento di svolta nella storia del Novecento, che ha investito molteplici dimensioni, dalle relazioni internazionali all’economia, costituendo uno spartiacque anche sul versante dell’immaginario collettivo. L’idea di sviluppo progressivo e di estensione generalizzata del benessere che, dalla fine della Seconda guerra mondiale, aveva orientato le politiche economiche dell’intero pianeta (tanto le economie di mercato quanto quelle pianificate, pur con differenti risultati), conobbe una brusca battuta di arresto. L’elemento di maggiore criticità che ha caratterizzato il 1973 è probabilmente da ricondurre alla traumatica presa di coscienza dell’esaurimento della fase dei “miracoli economici” postbellici, cui si sostituirono anni di incertezza se non di vera e propria crisi, dovuta tanto a motivi strutturali (la delicata transizione verso un’economia postindustriale) quanto a ragioni congiunturali di grande impatto (la crisi petrolifera e l’impennata dei costi delle materie prime). Dopo la crisi energetica nulla sarebbe stato più come prima e fu progressivamente chiaro che si stava entrando in una nuova epoca.
P. 399
Bibliografia
Storia della politica internazionale nell’età contemporanea / G. Formigoni. – Il Mulino, 2006
Il conflitto arabo-israeliano / T. G. Fraser. – Il Mulino, 2009
Dopo gli imperi: l’integrazione europea nello scontro Nord-Sud / G. Garavini. – Le Monnier, 2004
Cap. 32. 1973: prima e dopo il settembre cileno
Osservando il golpe del generale Pinochet e dei suoi fedeli militari sullo sfondo degli esperimenti politico-istituzionali latinoamericani del secondo dopoguerra, vediamo come il settembre cileno segni la fine di un’epoca. Uno spartiacque che sancisce il passaggio, per molti versi traumatico e violento, da un’epoca dominata dalla politica a da una contrassegnata dall’antipolitica; la transizione dal dominio dell’ideologia a quello della tecnocrazia, dalla partecipazione di massa alla vita pubblica in ritiro nell’ambito privato, dalla contestazione al conformismo, dalla disobbedienza alla disciplina.
L’11 settembre 1973 il presidente socialista Salvador Allende si suicidò nella Moneda, il palazzo presidenziale di Santiago del Cile assediato dai carri armati dell’esercito e bombardato da caccia dell’aviazione. Con lui morì il primo e l’unico tentativo nelle Americhe di creare il socialismo per via democratica. Un tentativo infelice e già ferito a morte ancor prima che il generale Pinochet vi ponesse brutalmente fine: dal boicottaggio degli Stati Uniti, dalla larvata rivolta sociale e politica, dalle sue inguaribili velleità e viscerali lotte interne. Il caos creativo e inconcludente di quell’esperimento fu allora scalzato dall’ordine militare e dalla pace dei cimiteri. I militari, raccolti dietro la cupa immagine del loro capo dai perenni occhiali da sole a coprirgli lo sguardo, arrivarono per restare e ribaltare il paese da cima a fondo. E lo fecero. Ma la 2via cilena” aveva superato le frontiere. Amata o temuta, emulata o denigrata, era divenuta un modello o un’ossessione in tutto l’Occidente. Da replicare o scongiurare, a seconda. Non tutti, allora, ne furono consapevoli. Molti, anzi, colsero nel sacrificio di Allende un eroico messaggio che i posteri avrebbero raccolto già all’indomani, portando a compimento i sogni socialisti ch’egli aveva evocato fino all’ultimo istante della sua vita. Altri, invece, lo compresero al punto da ricavarne un duro insegnamento persino in Italia, dove Enrico Berlinguer trasse dai fatti cileni una lezione destinata a portare il Partito comunista alla ricerca del “compromesso storico” con la Democrazia cristiana.
P. 407
Ma qual era, in sintesi, il modello ora accantonato con sprezzo, ed entro i cui parametri si era mosso Allende, e quale quello abbracciato con zelo iconoclasta da Pinochet e dai suoi emuli? A essere schematici, ma neppure troppo, si passò allora, per mezzo di una terapia che i governi militari e i loro ideologi si proposero di somministrare senza alcuna anestesia, dallo stato al mercato o, per essere più precisi, dal dirigismo protezionista teorizzato dal Raul Prebisch e dalla Commissione economica dell’Onu per l’America Latina fin dagli anni Cinquanta al liberismo economico e al monetarismo ortodosso caro al guru del pensiero liberale alla Von Hayek, di casa nel Cile di Pinochet. L’idea, si diceva, era che proprio il capitalismo di stato perseguito dalle nazioni latinoamericane per almeno un trentennio avesse dato i natali e poi perpetuato nel tempo un blocco sociale inguaribilmente legato alla protezione dello Stato. Cominciarono allora, dunque, sotto la spinta politica ed ideologica dei militari e dei loro alleati civili l’abbattimento dello stato corporativo e individualista e l’adozione del modello economico che, seppur con risultati spesso diversi dalle premesse ideologiche dei suoi fautori, fu poi adottato un po’ ovunque nella regione nei due decenni successivi.
P. 411
Bibliografia
L’altro Occidente: l’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio / M. Carmagnani. – Einaudi, 2004
Tra innovazioni e continuità: l’America Latina nel nuovo millennio / a cura di G. Chiaramonti. – Cleup, 2009
Stati Uniti e America Latina dal 1823 a oggi / R. Nocera. – Carocci, 2009
Storia dell’America Latina contemporanea / L. Zanatta. – Laterza, 2010
Cap. 33. 1976: dal franchismo alla democrazia: la transizione spagnola
La morte di Franco costituì la premessa per l’avvio di un processo politico che condusse la Spagna a smantellare il precedente regime dittatoriale e ad approdare alla piena democrazia. La transizione si svolse in meno di tre anni, fu sostanzialmente incruenta e avvenne “dalla legge alla legge”, cioè senza traumatiche rotture, combinando una riforma politica pensata e realizzata dall’alto (da re Juan Carlos e da Adolfo Suarez) con la pressione proveniente dalla società civile e dai partiti dell’opposizione antifranchista. Se si considerano le resistenze alla trasformazione del sistema politico da parte dei settori beneficiati al franchismo, occorre riconoscere che il suo esito, pur voluto dalla stragrande maggioranza degli spagnoli, fu tutt’altro che scontato.
Dopo la pacifica rivoluzione portoghese dei garofani (25 aprile 1974), fu la morte del dittatore spagnolo Francisco Franco (20 novembre 1975) a costituire la premessa del ricongiungimento politico, dopo decenni di isolamento, della penisola iberica al continente. Poco dopo la Spagna iniziava lo smantellamento del regime di cui Franco era stato l’eroe eponimo. Un regime che aveva retto alla cesura rappresentata dalla fine del secondo conflitto mondiale, riuscendo a galleggiare sulle trasformazioni economiche, sociali, politiche e culturali che l’Europa aveva conosciuto nel secondo dopoguerra. È sul franchismo, dunque, che occorre dapprima soffermare l’attenzione.
Bibliografia
Storia della Spagna democratica: da Franco a Zapatero / C. Adagio e A. Botti. – B. Mondadori, 2006
Nazionalcattolicesimo e Spagna nuova / A. Botti. – Angeli, 1992
La Spagna da Franco a oggi / r. Carr, J. P. Fusi. – Laterza, 1981
Cap. 34. 1989: il crollo del muro di Berlino e la fine della divisione tedesca / di Giovanni Bernardino
La partizione della Germania in due stati ha rappresentato in Europa l’ultima eredità della Seconda guerra mondiale e al contempo il primo terreno di scontro tra Est e Ovest nell’ambito della guerra fredda. Il muro che divise per decenni l’ex capitale divenne ben presto agli occhi del mondo il simbolo tangibile della divisione del vecchio continente e delle gravi conseguenze in termini umani e morali che questa provocava. Pare naturale, dunque, che la sua rimozione nel 1989 abbia assunto un carattere epocale non soltanto per la Germania, ma per l’Europa nel suo complesso.
La sera del 9 novembre del 1989 la leadership della Repubblica democratica tedesca (Rdt) annunciò improvvisamente l’apertura delle proprie frontiere, concedendo ai cittadini la piena libertà di attraversarle. Entro poche ore, immagini confuse testimoniarono all’opinione pubblica mondiale l’inizio dello smantellamento del muro di Berlino, emblema della guerra fredda che separò per decenni il continente europeo in due blocchi ideologicamente e militaristi contrapposti. Proprio a causa del legame storico della divisione della città e il conflitto Est-Ovest, l’evento assumeva una portata epocale che travalicava i conflitti geografici tedeschi. Dunque, una disamina delle vicissitudini di Berlino e della Germania nel secondo dopoguerra sembrano necessarie per cogliere il vero significato della “rivoluzione dell’89” per ‘intera Europa.
Bibliografia
In nome dell’Europa / T. Garton Ash. – Mondadori, 1994
Il crollo: la crisi del comunismo e la fine della Germania Est / C. Maier. – Il Mulino, 1999
La Germania dalla divisione all’unificazione / J. K. A. Thomanecj e B. Niven. – Il Mulino, 2005
Cap. 35. 1992: L’Europa di Maastricht / di Gabriele D’Ottavio
L’Europa di Maastricht è il frutto di un lungo processo storico che si interseca continuamente con le dinamiche della guerra fredda. La caduta del muro di Berlino e l'implosione del blocco sovietico determinarono una forte spinta all’integrazione europea che culminò, il 7 febbraio 1992, nella firma del trattato istitutivo dell'unione europea. Essa nasceva sulla base delle precedenti esperienze comunitarie istituire due nuove forme di collaborazione nel settore della politica estera e della sicurezza in materia di giustizia e affari interni. Di particolare rilievo fu l'unione economica e monetaria, base per l'adozione nel 2002 della moneta comune, l'euro. Il successivo allargamento a est dell’Unione ha reso necessarie ulteriori riforme al suo impianto originario.
- Le origini
Per i tempi EI modi in cui maturarono, le prime comunità europee - la comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca) e là poi fallita comunità europea di difesa (Ced) - dimostrarono come la spinta alla coesione europea avesse tratto alimento da momenti di grande tensione internazionale. Nei momenti di distensione, però, era emerse nuove divisioni tra i paesi europei, che avevano contribuito a minare la logica integrazionista. Per il progressivo venir meno del timore che la guerra fredda potesse diventare “calda”, il progetto di integrazione si modificò. Da questo punto di vista, i trattati di Roma sancirono il passaggio verso un integrazione europea con forte impronta economica e una sede istituzionale meno invasivo della sovranità nazionale rispetto a quelli della Ceca e della Ced.
Fu questa una delle ragioni principali che spinsero il generale de Gaulle - da sempre contrario a una evoluzione sovranazionale della costruzione europea - a rinnovare una volta ritornato al potere nel giugno 1958 le obbligazioni europee con tratte dai precedenti governi della quarta Repubblica francese. Nel primo decennio di attuazione dei trattati di Roma alcuni progetti di riforma e alcune iniziative per la l'intervento della comunità economica europea (Cee) fallirono, ascoltando almeno in parte le conseguenze di un nuovo e virgola dopo la crisi dei missili di Cuba, più duraturo rilassamento delle tensioni tra est e ovest. la domanda di adesione della Gran Bretagna alla Cee venne respinta per ben due volte dalla Francia gollista (1963 e 1967). a sua volta, l'ispirazione del generale de Gaulle a realizzare, tranne il piano Fouchet (1961-62), un’Europa confederale, Più Franco centrica e indipendente dagli Stati Uniti si infranse innanzi all’opposizione degli altri paesi membri. La stessa sorte toccò al progetto alternativo di creare attorno all'asse Parigi Bonn un nucleo di potere decisionale europeo continentale in contrapposizione alle potenze anglosassoni. Infine, nel contesto della cosiddetta crisi della sedia vuota (1965) non sortire gli effetti sperati nel tentativo della commissione europea di rafforzare le prerogative delle istituzioni sovranazionali, nella controffensiva di de Gaulle volta ridimensionarle.
La crisi degli anni '60 e il loro superamento, se da un lato dimostrarlo la inconciliabilità tra i diversi modi di pensare il processo di costruzione europea rispetto a questioni quali il rapporto con l'Alleanza atlantica, le relazioni tra paesi grandi e paesi piccoli e la prospettiva di un’evoluzione sovranazionale dell’integrazione, dall’altro resero evidente quanto fosse difficile per i paesi membri rinunciare a quell’insieme di interessi comuni che si era sviluppato a partire alla fine degli anni Quaranta. Nonostante i tanti dissidi interni, La Cee, dimostratasi assai più rilevante della Comunità europea per l’energia atomica (Euratom), era diventata in pochi anni un importante fattore di modernizzazione, di crescita e di stabilità politico-economica, nonché una potente attrattiva per gli stati terzi e un punto di riferimento per i paesi alle prese con il fenomeno della decolonizzazione. Si ricordano al riguardo la nascita della politica agricola comune (1962), la firma dei primi accordi di associazione con l Grecia (1962) e Turchia (1963), il progressivo sviluppo di una politica commerciale e di una politica europea di cooperazione allo sviluppo. Nel 1967 entrò in vigore il trattato sulla “fusione degli esecutivi” delle tre Comunità, che comportò una razionalizzazione dell’assetot istituzionale. Da qui in avanti le Comunità europee ebbero un’unica Commissione e un unico Consiglio dei ministri, così come un unico parlamento.
In un periodo caratterizzato da grande dinamismo sulla scena internazionale ed europea, il processo d’integrazione subì negli anni Settanta importanti trasformazioni. La Cee si allargò alla Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca (1973); al contempo i paesi membri, guidati da una nuova generazione di politici, cercarono di impostare un ampio ventaglio di nuove politiche per rispondere ai problemi e/o cogliere le opportunità connesse alla distensione, alla crisi economica internazionale, all’appannamento della leadership degli Stati Uniti, alla competizione di nuovi poli economici emergenti in Asia, alla nuova ondata di democratizzazioni. In questo contesto vennero approntati alcuni strumenti innovativi per rafforzare la cooperazione politica, economica e monetaria tra i paesi membri, migliorare l’efficienza dei processi decisionali e ovviare al deficit democratico. In particolare, al di fuori del quadro comunitario vennero creati, con la Cpe, e, con il serpente monetario prima (1972) e con il Sistema monetario europeo (Sme) poi (1978), nuove regole per la fluttuazione delle valute dei paesi membri, accompagnate da innovativi meccanismi di intervento e di credito monetario. Inoltre, venne istituita la pratica degli incontri al vertice trai capi di Stato e di governo (1974) e introdotta l’elezione diretta del Parlamento europeo, che si tenne per la prima volta nel 1979. Tali iniziative e i loro limiti costituirono anche le premesse su cui nei primi anni Ottanta in una fase segnata da una ripresa delle tensioni internazionali, furono gettate le basi per la prima grande riforma dei trattati di Roma, l’Atto unico europeo (1987), che rispose anche alle esigenze derivanti dal nuovo allargamento della Cee a Grecia (1981), Spagna e Portogallo (1986). Oltre a riformulare le varie attività comunitarie all’interno di un quadro operativo più coerente di quello esistente, questo nuovo trattato designava la realizzazione di uno “spazio senza frontiere interne” attraverso il completamento del mercato comune entro il 31 dicembre 199. Per favorire il conseguimento di tale obiettivo, vennero apportate alcune importanti modifiche all’assetto istituzionale dei trattati di Roma, tra cui: l’estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio dei ministri, il rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo nel processo decisionale, la semi-istituzionalizzazione del Consiglio europeo, un consesso composto dai capi di Stato e di governo dei paesi membri che si riuniva con cadenza regolare e nel quale venivano definite le linee strategiche della politiche di integrazione. Anche la cooperazione europea in materia di politica estera, pur rimanendo al di fuori del quadro comunitario, ottenne nell’Atto unico un riconoscimento formale tramite l’istituzione di un Segretariato permanente con sede a Bruxelles. Venivano infine estese le competenze della Cee ad altri settori: ricerca e tecnologia, sviluppo regionale, politica sociale e politica ambientale
P. 431-33
Al riguardo vi è un’analisi che si è molto diffusa negli ultimi anni, fino al punto di trasformarsi in vulgata: la visione del progetto di Unione economica e monetaria (Uem) e la successiva europeizzazione del Marco, con la nascita della moneta comune, sarebbero state la contropartita fornita dai tedeschi in cambio del sostegno politico degli altri paesi membri alla riunificazione poi raggiunta il 3 ottobre 1990
P. 433
- Un processo aperto
Le principali crisi internazionali dell’ultimo ventennio, dalla prima guerra Del Golfo alla dissoluzione della Iugoslavia, dalla guerra contro il terrorismo internazionale dopo l'11 settembre 2001 alla più recente crisi economica e finanziaria, hanno messo a dura prova la capacità degli Stati membri di svolgere attraverso lui un ruolo autorevole incisivo sulla scena internazionale. in ognuno di questi scenari i principali Stati membri si sono mossi infatti prevalentemente secondo logiche nazionali, contribuendo evidenziare i molti limiti dell’Unione politica e dell'unione economica e monetaria figurati dal trattato istitutivo dell'unione europea. Da questo punto di vista virgola non hanno apportato sostanziali miglioramenti in me nemmeno ai già ricordati trattato di Amsterdam e Nizza, i quali hanno rinnovato, senza tuttavia trasformarli, i propositi e l'impianto istituzionale originali del trattato di Maastricht.
A stravolgere completamente la fisionomia dell’Unione europea EA spingere i paesi membri verso nuove importanti di forme ha contribuito invece l'ultimo grande allargamento ai paesi dell'Europa orientale (2004-07). Per rendere governabile un Unione di 27 paesi, una convenzione europea - un organo temporaneo e straordinario, per lo più composto da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei governi dei paesi membri che bei paesi candidati all'adesione, della commissione europea e del Parlamento europeo - e stata incaricata di redigere un progetto per un nuovo trattato istituzionale. Il testo definitivo è stato sottoscritto dai capi di Stato e di governo a Roma il 29 ottobre 2004 come “trattato che adotta una costituzione per l'Europa”. a dispetto del nome, questo trattato non partoriva una vera costituzione, mi si consolidava, sia pur apportando alcune significative novità virgola in un unico testo tutti i precedenti trattati, che conseguentemente sarebbero stati abrogati. I semi per la bocciatura dei referendum di ratifica tenutisi in Francia e Olanda (2005) si è aperta una fase di riflessione, ovvero una fase di stallo decisionale della quale si è usciti con un accordo su un nuovo trattato, il trattato di Lisbona, filmato del 2007 ed entrato in vigore il 1° Dicembre 2009. Essa si presenta come uno strumento essenzialmente tecnico e con un basso profilo politico : fatta eccezione per il rinvio vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea , il riconoscimento del suo valore giuridico equiparato a quello dei trattati, il testo sono stati espunti tutti i riferimenti alla costituzione e ai suoi simboli (nomi, bandiera, inno, eccetera). sono stati invece recuperati alcune innovazioni istituzionali già contenute nel trattato costituzionale i punti il superamento dei tre pilastri e il riconoscimento della personalità giuridica unica dell'unione; la previsione di un presidente del consiglio europeo a tempo pieno e di un altro rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza virgola che anche per vicepresidente della commissione; il rafforzamento del Parlamento europeo virgola in particolare attraverso l'estensione della sua competenza a nuove materie e l'ampliamento dei suoi poteri decisionali. Al momento non è ancora chiaro se e fino a che punto quest'ultimo trattato di formatore risponda ai problemi che avevano reso necessario rinnovare l'Europa di Maastricht appunto come in passato la costruzione europea resta un processo aperto a soluzioni e sviluppi diversi che sono per lo più imprevedibili.
Bibliografia
Storia e politica dell’Unione europea, 1926-2005 / G. Mammarella e P. Cacace. – Laterza, 2005
Storia dell’integrazione europea: dalla guerra fredda all’integrazione / B. Olivi e R. Santaniello. – Il Mulino, 2010
Germania, Italia, Europa: dallo stato di potenza alla “potenza civile” / G. E. Rusconi. – Einaudi, 2003
Cap. 36. 2001: 11 settembre: un tornante della storia?
Nell'immaginario comune, l'11 settembre occupa un posto di primo piano perché è stato percepito come una cesura che ha segnato in profondità la comprensione della nazione americana e la sua posizione nello scenario globale. Gli storici invece hanno collocato il tragico evento in una prospettiva di più lungo periodo nel tentativo di non identificare gli attentati con l'inizio di uno scontro di civiltà: poiché simili interpretazioni esacerba vanno le tensioni interne e internazionali, senza svalutare i cambiamenti occorsi, gli interpreti hanno considerato la continuità fra un prima e un dopo riguardo sia alla politica interna statunitense sia quella estera, con particolare riferimento al rapporto transatlantico.
La mattina dell' 11 settembre due mila uno l'organizzazione terroristica al qaida, guidata da Osama Bin Laden, lanciò una serie di attacchi contro gli Stati Uniti. Quattro aerei di linea pilotati da terroristi suicidi furono dirottati contro i simboli del potere economico e militare americano: le torri gemelle sede del World Trade Center a New York e il Pentagono a Washington. Quasi 3000 persone morirono il più grave attentato mai perpetrato sul suolo statunitense. Alcuni studiosi hanno fatto riferimento al 1941, quando eri giapponesi bombardarono la frutta americana ancorata a Pearl Harbor, altri invece ricordato l'invasione di Washington da parte dell’esercito britannico nel 1812 nella cosiddetta seconda guerra d'indipendenza. al di là dei precedenti , nell'immaginario collettivo virgola non soltanto americano, la data dell' 11 settembre - o meglio di espressione ormai comune 9/11 - occupa un posto di primo piano: il tragico evento è stato percepito anche in Europa come una cesura che ha segnato in profondità la comprensione della nazione americana e della sua posizione nello scenario globale.
Subito dopo gli attentati, storici e biblioteca li promossero diversi progetti -musei, archivi digitali e studi di storia orale - per coinvolgere la società civile americana colpita da un avvenimento impensabile. Veniva così avviato una riflessione collettiva volta a elaborare pubblicamente il trauma derivato dalla fine dell’invulnerabilità, trova rilevante per una nazione con una storia, come quella statunitense, segnata dalla consapevolezza di essere una potenza mondiale è un modello politico ed economico. Soprattutto per gli storici è importante collocare il tragico evento in una prospettiva di più lungo periodo che consentisse di non cadere nella tentazione di identificare gli attentati con l'inizio di uno scontro di civiltà rimuovi guerre culturali contro differenze etniche, razziali e religiose. Poiché simili interpretazioni riducevano l'11 settembre a strumento di battaglia politica, esacerbando le tensioni interne e internazionali, gli storici hanno discusso il carattere trasformativo dell’evento. Considerare le linee di continuità fra un prima e un dopo l'11 settembre non impedisce però di sottolineare i cambiamenti di ordine politico e sociale che seguirono gli attentati non soltanto negli Stati Uniti.
Bibliografia
Oltre il secolo americano? Gli Stati uniti prima e dopo l’11 settembre / R. baritono e E. Vezzosi (a cura di). – Carocci, 2011
Libertà e Impero: gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2011 / M. Del Pero. – Laterza, 2011
Il sesso del terrore: il nuovo maschilismo americano / S. Faludi. – Isbn, 2007
America/Islam: e adesso? / F. Romero e R. Guolo. – Donzelli, 2003
Destino manifesto: l’espansionismo americano e l’impero del bene / A. Stephanson. – Feltrineli, 2004
L’età contemporanea di Alberto Maria Banti vol. 1
- Visite: 144
Cap. 1. Nuovi modi di comunicare, consumare, produrre
- Le origini del sistema economico globalizzato
Fine Seicento-inizio Settecento: è una lunga fase di straordinario dinamismo economico quella che si inaugura allora.
Vari settori ne sono coinvolti: l’agricoltura e le manifatture, dove avvengono i mutamenti più spettacolari e prima ancora il commercio, specie quello a lunga percorrenza.
Lì c’è una risorsa straordinaria di cui l’Occidente può avvalersi: si tratta di beni, braccia, ricchezze, che arrivano a destinazione da molto lontano, da esotici paesi dell’Asia, dell’Africa o dell’America e che sbarcando dalle navi che attraccano ai porti di Londra, di Nantes o di Amsterdam, riverberano prosperità e ricchezza nel Vecchio Continente.
E’ per andare in cerca di queste esotiche risorse che gli europei di mettono in viaggio per andare molto lontano dalle loro dimore (un caso unico: nessun altro popolo, in nessun’altra parte del mondo, organizza spedizioni su così vasta scala come fanno gli europei anche in questi decenni).
Del resto è qualcosa che è già accaduto: alla fine del Quattrocento è stato il miraggio delle spezie che ha messo in moto una dinamica impensabile di scoperte geografiche, antropologiche, naturalistiche…..
E l’avidità, ora, non è minore che a quell’epoca.
Ma, ora come allora, sono all’opera anche ragioni diverse.
Si parte per tanti altri motivi: per sincera curiosità, voglia di conoscere, spirito di avventura; o per conquistare popoli “miscredenti” alla vera fede, che è quella in Cristo; o, viceversa, perché si ha paura di essere perseguitati nelle proprie terre di origine, in particolare se si hanno convinzioni religiose eterodosse; o perché si è inseguiti dai debitori; o per amore andato male…..; o per un insieme di queste ragioni.
Quali che siano le motivazioni originarie, l’effetto dei movimenti a lunga percorrenza che ne derivano è di tracciare percorsi stabili che danno vita ad una prima forma di globalizzazione [vedi parole della storia]; su quei percorsi, prevalentemente marittimi, si muovono navi, persone, merci, armi: e buona parte della straordinaria espansione economica vissuta dall’Occidente nei seguenti tre secoli si fonda sugli intensi spostamenti che – sin da questi decenni di fine Seicento-inizio Settecento – hanno luogo su rotte remote che portano a terre lontane.
Nei porti principali dell’Occidente arrivano, da queste esotiche terre lontane, nuovi, strani beni di consumo, per i quali – in qualche caso – si inventano anche posti appositi, che prima nemmeno esistevano.
Uno di questi posti è la “bottega del caffè”: la prima in assoluto sembra sia stata aperta a Venezia nel 1647.
Non sorprende: originariamente il caffè viene dalle città ottomane e medio-orientali, aree con cui Venezia ha rapporti frequenti, per quanto non facili.
Il caffè, questa nuova bevanda che vi si può bere, ha subito un grande successo, poiché sembra avere mille virtù; aiuta a svegliarsi alla mattina o a rimanere svegli la sera; scalda oppure offre un’occasione per incontrarsi e parlare.
E subito le botteghe che vendono quella bevanda si diffondono in tutta Europa: se ne aprono a Londra nel 1652, a Marsiglia nel 1654, ad Amburgo nel 1677, e da lì passano a molte altre città ancora.
Nel corso del Settecento non vi è città di qualche rilievo che non ne abbia diverse, e a Parigi, negli anni Ottanta, se ne contano addirittura 800 circa.
Sono luoghi accoglienti e vi si possono consumare anche altri beni, oltre a svolgere interessanti attività sociali, come spiega Johann Pezzl in una sua descrizione di Vienna, edita nel 1786: “non si beve soltanto caffè, ma anche tè, cioccolata, punch, limonata, latte di mandorla, rosolio, gelati, ecc., tutte cose che sino a un paio di secoli fa in Germania non si conoscevano neanche di nome.
Vi si può studiare, schiacciare un pisolino, trattare affari, mercanteggiare, fare pubblicità, tramare intrighi e complotti, organizzare gite, leggere riviste e quotidiani, ecc.”.
Senza averne l’apparenza, momenti essenziali della società europea del 18. secolo si incrociano in questo luogo della vita quotidiana (dovunque, bisogna aggiungere, quasi esclusivamente frequentato da uomini).
La nascita di una nuova società dei consumi e la nascita di un’opinione pubblica [vedi parole della storia] scaturiscono dai gesti che vi si compiono.
Bere una bevanda calda, leggere un giornale: sono gesti che a noi sembrano incredibilmente banali, parte degli automatismi di tutti i giorni.
Ma non facciamoci ingannare: allora quei gesti sono delle novità elettrizzanti, estremamente alla moda, e qualche volta anche culturalmente e politicamente dirompenti.
Parole della storia
Globalizzazione
Il termine – entrato in uso negli ultimi anni venti – indica la crescente interdipendenza economica che lega le più disparate parti del mondo, attraverso scambi commerciali, accordi finanziari, movimenti di persone, interazioni politiche e culturali.
Le valutazioni sul significato del processo sono divergenti: vi è chi vede nella globalizzazione un processo complessivamente benefico, chi ne vede le minacce alla prosperità dell’Occidente, e chi, invece, vi vede un’ulteriore manifestazione dell’imperialismo occidentale a danno delle altre aree del mondo.
Ci sarà modi di tornare su questi temi più avanti: qui si intende solo sottolineare che, qualunque sia il significato che si vuole attribuire a questo processo, esso affonda le sue radici negli eventi che caratterizzano l’economia mondiale della tarda età moderna.
Modello malthusiano (o malthusianesimo)
L’espressione indica quel modello o teoria economica che attribuisce la causa della povertà economica a una crescita squilibrata della popolazione in rapporto alle risorse.
Il nome deriva da Thomas Robert Malthus (1766-1834), un economista inglese che nel 1798 pubblica il Saggio sul principio della popolazione, nel quale, polemizzando aspramente con le teorie mercantiliste che ritenevano l’aumento della popolazione un beneficio economico, illustra il modello demografico che è descritto al capitolo 1.5.
La crescita della popolazione non è benefica, scrive Malthus, perché mentre l’aumento demografico segue un andamento geometrico (e si muove secondo una progressione del tipo 1-2-4-8 ecc.), l’aumento delle risorse si muove secondo un andamento che è solo aritmetico (1-2-3-4 ecc.): lo squilibrio che si crea produce povertà e crisi demografiche.
Per ovviare a questo problema Malthus ritiene ci siano solo due soluzioni: i “freni preventivi” (che, come il ritardo nell’età al matrimonio o la castità prematrimoniale, possono essere pianificati allo scopo di ridurre la crescita della popolazione); o i “freni repressivi” (come le guerre o le carestie, che tra gli altri effetti hanno anche quello di ridurre la popolazione).
Lucida nella descrizione del modello demografico di età moderna, e largamente accettata all’inizio dell’Ottocento, la teoria di Malthus non coglie proprio il grande cambiamento allora in atto, che nel Novecento il demografo americano Ansley J. Coale (1917-2002) ha definito “transizione demografica”.
Opinione pubblica
Il termine indica l’insieme degli orientamenti e delle convinzioni condivise dalla maggior parte degli individui in uno spazio e in un tempo dato, ed è un concetto già usato, grosso modo in questi termini, sin dal 18. secolo.
La più influente descrizione delle trasformazioni nella sociabilità e nel mercato culturale settecentesco come premesse per la formazione di un’”opinione pubblica borghese” si trova in Storia e critica dell’opinione pubblica, un libro del 1962, scritto dal filosofo tedesco Jürgen Habermas.
Per la comprensione della nascita dell’”opinione pubblica”, egli considera essenzialmente la polarizzazione creatasi con l’assolutismo, che ha teso a separare le istituzioni pubbliche dello Stato (sovrano, corte, burocrazia, esercito), da un lato, dalla istituzioni private incastonate nella società (imprese, individui, famiglie) dall’altro.
E’ in questo spazio sociale distinto dalla corte e dagli apparati dello Stato assolutista che nascono nuovi strumenti di comunicazione (i giornali; i romanzi) e nuovi luoghi di incontro e di associazione (i caffè, i salotti, i club), all’interno dei quali intellettuali, professionisti, mercanti e non di rado anche membri di famiglie aristocratiche, discutono di argomenti di attualità, così come di questioni letterarie, filosofiche o religiose.
E’ attraverso la discussione di questi argomenti che cominciano a essere elaborate critiche e polemiche rivolte al sistema socio-politico assolutista.
Tutti questi processi segnano, secondo Habermas, la nascita di una diversa concezione della sfera pubblica: è una concezione che vuole che si aprano maggiori spazi affinché diverse componenti di una società possano esprimersi criticamente sulla gestione del potere.
Sono proprio questi nuovi atteggiamenti critici, che si diffondono nel corso del 18. secolo, e che si esprimono attraverso i giornali, i libri, le opere teatrali e le fervide discussioni nei nuovi luoghi di sociabilità, che danno forma all’inedito fenomeno dell’”opinione pubblica”.
Parlamento
Formatosi a metà del 13. secolo, come organismo di tipo puramente nobiliare, il Parlamento inglese acquista l’essenziale della sua struttura intorno alla metà del 14. secolo: da allora si articola in due Camere, una dei Lord, dove siedono – per diritto ereditario – i membri primogeniti delle più importanti famiglie nobiliari del Regno ( i cosiddetti Pari); e una dei Comuni, dove siedono i rappresentanti delle città e delle contee: ai seggi di questa seconda camera si accede per elezione, secondo norme molto varie da località a località, ma tutte regolate dal principio per cui solo i ricchi possono votare; non sorprende, dunque, che vi vengano eletti soprattutto membri della nobiltà meno titolata (la cosiddetta gentry), oltre che prestigiosi non nobili – giuristi o ricchi mercanti, per esempio.
Le prerogative che il Parlamento inglese riesce a conquistare sin dal tardo Medioevo sono piuttosto notevoli: tuttavia la centralità politica e istituzionale del Parlamento inglese si impone definitivamente solo nel corso delle due rivoluzioni del 17. secolo: il Bill of Rights, concesso dal sovrano Guglielmo d’Orange, nel 1689, fissa la conclusione del periodo rivoluzionario, stabilendo con chiarezza i limiti del potere monarchico e le prerogative del Parlamento.
Tra i limiti al potere regio vanno notati il divieto di imporre tasse senza autorizzazione parlamentare; il divieto di tenere un’armata personale, non controllata dal Parlamento; il divieto di autorizzare processi arbitrari.
Tra i diritti del Parlamento, organo che possiede il potere legislativo, vanno ricordati anche quelli a libere elezioni, alla piena libertà di parola all’interno del Parlamento, alla frequente convocazione del Parlamento stesso.
Nel corso del Settecento, inoltre, si stabilisce la pratica politica che vuole che i governi, che sono di nomina regia, siano tuttavia formati sulla base delle maggioranze che si creano all’interno del Parlamento.
Bibliografia
Storia della famiglia in Europa / Marzio Barbagli, David I. Kertzer (a cura di). – Laterza, 2002
La nascita del mondo moderno, 1780-1914 / C. A. Bayly. – Einaudi, 2009
Culture del consumo / P. Capuzzo. – Il Mulino, 2006
Prometeo liberato / D. Landes. – Einaudi, 2000
Storia agraria dell’Europa occidentale, 500-1850 / B. H. Slicher van Bath. – Einaudi, 1971
Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra / E. P. Thompson. – Il Saggiatore, 1969
Cap. 2. La rivoluzione americana
2.1 La cultura politica come potenziale eversivo
Alla fine della guerra dei sette anni (il conflitto combattuto in Europa e nelle colonie dell’America settentrionale e dell’India, tra il 1756 e il 1763, nella quale fu impegnata la maggior parte delle potenze europee), la Gran Bretagna emerge come la più grande potenza mondiale.
Se i suoi possedimenti europei non sono aumentati significativamente, i suoi domini coloniali invece si e di parecchio: non solo adesso controlla aree strategiche della penisola indiana, ma ha posto la sua egemonia pure su tutta l’area coloniale dell’America nord-orientale.
E’ un impero vasto da dominare; le esigenze dell’amministrazione e dell’esercito, già molto grandi durante la Guerra dei Sette Anni, sono ulteriormente cresciute visto l’ampliarsi dei possedimenti territoriali.
Come farvi fronte? L’idea, piuttosto semplice e condivisa sia da Giorgio 3. (1760-1820), il giovane sovrano britannico, sia dai suoi governi, è di affrontare l’aumento delle spese, derivato dalle conquiste territoriali nel Nord America, con un aumento della pressione fiscale sui contribuenti delle colonie nordamericane.
In apparenza è un ragionamento che non fa una piega: “Che le colonie d’America paghino per i servizi che la corona britannica offre loro”, così si ragiona a Londra.
Del resto l’area nordamericana è in piena espansione demografica ed economica; tra il 1750 e il 1775 la popolazione è passata da 1.200.000 abitanti a 2.50.000 abitanti; le piantagioni delle colonie del Sud così come le attività artigianali, industriali e cantieristiche delle aree settentrionali sono sollecitate dagli intensi flussi di traffico che le collegano all’Africa e all’Europa (vedi. Cap. 1.2) e attraversano una fase economica abbastanza favorevole; cosicché al governo britannico sembra piuttosto logico sfruttare il momento di crescita.
Ma è un calcolo sbagliato perché l’aumento della pressione fiscale suscita una serie di reazioni che conducono a una crisi politica di prim’ordine.
Questa non è la prima grande crisi fiscale che si abbatte su uno Stato europeo: in fondo, le rivoluzioni inglesi di un secolo prima hanno avuto, almeno in una certa misura, un’origine analoga.
Ma i governanti britannici non sanno far tesoro dell’esperienza dei loro avi e cercano di piegare con durezza le resistenze che incontrano.
Di fronte a loro, tuttavia, non si trovano stupidi e rozzi coloni, ma persone che non vogliono cedere assolutamente, anche perché si sentono orgogliosamente consapevoli dei loro diritti.
A dar vigore alla fermezza dei coloni concorrono almeno tre importanti componenti della cultura delle società coloniali nordamericane:
a) per prima la tradizione teologica dei gruppi protestanti puritani (vedi parole della storia), insediati soprattutto nelle colonie settentrionali.
Si tratta di una tradizione originariamente elaborata dai Padri Pellegrini, cioè dai membri di quelle comunità puritane che sono fuggite dalle repressioni religiose nell’Inghilterra della prima metà del Seicento; ed è una tradizione che vede l’America come una biblica “terra promessa” donata da Dio ai suoi figli i quali, per questo, hanno il “sacro” diritto di proteggerla, difendendo, al tempo stesso, la propria libertà.
b) poi questa visione religiosa del destino d’America - ripetuta innumerevoli volte nei testi teologici e nei sermoni dei membri delle comunità protestanti puritane – si fonde con l’elaborazione teorica che viene dall’Inghilterra post-rivoluzionaria, secondo cui gli individui godono di diritti naturali (vedi parole della storia) che non possono essere ignorati o estirpati dai sovrani, una teoria che gode di ampia simpatia nelle colonie d’America.
c) infine, queste due fonti di elaborazione di una primitiva cultura nordamericana dei diritti trovano sostegno nella letteratura politica radicale antimonarchica, di ispirazione illuminista, che dall’Europa raggiunge l’America e che trova accoglienza interessata tra le élite più colte delle colonie
I governanti inglesi non considerano con sufficiente attenzione il potenziale eversivo espresso da una cultura politica di questo tipo, peraltro così vicina a quella dei rivoluzionari inglesi del 17. secolo; e così l’aggressiva politica che intendono imporre alle colonie nordamericane finisce per provocare una nuova rivoluzione non meno radicale di quelle del secolo precedente.
Parole della storia
Confederazione, federazione
Una confederazione è una associazione di Stati autonomi, stabilita da un atto formale (per esempio un trattato), che talora prevede una serie di istituzioni comuni; in una confederazione, tuttavia, gli Stati membri mantengono gran parte delle loto prerogative e gli organi confederali di governo hanno poteri relativamente ridotti.
Una federazione è una formazione politica all’interno della quale le articolazioni che ne sono parte (che possono chiamarsi “regioni” o “Stati”) mantengono una larga autonomia, ma sono coordinate da un governo centrale al quale sono demandate in modo esclusivo importanti competenze (in particolare il potere di emettere moneta, la difesa, la politica estera).
Diritti naturali
Sin dal 17. secolo una corrente della filosofia politica (giusnaturalismo) ha elaborato una teoria che innova profondamente il concetto di diritto: il diritto di cui parlano i teorici del giusnaturalismo non è più soltanto il frutto di un patto tra il sovrano e i vari gruppi corporati (i ceti, gli ordini, le città, le corporazioni), che in tal modo ottengono una serie di “franchigie”, cioè di privilegi e di ben specifiche libertà; è piuttosto un insieme di diritti che esistono all’interno di un ipotetico stato di natura, prima che qualunque Stato si sia formato e che qualunque legge positiva sia approvata e messa in vigore.
I contenuti della libertà definita dal diritto naturale variano da pensatore a pensatore e possono includere il diritto alla tutela della persona, della proprietà individuale, della libertà di espressione e di scelta politica.
Tali “diritti naturali” sono considerati dal giusnaturalismo il necessario fondamento delle formazioni politiche e non possono essere violati da nessuna legge positiva.
Genere
Questo termine è entrato nel lessico storiografico degli anni Ottanta del 20. secolo e indica l’appartenenza sessuale di un individuo (maschio, eterosessuale, domma eterosessuale, ecc.) e i ruoli sociali e politici che gli vengono attribuiti proprio sulla base di tale appartenenza.
Il concetto di “genere” è stato coniato per sottolineare il carattere culturale della identità sessuale, poiché sia la storiografia sia l’antropologia hanno mostrato che tali identità variano profondamente, da luogo a luogo, e da periodo a periodo.
Fondamentale – per un primo approccio al concetto, è il saggio di Joan W. Scott: “Il “genere”: un utile categoria di analisi storica, in “Rivista di Storia Contemporanea”, 1987, n. 4 (pubblicato originariamente in “American Historical Review, 1986, n. 91)
Parlamenti locali.
In tutte le colonie britanniche vengono istituiti parlamenti provinciali bicamerali, , con almeno una camera elettiva; il diritto di voto viene riservato ai maschi, bianchi e ricchi; il governatore è, nella maggioranza dei casi, di nomina regia, e dipende dal governo di Londra.
Puritani
Propriamente, il nome indica quei gruppi protestanti inglesi, spesso influenzati dal calvinismo, che tra 16. e 17. secolo vogliono “purificare” la Chiesa anglicana da ogni residuo contatto col cattolicesimo.
In senso lato, il termine indica anche il rigore morale che connota diverse delle tendenze o dei gruppi che appartengono all’ambito puritano.
Nella prima metà del Settecento, nell’ambito del puritanesimo britannico si possono distinguere tre principali posizioni: a) gruppi favorevoli alla costituzione di una Chiesa presbiteriana di ispirazione calvinista; b) gli indipendenti, favorevoli alla legittimazione di singole e autonome congregazioni di fedeli; c) settari, sostenitori della piena e assoluta libertà di organizzazione e di professione dei fedeli.
Più volte, nell’Inghilterra degli Stuart, i puritani subiscono delle dure repressioni, che spingono alcuni di essi ad abbandonare l’Inghilterra per trovare un loro spazio nel Nuovo Mondo (20000 ca. emigrano tra il 1620 e il 1635): famosa la prima migrazione dei 102 Pilgrim Fathers (“Padri Pellegrini”) che nel 1620 emigrano nell’America del Nord a bordo della nave Mayflower.
Separazione dei poteri
La logica delle leggi e il loro fondamento politico sono al centro della riflessione teorica proposta da Montesquieu nel suo Lo spirito delle leggi (1748).
Egli vi opera una fondamentale distinzione tra forme di governo “moderato” e forme di governo “dispotiche”: le prime possono essere indifferentemente repubbliche o monarchie, purché ciò che le caratterizza sia un’articolata distribuzione e separazione dei poteri e in particolare del potere di fare le leggi (legislativo), di farle eseguire (esecutivo) e di farle rispettare (giudiziario); perché si abbia un governo “moderato” e, in quanto tale, anche giusto, questi tre poteri devono essere attribuiti a istituzioni diverse e quanto più possibile autonome le une dalle altre.
Si hanno, invece, dispotismi (o tirannie), quando i tre fondamentali poteri si concentrano in una sola istanza istituzionale (che può essere un sovrano in una monarchia o anche un’oligarchia aristocratica come nella Repubblica di Venezia).
Le forme di governo “moderato” sono – secondo Montesquieu – quelle più equilibrate e giuste, poiché il sistema di contrappesi attivato dalla distribuzione dei poteri che vi è in vigore pone un argine alla naturale inclinazione dell’animo umano ad abusare del potere; laddove, invece, tale divisione dei poteri non opera – come nei dispotismi – e i tre poteri si concentrano in una sola mano, l’arbitrio diventa la regola: e questo è il motivo per cui nei dispotismi e nelle tirannie è protetta soltanto la licenza e l’arbitrio dei despoti, mentre la libertà di tutti non è tutelata in alcun modo.
Suffragio universale, suffragio censitario (o ristretto.
Si parla di suffragio universale quando il diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti in un Parlamento è esteso a tutte le persone adulte che appartengono alla comunità politica in questione.
Storicamente il suffragio universale è stato prima appannaggio di tutti i maschi adulti, e in questo caso si parla di “suffragio universale maschile”; successivamente è stato esteso alle donne adulte e solo in questo caso è corretto usare la formula “suffragio universale”, senza altre qualificazioni.
Si parla di suffragio censitario (o ristretto) quando il diritto di voto è attribuito solo a una porzione degli adulti di una comunità in possesso di particolari requisiti, quali l’essere maschi, adulti, saper leggere e scrivere e pagare più di un certo livello di tasse.
Il termine “censitario” – da “censo”, cioè patrimonio o ricchezza – richiama particolarmente l’attenzione su questo requisito.
Si usa il più generico termine “ristretto” quando ci si vuole riferire all’effetto prodotto da tutto l’insieme dei requisiti che limitano l’attribuzione dei diritti di voto.
Oltre ai requisiti già ricordati ve ne possono essere altri; negli Stati Uniti, per esempio, l’essere bianco è stato a lungo un requisito essenziale per il pieno godimento del diritto di voto.
Bibliografia
La formazione degli Stati Uniti / A. Testi. – Il Mulino, 2003
I figli della libertà: alle origini della democrazia americana / G. S. Wood. – Giunti, 1996
Cap. 3. La Rivoluzione francese
3.1 La crisi della monarchia francese
Sin dalla metà del 18. secolo il formarsi di un’opinione pubblica [vedi parole della storia del cap. 1] consapevole e informata ha contribuito ad indebolire la struttura dello Stato monarchico francese; e il prestigio di Luigi 15 (1715-1774) e di Luigi 16. (1774-1792) ne ha risentito moltissimo.
Tuttavia il vero punto critico della monarchia francese è l’emergenza fiscale, causata dalle spese sostenute nelle guerre recenti, la guerra dei Sette anni e la guerra di indipendenza americana, cui la Francia ha partecipato a fianco dei coloni ribelli.
Dopo queste guerre la situazione finanziaria dello Stato francese è diventata davvero grave.
Un piano di riordino delle finanze, delle imposte e dell’intera struttura amministrativa è assolutamente necessario.
E così nel 1786 il ministro delle finanze, Charles Alexandre de Calonne (1734-1802), d’accordo col sovrano Luigi 16, prepara un ambizioso progetto di riforma che prevede l’abolizione delle dogane interne, la liberalizzazione del commercio del grano, la costituzione di assemblee elettive con compiti consultivi e, soprattutto, l’abolizione delle esenzioni fiscali di cui ancora godono nobili e clero.
Il re è d’accordo, il Parlamento di Parigi (vedi parole della storia) no.
L’opposizione del Parlamento al progetto di riforma non ha solo un contenuto sociale (difendere i privilegi fiscali di nobiltà e clero).
Essa, infatti, nasce anche dal desiderio di mantenere inalterati i rapporti di forza tra le istituzioni.
E’ anche per questo che i parlamentari si oppongono: vogliono restare uno dei perni del sistema istituzionale, senza che alcuna riforma ne minacci, sia pure indirettamente, la centralità.
Questo tra il governo e il Parlamento di Parigi è ancora un conflitto tipico dell’Età moderna: da una parte c’è il sovrano che vuole imporre la sua autorità; dall’altra c’è un corpo cetuale che fa resistenza.
Priva del consenso dei parlamentari la riforma non può fare passi avanti.
Allora si cercano altre soluzioni; il sovrano e i suoi ministri tentano perfino di sciogliere di forza il Parlamento, ma non hanno il coraggio necessario a portare fino in fondo quesa iniziativa.
Alla fine la via d’uscita, che appare a tutti la meno traumatica, è quella di convocare gli Stati generali, un organismo di rappresentanza cetuale mai più riunito dal 1614: a esso si vuole rinviare il compito di discutere il piano di riforma.
Nell’agosto del 1788 il governo ne annuncia la convocazione.
Ma nel suo tenace tradizionalismo istituzionale, già il successivo 25 settembre il Parlamento di Parigi chiede che gli Stati generali siano convocati secondo le regole consuete, ovvero facendo votare l’assemblea per ordini [vedi parole della storia].
Poiché gli ordini sono tre – la nobiltà, il clero e il Terzo Stato – ne consegue che con tutta probabilità, in un’assemblea regolata da questa procedura, saranno sempre l’opinione dei nobili e del clero, detentori dei privilegi, ad avere la meglio.
La richiesta formulata dal Parlamento è un modo per ostacolare ulteriormente il piano di riforma.
L’esito di questo contenzioso tra il governo e il Parlamento è un compromesso: si stabilisce così che negli Stati Generali il Terzo Stato (che rappresenta il 98% della popolazione francese) abbia un numero di rappresentanti pari alla somma dei rappresentanti degli altri due ordini: ma sulle procedure di voto non si prende alcuna decisione.
A questo punto la discussione si anima follemente.
Un po’ perché la procedura di elezione dei rappresentanti dei tre stati prevede che le assemblee elettorali che si riuniscono in tutto il territorio del regno possano esprimere richieste o manifestare proteste attraverso la redazione dei cahiers de doléances (“quaderni di lamentele”), poi affidati al rappresentante eletto affinché li presenti al sovrano e agli Stati generali; un po’ perché la discussione travalica presto i luoghi istituzionali, cosicché singole persone, intellettuali, avvocati, giornalisti o abati dicono la loro tramite pamphlets, cioè brevi testi a stampa con cui si interviene sulle questioni di attualità.
In questa esplosione discorsiva, che non era mai stata provocata nemmeno dalle fasi più intense del dibattito illuminista dei decenni precedenti, un testo spicca per lucidità di analisi, per geometria propositiva e per il successo che subito lo circonda: Che cos’è il Terzo Stato? dell’abate Emmanuel-Joseph Sieyès.
Il libretto, pubblicato nel gennaio, 1789, lancia una serie di proposte assolutamente deflagranti.
Sostenendo che una vera nazione esiste solo dove tutti siano soggetti alle medesime leggi e nessuno goda di speciali privilegi, Sieyès afferma senza mezzi termini che, mentre il Terzo Stato è l’espressione della nazione nella sua interezza, nobili e clero non sono altro che dei puri parassiti; per questo è giusto non solo che il Terzo Stato abbia una rappresentanza doppia rispetto a quella degli altri due ordini, ma anche che si voti per singola testa e non per ordine, poiché ogni deputato ha il diritto di concorrere individualmente alla formazione della volontà generale.
L’affermazione ha una importanza assoluta, poiché conferisce alla crisi in corso una chiarissima connotazione sociale (i non privilegiati contro i privilegiati), mostrando che non si tratta più soltanto di un conflitto istituzionale vecchio stile.
Inoltre – e forse questo è l’aspetto più significativo – rivoluziona il concetto di libertà proprio delle società cetuali dell’Europa moderna: aderendo a uno dei principi più profondi del pensiero illuminista, Sieyès rimarca che la libertà non è un diritto appartenente a specifici gruppi (gli ordini e i loro organismi) ma è un fatto individuale, che chiede quindi un’espressione egualmente individuale, ovvero il voto per singola testa.
Non che nel pensiero di Sieyès manchi del tutto una componente organicistica: da un lato, infatti, egli sostiene che la società non deve essere strutturata in corpi cetuali distinti, ma deve essere una società di singoli cittadini che hanno il diritto di esprimersi autonomamente; dall’altro, tuttavia, egli afferma che questi liberi cittadini si trovano saldamente re-inseriti dentro un corpo politico collettivo che li contiene e li trascende, la nazione.
Al momento questo snodo concettuale non comporta speciali problemi: in prospettiva, il rapporto tra nazione e individui, tra volontà nazionale e volontà individuale, emergerà come uno dei problemi essenziali sia del pensiero liberale sia di quello democratico.
Già questi aspetti del libretto di Sieyès sono molto significativi.
Ma ancora più rilevante è il piano d’azione concreta che egli prospetta ai rappresentanti del Terzo Stato nelle pagine conclusive del suo pamphlet: se è vero che essi simboleggiano la nazione nella sua interezza – scrive Sieyès - , non devono far altro che abbandonare gli Stati Generali, autoproclamarsi “Assemblea Nazionale” e scrivere una Costituzione; i membri degli ordini privilegiati potranno aderire alla costituenda Assemblea Nazionale se accetteranno di spogliarsi dei loro privilegi.
Parole della storia
Asimmetrie di genere
Il termine si riferisce alla distinzione gerarchica tra genere maschile e genere femminile che attraversa moltissime società e gran parte della storia dell’Occidente.
Tuttavia, per quanto possa sembrare paradossale, l’idea di una “naturale” superiorità dell’uomo sulla donna viene potentemente rilanciata nel corso del 18. secolo proprio dai pensatori che propongono i modelli socio-politici più innovativi.
Tra di essi Rousseau ha un posto in primo piano, poiché a lungo, soprattutto nel suo trattato pedagogico Emilio o Dell’educazione (1762), teorizza la diffusione di un nuovo rapporto matrimoniale, basato sull’amore romantico, cioè sulla passione dei due futuri sposi, e non più sugli accordi stretti dai genitori in base a criteri sociali ed economici.
Questo matrimonio di nuovo tipo, oltre che sulla passione d’amore, deve basarsi anche su una precisa divisione di ruoli: la donna, casta e attenta a difendere il suo onore, deve trovare il suo posto negli spazi domestici; deve innanzitutto occuparsi dei figli, che devono essere allattati al seno da lei stessa perché crescano sani e felici, e non dati a balia.
Ma poi la buona moglie deve anche occuparsi del marito: a costui soltanto dev’essere riservata la possibilità di calcare la scena pubblica (andare a lavorare, occuparsi di politica, occuparsi di cultura); alle donne questi spazi devono essere preclusi, perché naturalmente estranei alla sua conformazione fisica e alla sua “struttura nervosa”.
Questa nuova asimmetria di genere viene costruita come una risposta politica alla libertà sessuale, intellettuale e politica che da decenni le donne hanno conquistato nelle corti e negli ambienti aristocratici europei.
Per Rousseau e per gli autori che sostengono il nuovo matrimonio romantico, la libertà delle donne a corte o nei salon è il segno più chiaro della immoralità di quegli ambienti, confermata d’altronde dalla dissolutezza sessuale che vi domina.
Viceversa, la virtù di una società politicamente e socialmente rigenerata, deve manifestarsi nella diffusione della libertà politica riconquistata dagli uomini e nella casta modestia domestica nella quale devono essere confinate le donne.
Calendario rivoluzionario
Il nuovo calendario rivoluzionario conta gli anni a partire dal 22 settembre 1792, giorno successivo alla proclamazione della Repubblica: così l’anno compreso tra il 22 settembre 1892 e il 21 settembre 1793 è l’anno 1. della Repubblica; il successivo è l’anno 2.: e così via.
Oltre a mutare il conteggio degli anni, il calendario rivoluzionario cambia la scansione delle settimane, con l’abolizione della domenica: i giorni lavorativi sono nove; il giorno di riposo è il decimo, che si chiama decadì.
E’ una misura che rientra nel più complessivo programma di scristianizzazione.
Non si tratta di una riforma particolarmente apprezzata, poiché fa in modo che in un mese ci siano tre giorni soltanto di riposo, invece dei quattro consueti.
Infine viene cambiato il nome dei mesi.
Il primo mese dell’anno rivoluzionario è vendemmiaio (22/9-21/10) e poi seguono frimaio, nevoso, piovoso, ventoso, germinale, fiorile, pratile, messidoro, termidoro e fruttidoro.
Contratto sociale
E’ il titolo di un’opera fondamentale di Jean-Jacques Rousseau, pubblicata nel 1762.
Esaminando da una prospettiva radicale i presupposti contrattuali che hanno animato le istituzioni politiche europee di epoca moderna, Rousseau nega che un patto tra un sovrano e i suoi sudditi possa dare esiti positivi, perché esso è sempre viziato dall’originaria disuguaglianza di potere tra i contraenti.
Il vero contratto sociale, invece, dev’essere un patto sottoscritto da individui tutti eguali tra loro, tutti portatori dei loro diritti naturali, che riunendosi assieme e siglando l’accordo originario che fonda una nuova comunità politica, accettino anche di sottostare alle leggi comuni che nasceranno da quell’accordo collettivo.
Gli individui così riuniti in una nuova comunità, esprimono una “volontà generale”: questa “volontà generale” prende la forma di leggi fondamentali(una costituzione cioè) e di istituzioni specifiche: un corpo legislativo (al quale devono appartenere sempre tutti i cittadini); e un corpo esecutivo (un governo cioè), di cui deve far parte un ristretto numero di membri eletti da tutti gli altri.
Rousseau, dunque, immagina che la rifondazione del politico attraverso un patto collettivo, debba dar vita a una democrazia parzialmente diretta; in questo sistema politico ideale tutti i cittadini devono fare le leggi, senza che avvenga ciò che capita in Gran Bretagna dove, attraverso le elezioni, un certo numero di aventi diritto al voto delega un numero molto più piccolo di rappresentanti (i parlamentari) che – insieme ai Lord – sono gli unici che hanno il vero potere di fare le leggi.
Inflazione
Aumento generalizzato dei prezzi delle merci, cui corrisponde una riduzione del potere d’acquisto della moneta.
Possiamo dire che siamo di fronte a un semplice e isolato aumento di prezzo se, per esempio, solo una certa particolare merce, cha due anni fa costava cento euro e adesso costa centocinquanta euro; ma se questo aumento di prezzo di verifica – in proporzioni maggiori o minori – per la maggior parte delle merci e dei beni in commercio, ecco che siamo di fronte a un processo generalizzato di inflazione.
Ordini
Ordine è un sinonimo di “ceto” o “stato” (come nella locuzione Terzo stato).
Questi termini indicano un insieme di persone che, per la loro comune condizione economico-sociale, o per diritto di nascita, godono della medesima posizione riguardo ai diritti e ai doveri politici.
Diverse istituzioni cetuali di ancien regime sono articolate in tre grandi ordini: clero, nobiltà e Terzo Stato, una ripartizione che riflette l’antica distinzione medievale tra coloro che pregano, coloro che combattono e coloro che lavorano, strutturati gerarchicamente al loro interno.
Anche gli Stati Generali di Francia hanno questa articolazione interna.
Parlamento di Parigi
Il Parlamento di Parigi e gli altri parlamenti che esistono in varie città del Regno di Francia non sono assemblee con poteri legislativi quali il Parlamento inglese o il Congresso americano.
Sono invece dei tribunali; i magistrati che vi operano sono “proprietari” della funzione, il cui possesso dà anche diritto a un titolo nobiliare.
Il Parlamento di Parigi è il più importante tra i Parlamenti francesi perché svolge la funzione di Suprema Corte di giustizia; per tale ragione ha il diritto di registrare gli editti reali e, se necessario, di sollevare eccezioni sulla loro legittimità.
Privilegi feudali
L’espressione fa riferimento ai diritti dei titolari di signorie fondiarie.
Normalmente un “signore” è anche il principale proprietario terrieri della zona su cui esercita il diritto di signoria; ma è altrettanto normale che i diritti di signoria riguardino un’area che oltrepassa i confini delle proprietà terriere del signore.
Il signore può esercitare il diritto di riscuotere dazi sulle strade o sugli attracchi dei fiumi che attraversano la sua signoria; ha il diritto di riscuotere un censo, cioè un tributo, da tutti i proprietari della zona; e ha il diritto di nominare i magistrati nei tribunali di prima istanza che amministrano la giustizia nel territorio signorile.
Oltre a ciò, più raramente vanta diritti di servitù personale sui contadini (nel 1789 solo lo 0,5% dei contadini è gravato da forme di servitù della gleba).
Religione civile
L’idea di una religione civile, e di rituali e feste pubbliche che ne alimentino la diffusione, va ricondotta alle tesi espresse da Jean-Jacques Rousseau in due sue diverse opere.
Al termine del Contratto sociale (1762), Rousseau pone un capitolo conclusivo che si intitola, appunto, Della religione civile, nel quale auspica la fondazione di un nuovo modo di vivere la politica; tale religione non deve aver niente a che fare con le religioni costituite; deve, invece, essere articolata in dogmi spirituali e in rituali propri, col fine di aiutare il “popolo” di uno Stato – e in particolare di uno Stato democratico, come è quello che egli descrive in questa opera – a sentirsene profondamente parte attiva.
E così, per lui, l’emotività che circonda l’esperienza della fede, deve avvolgere anche la vita politica.
Nel Contratto sociale Rousseau si limita a enunciare questo progetto.
In un’opera successiva, scritta nel 1770-71, e pubblicata postuma nel 1782, le Considerazioni sul governo di Polonia e sul progetto di riformarlo, egli presenta delle semplificazioni molto suggestive dei cerimoniali e delle pratiche, attraverso le quali una religione civile deve avvicinare i cittadini al culto della propria patria, e dello Stato che la esprime.
Qui la pura razionalità del patto sottoscritto consapevolmente da tutti i fondatori della nuova comunità politica – descritto nel Contratto sociale – si perde, a favore della totale emozionalità che deve impossessarsi della politica, poiché – come scrive con una punta di cinismo – “chiunque abbia la pretesa di dare ordinamenti a un popolo deve saper dominare le opinioni e, per loro mezzo, governare le passioni degli uomini”.
Sanculottes (sanculotti).
Gruppo socio-politico, composto da artigiani, lavoranti, piccoli bottegai, impiegati: ha un orientamento radicale ed è uno dei principali attori delle vicende rivoluzionarie.
Il nome – in origine dispregiativo – fa riferimento ai pantaloni lunghi indossati dal popolo minuto, diversi da quelli usati dalla nobiltà, che arrivano fino al ginocchio; questi pantaloni in uso tra i nobili si chiamano culotte, da cui sans culotte = senza pantaloni corti.
Suffragio diretto, suffragio indiretto
Si parla di suffragio diretto quando gli elettori votano direttamente i propri rappresentanti.
Si parla di suffragio indiretto quando gli elettori eleggono altri individui – i quali, a loro volta, hanno il compito di eleggere i rappresentanti.
L’espressione “suffragio censitario indiretto” vuol dire che, secondo la Costituzione del 1792, sia gli elettori di primo grado sia gli elettori di secondo grado sono selezionati attraverso requisiti di censo; sono elettori di primo grado coloro i quali pagano “una contribuzione diretta uguale al valore di almeno tre giornate di lavoro”; mentre possono essere scelti come elettori di secondo grado solo coloro i quali hanno una ricchezza assai maggiore
Tricolore
Nel paragrafo è narrata una delle versioni sulla nascita del tricolore: Luigi 16. si appunta sul cappello, accanto alla coccarda bianca – colore attribuito ai Borbone – un nastro rosso e blu, simbolo del Municipio di Parigi: l’associazione dei tre colori – simbolo di unità e concordia – dà vita al tricolore.
Secondo un’altra versione la coccarda tricolore circola già da diversi giorni come emblema distintivo delle milizie della Guardia nazionale.
Se si è in dubbio sul vero momento di nascita del tricolore, è certo invece che esso diventa, sin dai primi mesi della Rivoluzione, uno dei simboli più universalmente diffusi, venendo considerato ufficialmente – sin dal 1790 – come emblema nazionale.
Il 15 febbraio del 1794 un decreto della Convenzione stabilisce definitivamente – sulla base di un disegno di Jacques-Louis David – che “il vessillo nazionale sarà formato da tre colori nazionali, disposti in tre bande uguali, poste verticalmente in modo che il blu sia attaccato al pennone, il bianco stia in mezzo e il rosso sventoli nell’aria”.
Bibliografia
Critica della Rivoluzione francese / F. Furet. – Laterza, 2004
Dizionario critico della Rivoluzione francese / F. Furet, m. Ozouf (a cura di). – Bompiani, 1994
La Rivoluzione francese / F. Furet, D. Richet. – Laterza, 2008
La Rivoluzione francese: politica, cultura, classi sociali / L. Hunt. – Il Mulino, 2007
La Rivoluzione francese / A. Mathiez, G. Lefebvre. – Einaudi, 2001
Il trono vuoto: la transizione della sovranità nella Rivoluzione francese /P. Viola. – Einaudi, 1989
Cap. 4. La Francia e l’Europa
4.1 Dopo il terrore: il Direttorio
Il 0 Termidoro 1794 Robespierre e i suoi sono destituiti; il giorno dopo vengono giustiziati.
A vincere, in quell’occasione, è un composito schieramento di membri della Convenzione (cioè dell’organo parlamentare rimasto nominalmente attivo durante il Terrore), legati più da un generico moderatismo e dalla comune avversione a Robespierre e ai giacobini che da un solido progetto politico condiviso.
In nome di questo tenue filo che li lega, essi cercano di cancellare ogni traccia dell’esperienza di governo dei due anni precedenti.
Si procede così, ovunque, alla chiusura dei club giacobini, i cui capi sono arrestati, mentre nelle province si lascia che gruppi controrivoluzionari aggrediscano e talora massacrino i militanti giacobini locali; si interrompe l’azione di scristianizzazione, proclamando la fine del culto dell’Essere Supremo; infine si sopprimono le principali misure di politica economica entrate in vigore nei due anni precedenti, tra le quali, in particolare, il calmiere dei prezzi.
Quest’ultima mossa dà una potentissima spinta all’inflazione, che raggiunge livelli mai visti in precedenza e determina un vertiginoso rimescolamento di ricchezze: coloro i quali rapidamente si arricchiscono (ed essenzialmente sono “quelli che fanno i prezzi”: i commercianti, gli appaltatori, gli imprenditori) guardano con indifferenza chi altrettanto rapidamente si impoverisce (e sono soprattutto quelli che vivono di redditi fissi: proprietari di terre o di immobili; stipendiati e salariati; possessori di titoli del debito pubblico).
L’instabilità economico-sociale non fa che accentuare l’inquietudine politica che ha seguito il rovesciamento di Robespierre.
Per questo si tenta subito di trovare un punto di equilibrio attraverso una nuova modifica degli assetti costituzionali: la Costituzione del 1793, peraltro mai entrata in vigore, viene abolita e se ne scrive una nuova che è approvata il 22 agosto 1795.
Si tratta di una Costituzione molto lontana dal modello adottato appena due anni prima: assai lunga e tecnicamente piuttosto complessa, istituisce un sistema politico ispirato a un’interpretazione molto rigida del principio di divisione dei poteri.
Il Parlamento è bicamerale: una Camera (il Consiglio dei Cinquecento, composto da uomini di almeno trent’anni) ha il compito di scrivere le leggi; l’altra (il Consiglio degli Anziani, composto da uomini sposati o vedovi di almeno quarant’anni) ha il compito di approvare o respingere le proposte formulate dai Cinquecento.
Attraverso un complicato sistema, le due Camere eleggono i cinque membri del Direttorio, una sorta di super esecutivo che ha il compito di nominare i ministri: costoro, tuttavia, non sono altro che funzionari amministrativi, poiché i veri titolari del potere esecutivo sono i cinque membri del Direttorio.
Il sistema elettorale è censitario e prevede elezioni a doppio grado.
Il numero degli elettori è molto ridotto: 200000 elettori di primo grado; 30000 di secondo grado; rispettivamente il 3% e lo 0,5% sul totale dei maschi adulti.
Per di più vengono introdotte norme che prevedono il rinnovo annuale parziale degli organi (le Camere e il Direttorio); viene introdotta anche una disposizione con cui si prevede che gli elettori debbano scegliere 2/3 dei deputati tra gli ex membri della Convenzione: il personale politico che ha rovesciato Robespierre e ha scritto la nuova Costituzione non vuole assolutamente veder messo in discussione il potere che ha appena conquistato.
La risposta dell’opinione pubblica a questo nuovo quadro costituzionale non è positiva.
Molti criticano il carattere spudoratamente oligarchico della norma dei 2/3, segno arrogante di una classe politica che non vuole, per nessuna ragione, abbandonare il potere; altri, soprattutto tra le classi popolari, criticano l’abbandono della politica economica di contenimento dell’inflazione e di controllo dei redditi, oltre alla natura elitaria della rappresentanza parlamentare; la destra filomonarchica è insoddisfatta per la conferma dell’assetto repubblicano; tutti sono sconcertati dal cattivo funzionamento del sistema il quale appare subito inceppato dalla esagerata segmentazione istituzionale prevista dalla Costituzione.
L’inquietudine politica e il disagio sociale trovano presto espressione in modi clamorosi, con insurrezioni e congiure che cercano di abbattere il sistema politico emerso dal rovesciamento dei giacobini.
A sinistra l’agitazione trova modo di esprimersi con due tentativi insurrezionali promossi dai sanculotti di Parigi tra l’aprile e il maggio 1795 (germinale e pratile anno 3.): entrambi sono facilmente repressi nel sangue dalle truppe di stanza in città.
Un anno più tardi (maggio 1796) viene scoperta una congiura, detta degli Eguali, coordinata da un ex Giacobino, François Noel (detto Graccus) Babeuf, il quale avrebbe voluto rovesciare il Direttorio per imporre un regime che avrebbe dovuto abolire la proprietà privata e instaurare una sorta di società comunista: processato e condannato, Babeuf viene giustiziato nel maggio del 1797.
A destra l’inquietudine si manifesta inizialmente in Vandea dove, fra il giugno e il luglio 1795, un corpo di spedizione finanziato da emigrati filomonarchici sbarca sulle coste e cerca di ravvivare l’insurrezione, ma viene rapidamente bloccato e disperso.
Nell’ottobre seguente, per protesta contro la norma che impone l’obbligo di scegliere i 2/3 dei deputati tra gli ex convenzionali scoppia a Parigi un’altra rivolta popolare, animata da capi filomonarchici; il Direttorio si affida, in questo caso, all’azione di un giovane generale, Napoleone Bonaparte, che il 5 ottobre 1795 (13 vendemmiaio anno 3.) non esita a dare l’ordine di disperdere la folla dei rivoltosi a cannonate.
In un certo senso si può attribuire a questo episodio, in sé abbastanza minore, il significato di una svolta storica di notevoli implicazioni politiche.
Dopo il 13 vendemmiaio anno 3. non ci saranno più insurrezioni di “popolo”; da allora, per 35 anni le strade di Parigi non vedranno più folle rivoluzionarie armate dirigersi contro un qualche obiettivo politico.
Al posto delle “giornate rivoluzionarie” si fa strada un’altra tecnica di risoluzione brutale delle crisi politiche: il colpo di Stato [vedi parole della storia].
Il primo vero e proprio colpo di Stato viene messo in atto dopo che nell’aprile del 1797 le elezioni hanno fatto registrare un netto successo della destra monarchica, tanto che nei due Consigli legislativi si delinea la possibilità di una maggioranza contraria agli orientamenti del Direttorio in carica.
Il Direttorio, guidato da Paul Barras, reagisce affidandosi al sostegno dei generali Bonaparte, Hoche e Augereau.
Le truppe di quest’ultimo il 4 settembre 1797 (18 fruttidoro anno 5.) occupano Parigi; il Direttorio procede all’annullamento dell’elezione di circa 140 deputati di opposizione, mentre 65 uomini politici dell’opposizione vengono deportati, la stampa filomonarchica viene censurata e nuove misure contro i preti refrattari e gli emigrati aristocratici vengono approvate.
Questo modo di risolvere la crisi politica non resta un esempio isolato.
Appena un anno dopo, nell’aprile del 1798, le nuove elezioni danno nuovamente un risultato sfavorevole al Direttorio in carica (ancora guidato da Barras).
Questa volta, però, la bilancia politica pende nella direzione opposta, con un grande successo elettorale della sinistra radicale e neo giacobina; nel maggio del 1798 il Direttorio affronta la crisi politica che si sta profilando annullando l’elezione di 104 deputati di opposizione con vari pretesti e sempre sotto la minaccia dell’intervento dell’esercito.
Questi due episodi meritano di essere sottolineati perché mostrano come anche nel periodo successivo al Terrore la lotta politica in Francia continui a essere concepita dai suoi protagonisti come una pratica a “somma zero”: cioè è uno scontro nel quale chi vince vuole conquistare tutto mentre chi perde è costretto a perdere tutto (libertà compresa).
In un contesto simile non c’è spazio per una normale dialettica elettorale e parlamentare, mentre è evidente che l’esercito e i suoi generali stanno diventando un elemento importantissimo nella lotta politica interna, oltre che nei numerosi impegni bellici nei quali, sin dal 1792, la Francia rivoluzionaria è stata coinvolta.
Parole della storia
Colpo di Stato (coup d’état).
L’espressione viene impiegata per la prima volta nel 17. secolo da Gabriel Naudé (in Considérations politiques sur le coup d’état, 1632), per indicare un “provvedimento straordinario” e “traumatico”, suggerito al sovrano dalla “sollecitudine per il bene pubblico”.
Negli anni del Direttorio l’espressione prende a indicare un meditato e pianificato sovvertimento dell’ordine politico-legale, attuato di solito con il sostegno dell’esercito.
Proprio a partire da questi anni tale concetto e la tecnica che esso designa entrano stabilmente a far parte delle “risorse” politiche correnti.
Fedecommessi, primogeniture
In epoca moderna le famiglie nobili adottano in forma piuttosto sistematica degli arrangiamenti successori che favoriscono uno solo dei figli maschi (che può essere il primogenito – e in questo caso si parla di primogenitura; o un dei discendenti maschi individuato attraverso più complesse procedure – e in questo caso si parla di fedecommesso, una forma di successione che vincola l’erede al rispetto della norma che gli impone di lasciare a sua volta il patrimonio a un solo erede maschio).
Queste soluzioni hanno come finalità la conservazione dell’intero patrimonio (normalmente composto di terre e palazzi) in una sola linea di discendenza.
Bibliografia
Istruire nelle verità repubblicane: la letteratura politica per il popolo nell’Italia in rivoluzione, 1796-1799 / L. Guerci. – Il Mulino, 1999
La sciabola di Sieyès: le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista / L. Scuccimarra. – Il Mulino, 2002
I furti d’arte: Napoleone e la nascita del Louvre / P. Wescher. – Einaudi, 1988
L’Italia giacobina / C. Zaghi. – Utet, 1989
Cap. 5. Napoleone
5.1 Dal Consolato all’Impero
Il 15 dicembre 1799 (24 frimaio anno 8.) un proclama diramato dai tre nuovi consoli annuncia ai cittadini francesi i fondamenti essenziali della nuova Costituzione, che viene promulgata il 25 dicembre seguente.
Per la prima volta dall’inizio della Rivoluzione francese, la Costituzione non è scritta da un’assemblea eletta, bensì da un gruppo ristretto di individui i quali si sono attribuiti questo compito dopo un colpo di Stato.
Non sorprende così che essa dia la preminenza all’uomo forte della situazione, il generale Bonaparte, che il testo costituzionale nomina espressamente “primo console”.
Le prerogative costituzionali del primo console – in carica per dieci anni – sono cospicue: a lui spetta il potere esecutivo e, in forma esclusiva, l’iniziativa legislativa, ovvero la possibilità di proporre disegni di legge.
Continua a esistere un Parlamento bicamerale, che funziona secondo un sistema simile a quello introdotto dalla Costituzione del 1795; ovvero alla Camera bassa (che si chiama Tribunato) spetta il compito di discutere i progetti di legge proposti dal primo console; se il Tribunato li approva, passano alla Camera alta (il Corpo legislativo), che ha il compito di approvarli o respingerli in via definitiva; né il Tribunato né il Corpo legislativo, peraltro, possono modificare i progetti di legge proposti dal primo console.
I membri del Parlamento sono eletti con un sistema solo parzialmente democratico: si vota a suffragio universale maschile, ma solo per liste di “eleggibili”, tra i quali un altro organo costituzionale, il Senato, sceglie i nomi di coloro che potranno sedere nelle due camere.
IL Senato è un organismo composto da ottanta membri nominati a vita su proposta del primo console e del Parlamento; ha il compito di controllare la costituzionalità delle leggi approvate dal Parlamento (cioè la loro coerenza con i principi della Costituzione) e, eventualmente, di avviare procedure di revisione costituzionale (cioè di introdurre modifiche nella Costituzione vigente).
Solo dopo che la Costituzione è entrata in vigore viene organizzato un plebiscito [vedi parole della storia] di approvazione: sia per questo particolare, sia per le modalità di esecuzione (caratterizzate da evidenti irregolarità e dal fatto che il voto è palese) il plebiscito è pilotato verso un risultato obbligato, che tuttavia è meno lusinghiero di quanto Napoleone si aspettasse.
I risultati proclamati il 7 febbraio del 1800 dicono che 3001007 cittadini hanno approvato la nuova Costituzione; che solo 1562 l’hanno respinta; che ci sono stati 4000000 di elettori che non sono andati a votare.
Appena entrato in carica, il nuovo regime deve subito preoccuparsi della situazione militare resa critica dall’attacco della Seconda coalizione antifrancese.
La Russia abbandona la coalizione, cosicché l’esercito francese si trova di fronte solo gli austriaci; Napoleone li batte in Italia, a Marengo, il 14 giugno 1800; un altro generale francese, Jean-Victor Moreau, li sconfigge definitivamente a Hohenlinden il 3 dicembre successivo.
Il 9 febbraio del 1801 viene firmata la pace di Lunéville, sulla base della quale la Repubblica francese si vede riconosciuto dall’Austria il controllo, diretto o indiretto, dell’Italia centro-settentrionale.
A completare il quadro, il 27 marzo 1802, Bonaparte firma ad Amiens un trattato di pace con la Gran Bretagna, che prevede l’evacuazione dei britannici da Malta (conquistata nel settembre 1800) e la restituzione dell’Egitto all’Impero ottomano (ma di fatto i francesi l’hanno già perso da alcuni mesi).
La pace con i principali nemici della Francia sembra dunque assicurata; molti dei territori persi dai francesi nel 1799 sono stati riconquistati; da tutto ciò il prestigio di Bonaparte esce potentemente rafforzato.
Il primo console non perde tempo e sfrutta la situazione favorevole per far introdurre una modifica nella Costituzione e farsi proclamare primo console a vita, col diritto di nominare il proprio successore.
Anche questa modifica viene sottoposta ad approvazione mediante un plebiscito che si tiene fra maggio e luglio del 1802; pure in questo caso i risultati sono positivi: i sì sono oltre 3000000 e i no 8374, ma ancora una volta coloro i quali non vanno a votare sono numerosissimi.
La pace fissata tra il 1801 e il 1802 non dura a lungo.
Da una parte la Francia annette al suo territorio il Piemonte, Parma e l’Isola d’Elba; dall’altra i britannici non evacuano Malta, come previsto dagli accordi di Amiens.
In gioco c’è, di nuovo, il controllo del Mediterraneo e la tensione tra Francia e Gran Bretagna si fa acuta finché, nel maggio del 1803, la Gran Bretagna dichiara ufficialmente guerra alla Francia.
Bonaparte avvia subito i preparativi per un grande attacco via mare all’isola.
Forze terrestri e navali cominciano a radunarsi nei pressi di Boulogne, mentre il primo console e i suoi generali studiano i migliori piani di attacco.
I britannici si preparano alla difesa militare e tentano una carta particolare per liberarsi dal pericolo.
Nell’estate del 1803, infatti, con l’appoggio del governo britannico viene ordito un complotto per uccidere Napoleone.
I congiurati sono scoperti e arrestati in Francia tra febbraio e marzo del 1804; interrogati, affermano cha a capo della congiura c’è un principe della famiglia Borbone, di cui, tuttavia, non fanno il nome.
Napoleone ritiene di individuare questo principe nella persona del duca d’Enghien, che il 14 marzo del 1804 viene bloccato e rapito da agenti francesi sul territorio di uno Stato neutrale, il Baden, dove d’Enghien era emigrato.
Frettolosamente giudicato da un tribunale militare e riconosciuto – senza alcun fondamento – colpevole, viene giustiziato il 21 marzo 1804.
Fuori della Francia l’episodio viene duramente criticato per la violazione della territorialità di uno Stato neutrale, oltre che per l’esecuzione di una persona innocente; in Francia, invece, la vicenda suscita un’opposta emozione e viene sfruttata da Napoleone per un ulteriore, decisivo mutamento costituzionale: il 18 maggio 1804 il Senato ratifica un testo costituzionale che proclama Napoleone e i suoi discendenti titolari della dignità imperiale; coerentemente sull’imperatore si concentra il massimo del potere, mentre gli altri organi previsti dalla Costituzione non hanno che funzioni di supporto e di cooperazione.
Anche questa modifica viene sottoposta a plebiscito confermativo: i voti favorevoli sono oltre 3000000; i contrari 2569; di nuovo moltissimi sono coloro il quali non vanno a votare.
In forma singolarmente ibrida, in questa occasione l’esercizio della volontà popolare si affianca alla messa in scena di un rito antico, quello dell’incoronazione dell’imperatore; il ricorso al cerimoniale tardomedievale fa parte di una strategia che intende sottolineare il carattere dichiaratamente neomonarchico del potere riconosciuto a Napoleone (come d’ora in avanti viene chiamato il nuovo imperatore).
Tuttavia Napoleone non è un monarca per diritto ereditario e quindi non lo è nemmeno per diritto divino: dunque è necessario che nella cerimonia – immortalata dal pannello di Jacques-Louis David – si introducano innovazioni rituali capaci di correggere, in modo spettacolare, queste evidenti “imperfezioni” nell’origine della nuova potestà imperiale.
Parole della storia
Guerrilla
Il termine spagnolo (che significa “piccola guerra”) entra in uso in questo periodo e indica una tecnica specifica di combattimento, adottata da formazioni armate ridotte, solitamente irregolari, che compiono atti di sabotaggio, attentati, agguati e attacchi a sorpresa contro un esercito regolare.
Liberales
Nella dialettica politica della Spagna del tempo, questo termine indica il gruppo politico sostenitore delle ipotesi di riforma costituzionale, in contrapposizione a un altro gruppo polemicamente chiamato dei serviles, che ha posizioni tradizionaliste e favorevoli alla Chiesa (si oppone, per esempio, all’abolizione dell’Inquisizione spagnola).
Negli anni seguenti l’espressione liberales comincia a circolare per il resto d’Europa; il termine “liberali” e poi il derivato “liberalismo” indicheranno uno specifico soggetto politico (cap. 6.9).
Plebiscito
Votazione normalmente compiuta a suffragio universale maschile, effettuata affinché il corpo elettorale esprima un parere su una questione di grande rilievo costituzionale.
Questione irlandese
L’Irlanda è completamente sottoposta al dominio inglese sin dal 16. secolo; tuttavia, le élite locali, seguite dalla gran maggioranza della popolazione, si oppongono all’egemonia inglese e all’introduzione della Riforma protestante.
Nel 17. secolo i governanti inglesi adottano la tecnica di espropriare i proprietari terrieri locali, per distribuire le terre tra coloni inglesi e scozzesi.
Nel 1641 lo stato di tensione politica, economica e sociale che ne deriva, porta a una grande ribellione contro la dominazione inglese, che si intreccia alle vicende della Rivoluzione inglese; la rivolta viene repressa nel sangue nel 1649-52, senza tuttavia placare la tensione tra coloni inglesi o scozzesi di fede protestante, da un lato, e popolazioni locali, di fede cattolica, dall’altro.
Nel 1688 la “Gloriosa rivoluzione”, che vede il rovesciamento del re Giacomo 2. Stuart, cattolico, da parte del Parlamento, con l’ascesa al trono del protestante Guglielmo d’Orange, ha delle ripercussioni significative anche in Irlanda dove, nei primi mesi del 1689, scoppia un’altra rivolta anti-inglese.
I leader della rivolta invitano Giacomo 2. Stuart a recarsi sull’isola, per tentare di separarla dal Regno d’Inghilterra.
Giacomo 2. vi si reca, in realtà nel tentativo non tanto di liberare l’Irlanda, quanto di riconquistare tutto il regno.
Il tentativo, tuttavia, fallisce: infatti, anche Guglielmo d’Orange sbarca sull’isola al comando di un corpo di spedizione che il 1. luglio 1690 batte nei pressi del fiume Boyne l’esercito irlandese di Giacomo Stuart.
Le conseguenze della battaglia del fiume Boyne sono pesanti: se in Irlanda l’esercizio del culto cattolico è autorizzato, il Parlamento inglese vara subito un nuovo piano di esproprio delle terre di possidenti cattolico-irlandesi, che vengono redistribuite tra protestanti anglo-scozzesi; i Test-Acts, che vietano ai cattolici di ricoprire cariche pubbliche civili e militari e di accedere a entrambe le Camere del Parlamento, approvati originariamente nel 1673-78 e aboliti da Giacomo 2. Stuart, vengono subito rimessi in vigore.
La tensione tra le élite protestanti di origine inglese o scozzese e irlandesi cattolici è fortissima.
La memoria della battaglia di Boyne si conserva tutt’oggi: ogni anno i cosiddetti “orangisti”, cioè discendenti protestanti dei coloni inglesi e scozzesi, che vivono nell’Irlanda del Nord (l’area dell’isola ancora parte del Regno Unito), a luglio celebrano la ricorrenza della battaglia vinta da Guglielmo d’Orange (da cui il loro nome).
Le manifestazioni sono state spesso occasione di scontri, anche molto violenti, con i cattolici irlandesi che vivono in quell’area.
Bibliografia
Le campagne di Napoleone / D. Chandler. – Rizzoli, 2006. – 2 voll.
Napoleone / V. Criscuolo. – Il Mulino, 1997
Napoleone / G. Lefebvre. – Laterza, 2009
Napoleone: il mito del salvatore / J. Tulard. – Bompiani, 2003
Napoleone e la conquista dell’Europa / S. J. Woolf. – Laterza, 2008
L’Italia di Napoleone / C. Zaghi. – Utet, 1989
Cap. 6. La Restaurazione
6.1 Il Congresso di Vienna
Da poco Napoleone è stato battuto e relegato nel suo piccolo principato dell’Isola d’Elba quando – nell’autunno del 1814 – Vienna comincia a riempirsi di una variopinta folla di gente di gran rango: diplomatici, ufficiali, politici, sovrani con le loro consorti o le loro accompagnatrici, accuditi gli uni da una folta schiera di collaboratori, attendenti, servitori, seguite le altre dalle proprie dame di compagnia e dalle cameriere personali.
Ciò che li richiama a Vienna non è non solo un incredibile stagione di appuntamenti mondani, come da tempo non se n’erano più visti, ma soprattutto l’urgenza di un incontro diplomatico ai massimi livelli, promosso dalle principali potenze che hanno sconfitto l’imperatore dei francesi: l’Austria, in primo luogo, rappresentata dal suo imperatore, Francesco 1., e dal suo cancelliere, l’autorevole galante Metternich; e poi la Russia, la Prussia e la Gran Bretagna, tutte rappresentate da delegazioni diplomatiche guidate dai sovrani o dai ministri degli Esteri.
A costoro si uniscono numerosi esponenti di altri paesi europei, più o meno grandi, più o meno importanti, fra i quali la Francia nuovamente borbonica, le cui sorti sono riposte nelle abilissime mani del suo ministro degli esteri, Talleyrand.
Il resto d’Europa non sa molto di ciò che i viennesi vedono dal 1° novembre 1814, data di inaugurazione del Congresso di Vienna, alla firma dell’atto finale, avvenuta il 9 giugno 1815: solo notizie di seconda mano sui balli, sui ricevimenti, sulle toilette, sugli incontro clandestini, sugli intrighi diplomatici che scandiscono la vita della capitale austriaca.
Tutti gli europei sanno presto, invece, quali destini geopolitici i grandi che hanno stabilito per loro.
Il criterio fondamentale che i responsabili della politica estera delle grandi potenze vincitrici di Napoleone pongono alla base della ristrutturazione d’Europa è il principio di legittimità: esso implica la restaurazione dei poteri “legittimi” nelle aree territoriali dalla quali essi sono stati scalzati dalla Rivoluzione francese e dalle conquiste napoleoniche.
L’intento è quello di ridisegnare i confini degli Stati e le loro istituzioni in modo da riportare l’intera Europa agli assetti che vigevano prima del 1789: in realtà tale criterio viene spesso disatteso, sia nella sistemazione geopolitica della nuova Europa, sia nelle architetture istituzionali degli Stati restaurati.
Nel complesso i mutamenti geopolitici sono assai significativi:
a) la Russia ingloba il Regno costituzionale di Polonia, la cui corona spetta allo zar, e la Finlandia, sottratta alla Svezia;
b) la Prussia a est riottiene la Posnania e a ovest i territori renani che nel periodo napoleonico erano stati inclusi nel Regno di Vestfalia
c) l’Austria riprende tutti i territori precedentemente persi ( Tirolo, Slovenia, Croazia, Dalmazia), con l’aggiunta del nuovo Regno Lombardo-Veneto.
Cede i Paesi Bassi austriaci che – insieme con l’Olanda – vanno a far parte del nuovo Regno dei Paesi Bassi
d) in Germania,, al posto della napoleonica Confederazione del Reno, abolita sin dal 1813, viene ora costituita la Confederazione germanica, organismo sovranazionale che raggruppa 39 Stati, tra cui l’Impero austriaco (limitatamente alle aree dell’Austria, della Slovenia, della Boemia e della Moravia), la Prussia (a esclusione della Prussia orientale e della Posnania), la Baviera, la Danimarca (limitatamente all’Holstein), lo Hannover, la Sassonia, il Wüttemberg e altri 7 granducati, 9 ducati, 11 principati minori, le 4 città di Amburgo, Brema, Francoforte sul Meno e Lubecca.
Possiede un organo centrale di coordinamento, la Dieta della Confederazione, costruita dagli ambasciatori degli Stati membri, con presidenza permanente all’Austria e vicepresidenza permanente alla Prussia; la Dieta ha il compito di coordinare al politica militare degli Stati ed eventualmente la politica commerciale, ma non ha grandi poteri legislativi o esecutivi: possono aver forza di legge sui territori della Confederazione solo quelle norme che siano state approvate da tutti i rappresentanti degli Stati membri;
e) in Spagna torna sul trono Ferdinando 7. di Borbone (1814-33), che come primo atto di governo abolisce la Costituzione di Cadice, approvata dalle Cortes nel 1812 durante la guerra di liberazione antinapoleonica;
f) In Italia, infine, la situazione è la seguente: viene ampliato il Regno di Sardegna, sotto Vittorio Emanuele 1. di Savoia (1802-21), che riottiene Savoia e Nizza e incorpora il territorio dell’antica Repubblica di Genova; il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla è affidato alla ex moglie di Napoleone, Maria Luisa d’Austria (1815-47): il Ducato di Modena è affidato a Francesco 4. d'Austria-Este (1814-46); il Ducato di Massa e Carrara è dato alla madre di Francesco 4., Maria Beatrice Cybo d’Este (1814-29), moglie dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo; l’antica Repubblica di Lucca viene trasformata in Ducato di Lucca, conferito a Maria Luisa di Borbone-Parma (1814-24); il Granducato di Toscana viene restituito a Ferdinando 3. di Asburgo-Lorena (1790-1824); lo Stato della Chiesa è ricostituito sotto il regno di papa Pio 7., rientrato a Roma dalla sua prigionia in Francia sin dal maggio del 1814; il Regno delle Due Sicilie, strutturato in una compagine amministrativamente unificata, e non più divisa – come in precedenza – in due regni distinti, viene restituito a Ferdinando 4. di Borbone, che ora prende il nome di Ferdinando 1. delle Due Sicilie (1816-25)
Parole della storia
Romanticismo
Movimento intellettuale, letterario ed artistico diffusosi in Europa tra la fine del 18. secolo e la prima metà del 19.
Le opere che si ispirano a questo orientamento valorizzano la dimensione emotiva dell’espressione e della comunicazione artistica, il recupero delle storie, miti e contesti narrativi appartenenti a un passato medievale e primo-moderno, l’esplorazione di una appassionata spiritualità e religiosità.
Le opere di quasi tutti gli intellettuali o gli artisti citati nel nostro capitolo condividono, in misura maggiore o minore, queste caratteristiche.
Bibliografia
L’Età della Restaurazione: reazione e rivoluzione in Europa, 1814-1830 / P. Casana Testore. – Loescher, 1981
L’uomo romantico / F. Furet (a cura di). – Laterza, 1995
La nazionalizzazione delle masse: simbolismo politico e movimenti di massa in Germania, 1812-1933 / G. L. Mosse. – Il Mulino, 2009
Cap. 7. Tornano le rivoluzioni, 1820-31
7.1 Cicli rivoluzionari
Negli anni del Congresso di Vienna le inquietudini alimentate dai gruppi che si oppongono all’ordine della Restaurazione conquistano spazi non piccoli nelle opinioni pubbliche europee.
Si vogliono cambiamenti e, poiché gli assetti istituzionali degli Stati post Restaurazione non ammettono quasi alcuna dialettica politica, il modo per ottenerli sembra essere uno solo: ripercorrere la strada che nel 1776 e nel 1789 si è mostrata così efficace, la strada che passa attraverso la rivoluzione.
E’ così che, tra il 1820 e il 1849, ben tre cicli rivoluzionari distinti si susseguono fra America ed Europa:
a) i primi due (1820-25 e 1830-31) hanno un carattere eminentemente politico, orientato da movimenti di ispirazione nazional-liberale;
b) nel terzo (1848-49), dove pure gli obiettivi politici nazional-liberali sono ancora largamente preminenti, si cominciano a sentir circolare più spesso parole d’ordine che incitano a una trasformazione democratica degli assetti politici, se non addirittura a una vera e propria rivoluzione sociale.
Bibliografia
Storia d’Italia moderna, vol. 2.: Lalla Restaurazione alla rivoluzione nazionale, 1815-1846 / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1994
Le rivoluzioni borghesi, 1789-1848 / E. J. Hobsbawm. – Laterza, 1991
La libertà che guida il popolo: le tre gloriose giornate del luglio 1830 e le “Chartes” nel costituzionalismo francese / L. Lacché. – Il Mulino, 2002
Cap. 8. Il Risorgimento italiano
8.1. Immaginare una nazione
Nei due cicli rivoluzionari che scuotono l’Europa tra 1829 e 1831 la penisola italiana è sempre coinvolta: Napoli, la Sicilia, il Piemonte, la Lombardia nel 1820-21; diverse aree del Regno delle Due Sicilie con turbolenze e congiure di minor portata negli anni successivi; i Ducati padani e lo Stato della Chiesa nel 1831.
Sono segni chiari di un’ampia diffusione del movimento politico che si ispira alle nuove idee di nazione.
Ma il processo non è trionfale né facile.
I tentativi rivoluzionari sono eventi che hanno luogo nelle città (Napoli, Palermo, Alessandria, Torino, Modena, Bologna, ecc.); a esse le campagne guardano con apatia.
Da un certo punto di vista quell’apatia è già un grande successo: sicuramente lo è rispetto alle insorgenze antigiacobine o al sanfedismo degli anni 1786-99.
Nondimeno sono inquiete le campagne.
Le attraversano ancora importanti fenomeni di brigantaggio, nel Mezzogiorno continentale come nel Lazio pontificio, nelle Romagne, nel Polesine o nel Veneto.
Ma le ragioni di quelle inquietudini hanno a che fare col profondo disagio sociale che per motivi vari scuote le comunità contadine; niente di immediatamente connesso con le aspirazioni all’indipendenza o alla Costituzione.
Inoltre, tra gli stessi rivoluzionari, oltre a quelli che lottano senza riserve per la libertà della nazione italiana, ve ne sono altri che antepongono interessi regionali o municipali agli obiettivi nazionali.
E poi ci sono contrasti sulle gerarchie territoriali e sulle relative forme da dare a un possibile Stato nuovo (federale o unitario?) che si intrecciano e mai sopite divergenze sugli assetti costituzionali (monarchia o repubblica? Rappresentanza democratica o censitaria?).
Sono disaccordi che non rafforzano certo il movimento.
Ma a rilanciarlo, a dargli animo, ad ampliarne i confini interviene un fenomeno tipico di tutta l’Europa romantica.
Succede cioè che tra il 1815 e il 1847 vengono prodotte opere artistiche di natura molto varia – raccolte poetiche, tragedie, romanzi, saggi storici, melodrammi, pitture – che rielaborano in vari modi il mito della nazione italiana, della sua storia passata e delle sue vicende recenti, strutturando una narrazione compatta e avvincente intorno a specifici temi e figure.
Succede poi che le modalità narrative adottate siano derivate – come stile e almeno come iniziale spunto tematico – dalla coeva produzione letteraria europea di ispirazione romantica, cioè dalle opere di autori di culto per le giovani generazioni dell’epoca quali Schiller, Scott, Byron o Hugo.
Succede infine che i testi italiani di ispirazione nazional-patriottica siano il frutto del lavoro di alcune delle menti più brillanti della penisole, quali Giovanni Berchet, Giacomo Leopardi, Silvio Pellico, Alessandro Manzoni, Francesco Domenico Guerrazzi, Massimo d’Azeglio, Giuseppe Verdi e altri ancora: le loro opere sono momenti chiave dell’esperienza culturale romantica italiana, come le Poesie (Berchet) o l’Adelchi (Manzoni), L’assedio di Firenze (Guerrazzi) o Ettore Fieramosca (d’Azeglio), Le mie prigioni (Pellico) o Giovanni da Procida (Niccolini), Nabucco o I Lombardi alla prima crociata (Verdi) e altre ancora.
Alcune di queste opere, poi, sono dei veri e propri best-seller (a volte nonostante siano proibite dalla censura), come è il caso delle Poesie di Berchet, che hanno quindici edizioni dai primi anni Venti al 1848, dell’Ettore Fieramosca di d’Azeglio, che ne ha tredici tra il 1833 e il 1848, della Francesca da Rimini di Pellico, che ne ha venti tra il 1818 e il 1848, o delle Mie prigioni dello stesso Silvio Pellico, che ne hanno nove dal 1832 al 1848; segno che toccano corde molto sensibili.
Ancor più interessante è che – nella grandissima varietà dei generi, degli stili, delle ispirazioni e degli intrecci – tutti questi tendono a disegnare un quadro coerente di che cosa sia la nazione italiana e di perché occorra battersi per essa.
Intanto chi legge è invitato a riconoscere la comunità nazionale italiana come una realtà legata a fattori bio-culturali.
Non diversamente da ciò che accade in altri contesti dell’Europa romantica, gli intellettuali italiani che contribuiscono alla formazione del discorso nazional-patriottico immaginano la nazione come una comunità di parentela, le cui reti di relazione collegano intimamente la generazione presente alle passate e alle future.
La metafora della parentela viene impiegata e declinata in ogni possibile contesto: la patria è madre, tutti i suoi figli (e figlie) sono fratelli (e sorelle), i capi politici e militari sono padri della patria.
Il sangue è uno dei legami forti che tiene insieme la comunità.
L’altro è la cultura della nazione, la cui coesione è garantita da una comune confessione religiosa, da una lingua comune, da un comune passato.
Si tratta, peraltro, di un passato triste, di decadenza, di oppressione straniera, di barbara protervia e di interna divisione, che – scrivono gli intellettuali nazional-patriottici – ora è necessario riscattare con uno sforzo di volontà, di ardore, di coraggio, al tempo stesso militare e politico.
Nessuno meglio di Alessandro Manzoni ha saputo riassumere con straordinaria capacità evocativa tutti questi elementi in pochissimi tratti, quando, nell’ode Marzo 1821, immagina la nazione italiana in questo modo: “una gente che libera tutta, / o fia serva tra l’Alpe ed il mare; / una d’arme, di lingua, d’altare, / di memorie, di sangue e di cor” (“una nazione che abbia un solo esercito, una sola lingua, un’unica religione, memorie comuni, un unico sangue e una passione da tutti condivisa”).
Questo nucleo concettuale profondo, poi, viene fatto giocare in vivaci narrazioni poetiche, romanzesche o drammaturgiche che mettono in scena la storia o il presente della nazione, affidandosi a intrecci e a personaggi carichi di fortissime valenze simboliche-emotive.
Naturalmente le storie narrate sono estremamente varie; ma al loro interno si possono individuare almeno tre figure principali, intorno alle quali si snodano i dispositivi narrativi:
a) la prima figura è quella dell’eroe nazionale: si tratta di un uomo, di un soldato valoroso, pieno di coraggio, pronto a guidare la sua comunità contro i nemici, contro gli oppressori stranieri, leale nei confronti della patria, ma sfortunato, perché quasi sempre destinato a una morte drammatica;
b) la seconda figura è quella del traditore, che sempre riemerge in questi intrecci: il tradimento è provocato da ambizione, da desiderio di potere, di gloria o di denaro ed è la causa tanto della morte o della sventura dell’eroe quanto della disfatta politico-militare della comunità nazionale;
c) a volte il traditore porta morte o dolore anche alla terza figura chiave, cioè l’eroina nazionale: costei condivide con l’eroe un unico elemento fondamentale, il senso di lealtà nei confronti della comunità.
Le altre connotazioni le appartengono in modo esclusivo: è una donna indiscutibilmente virtuosa, è molto spesso una madre affettuosa o una sposa amorosa, è sensibile, casta, irreprensibile, ma – punto importante – il suo onore è minacciato dal traditore o dai nemici stranieri e la minaccia è portata soprattutto contro la sua purezza sessuale.
Quando il suo onore sia stato, in una maniera o nell’altra, offeso, l’eroina ha davanti a sé un destino di morte prematura o di esclusione dalla comunità.
Quali sono gli elementi di forza di un simile modello narrativo?
Il primo, importante, risiede nella fondamentale triade delle figure che articolano la narrativa nazional-patriottica del Risorgimento, triade che evoca il profilo di tre analoghe figure che svolgono un ruolo cruciale in tutt’altro ambito testuale, quello delle scritture evangeliche.
L’eroe nazionale, infatti, ha molti tratti che lo avvicinano alla figura di Cristo: come Cristo, e i martiri, l’eroe svolge una funzione testimoniale, grazie alla morte o alle sofferenze alla quali di solito è destinato.
Mentre nella storia di Cristo il sacrificio è testimonianza di uno scandalo etico (la caduta nel peccato), nel caso della narrativa nazionale esso è testimonianza di uno scandalo etico e politico (il disonore e la divisione della nazione).
Come per Gesù Cristo e i suoi santi, ma a un differente livello, la morte o la sofferenza dell’eroe costituiscono la più grande offerta sacrificale, un’offerta che può liberare l’intera comunità nazionale dallo stato di disonore e di disunione nella quale essa è caduta aprendo la via alla risurrezione (al “risorgimento”), tema questo, incessantemente ripreso ed esplorato anche dalla letteratura più specificamente politica.
Un riferimento diretto alla storia di Gesù Cristo, poi, può essere trovato nella figura del traditore, secondo elemento di forza del modello narrativo: anch’egli è al centro della narrativa nazional-patriottica, com’è al centro della storia di Cristo; se Giuda è la causa diretta della sofferenza di Cristo, il traditore è molto spesso la causa immediata della sfortuna o della morte dell’eroe, e di conseguenza della nazione.
Terzo elemento di forza, infine: la figura dell’eroina, la minaccia delle donne.
Le eroine nazionali sono presentate come pure e caste e spesso si dice esplicitamente che la loro virtù le fa somigliare a delle sante martiri, se non addirittura a Maria Vergine.
Da questo punto di vista si può vedere di nuovo sia la trasposizione della figura della madre di Cristo dalle Sacre Scritture alla narrativa nazional-patriottica, sia la trasposizione del modello delle vergini delle vergini martiri: per le sante martiri la morte è ancora una testimonianza, in questo caso di una fede e di una purezza che non può essere vinta dall’aggressione dei pagani; e ci sono esempi, ben noti nell’Ottocento, di sante martiri che per sfuggire all’aggressione sessuale dei soldati pagani si spingono sino al suicidio, senza perdere alcunché della loro purezza spirituale.
Analogamente nelle narrazioni del Risorgimento le donne che vengono aggredite, se non sono salvate in tempo dall’intervento dell’eroe, trovano sollievo nella morte che è cercata come espiazione per il torto subito, e quindi per il disonore che si è dovuto patire, o come un mezzo estremo per evitare quel disonore.
Ma le donne vanno difese.
E con esse va difeso l’onore della nazione: e solo se si recupera l’onore si può recuperare la libertà.
Questo snodo argomentativo pone al centro del discorso risorgimentale l’esaltazione della guerra e dell’eroismo bellico; il valore della predisposizione alla guerra, prima ancora che strettamente militare è simbolico e ha qualcosa di religioso.
I capi politici e gli intellettuali risorgimentali chiedono agli uomini della nazione di essere pronti a sacrificarsi per essa, come per le loro famiglie, per le loro donne, per i loro amici.
Sacrificarsi significa rendere sacra la propria azione; significa farne qualcosa di religioso; è questo passaggio che consente di vedere lo scontro militare come una guerra santa, una sacra crociata, i cui caduti sono martiri che devono essere eternamente ricordati come esempio agli altri membri della nazione.
In questi anni, dunque, anche in Italia le idee sulla nazione sono raccontate e rappresentate in modi che fanno sistematico appello a un’intensa estetica della politica.
In una forma emotivamente molto efficace, romanzi, poesie, pitture e melodrammi collegano strettamente tra loro aspirazioni politiche e discorsi sul genere sessuale, riferimenti alla tradizione religiosa e allusioni erotiche, in uno strano miscuglio, al tempo stesso insolito e tradizionale; alla fine queste narrazioni appaiono persuasive, anche perché i materiali di cui son fatte – la cristologia, il linguaggio dell’onore, il duello, la guerra – rimandano a valori che sono molto vivi nell’esperienza degli uomini e delle donne italiani all’inizio del 19. secolo.
Il Cristo, il traditore, la Vergine, le martiri o le sante costituiscono una sequenza di figure il cui significato simbolico è profondamente radicato in un paese cattolico come l’Italia ottocentesca, nel quale la grandissima maggioranza della popolazione si è formata sulla conoscenza (superficiale o approfondita che sia) delle Scritture e della liturgia; né meno vivo è il linguaggio dell’onore, o la pratica del duello, all’epoca ancora molto diffusa.
Si tratta di un sistema discorsivo ad altissima temperatura emotiva; ed è in gran parte a questa sua caratteristica che si deve la sua ampia capacità di diffusione; tuttavia, per quanto efficace sia, è chiaro che tale sistema discorsivo non potrebbe trasformarsi in azione politica senza l’opera di propaganda e di indirizzo svolta in questi anni, come temerarietà e tenacia, dai capi e dai militanti delle organizzazioni e delle costellazioni associative di orientamento nazional-patriottico.
Parole della storia
Repubblica unitaria
Una repubblica unitaria come la immagina Mazzini è uno Stato che possiede organismi centralizzati (Parlamento e governo), i quali hanno competenza su ogni materia e producono leggi che valgono allo stesso modo in tutto il territorio dello Stato.
Stato federale
Uno Stato federale è composto da unità statali diverse, tutte dotate di ampia autonomia, ma coordinate da un governo centrale cui è attribuita la competenza esclusiva solo su alcune particolari materie.
Il modello principale di una repubblica federale è quello offerto dagli Stati Uniti.
Nel corso del Risorgimento, tra i democratici, l’ipotesi di una repubblica federale italiana è sostenuta soprattutto da Carlo Cattaneo (1801-1869): intellettuale lombardo, fonda nel 1839 a Milano la rivista di cultura e attualità “Il Politecnico”, molto apprezzata ma poco diffusa.
Autore di importanti studi sull’agricoltura lombarda, egli sostiene la necessità di dare al possibile Stato italiano un assetto federale, rispettoso delle autonomie e delle varie caratteristiche storiche che sono proprie delle diverse aree del paese.
L’ipotesi di Cattaneo è sostenuta anche da Giuseppe Ferrari (1811-1876): lombardo anch’egli, dal 1839 si trasferisce a Parigi dove insegna alla Sorbona; pure Ferrari sostiene il programma di uno Stato italiano che abbia la forma di una federazione di repubbliche democratiche, che egli vorrebbe anche capaci di coraggiose riforme sociali.
Né Cattaneo né Ferrari, in tutta la loro attività, sono mai stati capaci di suscitare il seguito che Mazzini ha saputo creare intorno al suo programma.
Bibliografia
La nazione del Risorgimento / A. M. Banti. – Einaudi, 2006
Il Risorgimento italiano / A. M. Banti. – Laterza, 2009
Il Risorgimento e l’unificazione dell’Italia / D. Beales, E. F. Biagini. – Il Mulino, 2005
Il lungo Risorgimento: la nascita dell’Italia contemporanea, 1770-1922 / G. Pecout. – Bruno Mondadori, 1999
Il Risorgimento: Storia e interpretazioni / L. Riall. – Donzelli, 2007
Cap. 9. Le rivoluzioni del 1848-49
9.1 Le premesse
Negli anni Quaranta la penisola italiana non è certo l’unica area nella quale si palesino contrasti.
Ovunque, in Europa, pressioni per un allargamento dello spazio politico e delle norme che disciplinano la partecipazione al gioco elettorale si intrecciano alla diffusione di ideali nazionalisti, la cui realizzazione comporterebbe il completo mutamento degli assetti geopolitici esistenti, specie nell’Europa centro-orientale e in Italia.
Lo stato di tensione si manifesta spesso in modi violenti, come in Svizzera, dove tra il 1845 e il 1847 si consuma uno scontro armato tra sette cantoni cattolici e conservatori, uniti in una Lega secessionista (il Sonderbund), e il resto dei cantoni della Confederazione, a maggioranza protestante e di orientamento liberale; la vittoria di questi ultimi porta all’adozione di una nuova Costituzione che riorganizza la Svizzera, limitando l’autonomia dei cantoni e dotando lo Stato federale di istituti rappresentativi.
All’inizio del 1846, inoltre, un tentativo di insurrezione nazionalista polacca, organizzato in Galizia (parte dell’Impero austriaco) da nobili proprietari terrieri, viene represso da una feroce rivolta dei contadini, incoraggiati dalle autorità austriache.
Sebbene in questo caso la rivolta contadina favorisca la conservazione dell’ordine politico e sociale, l’episodio spaventa moltissimo le élite di proprietari dell’Impero asburgico, rendendole perfettamente consapevoli del tremendo stato di ostilità che separa i contadini – sottoposti a varie forme di servitù – dai loro padroni: è una condizione di avversione che il peggioramento delle condizioni economiche, che allora caratterizza l’intera Europa, ha fatto esplodere in modo particolarmente aspro.
In effetti, è soprattutto il contesto economico e sociale a preoccupare.
Tra il 1845 e il 1847 una sequenza ininterrotta di cattive annate agricole fa diminuire drasticamente l’offerta di beni alimentari sui mercati, aumentandone di molto i prezzi.
Questo processo ha come conseguenza una caduta nella domanda di beni di consumo di produzione artigianale o industriale, mettendo in grave crisi aziende industriali e laboratori artigiani.
La soluzione più ovvia per fronteggiare la crisi è licenziare gli operai o i lavoranti o impiegarli per un numero minore di ore, o a un salario più basso.
E così, in modo circolare, la crisi nei settori industriali o artigianali si salda con la crisi agricola, perché molte famiglie di operai disoccupati o sottoccupati fanno fatica, ora, a ottenere risorse minime per comprare i beni alimentari di prima necessità.
Dire che alla fine del 1847 l’Europa è inquieta è dire poco.
Nelle campagne (in Irlanda, per esempio, dove alla carestia si è aggiunta una malattia delle patate che ha distrutto i raccolti) la gente muore di fame; nelle città la situazione non è migliore; in Italia tumulti per il rincaro del pane si mescolano alle manifestazioni di giubilo per ‘avvento di Pio 9., il “papa liberale”; in Svizzera ci si spara addosso; in Galizia congiura nazionale e rivolta contadina si intrecciano mortalmente; ovunque parole come “democrazia”, “eguaglianza”, “pane e lavoro subito” circolano incessantemente, dando speranza a chi ha di meno e mettendo paura a chi ha di più.
9.4 Un bilancio
Alla fine del 1849 i risultati di due anni di rivoluzione sembrano miseri rispetto alle speranze che si sono accese all’inizio del 1848.
Mutamenti geopolitici significativi non ce ne sono.
Quanto alle trasformazioni istituzionali, la Francia non è più una monarchia costituzionale bensì una repubblica presidenziale, il cui governo, tuttavia, ha chiare tendenze conservatrici.
Delle garanzie costituzionali concesse un po’ ovunque, invece, non resta quasi più nulla, se non lo Statuto che è in vigore dal 1848 nel Regno di Sardegna e la Costituzione in vigore dal 1849 nel Regno di Prussia.
Sembra davvero poco ma, in un certo senso, non è così: non è un caso se proprio questi due Stati saranno, nei decenni seguenti, tra i più attivi promotori di mutamenti alla carta geopolitica d’Europa.
Ma il bilancio del biennio rivoluzionario (e, visto con uno sguardo più prospettico, di tutti e tre i cicli rivoluzionari che vanno dal 1820 al 1849) non si riduce a questo, giacché le eredità sono di più larga portata e di più lunga durata.
Per molti aspetti (estensione geografica, virulenza dei conflitti, natura di uno degli attori politici – il potere monarchico) i tre cicli rivoluzionari che attraversano l’Europa dal 1820 al 1849 potrebbero essere paragonati ad altre crisi generali che già l’hanno scossa nei secoli precedenti.
E’ chiaro tuttavia che, al di là di molte altre possibili diversità, una sopra tutte si impone: mentre in epoca moderna le rivolte politicamente più consapevoli vogliono garantire franchigie a corpi territoriali e cetuali che desiderano negoziare i loro spazi (e in particolare l’entità della pressione fiscale cui vengono sottoposti) col potere sovrano, le rivoluzioni della prima metà del 19. secolo hanno come posta immediata la questione della sovranità.
Ovviamente le esperienze delle rivoluzioni inglesi, di quella americana e di quella francese, hanno segnato una svolta che i rivoluzionari primottocenteschi hanno assimilato profondamente; da esse, tuttavia, le rivoluzioni ottocentesche si differenziano nel porre immediatamente al centro del conflitto la questione della sovranità, senza passare attraverso la contestazione intorno all’entità e alla natura della pressione fiscale.
Infatti solo ben dentro il 20. secolo la questione fiscale tornerà ad essere un fattore primario dal conflitto politico.
Ora, invece, si chiede altro; in particolare si chiede, con grande determinazione, che la sovranità sia affidata al “popolo”: tale sovranità può essere esclusivamente demandata al popolo (come in una repubblica democratica) o può essere condivisa dal popolo e da un monarca; ma certo il popolo è diventato un ineludibile concetto chiave della politica che – si noti bene - conserva ovunque una connotazione esclusivamente maschile (infatti, nonostante la partecipazione delle donne alle rivoluzioni del 1848-49 si ampia e multiforme, nessuna Costituzione concessa o votata in quasi due anni riconosce alle donne il diritto di partecipare alla vita politica).
Tuttavia, se i connotati politici e di genere del concetto di “popolo” sono acquisiti, e trovano conferma nella mentalità e nelle pratiche correnti, è la natura sociale del concetto che comincia a diventare dubbia.
In astratto “popolo” è una parola che dovrebbe designare l’insieme degli individui che in un dato territorio condividono tratti comuni, senza alcuna divisione interna.
A questa definizione di attengono o costituenti francesi quando, nella Costituzione del 4 novembre 1848, scrivono: “Sono aboliti per sempre tutti i nobili nobiliari, tutte le distinzioni di nascita, di classe o di casta”.
Ma la realtà – in particolare quella francese, e in una certa misura anche quella tedesca – è diversa: i conflitti sociali sono apparsi chiaramente come uno degli aspetti essenziali della rivoluzione del 1848-49, infinitamente di più che nei due cicli rivoluzionari precedenti.
E uno scontro violento come quello che si ha a Parigi nelle “giornate del giugno 1848” mostra chiaramente che il “popolo” non è unito, ma è diviso da fratture profonde le quali, nonostante ciò che è scritto nella Costituzione della Seconda Repubblica, cominciano a essere designate con l’espressione “conflitti di classi” [cfr. cap. 11].
Le classi sociali, notano ora diversi osservatori coevi, spezzano in parti diverse e contrapposte la presunta unità del popolo: e questa sembra proprio una realtà che l’unanimismo della retorica nazional-patriottica non può nascondere.
In Francia o in Germania i conflitti tra le classi sociali diverse – per nascita, ricchezza, tenore di vita e istruzione – sono chiaramente all’ordine del giorno.
Eppure resta, tenace, l’uso del concetto di “popolo” come sinonimo dell’altro lemma chiave delle rivoluzioni europee: “nazione”.
Il termine e l’idea, come abbiamo già visto, hanno messo radici profonde.
E anche in Francia questa è la parola guida della lotta politica.
Ma lo è a molto maggior ragione in tutte quelle aree nelle quali si ritiene che non ci sia corrispondenza tra l’esistenza di un popolo-nazione, con sue ben chiare caratteristiche, e le istituzioni statali: e ciò è molto evidente in Germania, nei territori dell’Impero austrico e in Italia, dove si è lottato strenuamente, sebbene senza successo, perché le “nazioni” avessero un loro “Stato-nazione”.
Bisogna aggiungere che, mentre l’idea nazionale mostra il suo grandissimo potere di fascinazione, comincia pure a mostrare un lato decisamente inquietante: il disprezzo per le “altre” nazioni, perfino una certa aggressività, verbale e fisica, contro gruppi nazionali che ora vengono considerati “nemici storici” della nazione d’appartenenza.
Gli italiani inveiscono contro i “tedeschi” (che sarebbero gli austriaci) e i croati; questi ultimi mostrano un violento risentimento contro gli ungheresi; gli ungheresi lottano con determinazione contro gli austriaci, mentre palesano un grande disprezzo per i croati, serbi e rumeno; tra tedeschi e cechi c’è un evidentissimo attrito, così come ce n’è tra tedeschi e polacchi.
La geografia delle ostilità nazionali potrebbe andare avanti ancora.
Come ha mostrato fra i primi Lewis Namier, nel 1848-49, l’idea di una “fratellanza” tra le nazioni, ancora inseguita da Mazzini quando, nel 1834, fonda la sua Giovane Europa, si sta sbriciolando di fronte a un’altra dinamica: quella che fa sì che ogni nazionalismo si definisca per contrasto, identificando degli “altri da sé” (gente che parla un’altra lingua, che ha un’altra storia, a volte un’altra religione), i quali da semplici “diversi” diventano facilmente dei “nemici”.
Il dramma di questa deriva dell’idea nazionalista sta nella sua “fisicità”, percepibile già nel corso del biennio rivoluzionario: tanto più vicini sono gli “altri”, tanto più li si vuole allontanare o sottomettere politicamente o perfino eliminare del tutto, senza che ci siano poi molti spazi per più sagge e umane mediazioni.
Parole della storia
Dreiklassenwahlsystem (“sistema elettorale delle tre classi”)
Il sistema individua tre classi di elettori: nella prima vi sono i più ricchi, cioè coloro che pagano le contribuzioni fiscali più alte, la cui somma deve essere pari a un terzo del gettito fiscale totale; nella seconda classe vi sono quelli che hanno ricchezze e contribuzioni fiscali medie; nella terza vi sono i più poveri.
Ciascuna di queste classi di elettori ha il diritto di eleggere un terzo degli elettori di secondo grado (coloro che a loro volta devono scegliere i rappresentanti alla Camera).
La conseguenza di questo sistema – solo apparentemente complicato – è che un piccolo gruppo di ricchi e super-ricchi ha una rappresentanza parlamentare enormemente superiore al suo peso numerico.
Così, per esempio, nel 1850 i membri della prima classe (quella che accoglie i più ricchi) sono il 5% dei votanti, quelli della seconda il 12, 5% e quelli della terza (i più poveri) l’82,5%. Ma ciascuno di questi gruppo elegge il 33% dei membri della Camera bassa.
Bibliografia
Storia dell’Italia moderna, vol. 3.: La rivoluzione nazionale, 1846-1849 / G. Candeloro. – Feltrinelli, 1995
La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi sull’Ottocento europeo / L. B. Namier. – Einaudi, 1977
Le rivoluzioni del 1848 / R- Proce. – Il Mulino, 2004
Cap. 10. Un progresso che sembra non avere ostacoli
10.1 Un nuovo modo di viaggiare (e le sue conseguenze)
Due giovani, un ragazzo e una ragazza di quindici anni circa, lasciano l’Europa nel 1815 per andare lontano, molto lontano, in India o in America del Sud, o in una qualche isola al largo delle coste dell’Africa.
Il viaggio è lungo, ma arrivano felicemente a destinazione.
E poi passano gli anni, uno dopo l’altro: e, col passare degli anni, si dimenticano dell’Europa, dalla quale, del resto, ricevono scarne notizie; al paese d’origine rivolgono solo, di tanto in tanto, qualche pensiero distratto, preso come sono dalla loro nuova vita.
E passano ancora altri anni: dieci, poi venti, trenta, quaranta.
Sono diventati grandi, adulti, maturi.
Le loro vite hanno preso corsi diversi.
Ma prima l’una e poi l’altro decidono di tornare in Europa.
Sono gli anni tra il 1850 e il 1855.
Una storia che potrebbe essere successa davvero.
E se fosse successa, che avrebbero trovato al loro ritorno?
Immaginiamoli che arrivano a Liverpool, a Nantes o ad Amburgo.
Hanno sentito, durante il viaggio in nave, già molti racconti sull’incredibile biennio appena trascorso, quello della rivoluzione europea del 1848-49.
Ma hanno capito che ci sono stati pochi cambiamenti sulla carta politica.
E – dopo il loro arrivo – possono constatare che pochi sono i cambiamenti nelle istituzioni.
Ma se lo spazio della politica sembra quasi immutato, non possono davvero trattenere la loro sorpresa quando scoprono che tipo di viaggio devono fare, se vogliono arrivare a Londra o a Parigi o a Berlino.
All’inizio dell’Ottocento il modo più rapido e sicuro di viaggiare era quello tradizionale, via mare con le navi a vela; per terra si viaggiava con le carrozze trainate da cavalli, ma le strade erano poche, maltenute e pericolose, e i viaggi via terra erano lunghi e disagevoli.
Da allora, però, il sistema dei trasporti ha attraversato un periodo di profonde trasformazioni e, come di consueto, ciò ha avuto luogo prima nel Regno Unito e poi nell’Europa continentale.
La cosa più banale che è avvenuta è che sono state costruite nuove strade, il cui chilometraggio quasi ovunque come minimo è raddoppiato, il cui fondo è stato battuto e viene riparato con maggiore cura e frequenza; poi è accaduto che la qualità tecnica delle carrozze (sospensioni, resistenza, peso complessivo) è stata incredibilmente migliorata.
A metà Ottocento le nuove strade e le nuove carrozze consentono trasferimenti assai più rapide di prima: il nuovo servizio postale attivo tra Berlino e Magdeburgo, che all’inizio del secolo impiegava due giorni e mezzo per completare la tratta, dalla metà degli anni Venti riesce a metterci solo quindici ore.
Sono progressi notevoli.
Tuttavia se vogliono muoversi più velocemente e tranquillamente, i nostri due viaggiatori possono prendere un nuovo mezzo di trasporto, che quando erano ragazzini semplicemente non esisteva: il treno.
Il treno viene sperimentato per la prima volta come mezzo di trasporto delle partite di carbone che dalle miniere inglesi devono essere portate alle fabbriche, che impiegano le macchine a vapore.
Inizialmente il carbone viene caricato su vagoni montati su rotaie e trainati da cavalli.
All’inizio dell’Ottocento si sperimentano le primi motrici a vapore: su un vagone si monta una macchina a vapore che, attraverso un sistema di trasmissioni e ingranaggi, è in grado di far muovere le ruote con una forza tale da poter trainare anche altri vagoni.
Poiché il sistema sembra funzionare, negli anni Venti si prova a utilizzarlo per il trasporto passeggeri.
Le prime reazioni di osservatori e passeggeri non sono particolarmente entusiaste: il treno sembra scomodo e, soprattutto, terribilmente pericoloso.
Poi diventa chiaro che i vantaggi offerti sono enormi e il pericolo minimo; cosicché le resistenze iniziali vengono facilmente vinte e si avvia la costruzione su larga scala di una rete di linee ferroviarie che nel Regno Unito sono realizzate e gestite da imprese private, mentre nell’Europa continentale sono progettate e cofinanziate dagli Stati in cooperazione con imprese private.
Il successo è tale che tra il 1825 e il 1880 la rete ferroviaria europea passa da poco più di 2000 chilometri complessivi a circa 101.000 chilometri, concentrati soprattutto nel Regno Unito e nell’Europa centro-settentrionale.
Le conseguenze sono vertiginose.
La velocità di movimento aumenta incredibilmente.
All’inizio dell’Ottocento, quando ci si muoveva esclusivamente in carrozze a cavalli, per andare da Londra a Edimburgo (distanza 640 km) potevano volerci sei o sette giorni; per arrivare da Londra a Manchester (distanza 330 km) 1 o 2 giorni; nel 1850, col treno, gli stessi viaggi si possono fare in 17 ore (Londra-Edimburgo) o in 6 ore (Londra-Manchester).
Il prezzo del viaggio, poi, è incredibilmente più basso (nel 1840 un biglietto di terza classe costa un decimo della tariffa per un viaggio in un qualunque tipo di carrozza a cavalli).
Ovviamente, poi, il costo di trasporto delle merci diminuisce, in ragione del minor tempo e della maggiore sicurezza.
Sul treno si possono spedire anche merci molto pesanti o di grande volume, perché costa comunque meno che mandarle con altri mezzi.
Ma, soprattutto, merci rapidamente deperibili possono essere spostate più agevolmente.
Peraltro implicazioni non meno spettacolari sono prodotte dalle interdipendenze strutturali attivate dal sistema di trasporto su rotaia: per costruire i binari e i vagoni ci vogliono legno, ferro, ghisa; e gli stessi materiali servono per costruire gli avveniristici ponti che servono per completare il tracciato delle linee ferroviarie; le industria siderurgiche, meccaniche e del legname ricevono dunque nuove commissioni; tendono quindi ad ampliare gli impianti e a utilizzare più macchine e più operai; l’aumento delle macchine incrementa la domanda relativa; e così via, a catena.
Tanto le carrozze motrici quanto le macchine per la produzione di metalli lavorati hanno bisogno, a loro volta, di nuove caldaie a vapore e le macchine a vapore hanno bisogno di altro carbone.
Cosicché, dal punto di vista economico, l’esplosione della domanda di manufatti industriali implicata dal boom delle ferrovie ci riporta – singolarmente – dal carbone (da trasportare) al carbone (da buttare entro le caldaie delle macchine a vapore o delle caldaie delle locomotive).
Tutte queste trasformazioni nella domanda dei beni industriali stimolano anche una nuova sequenza di innovazioni, che in questo periodo si concentra soprattutto nel settore siderurgico: nel 1856 viene brevettato il convertitore Bessemer, nel 1864 il forno a riverbero Siemens-Martin e infine nel 1877 il forno a rivestimento basico Gilchrist-Thomas, tre sistemi di lavorazione del minerale ferroso, che consentono la produzione di acciaio (un metallo più flessibile e infinitamente più resistente sia del ferro sia della ghisa) di buona qualità e a costi relativamente bassi.
Il materiale che si ottiene si rivela ideale per la costruzione dei binari, delle piastre per le caldaie, delle lamiere per i macchinari o delle sbarre per le costruzioni edili.
Ancora nuove prospettive si aprono, dunque, all’iniziativa imprenditoriale.
Parole della storia
Bilancia commerciale
Prospetto degli scambi commerciali in entrata (importazioni) e in uscita (esportazioni) operati dai residenti di un determinato paese; il confronto viene compiuto sulla base del valore delle merci importate ed esportate; quando il valore delle esportazioni supera quello delle importazioni si dice che un paese ha un “saldo visibile” in attivo.
Canale di Suez
E’ un canale artificiale scavato tra il 1859 e il 1869, che taglia l’istmo fra l’Egitto e il Monte Sinai e perciò mette in comunicazione il Mar Rosso e il Mediterraneo; la società che lo gestisce è a capitale franco-inglese.
Per celebrare l’apertura del canale il Khedivé (governatore) dell’Egitto (all’epoca sotto sovranità ottomana) commissiona a Giuseppe Verdi l’opera Aida, messa in scena per la prima volta all’Opera del Cairo il 24 dicembre 1871.
Razze, razza
Il termine “razza” serve ad indicare una comunità umana dotata di caratteristiche fisiche o biologiche simili (come, per esempio, il colore della pelle, i tratti fisionomici, il colore e la forma dei capelli).
Oggi la grande maggioranza degli studiosi sia di scienze fisiche sia di scienze sociali concorda nel ritenere il concetto di razza come scarsamente utilizzabile per distinguere le comunità umane.
Tale posizione può essere riassunta utilizzando la delibera approvata nel 1998 dal Comitato esecutivo dell’American Anthropological Association, autorevole associazione che riunisce gli antropologi americani: “Le prove derivanti dall’analisi genetica (per es. il DNA) indicano che le maggiori variazioni genetiche si riscontrano all’interno dei cosiddetti gruppi razziali.
Ciò significa che c’è una maggiore variazione genetica all’interno dei gruppi razziali che tra essi.
Tra le popolazioni vicine c’è una vasta sovrapposizione di geni e delle loro espressioni fenotipiche (cioè fisiche).
Nella storia ogni volta che gruppi differenti sono entrati in contatto, si sono anche incrociati.
La continua condivisione dei materiali genetici ha fatto sì che tutta l’umanità appartenga a un’unica specie”.
(presso il sito ufficiale dell’American Anthropological Association: http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm).
Sviluppo economico
Il processo di crescita del prodotto interno lordo (Pil) di un paese, calcolato normalmente su base annua.
Il Pil è un indice che riassume il valore complessivo di beni (merci) e servizi prodotti da un paese nel periodo di tempo dato.
Col termine servizi si indicano tutte quelle attività generatrici di beni di consumo immateriali per usufruire dei quali è necessario pagare un corrispettivo: per esempio, servizi telefonici, prestazioni di liberi professionisti, spettacoli, ecc.
Bibliografia
Storia della famiglia in Europa: il lungo Ottocento / M. Barbagli, D. I. Kertzer (a cura di). – Laterza, 2003
Il trionfo della borghesia, 1848-1875 / E. J. Hobsbawm. – Laterza, 2006
Darwin / J. Howard. – Il Mulino, 2003
La conquista pacifica: l’industrializzazione in Europa dal 1760 al 1970 / S. Pollard. – Il Mulino, 1994
Storia dei viaggi in ferrovia / W. Schivelbusch. – Einaudi, 2003
Cap. 11. Le classi sociali
11.1. Borghesi e proletari
Una storia di successo ha bisogno dei suoi eroi positivi.
Nell’Europa dell’Ottocento gli eroi per eccellenza sono i borghesi, in particolare gli imprenditori, coloro i quali impiantano le fabbriche tessili, le miniere di carbone, le acciaierie, le linee ferroviarie, le linee telegrafiche, le banche.
Sono loro gli individui che catturano l’immaginazione di tutti: sono loro quelli che suscitano l’ammirazione e l’invidia di tutti.
Leggiamone una descrizione tratta dal Manifesto del partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels:
“Nessuno ha cantato le lodi della borghesia imprenditoriale con più convinzione di Karl Marx e Friedrich Engels, i quali nel loro Manifesto del Partito Comunista (1848) l’hanno descritta come uno dei più rivoluzionari soggetti sociali mai apparsi nella storia dell’umanità.
Il Manifesto del Partito Comunista viene pubblicato a Londra nel febbraio 1848 e presenta per la prima volta in modo molto chiaro i fondamenti essenziali di una visione filosofica che Marx ed Engels svilupperanno ulteriormente negli anni seguenti.
Nel brano qui antologizzato Marx ed Engels esaltano il ruolo “rivoluzionario” che la borghesia sta giocando nella storia dell’umanità; va notata l’attenta finezza con la quale i due autori registrano gli aspetti più importanti delle trasformazioni economiche accadute nei cent’anni precedenti al 1848: la globalizzazione dei mercati, la liberalizzazione dei commerci, l’onda delle innovazioni tecnologiche che hanno trasformato il modo di produrre e di consumare non sfuggono alla loro efficacissima sintesi.
Protagonista positivo di tutti questi cambiamenti è il “borghese”, termine che per gli autori è sinonimo di “imprenditore”, nella accezione più ampia di questo termine”.
“La borghesia ha avuto nella storia una parte sommamente rivoluzionaria.
Dove ha raggiunto il dominio, la borghesia ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, patriarcali, idilliche […].
Solo la borghesia ha dimostrato che cosa possa compiere l’attività dell’uomo.
Essa ha compiuto ben altre meraviglie che piramidi egiziane, acquedotti romani e cattedrali gotiche, ha portato a termine ben altre spedizioni che le migrazioni dei popoli e le crociate.
La borghesia non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali.
Prima condizione di esistenza di tutte le classi industriali precedenti era invece l’immutato mantenimento del vecchio sistema di produzione.
Il continuo rivoluzionamento della produzione, l’ininterrotto scuotimento di tutte le situazioni sociali, l’incertezza e il movimento eterni contraddistinguono l’epoca dei borghesi fra tutte le epoche precedenti.
Si dissolvono tutti i rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguito di idee e di concetti antichi e venerandi, e tutte le idee e i concetti nuovi invecchiano prima di potersi fissare.
Si volatilizza tutto ciò che vi era di corporativo e di stabile, è profanata ogni cosa sacra, e gli uomini sono finalmente costretti a guardare con occhio disincantato la propria posizione e i propri reciproci rapporti.
Il bisogno di uno smercio sempre più esteso per i suoi prodotti sospinge la borghesia a percorrere tutto il globo terrestre.
Dappertutto deve annidarsi, dappertutto deve costruire le sue basi, dappertutto deve creare relazioni.
Con lo sfruttamento del mercato mondiale la borghesia ha dato un’impronta cosmopolitica alla produzione e al consumo di tutti i paesi.
Ha tolto di sotto i piedi dell’industria il suo terreno nazionale, con gran rammarico dei reazionari.
Le antichissime industria nazionali sono state distrutte e ancora adesso vengono distrutte ogni giorno.
Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui introduzione diventa questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili, da industrie che non lavorano più soltanto materie prime del luogo, ma delle zone più remote e i cui prodotti non vengono consumati solo nel paese stesso, ma anche in tutte le parti del mondo.
Ai vecchi bisogni, soddisfatti con i prodotti del paese, subentrano bisogni nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei climi più lontani.
All’antica autosufficienza e all’antico isolamento locali e nazionali subentrano uno scambio universale, una interdipendenza universale fra le nazioni.
E come per la produzione materiale, così per quella intellettuale.
I prodotti intellettuali delle singole nazioni divengono bene comune.
L’unilateralità e la ristrettezza nazionali divengono sempre più impossibili e dalle molte letterature nazionali e locali si forma una letteratura mondiale.
Con il rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni infinitamente agevolate, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni, anche le più barbare.
I bassi prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con la quale spiana tutte le muraglie cinesi, con la quale costringe alla capitolazione la più tenace xenofobia dei barbari.
Costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe ad introdurre in casa loro la cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesi.
In una parola: essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza.
La borghesia ha assoggettato la campagna al dominio della città.
Ha creato città enormi, ha accresciuto su grande scala la cifra della popolazione urbana in confronto di quella rurale, strappando in tal modo una parte notevole della popolazione all’idiotismo della vita rurale.
Come ha reso la campagna dipendente dalla città, la borghesia ha reso i paesi barbari e semibarbari dipendenti da quelli inciviliti, i popoli contadini da quelli borghesi, l’Oriente dall’Occidente […].
Durante il suo dominio di classe appena secolare la borghesia ha creato forze produttive in massa molto maggiore e più colossali che non avessero mai fatto tutte insieme le altre generazioni del passato.
Il soggiogamento delle forze naturali, le macchine, l’applicazione della chimica all’industria e all’agricoltura, la navigazione a vapore, le ferrovie, i telegrafi elettrici, il dissodamento d’interi continenti, la navigabilità dei fiumi, popolazioni intere sorte quasi per incanto dal suolo – quale dei secolo antecedenti immaginava che nel grembo del lavoro sociale stessero sopite tali forze produttive?”
[Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto del Partito Comunista, a cura di Emma Cantimori Mezzomonti, Einaudi, 1974, pp. 102-6]
Nell’analisi di Marx ed Engels il passo appena citato è la premessa per osservare che il sistema economico costruito dalla borghesia ha due elementi di grande debolezza: in primo luogo le crisi interne di sovrapproduzione che – secondo i due autori – porteranno prima o poi il sistema a un crollo.
Sono crisi determinate da un eccesso nell’offerta dei beni rispetto alle capacità di assorbimento dei consumatori, eccesso che fa sì che le merci restino invendute, che le risorse finanziarie investite o prestate non fruttino, che posti di lavoro e risorse vadano perduti nel tentativo di riportare l’offerta a livello della domanda; oltre a questo tipo di crisi (che, pur verificandosi, non hanno l’effetto catastrofico previsto da Marx ed Engels) un secondo elemento indebolisce a loro parere il funzionamento complessivo del sistema capitalistico (vedi parole della storia] ovvero la nascita di un “proletariato” di fabbrica.
Col termine “proletariato” i due autori vogliono indicare l’insieme degli operai che lavorano nelle nuove imprese produttive, a tecnologia avanzata; usano quella parola, derivata dal latino, per sottolineare che la povertà di questi soggetti sociali è tale che l’unica cosa che possiedono, oltre alla loro vita e al loro lavoro, sono i loro figli, la prole appunto.
E’ un’esagerazione retorica: serve ai due autori per affermare che il contrasto tra le due classi, che essi vedono operare sulla scena della nuova società europea, è straordinariamente profondo e drammatico.
Soffermiamoci sull’immagine di società che Marx ed Engels descrivono nel loro testo.
E’ una società duale, dominata da due grandi classi, la borghesia e il proletariato, in aspra lotta tra loro.
E’ una descrizione un po’ stilizzata del mondo delle città industriali, ma in termini molto generali non è un’immagine sbagliata.
E’ vero che c’è un grande divario di ricchezze tra i capitalisti e gli operai: è vero che le condizioni di vita degli operai sono pessime; ed è anche vero che costoro hanno cominciato da tempo ad organizzarsi, dotandosi di associazioni che cercano di fare pressioni sugli imprenditori e sull’opinione pubblica per ottenere migliori condizioni di lavoro (orari giornalieri più brevi, salari più alti, turni meno massacranti, sostegno e garanzie in caso di infortuni o malattie).
Sin dalla fine del Settecento in Gran Bretagna sono iniziate le prime forme di protesta, che inizialmente hanno assunto l’aspetto dell’attacco o del sabotaggio delle macchine (si tratta dei moti “luddisti”, 1799 e 1811-13; cfr. 1.6).
A questa protesta, subito duramente repressa, hanno fatto seguito i primi tentativi di organizzazione, che in Gran Bretagna hanno preso la forma di società di mutuo soccorso (cioè associazioni i cui aderenti si impegnano ad aiutarsi reciprocamente nel caso di bisogno) e poi di veri e propri sindacati (Trade Unions), organizzazioni che cercano di orientare i lavoratori e di difenderne gli interessi.
Una forma di protesta adottata per contrastare tagli nei salari o per contestare orari e condizioni di lavoro è lo sciopero, cioè l’astensione dal lavoro, volontaria e collettiva, così da bloccare il funzionamento della fabbrica.
Tanto le organizzazioni sindacali quanto gli scioperi sono, tuttavia, inizialmente considerati illegali: in Gran Bretagna nel 1824 una legge abolisce il divieto di coalizione sindacale, dando così un primo riconoscimento legale indiretto alle Trade Unions, mentre una legge dell’anno successivo ammette gli scioperi purché siano attuati senza alcuna forma di coercizione o violenza da parte degli scioperanti; nel continente europeo, invece, le organizzazioni sindacali diventano legali solo a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento.
La descrizione della società contemporanea, presentata o solo accennata nel Manifesto, è certamente giusta.
Di errato, nell’analisi di Marx ed Engels, è l’idea che la borghesia e proletariato siano gruppi sociali in un certo senso “naturalmente” compatti al loro interno.
Non è così.
I processi sociali non danno automaticamente vita a una “borghesia” o a una “classe operaia” i cui membri abbiano tutti le stesse caratteristiche, le stesse idee, gli stessi interessi.
Quando una qualche coesione si forma è per effetto di azione e propaganda politica, non di processi sociali che si svolgono indipendentemente dalle scelte dei singoli.
Ma in realtà le differenze prevalgono.
Intanto vi sono le differenze nazionali, che si fanno sentire con grande evidenza specie all’interno degli ambienti operai.
Quando, nella prima metà dell’Ottocento, i cittadini irlandesi emigrano in Gran Bretagna in cerca di lavoro nelle fabbriche, gli operai inglesi o gallesi o scozzesi non li accolgono affatto a braccia aperte; lo stesso accade quando i manovali polacchi vanno a lavorare in Germania; o quando gli operai tedeschi o quelli cechi competono per trovare lavoro nell’area dei Sudeti; o quando i lavoratori italiani cercano lavoro nella Francia meridionale.
E le differenze nazionali non sono meno importanti tra i gruppi imprenditoriali e finanziari, anche se al momento (metà 19. secolo) l’ideologia liberista tende ad attenuare queste divergenze.
Poi ci sono le differenze confessionali, che talora si sovrappongono a quelle nazionali, a volte operano autonomamente.
In Gran Bretagna, gli imprenditori anglicani tendono a frequentare associazioni distinte da quelle frequentate da imprenditori che aderiscono a qualche altra confessione protestante; talora le differenze religiose si riflettono in differenze di tipo politico, gli uni essendo spesso simpatizzanti tory [cfr. 13.1], gli altri più frequentemente simpatizzanti whig [cfr. 13.1].
In Germania, imprenditori cattolici e luterani hanno simili motivi di distanza.
E poi c’è la retorica della concorrenza, che abita la mente di tutti e che rende non immediatamente facile la cooperazione.
Gli operai non gradiscono la concorrenza delle donne e dei bambini, preferiti spesso dagli imprenditori perché normalmente sono pagati meno; quelli che sono impiegati in un settore stentano a condividere le difficoltà vissute da quelli che lavorano in un settore diverso.
E ciò vale anche per gli imprenditori: se non ci sono altri motivi (interessi finanziari, parentela, amicizia personale), che la produzione della seta sia investita da una crisi dovuta a una grave malattia dei bachi da seta, mettendo economicamente in ginocchio gli imprenditori del settore, è un fatto che può dispiacere agli imprenditori impegnati nel settore del cotone, tanto quanto può far loro dispiacere la notizia di un terremoto in Cile.
E via dicendo.
Su questo punto – vale la pena di ripeterlo – la conclusione della più recente storiografia è che la coesione dei gruppi sociali non sia un effetto “naturale” dei processi sociali, bensì un prodotto dell’organizzazione e dell’azione politica.
Solo se qualche capo sindacale o qualche intellettuale (proprio come Marx ed Engels) comincia a sottolineare i vantaggi di possibili azioni comuni, possono crearsi convergenze tra persone che, altrimenti, non sono mosse da una spinta autonoma ad associarsi e a lottare gli uni a fianco degli altri.
C’è ancora un altro aspetto della descrizione di Marx ed Engels che merita di essere corretto.
La società europea ottocentesca non ha affatto una struttura semplice, articolata essenzialmente in due classi, la borghesia imprenditoriale e il proletariato: ha, invece, una struttura molto più complessa, di una complessità che si va accentuando con il passare degli anni.
Intanto tra i gruppi sociali economicamente più agiati ve ne sono di quelli che non hanno niente a che fare con i processi di produzione industriale, o che vi sono correlati solo in ragione di prestazione professionali specifiche.
Si tratta in primo luogo dei liberi professionisti – notai, avvocati, medici, ingegneri – soggetti sociali che possiedono un’ottima educazione accumulata durante un lungo periodo di studi e che hanno redditi buoni, talora assai elevati, grazia alla loro specializzazione.
Il loro numero e l’importanza delle loro prestazioni vanno crescendo, come va crescendo anche il numero (e, da più di un punto di vista, l’importanza sociale) di altri soggetti raccolti spesso sotto l’etichetta di “ceto medio”: funzionari e impiegati statali; dirigenti e impiegati di imprese private; maestri e insegnanti; commercianti e artigiani.
Si tratta di un’area della società in continua crescita numerica, e socialmente molto significativa: molti di coloro che salgono sulle barricate nel 1830 o nel 1848-49, tanto per fare un esempio, vengono proprio da questi gruppi.
Dato il giusto peso a tutte le possibili complessità delle società ottocentesche, salta agli occhi la grande differenza di mezzi e di mezzi e di condizioni di vita tra chi ha successo, da un lato, e chi si trova in basso nella scala sociale, dall’altro.
Differenze di questo genere erano evidenti pure a chi avesse camminato per le strade di una città europea di antico regime: ma ora il divario sembra farsi più netto.
Ciò che soprattutto brucia è che i ricchi borghesi sono, molto spesso, “nuovi” ricchi: non persone che hanno un nome altisonante, un palazzo ereditato dagli avi, un albero genealogico, rispettate per il nome che portano.
I borghesi (industriali o professionisti che siano) sono, quasi sempre, “nuovi” ricchi, persone che venendo da famiglie di artigiani, di commercianti, di piccoli proprietari si sono “fatte da sé”: quando una persona di ambiente operaio li incontra nell’opulento centro di una grande città, e misura la ricchezza della stoffa con cui sono fatti i loro vestiti e immagina l’agio in cui possono vivere, non può che sentire rabbia e risentimento; viceversa un brivido d’ansia attraversa le schiene dei borghesi che incrociano quello sguardo, carico di un cupo rimprovero.
Peraltro ciò che aiuta a stabilizzare le società ottocentesche, insieme con i più diretti strumenti di controllo sociale (per esempio i fucili dell’esercito, quando ce n’è bisogno), è la geografia delle città che muta rispetto a quella di epoca moderna.
I quartieri si differenziano per gruppi sociali: ci sono i quartieri residenziali per famiglie borghesi, in una determinata area urbana e i quartieri dormitorio pe rle classi sociali, che stanno da tutta un’altra parte; perfino sui treni ci sono vagoni di prima classe, di seconda classe e di terza classe.
La possibilità di incontro sono relativamente poche e si può perfino vivere un’intera vita senza mai passare in una strada che appartenga allo spazio geografico di un’altra classe sociale.
Ma quando l’incontro avviene, niente potrebbe essere più doloroso.
Parole della storia
Sistema capitalistico
Sistema economico e sociale caratterizzato da una larga formazione e mobilità dei capitali, della proprietà privata dei mezzi di produzione, dalla ricerca del profitto individuale e dalla separazione dei produttori in classi (la “borghesia”) detentrici dei capitali e classi lavoratrici (il “proletariato”).
Bibliografia
L’uomo dell’Ottocento / U. Frevert … et al (a cura di). – Laterza, 2000
Lavoro, cultura e mentalità nella società industriale / E. J. Hobsbawm. – Laterza, 1990
Vecchie e nuove classi nell’Europa del 19. secolo / J. Kocka, H.-G. Haupt. – In: Storia d’Europa, vol. 5.: L’età contemporanea, secoli 19.-20 / a cura di P. Bairoch, E. J. Hobsbawm. – Einaudi, 1996
Le aristocrazie terriere nell’Europa contemporanea / M. Malatesta. – Laterza, 1999
Professionisti e gentiluomini: storia delle professioni nell’Europa contemporanea / M. Malatesta. – Einaudi, 2006
Storia del marxismo, vol. 1.: Il marxismo ai tempi di Marx. – Einaudi, 1978
Cap. 12. Passioni e sentimenti
12.1 Matrimoni combinati, passioni d’amore
Il gioco delle differenze di classe [cfr. cap. 11], implacabile, attraversa pure le famiglie.
Quando Darwin si lamenta nell’Origine dell’uomo [cfr. cap. 10.5] che in genere si pone poca attenzione nel selezionare il coniuge, in una certa misura sbaglia.
Poiché nell’Ottocento ci sono ancora genitori, soprattutto di classe alta, che continuano a comportarsi come i loro avi dei secoli precedenti e cercano di orientare i figli e le figlie verso un matrimonio che sia in primo luogo un’alleanza economica e sociale tra famiglie ricche e prestigiose.
Tuttavia, ora sono sempre più numerose le giovani coppie che vogliono assolutamente sposarsi perché si amano, anche a costo di andare contro la volontà dei recalcitranti genitori.
Gli archivi e le biblioteche europee contengono una grande quantità di documenti privati (lettere, diari, memorie) che danno testimonianza della svolta che proprio in questi anni si sta compiendo nel modi di concepire la relazione matrimoniale.
L’amore romantico, cioè l’idea che una relazione e il matrimonio che ne consegue debbano basarsi sull’incontro di due anime appassionate, viene considerato da molti giovani come il necessario fondamento di un futuro felice.
E così il fuoco della passione divora molti cuori, guida molte scelte, e lo fa con un’intensità che – vista con gli occhi di oggi – al tempo stesso commuove e sconcerta.
La passione d’amore non è una garanzia di un matrimonio solido, felice e duraturo.
Ma, nonostante ciò, nei manuali pedagogici, negli articoli di giornale e – soprattutto – nella narrativa, finisce egualmente per imporsi l’idea che la passione d’amore sia una condizione assolutamente necessaria alla costruzione di un buon matrimonio.
E’ un’”invenzione” liberatoria quella dell’amore romantico, non c’è dubbio.
Giovani contro vecchi, in un certo senso.
Una promessa di calda felicità, invece che una garanzia di arida sicurezza.
Il sogno di una vita affettiva ricca, appassionata, intensa.
Un bel sogno, che qualche volta non si realizza affatto, ma che, in altri casi, riesce a farsi realtà.
E poi è disegnato a colori così seducenti dai romanzi di moltissimi altri autori – specie di quelli che scrivono opere narrative per il grande pubblico -, che a molte donne e a molti uomini finisce per sembrare un sogno assolutamente irresistibile.
Sono questi i motivi per cui l’amore romantico diventa un modello di comportamento che dai primi dell’Ottocento mette stabilmente radici nella cultura occidentale, senza poi abbandonarla mai più.
Con tutto ciò non si può dimenticare che il sogno dell’amore romantico ha un prezzo, e questo prezzo viene pagato interamente dalle donne.
Le premesse perché le cose vadano così sono state poste sin dal 18. secolo, quando nasce l’idea di un matrimonio affettivo polemicamente contrapposto alla sciatta dissolutezza dei matrimoni aristocratici.
Il moralismo borghese settecentesco di Richardson, di Hogarth o di Rousseau, nel criticare il libertinaggio aristocratico o monarchico, chiede che il “nuovo” matrimonio affettivo si basi su una rigorosa castità sessuale delle donne, garanzia di un ordinato svolgersi della successione familiare; chiede inoltre che il matrimonio affettivo sia anche una relazione diseguale che – rispecchiando la forma complessiva della società – riconosca la superiorità morale e intellettuale dell’uomo sulla donna.
Sono posizioni che non necessariamente tutte le donne accettano di buon grado.
Ma abbiamo visto che in un cruciale momento fondativo dell’Occidente contemporaneo – la Rivoluzione francese [cfr. 3.8.1] – la velleità di riscatto femminile sono state frustrate senza pietà dai capi politici maschi.
Il modello antifemminile che lì si sperimenta, e che trova la sua sistemazione normativa nel Codice civile del 1804, si diffonde rapidamente in altri paesi europei che, direttamente o indirettamente, assumono il Codice francese come un modello da imitare.
Ma anche in altri casi, come nel Regno unito, se da un lato la legislazione riconosce il matrimonio civile e ne fa un rapporto contrattuale tra pari, dall’altro continua a considerare la donna come un soggetto che – in definitiva – non ha vera parità di diritti, né civili, né tanto meno politici, rispetto all’uomo.
Bibliografia
Le donne in Europa, vol. 4: Nella città moderna / B. S. Anderson, J. P. Zinsser. – Laterza, 1993
Idoli di perversità: la donna nell’immaginario artistico filosofico letterario e scientifico tra Otto e Novecento / B. Dijkstra. – Garzanti, 1988
Storia delle donne in Occidente: l’Ottocento / G. Duby, M. Perrot. – Laterza, 2007
Sessualità e nazionalismo: mentalità borghese e rispettabilità / G. L. Mosse. – Laterza, 1996
La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica / M. Praz. – Sansoni, 2008
Cap. 13. Il modello parlamentare: il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
13.1. Dall’inizio dell’Ottocento alla riforma elettorale del 1832
Nel mare in tempesta delle rivoluzioni che incessantemente si abbattono sull’Occidente dalla fine del Settecento al 1849, la grandissima stabilità istituzionale del Regno Unito sembra spiccare con la forza di una straordinaria eccezione, e attira le attenzioni (e spesso anche l’ammirazione) di tutti gli osservatori europei.
La struttura costituzionale, articolata nella diarchia re-Parlamento, in funzione ormai da ben più di un secolo, ha superato indenne l’impatto della Rivoluzione francese e delle guerre napoleoniche e non viene messa in discussione nemmeno dai vari cicli rivoluzionari che tra il 1820 e il 1849 scuotono l’Europa e che non sfiorano nemmeno lontanamente il Regno Unito.
Inoltre, all’inizio dell’Ottocento, alla solida stabilità istituzionale corrisponde pure una grande fissità del quadro politico.
Infatti tra fine Settecento e inizio Ottocento lo schieramento parlamentare tory [vedi parole della storia] si è proposto come il più deciso guardiano dell’identità e delle tradizioni britanniche e ciò gli ha conquistato il sostegno di quella larga parte dell’opinione pubblica guidata da sentimenti patriottici antifrancesi; viceversa, l’iniziale simpatia di diversi capi whig [vedi parole della storia] per la Rivoluzione francese ha pesato negativamente sul prestigio di quest’altro raggruppamento parlamentare.
La lunga guerra contro Napoleone viene dunque condotta sotto la guida di governi tory e il successo finale rinsalda trionfalmente la loro forza politica.
A consolidare definitivamente la loro egemonia provvedono le Corn Laws (Leggi sul grano) introdotte nel 1815: si tratta di norme che innalzano i dazi di importazione sui cereali stranieri, col fine di proteggere la produzione agricola britannica mantenendone elevati i prezzi: sono misure che vogliono difendere gli interessi delle élite terriere britanniche, e ciò perché i proprietari terrieri e gli affittuari costituiscono l’asse portante dell’elettorato tory (e, in genere, una percentuale preponderante dell’elettorato nel suo complesso).
Non sorprende dunque che, forti di questi successi, il tory a lungo controllino incontrastati la scena politica del regno: dal 1812 al 1830 costoro danno vita a ben quattro governi, mentre i whig non ne presiedono nemmeno uno.
L’opposizione whig fatica molto nel recuperare consensi e riesce a trovare la sua strada solo quando è in grado di identificare un tema che le consente di mutare significativamente interlocutori e strategie di comunicazione politica: questo tema è la riforma delle norme che disciplinano l’elezione dei deputati alla Camera dei Comuni.
La questione – dicono i whig – si impone assolutamente, perché è necessario includere nel campo della politica attiva i protagonisti della rivoluzione industriale inglese – gli imprenditori, i mercanti, i banchieri -, cioè quell’insieme di soggetti che essi chiamano la middle class (la “classe media”).
Ma come è possibile che il sistema elettorale inglese, che identifica nella ricchezza la qualità principale per diventare elettori, escluda la maggior parte degli imprenditori, dei mercanti o dei banchieri, i quali hanno certamente un livello di reddito sufficiente per essere riconosciuti elettori?
La questione non riguarda i livelli di reddito dei singoli individui, ma il modo in cui sono state disegnate le circoscrizioni elettorali.
Le circoscrizioni sono quelle aree territoriali la cui popolazione ha il diritto di eleggere un certo numero di rappresentanti alla Camera dei Comuni.
Le norme che le definiscono risalgono alla fine del 17. O all’inizio del 18. secolo.
Ma da allora molte cose sono cambiate.
Soprattutto è avvenuto che la popolazione si è spostata da un’area geografica all’altra e che numerose zone rurali si sono spopolate, mentre sono cresciuti gli abitanti delle nuove città industriali.
L’effetto combinato di queste circostanze ha fatto sì che alcune zone che in epoca moderna erano quasi spopolate (e che quindi non godevano del diritto di eleggere deputati) abbiano avuto un consistente aumento della loro popolazione, mentre in altre aree si è avuto il processo inverso.
Negli anni Venti dell’Ottocento capita così che tra le aree che non hanno diritto a un deputato vi siano Manchester (180000 abitanti), Birmingham (144000), Leeds (92000); capita invece che ne abbiano diritto Dunwich, che in epoca moderna era stato un porto significativo ma che ora non ha che 32 elettori, o Sarun, che con soli 11 elettori ha diritto a eleggere un deputato.
Casi come quelli di Dunwich o Sarun sono definiti rotten boroughs (cioè “borghi putridi”), anche in riferimento alle pratiche clientelari (vedi parole della storia) che un così basso numero di elettori può facilmente consentire.
Il raggruppamento whig, capeggiato da Charles Grey (1764-1845), Henry Brougham (1778-1868) e John Russell (1792-1878), vuole rettificare questo stato di cose, dando così una rappresentanza alle zone dove ha preso corpo la nuova Gran Bretagna industriale.
La campagna a favore della riforma è condotta con grande efficacia, con articoli di stampa e manifestazioni fuori del Parlamento; ma difficilmente lo schieramento whig sarebbe in grado di vincerla se non intervenisse una grave crisi che nel 1829 spezza l’egemonia tory.
Dopo la costituzione del Regno Unito (1801), in Irlanda si sono formate organizzazioni cattoliche che hanno chiesto con insistenza l’abolizione delle norme di legge di fine 17. secolo (Test Acts) che impediscono ai cattolici di partecipare direttamente alla vita politica (cfr. cap. 5.4.11).
La maggioranza della popolazione irlandese è di confessione cattolica e guarda con simpatia alle manifestazioni e alle iniziative pubbliche organizzate a tal fine dalla Associazione Cattolica guidata da Daniel O’Connell (1775-1847); nelle zone rurali, poi, il dissidio politico si sta trasformando in un duro contrasto sociale che contrappone i proprietari terrieri, molti dei quali di origini inglesi e di confessione protestante, ai contadini, in larga maggioranza irlandesi e cattolici.
Per depotenziare la tensione che sembra farsi sempre più grave, il capo del governo tory, il duca di Wellington (1769-1851), decide di giocare la carta di una doppia riforma, che prevede l’emancipazione sia dei protestanti dissidenti (cioè quelli appartenenti a sette minoritarie) sia dei cattolici.
La prima legge, approvata nel 1828, abolisce le discriminazioni nei confronti dei protestanti dissidenti, aprendo loro le porte degli incarichi pubblici, che in precedenza erano loro preclusi a esclusivo vantaggio degli anglicani.
La seconda legge, approvata nel 1829, abolisce ogni discriminazione nei confronti dei cattolici e in particolare abolisce la loro esclusione dall’elettorato attivo e passivo.
La mossa non si rivela felice: da un lato, non placa le tensioni in Irlanda, dove, col peggiorare delle condizioni economiche delle aree rurali, nei decenni successivi le tensioni tra proprietari e contadini diventano ancora più gravi che in precedenza; dall’altro, le due leggi (e soprattutto l’emancipazione dei cattolici) provocano una grave crisi all’interno dell’elettorato tory, tradizionalmente incline a sostenere la supremazia della Chiesa anglicana e dei suoi adepti; alle sue elezioni del novembre del 1830 la crisi si traduce in un grave insuccesso dei tory, che riporta i whig al governo dopo ben 36 anni.
Come conseguenza, nel 1832 il Parlamento – ora a maggioranza whig – approva la riforma elettorale che ridisegna le circoscrizioni per adattarle alla realtà contemporanea e raddoppia il corpo elettorale, portandolo da poco di più del 2% sul totale della popolazione al 4%.
Ancor più che sul piano quantitativo, la riforma è significativa per il mutamento nel profilo sociale del corpo elettorale, di cui ora fanno parte nuovi elettori che vengono soprattutto dalla borghesia capitalistica delle aree industriali.
Nel corso della campagna per la riforma vi è chi ha chiesto un’estensione del voto alle donne che abbiano i giusti requisiti (ricchezza, alfabetismo, età).
In modo molto netto gli estensori del Reform Act del 1832 rispondono a questa sollecitazione precisando nel testo di legge che il suffragio è un diritto riservato solo ed esclusivamente agli uomini: e questa è la prima volta che si sente il bisogno di dichiarare esplicitamente l’esclusione delle donne dal godimento dei diritti politici.
Parole della storia
Campagne elettorali
Nella Gran Bretagna del 18. secolo e dell’inizio del 19. secolo, le elezioni sono un evento pubblico, elettrizzante e festoso come un carnevale; sono, cioè, un evento che al tempo stesso ha un carattere rituale e che coinvolge grandi masse di persone, compresi coloro che non hanno diritto di votare (che sono la grandissima maggioranza: tra il 98 e il 99% del totale della popolazione).
Di solito, la campagna elettorale si apre con la presentazione dei candidati, che sfilano nel collegio elettorale che li voterà in una processione pubblica, contornati da ali di folla e accompagnati dai loro sostenitori che esibiscono le coccarde e le bandiere coi colori del raggruppamento politico per il quale il candidato si presenta; c’è, poi, la formale richiesta del voto, durante la quale un candidato si rivolge agli elettori e ai non elettori (donne comprese) in un pubblico comizio, un’occasione durante la quale la folla può interloquire con lui, a volte anche con qualche ruvidezza (fischi, urli, qualche insulto), e non di rado con entusiasmo (gridando hurrà, applaudendo, sventolando i cappelli in aria).
Dopo, il candidato offre un banchetto privato ai principali elettori che lo sostengono, e talora perfino un ballo in onore delle mogli e delle figlie dei notabili del luogo.
Poi c’è la nomina ufficiale dei candidati e infine la votazione effettiva.
Il seggio resta aperto al pubblico per quaranta giorni: il voto è palese, cioè viene pronunciato davanti a tutti su un palco sopraelevato sul quale sfilano, uno per uno, i votanti (e allora la folla che assiste può approvare o disapprovare sonoramente il voto che viene espresso); durante il periodo del voto i candidati continuano a fare comizi, per convincere gli elettori o per spingere a votare coloro che ancora non lo hanno fatto: è normale, inoltre, che si mettano in atto anche tentativi di corruzione degli elettori, cercando di comprarne i voti con denaro sonante o con promesse di favori futuri.
A votazione conclusa, infine, c’è la proclamazione del vincitore; anche questa è un’occasione pubblica, che culmina nell’”insediamento”, il rituale della sfilata per il collegio elettorale del vincitore, portato a braccia sopra una portantina.
In definitiva le elezioni sono dei rituali che coinvolgono attivamente grandi masse di persone; soprattutto importante è la partecipazione attiva di coloro che non hanno diritto di voto, uomini o donne che siano che, nonostante la loro esclusione formale dal corpo elettorale, sono ammessi ai comizi e ai vari rituali elettorali e per questo sono indotti a sentirsi parte del sistema politico nel suo complesso.
E’ questa partecipazione attiva degli esclusi che ha indotto gli storici del sistema elettorale nella Gran Bretagna pre-1832 a parlare di “rappresentanza virtuale”.
Pratiche clientelari, clientelismo.
Sistema di relazioni asimmetriche tra un potente che elargisce favori e i beneficiari del favore che gli tributano fedeltà ed appoggio.
In contesti di rappresentanza parlamentare il termine è usato per descrivere un particolare modo di procacciarsi voti e consenso: in questo casi si parla pure di “voto di scambio”, per sottolineare che alcuni votanti sono disposti a votare per un esponente politico in cambio di un favore personale che questo ha dato loro (o che ha promesso di lare loro) – “favore” che può essere una somma di denaro o un aiuto nella ricerca di un impiego o un’altra forma di intervento che soddisfi qualche esigenza dei “clienti”.
Tory, whig
I nomi designano i due principali raggruppamenti parlamentari britannici, che hanno preso forma sin dalla fine del 17. secolo.
Nel corso del Settecento le posizioni politiche dei due raggruppamenti si sono precisate e, a grandi linee, si può dire che i tory (un termine originariamente insultante, perché indica i banditi irlandesi) sostengono la Chiesa anglicana, le élite terriere e i diritti del sovrano; i whig (un nomignolo in origine non meno insultante, perché designa i ladri di cavalli scozzesi) sostengono invece la priorità del Parlamento e gli interessi dei mercanti, dei commercianti e degli imprenditori.
A partire dalla riforma elettorale del 1832 questi due schieramenti politici cominciano a cambiare denominazione: sono i tory per primi che prendono a definirsi “conservatori”; a partire dalla metà del secolo anche i whig muteranno denominazione e cominceranno a chiamarsi “liberali”.
Le nuove denominazioni vogliono esplicitare immediatamente l’orientamento ideale che ispira le scelte politiche dei due raggruppamenti.
Bibliografia
Le origini del movimento operaio inglese, 1815-1848: documenti e testi critici / E. Grendi (a cura di). – Laterza, 1973
La grande trasformazione: le origini economiche e politiche della nostra epoca / K. Polanyi. – Einaudi, 2000
Cap. 14. La Francia del Secondo Impero e l’Unità d’Italia
14.1 I cambiamenti nell’Europa continentale
Nonostante i conflitti, le lotte e i mutamenti che lo attraversano, il sistema politico britannico mantiene effettivamente una sua eccezionale stabilità e continuità strutturale, quasi a conferire spessore di verità alla descrizione che Edmund Burke ne aveva dato nel 1790, nel suo Riflessioni sulla Rivoluzione francese (cfr. cap. 6.4).
Ben diversa è la situazione nel continente: il quadro politico è stato instabile per i primi cinquant’anni dell’Ottocento e continua a esserlo nel periodo che va dal 1850 al 1870.
In questo ventennio i fattori di mutamento sono essenzialmente due: l’attivismo francese in materia di politica internazionale, sostenuto – in qualche misura – dalla Gran Bretagna; la forza degli ideali nazionalisti, che contagia anche attori politici che in precedenza li avevano combattuti.
Questi due fattori di mutamento producono le seguenti trasformazioni:
a) la formazione di due grandi Stati unitari (Italia e Germania) proprio in quella parte del continente europeo che sin dal tardo Medioevo era stata ininterrottamente caratterizzata da una grande frammentazione politica.
b) la diffusione del sistema rappresentativo costituzionale nella maggior parte degli Stati dell’Europa continentale; sebbene la declinazione istituzionale dominante continui a essere quella monarchica, ora si ribalta la situazione che poteva essere osservata guardando l’Europa all’inizio del Settecento, quando la Gran Bretagna parlamentare era sola in mezzo a un contesto di monarchie assolute; sono le monarchie assolute (l’Impero russo o quello ottomano) a essere ora l’eccezione, in un contesto di monarchie costituzionali.
Per quanto possa sembrare strano, all’origine di questi processi di mutamento vi è soprattutto la politica estera di uno Stato – la Francia – che all’inizio degli anni Cinquanta assume forme istituzionali autoritarie.
Parole della storia
Accentramento, decentramento
La struttura amministrativa del Regno d’Italia viene definita dalla legge del 20 marzo 1865, che stabilisce una struttura rigorosamente accentrata.
Le articolazioni amministrative esistenti sono i comuni e le province: dotate di organismo elettivi (consiglio comunale e provinciale), la cui formazione è disciplinata da leggi elettorali di impianto simile a quello della legge politica, queste due articolazioni amministrative sono sottoposte immediatamente al controllo di un funzionario direttamente dipendente dal ministero dell’Interno, il prefetto, che sorveglia tanto i bilanci quanto gli atti amministrativi approvati da comuni e province.
Si tratta, dunque, di un sistema amministrativo rigorosamente accentrato, tale, cioè, da garantire al potere centrale larghe possibilità d’intervento sugli organismi locali.
La scelta è dettata dall’intima convinzione di buona parte della classe dirigente liberale, formatasi nell’ammirazione per il sistema amministrativo francese; ma è dettata anche dalla paura che forze antiunitarie, per esempio quelle che si esprimono attraverso il brigantaggio meridionale, possano mettere in discussione l’Unità appena raggiunta.
A favore di soluzioni più decentrate – cioè capaci di garantire maggiori autonomie ai comuni e alle province, con una migliore articolazione della struttura amministrativa, possibilmente arricchita dall’istituzione delle regioni – si esprimono pochi autorevoli uomini politici liberali (tra cui Marco Minghetti e Stefano Jacini).
Favorevoli a una soluzione più radicalmente federalista sono alcuni democratici (tra cui il più importante è il lombardo Carlo Cattaneo), che tuttavia non hanno sostanzialmente alcun seguito, né tra i liberali, né tra gli stessi democratici.
Censimento
Si tratta di un’operazione organizzata da uno Stato al fine di ottenere una ricca serie di informazioni sulla popolazione.
Un censimento deve tenersi in un breve tasso di tempo (non più di qualche giorno); è compiuto attraverso la distribuzione alle famiglie di schede informative sulle quali il capofamiglia deve indicare l’età, la professione, il grado di alfabetizzazione, lo stato civile e altro ancora di ciascun membro del nucleo familiare.
Le schede vengono poi raccolte da addetti incaricati e trasferite a uffici che hanno il compito di elaborare statisticamente le informazioni.
Quello organizzato dal Regno d’Italia nel 1861 è il primo censimento realizzato sul territorio della penisola con tecniche moderne.
Da allora se ne sono tenuti molti altri con cadenza regolare, in genere decennale.
Guarentigie
La parola significa “garanzie” e si riferisce a ciò che lo Stato italiano riconosce al papa in cambio della conquista definitiva dello Stato pontificio e di Roma.
Le principali prerogative riconosciute sono le seguenti: la persona del papa è dichiarata inviolabile; al papa si attribuisce lo status di sovrano; i palazzi del Vaticano, del Laterano e della Cancelleria a Roma e la villa di Castelgandolfo sono conisderati aree extraterritoriali, cioè non appartenenti al territorio dello Stato italiano; il pontefice ha il diritto di tenervi guardie armate; ai membri della Santa Sede viene riconosciuta piena libertà di comunicazione postale e telegrafica.
Il papa rifiuta di accettare la legge (rifiutando in tal modo anche il finanziamento annuo che pure essa prevede e che lo Stato italiano sarebbe pronto a pagargli); al tempo stesso rifiuta di riconoscere lo Stato italiano; di fatto, tuttavia, si avvale delle prerogative che la legge delle Guarentigie gli assicura.
Leggi Siccardi
Approvate nel 1850, prendono il nome dal ministro della Giustizia del governo D’Azeglio, Giuseppe Siccardi (1802-1857), e prevedono l’abolizione del foro ecclesiastico (cioè il tribunale speciale riservato alla trattazione di procedimenti che riguardano i membri del clero), l’abolizione del diritto di asilo attribuito alle chiese e ai luoghi di culto, la riduzione delle feste religiose riconosciute dallo Stato e il divieto agli istituti ed enti morali ecclesiastici o laici di acquisire immobili per acquisti, lasciti o donazioni, senza autorizzazione regia.
Secondo Impero
Tale denominazione, attribuita al sistema politico nato nel 1851-52, segue l’abitudine francese di numerare i frequenti regimi che lì si succedono e vuole anch’essa sottolineare il nesso diretto che collega il nuovo regime al “Primo” Impero del grande Napoleone (1804-14).
Statuto Albertino
Promulgato il 4 marzo 1848 dal re di Sardegna Carlo Alberto (da cui il nome attribuito convenzionalmente al documento) lo Statuto (termine che equivale a quello più moderno di Costituzione) prevede un sistema in cui il potere esecutivo è affidato interamente al re, che è il capo del governo e delle forze armate e ha il compito di nominare i funzionari dello Stato.
Il potere legislativo è affidato congiuntamente al re – che può proporre disegni di legge e deve promulgare i testi di legge – e a un Parlamento bicamerale che ha il compito di proporre, discutere e approvare i disegni di legge.
Il Parlamento è bicamerale perché è composto da un Senato vitalizio e da una Camera dei Deputati elettiva.
Il Senato si dice vitalizio perché i membri sono nominati a vita dal sovrano; il numero dei senatori non è stabilito, cosicché il sovrano può nominare quanti senatori vuole.
La Camera dei Deputati viene eletta da un corpo elettorale ristretto, , composto da maschi adulti, in grado di leggere e scrivere e in possesso di un notevole livello di ricchezza; i votanti nel Regno di Sardegna sono all’incirca il 2% del totale della popolazione.
Lo Statuto prevede che il governo sia responsabile solo nei confronti del re che lo nomina e non nei confronti del Parlamento, a cui, dunque, non viene riconosciuto il diritto di determinare l’orientamento dei governi, né il diritto di farli cadere con un voto di sfiducia.
Terre demaniali
Nel 1806 nel Mezzogiorno continentale e nel 1812 in Sicilia erano state approvate norme che avevano abolito le giurisdizioni feudali e avevano stabilito la divisione dei demani feudali, comunali ed ecclesiastici [cfr. cap. 5.4.4].
I demani erano le terre sulle quali potevano essere esercitati usi civici – come il diritto di semina, di raccolta del legname, di pascolo, ecc.; tali usi civici erano stati fin allora riservati a specifiche categorie di persone, per esempio gli abitanti dei territori di un feudo, o gli abitanti di un determinato villaggio, a cui quei diritti erano stati formalmente riconosciuti da qualche autorità.
In linea generale, le leggi che abolivano i demani avevano stabilito che una parte delle terre demaniali fossero divise tra coloro i quali avessero in precedenza goduto del diritto di usare queste terre.
L’incarico di suddividere le terre era stato attribuito alle amministrazioni locali, quasi sempre controllate da grandi proprietari.
In alcuni casi la divisione aveva avuto luogo; in altri, la divisione era stata ritardata o ostacolata dagli amministratori locali, poiché essi avevano tentato, talora con successo, di appropriarsi abusivamente di una parte, se non di tutte, le terre demaniali che avrebbero dovuto essere suddivise: e ciò aveva provocato il fortissimo risentimento di tutte quelle famiglie contadine che avrebbero avuto il diritto a una parte delle terre ex feudali e che invece se le erano viste negare.
Bibliografia
La forza del destino: storia d’Italia dal 1796 ad oggi / C. Dugan. – Laterza, 2009
Cavour contro Garibaldi / D. Mack Smith. – Rizzoli, 1999
Il secolo borghese in Francia, 1815-1914 / R. Magraw. – Il Mulino, 1996
Vita di Cavour / R. Romeo. – Laterza, 2004
Storia d’Italia, vol. 2.: Il nuovo Stato e la società civile / G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di). – Laterza, 2995
Cap. 15. L’unificazione tedesca e le sue conseguenze
15.1 La Prussia dopo il 1848-49
Tra gli anni Sessanta e gli anni settanta dell’Ottocento nel cuore d’Europa ha luogo un altro grande mutamento geopolitico che questa volta conduce alla formazione di uno Stato nazionale tedesco.
Non troppo diversamente da ciò che è successo nella Penisola italiana, questo processo viene guidato da una monarchia uscita con tratti nuovi dalla rivoluzione del 1848-49: si tratta del Regno di Prussia che, come quello di Sardegna, ha ora la forma di una monarchia costituzionale.
Come lo Statuto albertino anche la Costituzione prussiana, concessa dal re Federico Guglielmo 4. nel 1850, si fonda sulla preminenza del sovrano sul Parlamento; come il Parlamento dello Stato sardo, anche quello prussiano è bicamerale, con un Senato (Herrenhaus) ereditario e di nomina regia; la diversità maggiore riguarda la Camera elettiva, regolata da una legge elettorale che prevede la partecipazione di tutti i maschi adulti, ma che, col Dreiklassenwahlsystem (“sistema elettorale delle tre classi”), dà agli individui più ricchi una rappresentanza sproporzionalmente superiore al loro numero [cfr. cap. 9.3.5].
Dal punto di vista socio-politico la Prussia continua a reggersi su una solida alleanza tra i proprietari terrieri nobili delle regioni orientali – gli Junker – e il sovrano; non solo costui li predilige quando deve procedere alle nomine di nuovi membri del Senato, ma anche continua a preferirli nei ruoli direttivi della burocrazia e dell’esercito.
E poi, oltre a essere massicciamente presenti negli apparati dello Stato, gli Junker dispongono ancora di notevoli giurisdizioni feudali (Gutscherrschaften) e in particolare del diritto di nominare i funzionari sui quali esercitano la loro potestà di feudatari.
Un potere così robusto si traduce in un’autorità che le popolazioni rurali subiscono con timorosa deferenza.
In un articolo anonimo pubblicato su una rivista prussiana nel 1868 si dice che nelle campagne a est del fiume Elba (l’area più orientale della Prussia) “quando un bracciante riceve una scheda elettorale va ancora dal suo padrone a chiedere se può essere multato qualora non rispetti la convocazione [e non vada a votare].
Quanto alle idee politiche egli ricorda solo qualche massima militare, e votare contro la volontà del prefetto o del governatore provinciale, o addirittura contro il nobile proprietario terriero, è un’iniziativa che perfino in un’elezione gli sembrerebbe non rispettabile”.
A ulteriore spiegazione di questi atteggiamenti cos’ supinamente deferenti da parte dei contadini va aggiunto che le elezioni sono a suffragio palese; che una legge prussiana dell’11 marzo 1850, rimasta in vigore sino al 1908, proibisce ai contadini ogni genere di attività sindacale organizzata; e che un’altra legge del 24 aprile del 1854, rimasta in vigore fino al 1918, proibisce scioperi agricoli di ogni genere.
In tal modo, nei collegi rurali, la possibilità di successo per un qualche candidato che non sia gradito alle élite terriere locali sono assolutamente remote.
Un dominio di questo genere non è invece pensabile nelle aree urbane, specie in quelle occidentali, in rapido sviluppo economico e demografico: in quelle zone le elezioni mandano in Parlamento deputati di orientamento liberale, favorevoli a uno sviluppo maggiore delle istituzioni e delle garanzie costituzionali; e la partita politica che si apre nella Prussia di metà Ottocento si gioca proprio tra due schieramenti: una Destra conservatrice che ha radici agrarie e nobiliari e una Sinistra liberale che un profilo urbano e borghese.
Lo scontro tra queste due anime della politica prussiana si consuma intorno alle modalità di potenziamento di una istituzione tradizionalmente centrale nel sistema del potere prussiano, l’esercito.
Quello prussiano è un esercito che sin dal 1814 viene organizzato su base estremamente originale: dopo la sconfitta subita dalle armate napoleoniche, la parola d’ordine della “nazione in armi”, coniata nella Francia rivoluzionaria, viene ripresa dai riformatori tedeschi e applicata all’esercito prussiano nel contesto conservatore del Regno di Prussia dell’età della Restaurazione.
E così viene introdotta la coscrizione universale obbligatoria, con l’obbligo per ogni maschio adulto di svolgere un periodo di ferma biennale nell’esercito, seguito da altri due anni di iscrizione fra le truppe di riserva e da altri quattordici anni nella milizia territoriale; in questi sedici anni finali di militanza tra le truppe di riserva e nella milizia territoriale ai coscritti si chiedono solo brevi periodi annui di addestramento per conservare la propria efficienza.
Si tratta di un modello di organizzazione molto originale, sperimentato dalla sola Prussia in questo periodo.
Il vantaggio è nel disporre di un esercito “di quantità”, cioè con un considerevole numero di soldati pronti al bisogno tra quelli in servizio attivo e quelli iscritti nelle liste di riserva, fra l’altro abbastanza ben addestrati.
Inoltre gli storici che si sono occupati delle istituzioni militari prussiane sottolineano che si tratta di un sistema che produce potenti effetti nazionalizzanti: i coscritti imparano a conoscere i propri doveri di cittadini; partecipando alla vita politica (sebbene col “sistema delle tre classi”) non vivono il servizio militare solo come un’odiosa imposizione, ma pure come un dovere civico; e i valori nazionali, oltre che egli strumenti essenziali dell’appartenenza alla nazione (per esempio l’uso della lingua tedesca), ne sono potentemente favoriti.
Citazione
Per parte mia non ho alcuna fiducia nelle dittature e soprattutto nelle dittature civili.
Io credo che con un parlamento si possano fare parecchie cose che sarebbero impossibili per un potere assoluto.
Un’esperienza di tredici anni m’ha convinto che un ministero onesto ed energico, che non abbia nulla da temere dalle rivelazioni della tribuna e non si lasci intimidire dalla violenza dei partiti, ha tutto da guadagnare dalle lotte parlamentari.
Io non mi sono mai sentito debole se non quando le camere erano chiuse.
D’altra parte non potrei tradire la mia origine, rinnegare i principi di tutta la mia vita.
Sono figlio della libertà; è ad essa che debbo tutto quel che sono.
Se bisognasse mettere un velo sulla sua statua, non sarei io a farlo.
Se si dovesse riuscire a persuadere gli italiani che hanno bisogno di un dittatore, essi sceglierebbero Garibaldi e non me.
Ed avrebbero ragione.
La via parlamentare è più lunga, ma è più sicura.
Bismarck
Pag. 299
Bibliografia
La formazione dello Stato nazionale tedesco, 1800-1871 / J. Breully. – Il Mulino, 2004
Bismarck / L. Gall. – Rizzoli, 1982
Il tramonto dell’Impero asburgico / J. W. Mason. – Il Mulino, 2000
Bismarck: l’uomo e lo statista / A. J. P. Taylor. – Laterza, 2004
L’impero guglielmino, 1871-1918 / H.-U. Wehler. – De Donato, 1981
Cap. 16. Gli Stati Uniti e la Russia
16.1 Schiavitù e servitù
Le trasformazioni e i conflitti interni all’Europa non ne frenano affatto l’espansione economica, politica e militare fuori dai suoi confini.
E’ dal 16. secolo che gli europei vanno e vengono per i mari del mondo, intenti a conquistare economicamente o politicamente territori ritenuto appetibili.
Nondimeno, a metà Ottocento, le migliori mappe disponibili mostrano ancora vasti spazi bianchi in corrispondenza del centro dell’Africa, dell’Asia, dell’Australia o dell’America, sia del Sud sia del Nord, mentre nessuno sa niente di preciso dell’Artide e dell’Antartide.
A “colmare la lacuna” pensano intrepidi esploratori.
Qualche volta son persone animate da curiosità scientifica o da senso dell’avventura; qualche altra da spirito missionario; qualche altra ancora da più concreti desideri di scoprire nuove opportunità per arricchirsi.
Tuttavia l’espansione coloniale ottocentesca si presenta attraverso una retorica attenta a mostrare la civiltà occidentale come portatrice di progresso e di benessere per tutti, compresi i popoli ritenuti meno sviluppati o meno civili.
E così, per esempio, tra fine Settecento e inizio Ottocento, l’Occidente europeo scopre quanto orrore ci sia nella schiavitù, che accompagna il suo dominio sulle coste occidentali dell’Africa e su quelle orientali del continente americano.
Sin dagli ultimi decenni del Settecento in Gran Bretagna si è formato un movimento favorevole all’abolizione del commercio degli schiavi; e nel 1807, ascoltandone le ragioni, il Parlamento del Regno Unito vota una legge che abolisce il commercio degli schiavi nelle colonie.
La norma viene imitata da altri Stati, fra il quali gli Stati Uniti, che aboliscono l’importazione degli schiavi nel 1808, e la Francia, che lo fa nel 1815.
Tra 1774 e 1804, inoltre, la schiavitù è abolita negli Stati del Nord degli Stati Uniti d’America; più tardi viene abolita in Gran Bretagna (nel 1833) e in Francia (1848).
Vero è che, nonostante queste importanti misure, la tratta continua ancora nel 19. secolo, sia perché alcuni Stati continuano ad autorizzarla, sia perché prospera un commercio clandestino, spesso largamente tollerato; cambia tuttavia la destinazione dei flussi di traffico: non più le Antille inglesi, francesi e olandesi e gli Stati Uniti, dove lo sbarco di schiavi è formalmente proibito, ma Cuba, colonia spagnola che lo autorizza essenzialmente per tutti il secolo, e il Brasile, dove il traffico viene abolito solo nel 1850.
Ma non c’è dubbio che la stagione della schiavitù si sta chiudendo.
Un grande risultato, per un movimento che è stato sostenuto da parole ispirate e piene di reale spirito di fratellanza e di umanità, come quelle pronunciate nel Parlamento di Westminster da William Wilberforce (1759-1833), uno dei capi dell’abolizionismo britannico, secondo il quale “un commercio fondato sull’iniquità e proseguito in simili orribili condizioni deve essere abolito, quali ne siano le conseguenze. Non posso credere che l’Onnipotente, che ha proibito la rapina e l’assassinio, li abbia resi necessari in una qualche parte dell’universo”.
La spinta che viene dall’Illuminismo universalista, cioè da quell’elaborazione filosofica che vuole gli uomini uguali nei diritti (se non nelle effettive condizioni di vita), meritevoli di un trattamento equo e umano, si esercita pure nei confronti di un’altra forma di brutale assoggettamento personale, la servitù della gleba, ovvero il legame servile che collega un contadino e la sua famiglia a un’azienda agricola, non molto diversamente dal legame al quale sono soggiogate le “scorte vive” (cioè il bestiame).
Sin dalla fine del Settecento le varie forme di servitù della gleba che si potevano incontrare nelle campagne europee cominciano ad essere messe in discussione e poi, man mano, eliminate.
La notte del 4 agosto 1789, quando l’Assemblea nazionale francese decide di abolire completamente ogni aspetto del sistema feudale ancora esistente nelle campagne del Regno di Francia [cfr. cap. 3.2], inaugura una stagione di decisa defeudalizzazione delle comunità rurali europee.
Nel corso dell’Ottocento, infatti, altre importanti riforme analoghe seguono il gesto così radicale compiuto dalla prima Assemblea rivoluzionaria francese.
Nel 1806 il sistema feudale viene abolito nel Regno di Napoli; nel 1812 la stessa operazione viene compiuta nella Sicilia borbonica [cfr. cap. 5.4.4].
Nel 1807 in Prussia viene abolita la servitù della gleba (anche se sono conservate le giurisdizioni feudali: cfr. cap. 5.4.3].
Nel 1848la servitù della gleba viene abolita su tutti i territori dell’Impero austriaco.
Anche nelle campagne europee l’universalismo dei diritti si trasforma da alata utopia in effettiva realtà; e se è vero che alla teorica uguaglianza dei diritti continua ad affiancarsi un’effettiva e profonda disuguaglianza delle condizioni sociali, che fa delle comunità contadine le aree socialmente e culturalmente più depresse del “Vecchio Continente”, l’abolizione della servitù della gleba, come dei diritti feudali, e la proibizione della schiavitù sono decisioni che tutti coloro i quali hanno sostenuto la necessità di “riforme morali” nell’Occidente europeo salutano con grande soddisfazione.
E’ un quadro che – a metà Ottocento – è però caratterizzato da due grandi eccezioni: negli Stati meridionali degli Stati Uniti d’America la schiavitù non solo è ancora legale, ma è il perno del sistema economico che lì domina, basato su vaste piantagioni di cotone e di tabacco; nella grande estensione della Russia zarista la servitù della gleba continua a essere una delle fondamentali istituzioni che regolano la vita delle sue sterminate campagne.
Tali eccezioni colpiscono particolarmente perché si sta parlando di paesi che si impongono all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale come forti e ambiziose potenze (la Russia) e come Stati in rapida crescita, certamente destinati a un grande futuro (gli Stati Uniti d’America).
Ma proprio a metà del secolo la servitù in Russia e la schiavitù negli Stati Uniti sono al centro del dibattito e nel caso degli Stati Uniti la tensione intorno alla possibile abolizione della schiavitù negli Stati Uniti del Sud causa addirittura una gravissima guerra civile [vedi parole della storia].
Parole della storia
Autocrazia
Sistema politico nel quale il potere si concentra nelle mani di un unico soggetto sovrano, il cui potere non è sostanzialmente limitato da alcun altro soggetto istituzionale o sociale.
Guerra civile
Si può parlare di “guerra civile” quando i membri di una medesima comunità politica si dividono in gruppi che si fanno portatori di progetti politici inconciliabilmente opposti; la guerra scoppia per far prevalere un progetto politico a danno dell’altro.
Il carattere estremo della contrapposizione spiega la violenza che – normalmente – accompagna questo tipo di guerre.
Ku Klux Klan
Associazione segreta razzista, fondata nel 1866 nel Tennessee da veterani dell’esercito confederale; il nome deriva dalla combinazione della parola greca kyklos, “ciclo”, e clan.
Attiva negli Stati del Sud, l’associazione viene proibita e smantellata dalle autorità all’inizio degli anni Settanta.
L’organizzazione viene comunque ricostituita nel 1915 con un programma razzista e xenofobo e resta attiva per gran parte del 20. secolo.
Linciaggio.
Pratica con la quale un gruppo di privati cittadini, destituiti di ogni autorità, aggredisce qualcuno e, per applicare una forma di giustizia extralegale, lo sottopone a un processo sommario a cui seguono torture, percosse e talora l’uccisione del malcapitato, di solito per impiccagione.
Il nome di questa pratica viene fatto risalire a un tale colonnello Charles Lynch, che durante la guerra di indipendenza in Virginia si era attribuito il compito di punire e giustiziare i coloni fedeli alla Gran Bretagna (ma l’etimologia è incerta ed esistono altre ipotesi).
Dopo la guerra di Secessione il termine indica le numerose aggressioni di cui diventano vittime i neri, specie negli Stati del Sud.
Negli Stati Uniti la pratica del linciaggio dura a lungo, fino agli anni Settanta del 20. secolo.
Statistiche attendibili documentano che fra il 1865 e il 1965 le persone uccise con un linciaggio (in larghissima maggioranza dei neri) sono state più di 5000; la maggior parte dei linciaggi è stata compiuta tra il 1865 e il 1900
Bibliografia
La danza di Natasha: storia della cultura russa, 18.-20. secolo / O. Figes. – Einaudi, 2008
L’economia politica della schiavitù: studi sull’economia e la società del Sud schiavista / E. D. Genovese. – Einaudi, 1972
Storia della guerra civile americana / R. Luraghi. – Rizzoli, 2009
Cap. 17. Globalizzazione e dominio coloniale
17.1 Caratteri generali
Già evidente nel corso del 18. secolo, il processo di colonizzazione permanente di territori lontani dall’Europa prosegue nell’Ottocento su una scala ancora maggiore.
Gli straordinari progressi tecnici raggiunti in quest’epoca dalle industrie europee permettono un salto di qualità nei processi di integrazione commerciale: le distanze via terra possono essere coperte in tempi molto più brevi grazie alle ferrovie; sul mare operano velieri di ultima generazione, ampi, rapidi, maneggevoli e i tempi dei viaggi a lunga percorrenza si accorciano; inoltre si cominciano a vedere, sin dagli anni Quaranta-Cinquanta, le prime navi a vapore che, se non sono ancora in grado di sostituire il velieri, specie nelle tratte marittime più lunghe, possono tuttavia abbreviare i tempi di trasporto sulle più brevi distanze.
In conseguenza di tutto ciò, l’integrazione economica mondiale (o se si preferisce la globalizzazione) [cfr. cap. 1.1] fa passi da gigante.
In ciò è favorita dall’attività di esploratori (e talora missionari) europei, che intraprendono missioni conoscitive in Asia, in Africa, in Oceania, offrendo informazioni preziose su rotte di traffico da attraversare, materie prime e merci da acquisire, reti mercantili da contattare.
L’industrializzazione europea ha un’ulteriore importante ricaduta: mentre migliorano le tecniche per la produzione di tessuti, delle macchine utensili, dei treni e delle navi, migliorano pure le tecnologie e le soluzioni applicative per la produzione di armi.
Nel corso dell’Ottocento essa rappresenta probabilmente il singolo fattore che apre il più vasto divario tra l’Occidente (Europa e Stati Uniti) e tutte le altre civiltà presenti nel globo.
E’ un divario che si traduce in una notevole superiorità bellica: se nel periodo in esame, che va dai primi decenni agli anni settanta del 19. secolo, tale superiorità non determina una occupazione sistematica delle aree strategiche della Terra da parte delle maggiori potenze occidentali, fa sì tuttavia che esse siano in grado di dettar legge praticamente quasi dappertutto e quasi contro ogni altro gruppo etnico, o Stato, o Impero che incontrino sulla loro strada.
I principali modi del dominio coloniale sono essenzialmente tre:
a) dominio economico-commerciale indiretto (esercitato, per esempio, nei confronti dell’Impero ottomano, della Cina o del Giappone)
b) dominio coloniale diretto, con l’occupazione dei territori coloniali e l’instaurazione di forme di governo caratterizzate dall’assoggettamento della popolazione autoctona (India, Indonesia, Indocina) o dalla formazione di colonie bianche, costruite con l’eliminazione o l’allontanamento delle popolazioni autoctone (Canada, Australia, Sudafrica);
c) azione militare e diplomatica per l’esercizio di un’egemonia economica e/o politica su aree territoriali sottratte ad altri Stati (è il tipo di azione che le potenze europee sviluppano soprattutto nei confronti dell’Impero ottomano).
Altrettante sono le fondamentali risposte che vengono dalle società oggeto delle varie forme di aggressione coloniale:
a) le élite locali tentano un processo di modernizzazione [vedi parole della storia] delle strutture istituzionali, amministrative ed economiche, basato su un’originale imitazione delle istituzioni degli aggressori occidentali (Impero ottomano, Giappone);
b) le élite politiche e religiose delle società minacciate dall’espansione coloniale occidentale incoraggiano forme di irrigidimento dei tratti identitari propri delle società locali: questo tipo di opposizione si esprime anche con forme di resistenza armata che talora sono efficaci (Afghanistan), talaltra lo sono molto meno (India, Cina, Indonesia, Sudafrica, Oceania);
c) in entrambi i casi, sia i modernizzatori sia i tradizionalisti cercano di dialogare con le confessioni religiose dominanti nel paese, alle quali, in una forma o nell’altra, si rivolgono per cercare orizzonti etici che nobilitino la resistenza agli estranei occidentali.
E così, dunque, come accade in Occidente col nazionalismo, nei paesi sottoposti all’aggressione coloniale prendono vita forme di sacralizzazione del politico: in qualche caso tale processo di sacralizzazione porta a soluzioni monistiche nelle quali autorità religiosa e autorità politica si confondono nelle stesse figure e nelle stesse istituzioni (come accade soprattutto in Giappone); in altri casi, invece, il sistema di sacralizzazione della resistenza politica si basa su un più complicato dualismo, nel quale i capi politici e i capi religiosi cercano di far cooperare o addirittura coincidere i rispettivi valori e interessi (e questo è soprattutto l’importantissimo caso dei numerosi paesi islamici).
Queste sono le coordinate generali, all’interno della quali ha luogo l’esperienza del colonialismo ottocentesco; è tuttavia necessario osservare più da vicino i casi principali di incontro/scontro tra Occidente e paesi “altri”, per indagarne meglio la varietà delle interazioni e delle implicazioni.
Parole della storia
Compagnia olandese delle Indie Orientali (Verenigde Oostindische Compagnie)
Fondata nel 1602, ottiene dalla Repubblica delle Province Unite sia il monopolio dei commerci olandesi con l’Oriente, sia il compito di controllare militarmente e amministrare le basi che essa è in grado di procurarsi.
Pur avendo compiti amministrativi, la Compagnia non è un ente pubblico, ma privato; anzi è una delle prime società per azioni: le azioni possono essere acquistate alla borsa di Amsterdam dai risparmiatori che sperano di ricavarne dei dividendi.
Coloro che acquistano azioni per grosse somme hanno voce in capitolo sulla formazione degli organi dirigenti della Compagnia.
Cristiano-maroniti
Fedeli di una Chiesa cattolica orientale, diffusa in Libano, che possiede riti e gerarchia ecclesiastici propri.
Drusi
Fedeli di una confessione religiosa derivata dall’islamismo, ma poi evolutasi come una fede autonoma, diffusa in Libano e nella Siria meridionale
Giannizzeri
Il termine deriva dalla parola turca yeniçeri (“nuova milizia”).
Il corpo dei giannizzeri viene fondato nel 1330, come milizia d’élite.
In origine è formato da giovani rapiti alle famiglie cristiane, specie dell’area balcanica, ed educati alla fede musulmana e all’arte della guerra.
Col passare del tempo la grande e riconosciuta efficienza di questo corpo militare – che dal Seicento è composto da musulmani – garantisce ai suoi membri privilegi e riconoscimenti che lo trasformano quasi in un gruppo sociale a parte; da qui il comportamento indisciplinato e aggressivo che i giannizzeri manifestano nel corso del 18. e all’inizio del 19. secolo.
Jihad
Il termine significa “sforzo verso la via di Dio” e implica una molteplicità di attività che hanno a che fare con la fede del credente musulmano.
Maometto ha distinto un jihad maggiore (la lotta etica contro il male, che impegna per tutta la vita un musulmano virtuoso), da una jihad minore (la lotta armata contro i politeisti o contro i seguaci di altre religioni).
Il jihad minore viene normalmente tradotto con la locuzione “guerra santa islamica”.
La logica di questo secondo jihad prevede che esista una sfera di pace (där al-islam, che è essenzialmente l’area nella quale vige la Sharia) e una della guerra (där al-harb, dove non vige la sharia, e verso la quale la guerra è potenziale o in corso).
I nemici che non si convertono devono essere sottomessi; i fedeli musulmano che muoiono in un jihad sono dei martiri che vengono immediatamente trasportati in Paradiso, senza attendere la resurrezione nel giorno del giudizio
Manchu
Gruppo etnico proveniente dalla Manciuria, regione settentrionale della Cina, a cui appartiene la dinastia imperiale Quing (detta anche Manchu, per la sua origine), che nel 17. secolo si impone spodestando la precedente dinastia Ming.
Millet
Così si chiamano le varie istituzioni religiose, formalmente riconosciute, che all’interno dell’Impero ottomano regolano la vita delle diverse minoranze confessionali.
A seconda dei privilegi riconosciuti, esse possono godere di notevoli prerogative e autonomia.
Modernizzazione
Il termine designa quell’insieme di mutamenti che hanno luogo nell’economia, nella società e nella politica dei paesi occidentali al passaggio tra età moderna ed età contemporanea; tali mutamenti sono caratterizzati dallo sviluppo di sistemi produttivi industrializzati, di società prive di gruppi cetuali, di Stati basati su leggi valide per tutti e applicate da funzionari e impiegati specializzati, di una lotta politica regolata da Costituzioni e istituti rappresentativi progressivamente aperti a tutta la popolazione adulta.
Sati.
Parola che significa “casta sposa”.
Il termine indica il rito funebre indù nel quale la vedova di un indù accetta di farsi bruciare sul rogo destinato alla cremazione del corpo del marito.
Sebbene il rituale implichi che la vedova scelga volontariamente di farsi bruciare sul rogo, in alcune comunità indù le vedove erano costrette a sottoporsi al rituale anche contro la loro volontà.
Proibito dagli inglesi a partire dal 1829, il sati continua a essere praticato clandestinamente per tutto il 19. secolo.
Sistema delle caste.
Si tratta di un sistema di stratificazione sociale, rigido, sebbene non del tutto privo di mobilità sociale, e riguarda soprattutto la popolazione di religione indù.
Nella sua forma più semplice il sistema individua quattro grandi caste, basate sulle professioni e sulle qualità che a esse sono collegate: Bramini, che sono sacerdoti e insegnanti; Kshatrya, re, guerrieri e amministratori; Vaisya, agricoltori, mercanti, uomini d’affari; Sudra, servitori e operai.
Oltre a queste quattro caste vi è il gruppo dei paria, o fuori casta, cui sono riservati i lavori più umili; costoro sono considerati “intoccabili”, poiché se un indù delle altre caste li sfiora deve procedere subito a rituali di purificazione.
Secondo la religione indù, la casta nella quale un individuo nasce è assegnata sulla base delle azioni compiute in una vita precedente: la collocazione sociale ha dunque un valore “temporaneo”, fino alla morte della persona e alla sua successiva reincarnazione.
Una divisione in due caste esiste anche tra gli indiani di confessione musulmana.
Sunniti, sciiti
Sono i seguaci delle due principali correnti dottrinali islamiche.
La corrente sciita – che raccoglie la minoranza dei musulmani, ed è diffusa soprattutto in Iraq, in Afghanistan e in India – sostiene che la guida spirituale della comunità islamica deve essere riservata ai discendenti di Maometto (il termina shia, da cui deriva il nome della corrente, è un’abbreviazione che significa “seguaci di Alì”; Alì, 600-661, era il cugino e genero di Maometto e suo primo successore).
La massima autorità religiosa sciita è l’imam; secondo le prescrizioni di Maometto gli imam sono solo dodici: i fedeli sciiti ritengono che il dodicesimo imam, Muhammad al-Muntazar (vissuto alla fine del 9. secolo), non sia morto ma solo scomparso; credono anche che farà ritorno alla fine dei tempi come messia (al-mahdi, “il Guidato”) e porterà pace, giustizia e unità.
Nell’attesa la funzione di vicari (cioè di sostituti temporanei) dell’imam scomparso e svolta dai mullah (termine iranico che ha lo stesso significato di ulema), a cui viene riconosciuto l’importante diritto di dare interpretazioni della Sharia (la legge islamica derivata dal Corano e dalla sunna); il mullah scelgono tra di loro alcuni che sono ritenuti particolarmente autorevoli; costoro sono gli ayatollah; pochissimi ayatollah vengono poi investiti del rango di marga’al-taqlid (“modelli da imitare”).
Importante, per gli sciiti, è il culto dei martiri, che ricorda l’originaria persecuzione subita dai discendenti di Maometto a opera di clan religiosi rivali: il “massacro di Karbala”, una battaglia tra clan rivali combattuta nel 680, durante la quale venne ucciso al-Husayn, figlio di Alì, è uno dei miti identitari fondamentali dello sciismo: emblema della sofferenza e del martirio, rappresenta per questa corrente qualcosa di simile a ciò che la Passione di Cristo significa per i cristiani: riconcilia il credente con le ingiustizie del mondo, offrendo al tempo stesso una promessa di redenzione.
Il sunnismo, la corrente musulmana largamente maggioritaria sia all’interno dell’Impero ottomano sia fuori dei suoi confini, si basa sulla negazione della dottrina sciita al quale vuole che il ruolo di guida spirituale sia riservato a discendenti della famiglia del profeta: afferma invece che ogni credente può accedere alla guida politica e spirituale dell’islam.
La guida religiosa della comunità sunnita è affidata agli ulema, tra i quali non vi è gerarchia e agli imam, che svolgono il compito di guide nei rituali e nelle preghiere compiute nelle moschee (i principali luoghi di culto).
Gli ulema sunniti sono autorizzati a fornire interpretazioni della Sharia, che dev’essere quanto più possibile fedele al Corano e alla sunna (parola dalla quale deriva il nome della corrente); da qui un conservatorismo dottrinario nel sunnismo rispetto allo sciismo.
Ulema.
E’ il plurale di alim, parola araba che significa “dotto”.
Gli ulema sono tra le massime autorità religiose islamiche.
Non sono preti, poiché nell’islam non esiste una Chiesa paragonabile a quelle cristiane; sono piuttosto degli studiosi incaricati di dare interpretazioni della Sharia (legge islamica), cioè dell’insieme di norme etiche e di comportamento derivate dai sacri testi islamici (che sono il Corano – il testo che riporta la voce di Allah, così com’è stata ascoltata dal suo profeta, Maometto; e la sunna, ovvero l’insieme di testimonianze relative a ciò che il Profeta Maometto ha fatto e detto nella sua vita).
Bibliografia
Storia dell’Asia orientale, 1850-1949 / E. Collotti Pischel. – Carocci, 2008
Storia delle società islamiche, vol.3.: I popoli musulmani / I. M. Lapidus. – Einaudi, 2000
Storia dell’Impero ottomano / a cura di R. Mantran. – Argo, 2004
Storia della Cina moderna, secoli 18.-20. / J. Osterhammel. – Einaudi, 1992
Storia del colonialismo / W. Reinhard. – Einaudi, 2002
Storia dell’India / D. Rothermund. – Il Mulino, 2007
Islam. – M. Ruthven. – Einaudi, 2007
Orientalismo: l’immagine europea dell’Oriente / E. W. Said. – Feltrinelli, 2007
Cap. 18. Popolazione e produzione
18.1 “Bisogna essere del proprio tempo”.
Intorno alla metà dell’Ottocento in Europa si va imponendo una nuova corrente artistica, forte di importantissimi sviluppi anche in letteratura, il realismo.
“Bisogna essere del proprio tempo”: ecco uno degli slogan più efficaci che connotano il nuovo atteggiamento realista nei confronti del mondo circostante.
Questo atteggiamento induce molti pittori ad abbandonare i temi mitologici o storici, in voga fra tardo Settecento e primo Ottocento, per volgersi verso soggetti nuovi e tanto attuali: “la sorte degli umili lavoratori delle città e dei campi, la vita quotidiana del ceto medio, la donna contemporanea (e in particolare la donna traviata), le ferrovie, l’industria, la città moderna coi suoi caffè e i suoi teatri, gli operai e i vagabondi, i parchi, i boulevard e la vita che in essi si svolge.
Fra tutti questi temi di vita contemporanea, quello che è sentito come la vera incarnazione dell’esperienza moderna e viene trattato con la massima concretezza e insistenza dagli artisti della metà dell’Ottocento, in Francia come in Inghilterra e nel resto dell’Europa, è il tema del lavoro”.
Così scrive la storica dell’arte Linda Nochlin nel suo bel volume sul Realismo nella pittura europea del 19. secolo (1971).
Essere del proprio tempo, guardare con occhi nuovi la realtà che si ha intorno.
E guardarla con sguardo vivo, penetrante, talora partecipe.
E’ ciò che fanno i pittori realisti e, nel migliore dei casi – per esempio Jean-François Millet (1814-1875), Angiolo Tommasi (1858-1923) e Claude Monet (1840-1926) -, i loro occhi sanno cogliere con una straordinaria profondità l’essenza dei più importanti fenomeni storici che hanno luogo intorno a loro.
Parole della storia
Azioni, Borse azionarie
Luoghi riservati alla vendita e all’acquisto di titoli pubblici o privati, fra cui le azioni, ovvero documenti di valore unitario specifico, con il cui acquisto un privato contribuisce al finanziamento di un’impresa, ricavandone un cambio di dividendi.
Il dividendo è la quota derivata dal profitto di una società e corrisposta all’azionista in misura dell’investimento da lui effettuato: grosso modo, se il profitto di una società è pari a 100 e un investitore ha contribuito agli investimenti per il 10%, il suo dividendo sul profitto sarà pari a 10.
Società per azioni
Sono imprese finanziate principalmente attraverso il sistema della collocazione delle azioni in Borsa.
I titolari delle azioni di una data società hanno il diritto di eleggere i membri del consiglio di amministrazione, disponendo di un numero di voti commisurato alla quantità e al valore delle azioni possedute.
I membri del consiglio hanno il compito di dirigere effettivamente l’azienda, ma possono anche eleggere l’amministratore delegato, soggetto cui vengono, per l’appunto, delegate le funzioni e i compiti del suddetto consiglio.
Bibliografia
Storia dell’emigrazione italiana / a cura di P. Bevilacqua … et al. – Donzelli, 2001
La dinamica del mutamento in agricoltura / D. Grigg. – Il Mulino, 1985
Il cambiamento tecnologico, 1750-1945 / J. Mokyr. – In: Storia d’Europa, vol. 5.: L’età contemporanea, secoli 19.-20 / a cura di P. Bairoch, E. J. Hobsbawm. – Einaudi, 1996
Cap. 19. Studiare, lavorare, comprare, amare
19.2 Sistemi educativi e strutture sociali: le scuole elementari
Tutte le trasformazioni demografiche ed economiche in atto promuovono mutamenti paralleli nelle strutture sociali.
Per alcuni gli anni che vanno dal 1870 al 1914 sono caratterizzati da peggioramenti netti delle condizioni di vita; per esempio in tutte le zone rurali la tensione tra braccianti e proprietari terrieri raggiunge l’apice proprio alla fine Ottocento e inizio Novecento, per motivi diversi da area ad area.
Nelle campagne dell’Europa occidentale a causa della crisi agraria diminuisce la domanda di forza lavoro; il mercato del lavoro viene parzialmente riequilibrato dai flussi migratori in uscita, ma non abbastanza da garantire la piena occupazione a tutti quelli che restano: alcuni braccianti o contadini conservano impieghi stabili, con retribuzioni che non diminuiscono; molti altri si ritrovano disoccupati: e tra costoro, quelli che non emigrano svolgono lavori saltuari, molto mal retribuiti.
Nelle campagne dell’Europa orientale (Austria-Ungheria, Polonia, Russia) risultati simili sono dati dall’intersecarsi di due fenomeni: l’aumento della popolazione nelle zone rurali e l’abolizione della servitù della gleba.
I regolamenti di abolizione della servitù (cioè dell’obbligo di restare legati a una particolare azienda agricola) prevedono anche forme di acquisto o di riscatto di appezzamenti terrieri, riservati alle famiglie ex serve.
Ben presto, tuttavia, appare chiaro che per molti ex servi i regolamenti per il riscatto delle terre sono troppo gravosi; molte famiglie contadine si trovano dunque costrette a offrirsi come manodopera bracciantile sul mercato del lavoro, in un momento in cui (anche a causa della crescita demografica) l’offerta tende a essere superiore alla domanda.
Anche in questo caso, seppure per ragioni diverse che nelle campagne occidentali, la soluzione che molti scelgono è l’emigrazione verso l’America, mentre chi resta deve comunque fronteggiare condizioni lavorative a livelli salariali estremamente miseri.
Le cose vanno meglio per la manodopera industriale, poiché, nonostante la “grande depressione” [cfr. cap. 18.4], la richiesta di operai resta piuttosto elevata.
Semmai, nelle città industriali, ciò che colpisce è la differenziazione interna tra gli operai, una parte dei quali sono assegnati a mansioni semplici e non specializzate, mentre altri – con una migliore preparazione tecnica – hanno mansioni più complesse e meglio retribuite.
Il punto da cogliere in questo processo è che la formazione di gruppi di operai più qualificati è possibile solo quando sia stato formato un sistema educativo in grado tanto di alfabetizzare gli scolari (cioè di insegnar loro a leggere e a scrivere) quanto di fornirli di un preliminare istruzione professionalizzante.
Ed è anche per assicurare un’adeguata preparazione ai futuri operai che i governi, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, si preoccupano di potenziare (e spesso persino di fondare ex novo) sistemi di istruzione pubblica che prevedono l’obbligatorietà della frequenza ai primi anni di scuola elementare.
Alla metà dell’Ottocento i sistemi educativi esistenti nei vari paesi hanno caratteristiche ed efficacia molto diversi.
Ci sono Stati come la Prussia che sin dal primo ottocento dispongono di un ottimo sistema educativo pubblico; ce ne sono altri, come la Francia, L’Olanda, il Belgio, la Gran Bretagna, che hanno una rete abbastanza buona di scuole primarie statali e private (queste ultime spesso gestite da enti religiosi); e infine ce ne sono altri ancora, come gli Stati italiani preunitari, che nel primo Ottocento hanno solo qualche approssimativa e non sistematica rete di scuole primarie private o pubbliche, cosicché il Regno d’Italia dopo la sua costituzione deve provvedere a edificare l’intero sistema educativo primario.
Naturalmente differenze di questo genere incidono molto sui livelli di alfabetizzazione, che effettivamente sono molto vari; su di essi, poi, influisce la pratica della lettura dei testi sacri, sollecitata dalle confessioni protestanti ed essenzialmente scoraggiata nei paesi cattolici; dovunque, infine, a prescindere dall’influenza del sistema educativo o delle pratiche religiose, sono i ragazzi a ricevere un’istruzione migliore e le ragazze a essere invece più trascurate.
Sebbene queste differenze restino vistose ancora nella seconda metà dell’Ottocento, ovunque i livelli di analfabetismo stanno scendendo.
Tra fine Ottocento e inizio Novecento un numero sempre maggiore di ragazzi e di ragazze impara a leggere e a scrivere.
Questo risultato è dovuto a una scelta comune a tutte le élite dirigenti che in Europa e negli Stati Uniti – quali che siano le loro convinzioni politiche o ideali – fondano un sistema scolastico nazionale basato sull’obbligatorietà dell’istruzione elementare.
Mentre si innalza l’età alla quale è obbligatorio andare alla scuola elementare, si innalza pure l’età minima prima della quale non è possibile essere assunti in una fabbrica, in un’azienda contadina o in una bottega.
Non si deve pensare che questo doppio movimento sia facile e immediato: esso infatti si scontra con le resistenze di tutti coloro (imprenditori o politici di orientamento conservatore) i quali ritengono che le classi popolari non abbiano bisogno di alcuna istruzione, né che ce ne sia bisogno per svolgere mansioni di lavoro semplici e ripetitive; e si scontra pure con le resistenze che vengono dalla varie Chiese, le quali non vogliono osteggiare l’istruzione elementare in quanto tale, ma vogliono difendere con determinazione le scuole private da loro gestite.
La prima resistenza viene vinta da due controargomentazioni.
Chi è favorevole a una scuola elementare statale e obbligatoria osserva che i giovani, e soprattutto quelli provenienti dalle classi povere, sono spesso sottoposti a brutali processi di sradicamento socio-territoriale dovuti a frequenti fenomeni migratori, un’esperienza che può avere effetti molto negativi sulla loro formazione e quindi sulla loro condotta: proprio per questo hanno bisogno di un’istruzione primaria obbligatoria, affinché trovino nella scuola un luogo nel quale apprendere gli insegnamenti etici fondamentali che quasi sicuramente non riescono a ricevere dai loro genitori.
Da questo punto di vista, quindi, le scuole elementari sono concepite come istituti di formazione morale e di disciplinamento.
Poi ci si rende conto che individui più istruiti – si apure solo a un livello elementare – possono essere lavoratori più efficienti, meglio in grado di imparare le nuove mansioni richieste dalla nuove macchine e dai nuovi modi di lavorazione.
Le resistenze delle Chiese è invece motivo di notevoli tensioni politiche, che appassionano e dividono profondamente le opinioni pubbliche nazionali [cfr. cap. 22].
Comunque, alla fine, in forme più o meno radicali, essenzialmente ovunque si impongono sistemi di istruzione elementare obbligatoria, regolati e finanziati dagli Stati sulla base del principio secondo cui la primaria formazione dei cittadini è un compito che solo le scuole pubbliche possono svolgere nel migliore dei modi.
Muovendo da queste premesse, dunque, nella seconda metà dell’Ottocento i maggiori Stati occidentali si dotano di norme che istituiscono e regolano l’istruzione elementare.
Nell’Impero austro-ungarico una delle del 1869 rende obbligatoria l’istruzione primaria fino all’età di quattordici anni e la sottopone al controllo delle comunità locali, distrettuali e provinciali.
Nel Regno Unito viene approvato nel 1870 l’Education Act, che istituisce le scuole elementari pubbliche, la cui frequenza ne 1876 diventa obbligatoria per i bambini fino ai dieci anni.
Nell’Impero tedesco una norma del 1872 riorganizza l’istruzione elementare pubblica, basandola anche qui sul principio dell’obbligatorietà, peraltro già previsto dalla precedenti normative prussiane.
In Francia tra il 1881 e il 1886 vengono approvate leggi che stabiliscono la gratuità, l’obbligatorietà e la laicità dell’istruzione elementare, a carico dello Stato.
In Italia la scuola elementare pubblica viene istituita sin dall’unificazione con la Legge Casati del 1859; una legge del 1877 ne rende obbligatoria la frequenza per i primi due anni, che diventano cinque con un’altra legge del 1904.
Negli Stati Uniti, infine, nella seconda metà dell’ottocento, la maggioranza degli Stati approva leggi che introducono l’istruzione elementare obbligatoria e stabiliscono le forme di finanziamento pubblico per la costruzione degli edifici e le retribuzioni degli insegnanti.
Parole della storia
Mobilità sociale
Il concetto indica l’intensità dei passaggi da una condizione sociale o professionale a un'altra, in una determinata società.
Può essere ascendente, quando si passa da una condizione sociale inferiore a una superiore; o discendente, quando si percorre il cammino inverso.
Il concetto – largamente usato negli studi sociologici e storico-sociali – può riferirsi a singoli individui (esaminando dunque le biografie individuali dal punto di vista della maggiore o minore riuscita sociale); ma può riferirsi anche a intere generazioni, comparando la condizione sociale prevalente dei genitori e dei figli.
La mobilità può essere reale, quando riguarda gli effettivi passaggi di condizione sociale, o percepita, quando si riferisce alle impressioni o alle aspettative di mobilità diffuse in una società.
Profitto
Il profitto di un’azienda industriale o commerciale è il denaro che essa ricava dalla vendita dei suoi prodotti o delle sue merci, diminuito dei salari (per operai e contadini) e degli stipendi (per impiegati e funzionari) pagati ai dipendenti, dei costi di mantenimento dei locali e delle fabbriche, dei costi di acquisto delle materie prime e delle merci, degli interessi pagati su eventuali prestiti.
In un’azienda gestita privatamente il profitto è il reddito che spetta all’imprenditore, per la sua attività di gestione dell’impresa; in una società per azioni il profitto è ciò che serve a retribuire gli investimenti degli azionisti.
Bibliografia
Il secolo dei consumi: dinamiche sociali nell’Europa del Novecento / S. Cavazza, E. Scarpellini (a cura di). – Carocci, 2006
La volontà di sapere / M. Foucault. – Feltrinelli, 2001
L’età degli imperi, 1875-1914 / E. J. Hobsbawm. – Laterza, 2007
In Europa tutti vanno a scuola / R. A. Houston. – In: Storia d’Europa, vol. 5.: L’età contemporanea / a cura di P. Bairoch, E. J. Hobsbawm. – Einaudi, 1996
Storia del pudore: la questione sessuale in Italia, 1860-1940 / B. P. F. Wanrooij. – Marsilio, 1990
Cap. 20. Il “Sole dell’avvenire”
20.1 Le origini del pensiero socialista
Nel corso dell’Ottocento l’esperienza sociale degli strati più umili delle popolazioni occidentali è stata attraversata da un’impressionante quantità di trasformazioni.
Un operaio specializzato della fine dell’Ottocento vive in luoghi e in contesti infinitamente diversi rispetto a quelli nei quali hanno vissuto i suoi avi, la maggior parte dei quali era costituita da contadini poverissimi e quali sempre analfabeti.
Costoro abitavano in campagna, isolati dai grandi flussi di traffico, soggiogati alle direttive dei proprietari terrieri e alle prediche dei preti o dei pastori locali; l’analfabetismo impediva loro di ampliare le proprie conoscenze.
Solo di tanto in tanto, quando le condizioni di vita sembravano intollerabilmente minacciate, si abbandonavano a ribellioni, di solito di portata locale, e sempre (o quasi sempre) sanguinosamente represse.
Alla fine dell’Ottocento il quadro è decisamente diverso.
Gli operai, in particolare quelli specializzati, hanno potuto frequentare qualche classe almeno della scuola elementare; hanno imparato a leggere e scrivere e sono in grado di farsi un’idea autonoma della loro collocazione sociale o delle loro possibili aspirazioni politiche.
Ma anche per gli operai che sono rimasti analfabeti si schiudono nuove possibilità: possono essere contattati da quelli che sanno leggere e scrivere e, attraverso ciò che costoro raccontano al pub o durante gli intervalli di lavoro, possono ampliare i loro orizzonti.
Spezzoni di nuove conoscenze, di nuovi pensieri, di nuove speranze arrivano anche a loro.
Nuovi pensieri e nuove speranze derivano, in forma magari semplificata, dai sistemi filosofici elaborati da numerosi intellettuali di estrazione nobiliare o borghese i quali dalla prima metà dell’Ottocento hanno cominciato a osservare con sguardo critico le trasformazioni sociali prodotte dall’industrializzazione.
Le origini di un pensiero antagonista alle condizioni sociali e politiche esistenti vanno rintracciate nell’elaborazione e nelle esperienze di una costellazione di uomini (e di qualche donna) che sin dall’inizio dell’Ottocento capiscono l’importanza delle novità introdotte dall’industrialismo, ne criticano gli effetti e propongono delle soluzioni.
Tra di essi spicca intento Claude-Henri de Saint-Simon (1760-1825), un aristocratico francese che negli anni Venti dell’Ottocento teorizza la nascita di una futura società dominata da produttori e da tecnici capaci di impiegare le innovazioni tecnologiche a beneficio dell’intera collettività sociale.
Molto più critica di quella di Saint-Simon è la posizione di Robert Owen (1771-1858), un industriale gallese che cerca di costruire a New Lanark, in Scozia, un’impresa modello nella quale edifica case per gli operai, mettendo in piedi anche scuole per i loro figli e luoghi di ritrovo e sociabilità collettiva per tutti i membri della comunità.
Questa iniziativa, però, come altre di cui si farà promotore negli Stati Uniti nei primi decenni dell’Ottocento, si rivela economicamente e socialmente fallimentare.
Non troppo dissimile da quella di Owen è la proposta di Charles Fourier (1772-1837): muovendo da una visione egualmente critica dello sviluppo industriale, anch’egli immagina che per evitarne i disastri possano essere costituite tante piccole comunità autosufficienti, che egli chiama i falansteri, internamente ordinate sulla base di principi egualitari; anche in questo caso, i tentativi di realizzare questi esperimenti non hanno alcun successo.
Molto più radicali le proposte di intellettuali e agitatori politici di una generazione successiva, come quelle di Etienne Cahet (1788-1856), il primo a usare la parola “comunismo” per descrivere la possibile società futura che deve nascere dal superamento delle contraddizioni e dei contrasti della società industriale, per dar vita a una dimensione sociale nella quale beni e strumenti di produzione siano posseduti e gestiti in modo comunitario.
Sullo stesso piano si pone anche Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), il quale nel saggio Che cos’è la proprietà?, pubblicato nel 1840, afferma che “la proprietà è un furto” e si fa sostenitore di iniziative politiche anarchiche, cioè favorevoli a una trasformazione che combatta ogni centro di potere e che porti alla costituzione di una società priva di Stato e perfettamente egualitaria, dove i lavoratori abbiano il possesso dei mezzi di produzione e si organizzino sulla base della cooperazione e dell’aiuto reciproco (il cosiddetto “mutualismo”).
Accanto a questi uomini, anche alcune donne si avvicinano ai gruppi saintsimoniani o a quelli costituiti dai seguaci di Owen.
Tra di esse un ruolo di spicco spetta a Flora Tristan (1803-1844), presenza attiva negli ambienti dell’opposizione politica e culturale francese: dopo una visita a Londra scrive dei resoconti appassionati sulle pessime condizioni della classe operaia inglese; oltre a ciò pone esplicitamente il problema della donna in una società giusta: “L’emancipazione dei lavoratori – scrive – è impossibile se le donne sono costrette a vivere una vita di degradazione”.
Per quanto temporaneamente o localmente influenti, le teorie di tutti questi pensatori non sono in grado di offrire un quadro chiaro e convincente, sul quale basare un’organica azione politica capace id attrarre stabilmente gli operai che un po’ ovunque vengono travolti dai progressi dell’industrializzazione.
E’ invece ciò che riescono a fare due pensatori tedeschi, che elaborano una dottrina che non solo fonda il moderno movimento operaio, ma influenza profondamente il pensiero e la vita politica europea e mondiale per i successivi centocinquant’anni.
Si tratta di Karl Marx (1818-1883) e di Friedrich Engels (1820-1895) [cfr. cap. 11.1].
Marx ed Engels devono la loro fama e il loro impatto sul movimento socialista (come su tutto il pensiero economico e sociale successivo) all’analisi delle modalità di funzionamento del sistema capitalistico e, in particolare, delle forme di produzione introdotte dalla rivoluzione industriale e dal macchinismo.
Tale analisi fonda quello che loro stessi chiamano “socialismo scientifico”, per differenziare la loro proposta da tutte le precedenti teorie definite “utopiste”, perché basate solo su principi umanitari e non su una seria e rigorosa analisi economico-politica.
Marx ed Engels presentano un primo disegno delle trasformazioni in corso e dei loro effetti nel Manifesto del Partito comunista, un piccolo libro pubblicato nel febbraio del 1848.
In forma più sistematica, già negli anni precedenti Engels aveva offerto un’impietosa descrizione della Situazione della classe operaia in Inghilterra, titolo di un suo libro pubblicato nel 1845; ma poi è soprattutto Marx che esplora in profondità le caratteristiche e i limiti del sistema di produzione industriale nel Capitale, una grande opera in tre volumi, di solo il primo viene pubblicato prima della morte dell’autore (nel 1867), mentre il secondo e il terzo sono pubblicati postumi, ne 1885 e nel 1895.
Nel Capitale, come in altre opere di minor respiro, tanto Marx quanto Engels sostengono che il sistema capitalistico – cioè il sistema economico nato dalla rivoluzione industriale – contiene in sé limiti e contraddizioni che lo spingono irrimediabilmente verso una crisi generale che ne provocherà la fine.
Innanzitutto tali limiti derivano dal rimodellamento della struttura della società, che tende a polarizzarsi nel terribile contrasto di interessi, che contrappone un numero sempre più grande di operai impoveriti (il proletariato) e un numero sempre più piccolo di imprenditori nelle mani dei quali si concentrano risorse e mezzi di produzione (la borghesia).
Tale contrasto di interessi provoca un vero e proprio conflitto sociale, che Marx ed Engels chiamano lotta di classe.
Questa evoluzione sociale rende più acuto un secondo grave limite del capitalismo, che si manifesta nelle crisi periodiche di sovrapproduzione: queste crisi sono dovute al sovrainvestimento di capitali nei settori che finiscono per offrire più merci di quante il mercato possa assorbirne.
Tale dinamica è determinata dalla trasformazione della struttura sociale, poiché la massa crescente di poveri proletari, che secondo Marx ed Engels è una caratteristica tipica della società capitalistica, non può comprare i beni che il sistema produttivo nato dalla rivoluzione industriale è tecnicamente in grado di produrre.
Sebbene tale analisi si riveli alla fine fallace, poiché il processo di drastica polarizzazione della società previsto da Marx ed Engels non ha luogo nei termini che essi immaginano, nell’immediato essa sembra avere una prima impressionante conferma con la discesa dei prezzi della “grande depressione” (1873-96) [cfr. cap. 18.4], da molti erroneamente interpretata proprio come una gravissima crisi di sovrapproduzione.
Sulla base di questa analisi Marx ed Engels formulano una chiarissima proposta politica.
Sostengono che, se il capitalismo ha già in sé gli elementi che lo porteranno alla sua ineluttabile crollo finale, compito di tutti coloro che aspirano alla costruzione di una società più giusta e più libera è il creare organizzazioni politiche capaci di diffondere visioni critiche del sistema socio-economico vigente e quindi di accelerare l’evoluzione della lotta di classe.
L’esasperazione del conflitto sociale avrà come esito una rivoluzione che porterà alla crisi conclusiva del capitalismo industriale e al suo superamento attraverso la formazione di una società nuova: è proprio questo il compito che dev’essere attribuito al movimento che nel Manifesto Marx ed Engels chiamano comunista.
La conclusione del Manifesto sottolinea uno degli aspetti più innovativi del pensiero di Marx ed Engels: proprio in netta contrapposizione con il fondamento nazionalista assunto dai movimenti politici borghesi (conservatori, liberali o democratici che siano), essi vogliono che il movimento dei proletari sia un movimento internazionalista, poiché tanto le leggi di funzionamento del sistema industriale quanto le sofferenze del proletariato sono le stesse in ogni luogo, senza che i confini statali o le differenze nazionali vi incidano molto.
Quindi, poiché i proletari sono tali in tutto il mondo, essi si devono unire contro i loro comuni nemici che sono i capitalisti e i potenti, a qualunque Stato-nazione essi appartengano.
Questa proposta internazionalista è presa sul serio sia da Marx ed Engels sia da molti altri individui che, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, qua e là in Europa hanno fondato organizzazioni operaie e sindacali.
La prima grande organizzazione del movimento operaio, che viene fondata a Londra nel 1864 con il decisivo contributo di Marx e di Engels, ha il caratteri di una federazione internazionale delle organizzazioni operaie e socialista: si tratta dell’Associazione internazionale dei lavoratori, meglio nota – successivamente – col nome di Prima Internazionale.
Bibliografia
Storia del pensiero socialista / G. D. H. Cole. – Laterza, 1968
Il PSI e la nascita del partito di massa, 1892-1922 / M. Ridolfi. – Laterza, 1992
Il socialdemocratici nella Germania imperiale / G. Roth. – Il Mulino, 1971
Storia del marxismo. – Einaudi, 1979
Cap. 21. Nazionalismo e razzismo
21.1 “Insegnare la nazione”
Masse di persone in movimento, geografico e sociale; relativamente più istruite; capaci di guardare al di là dei confini del loro quartiere o del loro villaggio (o, più spesso ancora, costrette a farlo); masse che vanno a vivere nelle caotiche vie delle grandi città europee o americane.
Alle spalle di queste masse c’è una lunga storia politica di rivolte e rivoluzioni; una lunga elaborazione filosofica intorno alla migliore difesa delle libertà e dei diritti; il sorgere del sistema rappresentativo; l’emergere di visioni radicalmente nuove del futuro politico e sociale, come quelle anarchiche e socialiste.
Le masse, fisicamente nobili e inquiete, lo sono anche politicamente: hanno bisogno di ottenere risposte.
Talora sono risposte incoraggianti, che aprono spazi alla loro partecipazione alla vita politica, o che prefigurano sistemi che ne aiutino le componenti più povere e più deboli a meglio inserirsi nella vita.
A volte sono risposte arcigne, volte a tenerle a bada, specie quando di masse prive di diritti e inclini alla protesta.
Nel complesso le soluzioni che puntano a una loro integrazione prevalgono, sebbene non escludano necessariamente le altre: e una di esse, una delle più importanti, è la “nazionalizzazione delle masse”.
Nell’Occidente di fine secolo il discorso nazionalista offre una base di legittimazione fondamentale per le élite politiche e sociali: essenziale per i sistemi politici europei tardottocenteschi è infatti l’idea secondo la quale la fonte primaria della legittimità politica sta nel popolo-nazione.
Perché tale principio sia operativo non è necessario il coinvolgimento attivo dell’intera comunità nazionale nei processi di decisione politica.
Ci sono infatti diversi Stati nei quali gran parte della popolazione non ha diritto al voto.
Ma anche in questi casi è in nome della collettività nazionale che le ristrette élite politiche dicono di agire; e su questa affermazione fondano il loro diritto all’esercizio del potere.
Tuttavia queste stesse élite, che si basano su tale dinamica di legittimazione, hanno l’assoluto bisogno di “insegnare la nazione” ad artigiani, operai, contadini e braccianti, persone che abitano in quartieri e in villaggi nei quali spesso l’alfabetizzazione sta appena iniziando a fare i primi passi.
Parlare a questi interlocutori di un’essenza piuttosto astratta come la nazione non è uno scherzo.
Molti di loro non sanno leggere e dunque non possono informarsi con i giornali o con i libri.
Molto hanno una notevole dose di diffidenza nei confronti di “quelli che comandano” e per questo sono più attratti dall’internazionalismo socialista che dal nazionalismo delle élite.
Ma proprio per questo le élite socio-politiche sanno che è assolutamente essenziale che la loro voce arrivi fino a queste masse distanti.
E’ una voce che le deve convincere di essere parte integrante di una compatta comunità nazionale; che in nome di questa comunità nazionale vengono prese tutte le decisioni; e che queste decisioni devono essere accettate da tutti, proprio perché prese per il bene e in nome di tutti.
In questo consiste la “nazionalizzazione delle masse”.
Ma come si fa ad attuarla?
Diciamo che “insegnare la nazione” ora è molto più semplice che durante la prima metà dell’Ottocento.
Allora il nazionalismo era un linguaggio politico eversivo, che incontrava l’opposizione delle istituzioni e delle polizie di molti Stati (per esempio dell’Austria, di alcuni degli Stati tedeschi, degli Stati italiani, dell’Impero tedesco, del Regno di Romania), ora che l’equilibrio internazionale non si basa più su una cieca opposizione alla formazione degli Stati-nazione, ora che un po’ ovunque le élite politiche hanno capito che il nazionalismo può essere una grande risorsa, la situazione è decisamente cambiata (anche se in alcune aree vi sono ancora movimenti nazionali considerati “eversivi”: Irlanda, Boemia, Croazia, Bosnia: cfr. cap. 25).
Per “insegnare la nazione” le è lite degli Stati-nazione possono far ricorso ai potenti strumenti istituzionali di cui dispongono.
Non si tratta più di far propaganda di nascosto, in taverne fumose, come poteva capitare negli anni Trenta o Quaranta ai militanti della Giovine Italia o della Giovine Europa: ora la propaganda nazionale può essere fatta attraverso i canali ufficiali, e alla luce del sole.
E gli strumenti a cui si può ricorrere sono soprattutto tre: la scuola, l’esercito e i rituali pubblici.
Parole della storia
Ghetto
Il termine indica un quartiere cittadino che – nelle città di epoca medievale e moderna – viene riservato agli ebrei.
Nel 1516 la concentrazione in un quartiere specifico diventa un obbligo per gli ebrei della Repubblica di Venezia; misura analoga viene presa nel 1555 da papa Paolo 4. per gli ebrei che vivono nei confini dello Stato pontificio.
Per estensione, il termine indica aree in cui – informalmente o formalmente – sono recluse persone che appartengono a uno specifico gruppo religioso o etnico.
Bibliografia
Il sionismo / I. Greilsammer. – Il Mulino, 2007
Il razzismo in Europa dalle origini all’olocausto / G. L. Mosse. – Laterza, 2008
Una patria per gli italiani: spazi, itinerari, monumenti nell’Italia unitaria, 1870-1900 / B. Tobia. – Laterza, 1998
Da contadini a francesi: la modernizzazione della Francia rurale, 1870-1914 / E. Weber. – Il Mulino, 1989
Cap. 22. La politica in Occidente
22.1 Caratteri generali
La nazionalizzazione delle masse offre uno strumento importante di integrazione socio-politica.
Ma v’è bisogno anche di risposte più materiali, che diano valore concreto al senso di appartenenza a una comunità nazionale.
Queste risposte sono di vario tipo.
La prima, e la più comune, consiste nell’ampliamento dei confini del sistema politico, con l’estensione del diritto di voto; una qualche forma di democratizzazione sembra a molti un’ineluttabile necessità: affinché le istituzioni riscuotano un largo consenso, bisogna che esse siano (o sembrino), almeno in qualche misura, espressione della volontà delle masse popolari.
Considerazioni di questo genere sono sostenute sia dai liberal-conservatori sia da liberal-democratici.
Tra i primi un posto di rilievo hanno Benjamin Disraeli, il dirigente conservatore inglese, promotore nel 1867 di una riforma elettorale che amplia il corpo elettorale britannico portandolo dal 4% all’8% del totale della popolazione [cfr. cap. 13.6], e Otto von Bismarck, il cancelliere dell’Impero tedesco [cfr. cap. 15.2], il quale è tra i più decisi sostenitori del suffragio universale maschile, nella convinzione che gli operai delle città possono farsi attrarre dalle sirene del socialismo, le masse contadine voteranno compattamente per il loro capi “naturali” – i nobili, i proprietari terrieri, le élite -, dando in tal modo solidità e stabilità al sistema socio-politico.
Tra i secondi gode di un notevole prestigio il filosofo inglese John Stuart Mill (1806-1873), autore di opere influenti come Sulla libertà (1859) o Considerazioni sul governo rappresentativo (1861), nelle quali propone una visione che unisce aspetti fondamentali del pensiero liberale e di quello democratico : pur ritenendo la libertà individuale un valore essenziale da proteggere contro ogni minaccia (compresa quella esercitata dalla “tirannia di una maggioranza” che non voglia rispettare il diritto delle minoranze), Mill è tuttavia a favore dell’ampliamento del diritto di voto alle classi meno abbienti e alle donne e dell’intervento dello Stato nel correggere quelle dinamiche economiche che producano ingiustizie e felicità.
Dal punto di vista politico, ancor più prestigiosa è la figura di William Gladstone [cfr. cap. 13.6], guida dei liberali britannici fino al 1893 e autore di una significativa politica di riforme.
In apparenza la prospettiva liberal-conservatrice e quella liberal-democratica sembrano divergere nettamente.
Ma alla prova dei fatti ciò non accade.
Tutti i capi politici del liberalismo europeo – siano di orientamento conservatore, siano di simpatie democratiche – quando si fanno sostenitori di riforme che aprono i confini del politico, lo fanno soprattutto perché sono mossi da motivazioni di carattere difensivo: evitare che le masse, respinte dalla chiusura dei sistemi politici vigenti, finiscano per seguire le ideologie e le pratiche eversive degli anarchici o dei socialisti,
Da tutto questo processo di ampliamento degli spazi del politico restano comunque escluse le donne.
Gli argomenti addotti sono quelli tradizionali: esse sono considerate inadatte psicologicamente, dipendenti da figure maschili all’interno della famiglia e quindi da loro troppo influenzabili; e poi, si dice, sono completamente assorbite dai compiti della maternità e delle cure domestiche per poter seguire le vicende della politica con attenzione adeguata [cfr. cap. 12.2].
Per questo, secondo l’opinione che domina tra i politici e gli intellettuali (maschi), esse devono restar fuori dalla vita pubblica.
Tuttavia, anche da questo punto di vista, le cose stanno cambiando.
Da un lato qualche non marginale voce maschile si alza per chiedere l’estensione del suffragio alle donne: importante è il saggio La servitù delle donne, pubblicato nel 1869 da John Stuart Mill, che peraltro attribuisce alla moglie, Harriet Hardy Taylor Mill (1807-1858), il merito di avergli aperto gli occhi sull’argomento.
Dall’altro, ed è il fenomeno di gran lunga più importante, sono le donne stesse a dotarsi di organizzazioni che lottano per la loro emancipazione, sia politica sia civile.
Se movimenti femminili nascono un po’ ovunque in Occidente, i meglio organizzati e più combattivi sono quelli che si formano nei paesi protestanti.
Sebbene le confessioni protestanti non contengano, nelle loro formulazioni dottrinali originarie, particolari aperture alle donne, pure l’idea dell’eguaglianza spirituale e del sacerdozio universale dei credenti, così come la pratica della lettura della Bibbia, sono aspetti che un certo numero di donne interpreta come un incoraggiamento all’indipendenza intellettuale e sociale.
Capita che pure in alcune confessioni protestanti minori (per esempio i quaccheri) l’uguaglianza tra uomini e donne sia esplicitamente riconosciuta.
E’ da questo retroterra culturale che nascono le prime iniziative per la costituzione di scuole femminili o per l’ammissione di ragazze nelle scuole elementari e superiori [cfr. cap. 19.3].
L’impatto dell’istruzione sulle donne è molto ben descritto da Christine Frederiksen, una perspicace insegnante danese, che nel 1884 scrive: “Fu dalle donne istruite delle classi medie che partì la richiesta di un’istruzione migliore e di una migliore retribuzione del lavoro femminile.
Si è pensato che il movimento sarebbe rimasto entro questi limiti.
Ma le donne sono esseri umani: date loro un’istruzione e una competenza e si dovrà dare loro tutto il resto”.
Quando questo bagaglio culturale (formazione protestante e migliore istruzione) s’intreccia con la riflessione sui diritti sviluppatasi in Europa e in Nord America tra Sette e Ottocento, le idee di indipendenza intellettuale e sociale si trasformano nel desiderio di avere “tutto il resto”, cioè di ottenere una piena eguaglianza civile e politica.
E’ soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che si sviluppano o più significativi movimenti suffragisti, attraverso i quali le militanti (le suffragiste) chiedono che il diritto di voto (“suffragio”) sia esteso anche alle donne.
Non è un caso: quelli sono i paesi che possiedono da più lungo tempo istituzioni rappresentative, rispettate e prestigiose; perciò per le suffragiste statunitensi e britanniche il diritto di voto ha un’importanza particolare, diversamente da altri paesi nei quali l’istituzione parlamentare è più recente o addirittura non esiste affatto.
Nel continente europeo il percorso dei movimenti femminili è diverso.
Le prime significative presenze femminili sulla scena pubblica si hanno in concomitanza con i primi tentativi rivoluzionari, in particolare nel corso delle rivoluzioni del 1848-49.
Poi, nei decenni seguenti, anche nell’Europa continentale si fondano organizzazioni votate all’emancipazione civile e politica delle donne.
Tuttavia del movimento femminile continentale vanno sottolineate due peculiarità.
Una riguarda in particolare i paesi cattolici, dove il movimento femminile è di solito meno dinamico che altrove: la tradizione cattolica, che lascia spazio all’azione femminile nelle organizzazioni caritative laiche, o negli ordini conventuali femminili, non offre però alcun elemento che induca a mettere in discussione la gerarchia dei generi.
E così le organizzazioni femminili (tra le quali ve ne sono alcune di orientamento esplicitamente cattolico) hanno un carattere assai meno radicale, mentre l’opinione pubblica in senso più lato mostra una sensibilità molto ridotta per la questione dell’emancipazione femminile.
L’altra peculiarità riguarda più in generale una divisione interna ai movimenti femminili continentali, derivata dall’esistenza di un importante movimento socialista.
Da un lato, infatti, vengono fondate associazioni favorevoli al voto delle donne e alla parità dei diritti dirette e sostenute soprattutto da donne borghesi di orientamento politico liberale o moderato, simili a quelle che si formano negli Stati Uniti o in Gran Bretagna.
Dall’altro, all’interno dei movimenti e dei partiti socialisti, che all’epoca si vanno costituendo, si formano nuclei associativi femminili, talora piuttosto grandi (il Partito socialdemocratico tedesco nel 1914 ha 175000 iscritte), che però non vogliono avere alcun contatto con le associazioni femminili borghesi.
Sulla questione dell’estensione del diritto di voto alle donne i movimenti femminili interni ai partiti socialisti sono molto cauti.
Ciò dipende dall’esplicita diffidenza che la maggior parte dei capi e dei militanti del socialismo europeo manifesta davanti all’ipotesi del voto alle donne.
Le ragioni addotte sono varie:
a) nei paesi cattolici i socialisti temono che le donne votino in grande maggioranza per i partito cattolici o comunque per quelli conservatori.
b) là dove gli uomini non hanno ancora conquistato il suffragio, i socialisti ritengono che sia questa la priorità assoluta e che il voto alle donne si auna faccenda marginale, o comunque da posporre alla conquista del suffragio universale maschile;
c) Infine tutti i partiti socialisti adottano la teoria elaborata da August Babel (nella Donna nel socialismo, 1879) e da Friedrich Engels (nell’Origine della famiglia, della proprietà e dello Stato, 1884), secondo cui la disuguaglianza tra uomini e donne è frutto della logica organizzativa del capitalismo che, mentre attribuisce agli uomini i compiti “produttivi”, riserva alle donne i soli compiti “riproduttivi”; così stando le cose, sarà solo dopo la rivoluzione socialista e dopo la distruzione della struttura economica capitalistica che potrà essere attuata una vera e profonda eguaglianza tra i sessi.
Qualunque sia il peso o la ragionevolezza di queste argomentazioni, è piuttosto chiaro che, anche quando vengono accettate dalle stesse militanti, esse tradiscono il notevole gradi di maschilismo che domina all’interno dei partiti socialisti, confermato dal fatto che solo rarissimamente le donne hanno qualche incarico di responsabilità negli organismi direttivi dei partiti socialisti europei.
D’altronde, la maggior parte delle stesse militanti socialiste accetta la teoria dell’”uguaglianza dopo la rivoluzione”: cosicché, mentre ritengono assolutamente prioritario l’impegno politico e sindacale in vista della rivoluzione, giudicano anche del tutto inutile la lotta per la parità civile e politica condotta dalle suffragiste borghesi; da qui l’incomunicabilità tra le due componenti del movimento.
Queste particolarità (peso della tradizione cattolica; e poi, un po’ ovunque, divisione tra componente borghese e componente socialista) spiegano come mai nell’Europa continentale il movimento delle donne sia meno attivo e visibile di quelli statunitense e britannico.
Tuttavia è un movimento che esiste e che all’inizio del Novecento ha assunto forme piuttosto ben strutturate: per la prima volta nella storia dell’Occidente un numero non trascurabile di donne ha deciso di “andare alla riscossa”, chiedendo istruzione, rispetto e accesso allo spazio del politico.
Si tratta di una straordinaria novità, pure se bisogna riconoscere che – nell’immediato – i risultato sono piuttosto deludenti: il voto femminile viene introdotto solo in realtà particolari e relativamente marginali (Australia, 1903; Finlandia, 1906; Norvegia, 1913) o solo in alcuni degli Stati degli Stati Uniti.
Per il resto, non solo le donne non hanno il diritto di voto, ma le legislazioni civili sono tuttora basate sul principio dell’asimmetria tra i sessi, mentre il libero accesso all’istruzione e alle professioni è ancora pieno di ostacoli.
Insomma: la questione femminile è stata coraggiosamente posta, ma per il momento resta del tutto irrisolta.
Se le donne non sono toccate dal processo di democratizzazione, i maschi adulti ne beneficiano un po’ ovunque.
All’inizio del Novecento il suffragio universale maschile esiste negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Spagna, in Austria; mentre forme di suffragio allargato (sempre e solo per i maschi adulti) sono state introdotte in Gran Bretagna e in Italia.
Anche se le donne ne sono escluse, questo è comunque un grande cambiamento.
Tuttavia concedere il voto a tutti i maschi adulti può non essere sufficiente ad avvicinarli alle istituzioni, quando questi sono contadini malnutriti od operai distrutti da giornate di lavoro lunghe e pesanti.
Perciò è necessario pensare ad altre dorme di intervento, non meno innovative del suffragio universale: politiche sociali che portino alla legalizzazione dei sindacati e degli scioperi, che migliorino le condizioni di lavoro, che costruiscano i primi sistemi previdenziali e assistenziali [vedi parole della storia]; o che proteggano lavoratori e consumatori dallo strapotere delle grandi aziende industriali.
Talora, peraltro, la “carota” della riforma sociale si accompagna al “bastone” del controllo e della repressione, specie contro i movimenti politici antisistema; e allora gli eserciti o le polizie scatenano azioni pesanti che, non di rado, costano decine, qualche volta anche centinaia, di morti.
Segno che il processo di integrazione non è per niente facile, per niente a portata di mano.
Tanto la costituzione di sistemi assistenziali e previdenziali quanto l’organizzazione di sistemi educativi elementari, controllati dallo Stato, in larga misura costituiscono le attività educative e benefiche svolte in precedenza, in forma quasi esclusiva, dalle Chiese.
Il processo non è indolore, soprattutto nei paesi cattolici, poiché la Chiesa cattolica, che mantiene una gelosa indipendenza dalla istituzioni statali che altre confessioni religiose invece non hanno, oppone una rigorosa resistenza nei confronti della laicizzazione degli Stati.
Le tensioni, peraltro, sono acuite dal generale irrigidimento delle posizioni dottrinali e politiche che papa Pio 9. (1846-78) ha assunto in conseguenza del processo di formazione del Regno d’Italia e della fine del suo potere temporale sullo Stato della Chiesa.
Tale irrigidimento si è manifestato soprattutto attraverso l’enciclica Quanta cura, del 1864, che contiene il Sillabo degli errori del nostro tempo (un elenco puntiglioso ne quale, fra le altre cose, si condannano il liberalismo, il socialismo, l’ateismo, il razionalismo), e il Concilio Vaticano, che vede la proclamazione dell’infallibilità del pontefice (1870).
Dopo la morte di Pio 9. (1878) la situazione sostanzialmente non cambia, anche se dal nuovo pontefice, Leone 13. (1878-1903), i cattolici ricevono indirizzi di azione profondamente innovativi.
Le novità non riguardano tanto le questioni dottrinali quanto il modo di avvicinarsi ai problemi sociali, un tema sul quale Leone 13. prende posizione nel 1891 con l’enciclica Rerum novarum.
In essa il papa, confermando la condanna del socialismo, riconosce tuttavia la necessità che gli imprenditori non trattino gli operai come una pura e semplice merce; afferma il dovere che gli imprenditori hanno di pagare un giusto salario; insiste pure sul dovere degli operai, trai quali egli annovera la laboriosità, la frugalità, il rispetto per l’ordine sociale.
Quando siano basate su questi principi e sul rispetto dei valori cristiani, aggiunge il papa, possono essere costituite associazioni operaie e artigiane, un’affermazione che dà legittimità alle società mutualistiche cattoliche già formatesi in vari paesi europei.
Gli orientamenti esposti nell’enciclica sollecitano lo sviluppo di una corrente intellettuale e politica definita democrazia cristiana; tra i teorici di maggior rilievo vi è Giuseppe Toniolo (1845-1918), un economista che elabora una teoria socio-economica di taglio corporativo, cioè fondata sull’idea di un’equa relazione e collaborazione tra i lavoratori e i datori di lavoro come presupposto per uno sviluppo economico dinamico ma privo di fratture e di conflitti sociali.
In parallelo a questi sviluppi alla fine dell’Ottocento si diffonde un orientamento teologico che viene chiamato modernismo, perché i suoi promotori auspicano che il corpus dottrinale cattolico trovi occasioni di rinnovamento da un più intenso contatto con i più recenti sviluppi scientifici e filosofici e da un’utilizzazione sistematica del metodo filologico e storico per giungere a una più aggiornata interpretazione dei testi sacri (nella quale si distingue particolarmente Alfred Loisy, 1857-1940, un teologo francese che applica questa metodologia in un suo libro del 1902, Il Vangelo e la Chiesa).
Le due tendenze non trovano opposizione durante il pontificato di Leone 13.
Viceversa alla morte di Leone 13. (1903) il pontefice che gli succede, Pio 10. (1903-14), si manifesta un atteggiamento di netta chiusura, soprattutto nei confronti del modernismo; e così, a difesa della tradizione dogmatica, Pio 10. nel 1907 emette una scomunica nei confronti dei sostenitori delle teorie moderniste, che effettivamente blocca l’ulteriore diffusione della corrente.
Questi sviluppi del movimento cattolico non necessariamente migliorano i rapporti con i governi sostenuti da maggioranze liberal-conservatrici (come in Germania o in Austria) o repubblicano-radicali (come in Francia): lì, come altrove in Occidente (per esempio in Italia [cfr. cap. 23.2], un potente processo di laicizzazione delle istituzioni statali sta rimodellando aspetti cruciali della vita pubblica.
Le politiche religiose messe in atto da tutti gli Stati occidentali tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento completano un ciclo plurisecolare, avviato sin dal 18. secolo dagli assolutismi monarchici.
L’essenza di tale ciclo sta nel trasferimento di numerose funzioni amministrative o educative dalle istituzioni ecclesiastiche a quelle statali e, di conseguenza, nella netta separazione tra la sfera statale e quella religiosa a cui restano (o dovrebbero restare, nelle intenzioni dei promotori di queste politiche) le sole funzioni spirituali.
Ciò che non deve sfuggire, è che questo processo non comporta affatto una desacralizzazione del politico, ma un mutamento nelle modalità di sacralizzazione del politico.
Adesso le istituzioni degli Stati, soprattutto attraverso il ricorso all’ideologia nazionale, sono in grado, anche senza la mediazione degli ecclesiastici, di presentare i fenomeni politici, e la comunità di riferimento, la nazione, come qualcosa di quasi religioso, o meglio di sacro: e ciò perché il discorso nazionale incorpora una mistica del sacrificio (alla lettera, “ciò che fa sacro”), che si esprime nella celebrazione della morte di coloro che combattono per la nazione o di coloro che comunque hanno compiuto grandi opere a beneficio della nazione.
Per questa ragione, questi decenni vedono non solo la proliferazione delle statue dei grandi (la stauomania [cfr. cap. 21.3]) ma anche la edificazione, o il completamento, o la valorizzazione di costruzioni riservate al culto della nuova religione nazional-patriottica; si tratta di edifici come il Panthéon di Parigi, definitivamente destinato a svolgere la funzione di tempio laico nel 1885; o il Niederwalddenkmal, grande monumento nazionale tedesco edificato nei pressi di Rüdesheim, sul Reno, ed inaugurato nel 1883; o il Pantheon di Roma, destinato nel 1878 ad accogliere la salma di re Vittorio Emanuele 2.
Talvolta non ci si limita a riadattare o costruire singoli edifici, ma si realizzano interi complessi monumentali, come il National Mall a Washington, portato a compimento tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
In quanto destinati ad accogliere le spoglie dei padri della patria e i simboli del passato nazionale nella cornice di liturgie e di rituali parareligiosi, questi edifici vengono coronati da una sorta di aura sacrale.
E’ così che larghe sezioni delle opinioni pubbliche cominciano a vederli come nuove chiese di una inedita religione politica; e il fatto che alcuni di questi edifici siano stati delle chiese (come il Panthéon di Parigi) o lo siano ancora (come il Pantheon di Roma, o l’Abbazia di Westminster, a Londra, che ha una simile funzione di sacrario nazionale) non fa che potenziare l’effetto.
Ciascuno di questi processi (democratizzazione, laicizzazione, integrazione della masse, sacralizzazione del politico) si sviluppa in modo diverso nei singoli paesi, che esamineremo muovendoci da Occidente verso Oriente, cominciando con “l’Estremo Occidente” degli Stati Uniti.
La sequenza geografica ci aiuterà a distinguere i vari sistemi politici tra di loro: infatti, sebbene in tutto l’Occidente la formazione della società di massa produca gravi tensioni e profondi conflitti, in alcuni contesti l’adattamento delle istituzioni e delle pratiche politiche alle nuove condizioni è assai migliore che in altri.
22.9. Una tipologia dei sistemi politici nella società di massa
Se ripercorriamo sinteticamente le vicende che abbiamo appena esaminato se ne può ricavare una generale tipologia dei sistemi politici, classificati in base alle loro maggiori o minori capacità di adattamento alle nuove condizioni create dal formarsi della società di massa:
a) i sistemi politici statunitense e inglese hanno élite dirigenti che si mostrano in grado di innovare profondamente le regole del gioco politico e – al tempo stesso – di trovare soluzioni per integrare efficacemente le masse operaie, dotate peraltro di forme organizzative politicamente assai moderate [cfr. cap. 20.5].
Ciò non significa che non ci siano prezzi da pagare.
Essi, però, si scaricano prevalentemente su ambiti socialmente o geograficamente marginali: negli Stati Uniti i neri e gli indiani sono esclusi dal gioco politico; nel Regno Unito sono gli irlandesi a vedere sistematicamente deluse le loro aspirazioni a una qualche forma di autonomia.
In modo solo apparentemente paradossale questi processi di marginalizzazione contribuiscono a rinsaldare il senso di appartenenza a coese comunità nazionale formate in un caso dai bianchi americani e nell’altro dagli inglesi e dagli scozzesi di confessione protestante.
b) In Francia e in Germania le importanti innovazioni politiche e istituzionali che vengono attuate non assicurano una piena e tranquilla integrazione e armonizzazione dei numerosi gruppi politici esistenti, i quali spesso hanno visioni e progetti molto distanti tra loro.
Tuttavia, anche in questo caso, efficaci processi di “nazionalizzazione delle masse” conferiscono una certa stabilità ai sistemi politici
c) a Est, infine, due Imperi dell’Europa centro-orientale sono in gravissima difficoltà: le élite austro-ungariche si trovano a dover fronteggiare, contemporaneamente, le proteste delle minoranza nazionali e la formazione di partiti politici antisistema: in Russia, l’irrigidimento cieco del governo zarista, conseguenza dell’uccisione dello zar Alessandro 3. (1881), porta il sistema politico a un punto di rottura, la cui soglia viene superata con lo scoppio della rivoluzione del 1905.
Nonostante la loro vastità e il loro peso politico e diplomatico, i due Imperi sono le formazioni politiche più fragili del mondo occidentale.
Parole della storia
Sistemi previdenziali e assistenziali
Insieme di norme che organizzano forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di assistenza in caso di malattia, o che fondano istituti che si occupano di pagare le pensioni di anzianità, ovvero quelle retribuzioni corrisposte ai lavoratori anche dopo la conclusione della loro attività lavorativa.
Tali sistemi possono essere regolati in modi molto vari: possono essere finanziati con contributi volontari od obbligatori: ci sono alcuni Stati che impongono obbligatoriamente ai lavoratori di aderire a un sistema assicurativo o pensionistico e altri che lasciano la decisione a discrezione degli interessati.
La riserva finanziaria necessaria a far fronte alle spese mediche per infortunio o malattia, o alle spese necessarie per pagare le pensioni di anzianità, viene realizzata con quote pagate – a cadenze temporali regolari – dai lavoratori e dai datori di lavoro; in alcuni casi anche gli Stati intervengono con un sostegno finanziario diretto.
Infine i sistemi assicurativi e pensionistici possono essere affidati ad aziende assicurative provate o possono essere gestiti direttamente dallo Stato.
Bibliografia
L’origine dei partiti nell’Europa contemporanea, 1870-1914 / M. Brigaglia (a cura di). – Il Mulino, 1985
La trasformazione politica nell’Europa liberale, 1870-1890 / P. Pombeni (a cura di). – Il Mulino, 1986
Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea, 1830-1968 / P. Pombeni. – Il Mulino, 1994
La libertà delle donne: voci della tradizione politica suffragista / a. Rossi Doria. – Rosenberg & Sellier, 1990
Trionfo e declino dei partiti politici negli Stati Uniti, 1860-1930 / A. Testi. – Otto, 2000
Cap. 23. La politica in Italia da Depretis a Giolitti
23.1. La Sinistra al potere
All’altezza del 1870 uno degli aspetti che più ha alimentato il conflitto politico in alcuni dei maggiori paesi europei è già stato affrontato con coraggio all’interno del Regno d’Italia: il processo di laicizzazione delle istituzioni, avviato da Cavour nel Regno di Sardegna [cfr. cap. 14.6], è proseguito con l’azione politica dei governi della Destra storica ed è culminato, in un modo clamoroso, con l’annessione nel 1870 di ciò che restava dello Stato pontificio.
Ciò ha comportato una rottura diplomatica e politica piuttosto grave con il pontefice, Pio 9., e con quella parte dell’opinione pubblica cattolica che ha deciso di seguirne le indicazioni politiche [cfr. cap. 14.7].
Il mondo cattolico intransigente, cioè fedele alle direttive di Pio 9. (e poi di Leone 13.), si organizza attraverso un’associazione politica nazionale, l’Opera dei Congressi, fondata nel 1874.
A fianco dell’Opera fioriscono innumerevoli altre iniziative (associazioni giovanili, femminili, ricreative, sindacali, organi di stampa, case editrici) e dipendono dall’approvazione del pontefice.
Il tratto politicamente qualificante di tutta questa galassia sta nella decisione di non partecipare alle elezioni politiche come segno di disconoscimento del Regno d’Italia.
Tale linea è ufficialmente incoraggiata dal Vaticano, che sin dal 1874, rispondendo a un interrogativo di esponenti cattolici sull’opportunità di partecipare alle politiche, ha risposto: “non expedit”, cioè “non è opportuno”.
Se i cattolici intransigenti non partecipano alle politiche, partecipano invece sistematicamente alle elezioni amministrative per l’elezione dei consiglieri comunali e provinciali, assicurandosi così un ottimo radicamento politico sul territorio (che in alcune aree come il Veneto, zone della Lombardia o Lucca, in Toscana, è particolarmente solido).
La scelta dei cattolici intransigenti (replicata, per opposte ragioni, da tutti coloro i quali restano fedeli agli ideali mazziniani e repubblicani) spiega l’alto livello di astensionismo che caratterizza le competizioni elettorali di questi anni.
Spiega anche l’indisturbato dominio liberale nella scena politica nazionale, ove, tuttavia, sin dai primi anni Settanta, qualcosa di importante sta avvenendo.
Capita, cioè, che una sezione dello schieramento liberale, fin allora all’opposizione, punti con decisione sempre maggiore a sostituire la Destra storica al governo del paese: questa nuova forza è costituita dal quella varia costellazione di uomini politici sommariamente raccolti sotto l’etichetta di Sinistra (una Sinistra liberale, beninteso).
Questi uomini, come si è detto [cfr. cap. 14.6], pur non costituendo un partito politico strutturato, sono tuttavia accomunati dal percorso biografico che hanno alle spalle e dagli obiettivi politici che si propongono di raggiungere: tra di essi spiccano i nomi di Agostino Depretis, Francesco Crispi, Benedetto Cairoli e Giovanni Nicotera.
Le biografie politiche di uomini come Depretis, Crispi, Cairoli o Nicotera sono importanti: tutti sono stati, in gioventù, convinti repubblicani e qualcuno di loro ha partecipato, più di una volta, a congiure o iniziative militari organizzate da Mazzini o da Garibaldi.
Al momento dell’unificazione, però, hanno deciso di sacrificare i loro ideali repubblicani in nome dell’indipendenza della nazione italiana unita sotto il re Vittorio Emanuele 2.; come ha dichiarato molto esplicitamente Francesco Crispi nel 1864, “la monarchia ci unisce, la repubblica divide”, per dire che continuare sulla strada della militanza repubblicana significherebbe soltanto indebolire le ragioni dell’unità nazionale.
Compiuta la scelta di accettare la monarchia, ne accolgono tutte le conseguenze: partecipano alle elezioni, quando sono eletti deputati pronunciano il giuramento di fedeltà allo Statuto e quindi alla monarchia costituzionale, manifestano il massimo rispetto per le istituzioni e per i simboli che esprimono la realtà del nuovo Stato-nazione.
Tuttavia non dimenticano completamente le loro passate convinzioni: molto più degli esponenti della Destra storica, arroccati su un aristocratico distacco dalle classi medie e popolari, gli esponenti della Sinistra hanno la piena consapevolezza della necessità di “fare gli italiani”.
Sanno, cioè, che è indispensabile trasmettere alle masse la coscienza di appartenere alla comunità nazionale per la quale sono state combattute le battaglie del Risorgimento, se possibile aprendo anche gli spazi del politico assai di più di quanto non sia stato fatto fin allora. [cfr. cap. 14.7]
L’occasione per attuare questo programma arriva nel 1876.
Già nelle elezioni del 1874 gli esponenti della Sinistra hanno ottenuto un buon successo, soprattutto nell’Italia meridionale; l’insoddisfazione degli elettori meridionali è dovuta soprattutto a quella che a molti è sembrata un’eccessiva “piemontesizzazione” della vita pubblica (con nomine di persone che vengono dal vecchio Regno di Sardegna, o in generale dalle regioni settentrionali, ai posti di prefetti, di funzionari e di burocrati negli uffici pubblici delle province meridionali).
Fondata o meno che sia questa insoddisfazione, essa ha portato comunque a un’affermazione della Sinistra nei collegi elettorali meridionali, che però non le ha dato una maggioranza alla Camera dei Deputati.
Ciononostante, nel 1876, una crisi interna alla Destra storica determina un rovesciamento delle alleanze politiche che permette a Depretis di costituire un governo della Sinistra.
I contemporanei parlano di rivoluzione parlamentare, rase un po’ roboante per descrivere un semplice cambio di maggioranza.
Oltre Tutto le modalità attraverso le quali matura il cambiamento non sono particolarmente “rivoluzionarie”.
La crisi del 1876 nasce da un problema relativo alla gestione della rete ferroviaria.
Le ferrovie, negli anni precedenti, sono state costruite e gestite da aziende private, con cospicui aiuti finanziari e normativi concessi dallo Stato.
Adesso Silvio Spaventa (1822-1893), ministro dei Lavori pubblici del governo di Destra, guidato da Marco Minghetti (1818-1886), ritiene sia giunto il momento di nazionalizzare le linee ferroviarie (cioè fare in modo che lo Stato ne acquisisca la proprietà e la gestione, sostituendo le società private).
Contro il progetto di schiera la sinistra, adducendo argomentazioni di carattere liberista (lo Stato non deve interferire con le forze del mercato); ma soprattutto accade che un cospicuo gruppo di parlamentari della Destra toscana, che ha interessi diretti nelle aziende private che gestiscono le ferrovie e teme di subire danno dall’eventuale approvazione del progetto del ministro Spaventa, per questa ragione si sganci dalla maggioranza e si unisca all’opposizione di Sinistra.
Possiamo dire che è un caso di conflitto di interessi [vedi parole della storia] a determinare la cosiddetta “rivoluzione parlamentare”.
A ogni modo tanto basta per cambiare l’intero quadro politico.
Questo mutamento, comunque, è reso meno traumatico dalle aperture che il nuovo presidente del Consiglio, Depretis, concede sin da subito ai rappresentanti della Destra, perché non si irrigidiscono in una opposizione pura e dura al nuovo governo di Sinistra da lui presieduto.
La sua parola d’ordine è quella della “trasformazione dei partiti”, una frase che egli inserisce nel discorso pronunciato l8 ottobre 1876 a Stradella, una cittadina in provincia di Pavia che è il suo collegio elettorale.
E’ un modo estremamente conciliante di accompagnare il cambio di maggioranza: di fatto con queste parole Depretis invita gli esponenti della Destra ad avvicinarsi alla maggioranza di Sinistra e a sostenerla, in nome di una rinnovata concordia nazionale; cosa che, già subito dopo il 1876, almeno in una certa misura, comincia a capitare.
Intanto, negli anni immediatamente seguenti, l’azione politica dei governi di Sinistra si qualifica per due riforme molto importanti e collegate tra loro.
La prima, proposta dal ministro dell’Istruzione Michele Coppino (1822-1901), viene approvata nel 1877 e riguarda l’istruzione elementare: porta l’obbligo della frequenza scolastica a nove anni d’età e determina le punizioni da comminare ai genitori che si rifiutino di mandare i figli a scuola.
Anche dopo questa riforma l’istituzione delle scuole elementari è un compito che continua a essere attribuito ai comuni; e così, i comuni più piccoli, o quelli delle aree economicamente depresse, e quindi a corto di risorse, fanno fatica ad affittare i locali e pagare maestri e inservienti (solo nel 1911 l’onere verrà trasferito allo Stato).
Tuttavia, nonostante queste difficoltà, sul medio periodo, i risultati raggiunti attraverso l’impianto di un sistema scolastico nazionale sono decisamente apprezzabili.
La legge del 1877 è il presupposto per un’altra riforma, anche più impegnativa, cioè l’allargamento del suffragio elettorale.
Approvata nel 1892, la nuova legge per le elezioni politiche (cioè quelle con le quali si elegge la Camera dei Deputati) abbassa il limite di età (si può votare a 21 anni, invece che a 25 come in precedenza); ma soprattutto introduce, come requisito alternativo, l’alfabetismo, estendendo il diritto di voto ai maschi adulti che mostrano di saper leggere e scrivere, o che hanno concluso il ciclo elementare obbligatorio.
Nella retorica della Sinistra questa legge introdurrebbe il “suffragio universale”, dato che la legge sull’istruzione elementare obbligatoria pone le premesse affinché tutti i maschi possano raggiungere il requisito dell’alfabetizzazione.
Le cose non vanno così, perché – come abbiamo appena visto – il processo di alfabetizzazione è piuttosto lento.
Nondimeno la legge produce un considerevole ampliamento del corpo elettorale, che passa dal 2% all’8% sul totale della popolazione.
Un simile ampliamento del corpo elettorale, fortemente voluto da Depretis e dagli uomini della Sinistra, desta comunque qualche preoccupazione: è necessario fare in modo che le ali “estreme antisistema” (i repubblicani, i primi gruppi di socialisti) non possano sfruttare l’ampliamento del suffragio per far eleggere loro rappresentanti in Parlamento.
Il sistema usato per far fronte al mutamento di scenario politico imposto dalla legge elettorale è assai diverso da quello messo in atto dalle élite politiche britanniche dopo le riforme del 1867 e del 1884-85 [cfr. cap. 22.3].
Invece di procedere al rafforzamento del bipolarismo e alla formazione di moderne organizzazioni partitiche, in Italia la riforma elettorale cancella la distinzione tra Destra e Sinistra e crea in Parlamento un grande Centro liberale, quasi privo di opposizioni.
L’operazione è diretta da Depretis, che rilancia lo slogan della “trasformazione dei partiti”, già formulato nel 1876.
Adesso questa parola d’ordine viene riproposta in termini anche più espliciti di prima: in un discorso tenuto di nuovo a Stradella, l’8 ottobre 1882, nell’imminenza delle prime elezioni che si tengono secondo le nuove regole elettorali, Depretis, rivolgendosi all’opposizione di Destra, dice: “se qualcheduno vuole entrare nelle nostre file, se vuole accettare il mio modesto programma, se qualcheduno vuole trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo?”
Depretis rivolge un invito così aperto perché vuole che si formino accordi elettorali tra i liberali di Destra e di Sinistra, che tolgano spazio alle possibili opposizioni antisistema.
L’appello viene accolto; molti esponenti della Destra stabiliscono accordi con gli esponenti della Sinistra, così da presentare liste elettorali comuni: e quindi, invece di un bipolarismo strutturato, si ha un grande Centro liberale e minuscole opposizioni, la più qualificata delle quali è quella dei liberal-democratici, che assumono il nome di Radicali e sono guidati da Felice Cavallotti; nelle elezioni del 22 ottobre 1882, per la prima volta nella storia del Parlamento italiano, viene eletto anche un socialista, Andrea Costa.
Tutta questa operazione si basa su un aspetto essenziale del sistema politico italiano, ovvero l’effettiva vicinanza ideologica dei liberali di Destra e di Sinistra.
Nondimeno viene duramente criticata dagli oppositori, il quali cominciano a condannare quello che viene chiamato il trasformismo.
Il termine deriva dallo slogan lanciato da Depretis (la “trasformazione dei partiti”) e vuole giudicare severamente il clima di opportunismo e di cinismo che sembra accompagnare questa fase politica; si critica soprattutto chi – precedentemente di Destra, e quindi all’opposizione – è ora pronto ad abbandonare le proprie convinzioni pur di poter restare all’interno della maggioranza e poter, per questo, beneficiare delle particolari disposizioni di favore che il governo può decidere di concedergli in cambio dell’appoggio; si critica l’assenza del bipolarismo e la mancata formazione di partiti politici moderni; si critica il ricorso alle pratiche clientelari per la raccolta del consenso e, in generale, il grave scadimento morale della vita pubblica che caratterizzerebbe il periodo.
Tutti questi aspetti appartengono effettivamente al quadro politico italiano, come appare molto chiaramente nel corso di un grave scandalo che scoppia qualche anno più tardi, lo scandalo della Banca Romana.
In quell’occasione due inchieste governative, l’una del 1889, l’altra del 1893, accertano che la Banca romana, istituto privato di credito abilitato all’emissione di cartamoneta per conto dello Stato, ha emesso illegalmente una enorme quantità di moneta, in parte duplicando i biglietti bancari già in circolo, in parte stampando cartamoneta non coperta dalle riserve di titoli e di metallo prezioso.
Nel 1893 il governatore della Banca, Bernardo Tanlongo, viene arrestato e posto sotto processo; nel corso dell’istruttoria emerge che la Banca romana, nella persona del suo governatore, negli anni precedenti ha regolarmente concesso a diversi politici (alcuni dei quali di fama nazionale, come Francesco Crispi o Giovanni Giolitti) finanziamenti in cambio di sostegni e coperture per la propria attività.
Lo scandalo finisce in una bolla di sapone: con motivazioni variamente pretestuose tutte le persone coinvolte (compreso Tanlongo) vengono assolte; nondimeno le accuse di grave scadimento morale della vita pubblica italiana ne risultano ampiamente confermate.
Tuttavia occorre ricordare che le caratteristiche del trasformismo (personalismi nell’organizzazione politica, scandali) non sono affatto una specialità italiana: come si è visto [cfr. capp. 13.4, 16.3, 22.2-4), almeno fino alla fine dell’Ottocento il clientelismo e la corruzione sono una caratteristica essenziale anche dei sistemi politici statunitense e britannico; mentre l’assenza dei partiti, la fluidità delle alleanze, il personalismo nei rapporti politici, gli scandali politico-finanziari sono tratti costitutivi della vita politica della Terza Repubblica francese (tanto che in Francia si usa parlare di “opportunismo”, termine dal significato molto simile a quello di “trasformismo”).
La disinvoltura con la quale gli uomini della sinistra affrontano le competizioni politiche li guida pure nel tracciare le linee della loro politica economica.
Andati al potere nel 1876, innalzando una bandiera liberista in opposizione alla possibile nazionalizzazione delle linee ferroviarie, appena due anni più tardi (1878) si fanno promotori di una prima tariffa protezionistica, favorevole agli interessi delle industrie tessili (cotone e lana) e metallurgiche.
La scelta è dettata dal mutamento delle condizioni economiche generali (siamo negli anni in cui ha avvio la “grande depressione”), ma ha anche altre chiare finalità strategiche: si vogliono difendere le imprese nazionali e, in particolare, si vogliono porre le premesse per la formazione di un’industria pesante (metallurgica e siderurgica) che possa produrre le attrezzature necessarie a esercito e marina, senza che ci sia bisogno di comprare navi e armi da imprese estere.
Dal 1881-82 le spese di bilancio per gli acquisti di forniture belliche sono in crescita.
Nel 1884 il governo favorisce la nascita di un’acciaieria a Terni, primo nucleo di un’industria siderurgica nazionale; altri interventi compiuti negli anni seguenti favoriscono le industrie meccaniche e la cantieristica italiana.
Infine, nel 1887, su iniziativa dell’ultimo governo Depretis, viene introdotta una robusta tariffa protezionistica che difende, al tempo stesso, l’agricoltura italiana (e soprattutto quella padana) colpita dalla crisi agraria [cfr. 18.5] e le principali industrie nazionali; dazi particolarmente alti sono imposti sui prodotti siderurgici e meccanici esteri, mentre sono tenuti bassi sulle materie prime necessarie alla meccanica e alla siderurgica nazionale (carbone e ferro in primo luogo).
23.2. L’azione di governo di Francesco Crispi
Proprio nel 1887 Depretis muore.
Al suo posto, alla guida del governo, subentra Francescoc Crispi, destinato a dominare la vita politica italiana dal 1887 al 1896.
Personalità di grande spessore, Crispi formula un programma politico articolato e ambizioso che si sostanzia in quattro punti fondamentali: nazionalizzazione delle masse, riforma istituzionale, repressione dei conflitti sociali, avvio di una politica coloniale.
………………..
Si possono riassumere come segue i diversi campi di intervento socio-economico attuati dai governi di inizio Novecento, soprattutto quelli guidati da Giolitti:
a) si sostengono direttamente le industrie, specie quelle siderurgiche e quelle meccaniche, che continuano a ricevere commesse dallo Stato per il potenziamento di esercito e marina;
b) una nuova politica sociale introduce norme di protezione e previdenza sociale per i lavoratori e riduce l’uso della forza pubblica per risolvere i conflitti di lavoro; l’aumento degli scioperi comporta un aumento delle retribuzioni dei lavoratori e l’aumento delle retribuzioni comporta un aumento della domanda dei beni di consumo;
c) questa dinamica è favorita anche da altri interventi (nazionalizzazione delle ferrovie; municipalizzazione dei servizi), che hanno come effetto la riduzione delle tariffe
d) importanti interventi speciali offrono aiuti talora decisivi alle economie agricole e industriali dell’Italia meridionale.
…………………..
In quello stesso 1911, sfruttando una grave crisi scoppiata all’interno dell’Impero ottomano (cfr. 25.4] il governo Giolitti decide di attaccarlo militarmente per impossessarsi della Libia, territorio ancora sotto sovranità ottomana.
L’impresa è caldeggiata - con grandissima partecipazione – da un’ampia gamma di sostenitori: da importanti gruppi finanziari italiani, i quali sperano che una conquista territoriale possa offrire nuove occasioni di investimento; da piccoli gruppi nazionalisti radicali, tra i quali spicca, in particolare, l’Associazione Nazionalista Italiana, fondata nel 1910 e guidata – fra gli altri – da Enrico Corradini (1865-1931) e Luigi Federzoni (1878-1967), che considera la “guerra di Libia” una grande occasione per provare la grandezza militare della nazione italiana: da buona parte della stampa e delle organizzazioni cattoliche, che vi vedono una possibile nuova crociata contro l’islam; ma soprattutto da tutta la grande stampa italiana di orientamento liberale, la quale ritiene che l’iniziativa possa far comparire definitivamente e autorevolmente l’Italia fra le grandi potenze.
Parole della storia
Conflitto di interessi
Nel contesto degli Stati nei quali vige una rigorosa distinzione tra funzioni pubbliche e funzioni private, si parla di conflitto di interessi quando un soggetto con importanti responsabilità decisionali pubbliche (per esempio un parlamentare) deve fare scelte su materie che coinvolgono i suoi interessi privati; in questo caso egli si troverebbe in conflitto con l’imparzialità richiesta per lo svolgimento della carica che occupa, potendo cedere alla tentazione di scegliere una soluzione favorevole ai propri personali interessi, anche quando sia contraria agli interessi della collettività
Fasci
La parola deriva dal fascio littorio, impiegato durante la Rivoluzione francese come simbolo di unità, forza, giustizia.
Nel corso dell’Ottocento il simbolo e il termine vengono variamente utilizzati da organizzazioni o da partiti, prevalentemente di orientamento democratico e socialista.
L’esempio più immediatamente precedente a quello dei Fasci siciliani è il Fascio della democrazia, alleanza di democratici, repubblicani e socialisti, fondato nel 1883.
Quarto Stato
Assai diffusa ai primi del Novecento come sinonimo di “proletariato” o di “classi popolari”, l’espressione allude esplicitamente alla Rivoluzione francese, ma sottintende che, se quella è stata la rivoluzione del “Terzo Stato” (cioè della “borghesia”), la prossima a compiersi potrebbe essere proprio quella del “Quarto Stato”.
Ultimatum
Documento formale inviato da uno Stato a un altro nel caso di una grave crisi dei rapporti diplomatici.
Lo Stato che emette l’ultimatum chiede allo Stato ricevente di ottemperare a particolari condizioni o di rispondere a una serie di questioni entro un termine temporale ben preciso.
L’ultimatum può anche contenere un’esposizione delle misure che lo Stato che lo ha emesso è pronto a prendere nel caso in cui lo Stato ricevente non accetti le condizioni che vi sono previste o non risponda in modo soddisfacente alle richieste formulate.
Bibliografia
Storia politica dlel’Italia liberale, 1861-1901 / F. Cammarano. – Laterza, 2004
Creare la nazione: vita di Francesco Crispi / C. Duggan. – Laterza, 2000
L’Italia giolittiana, 1899-1914 / E. Gentile. – Il Mulino, 1990
Storia d’Italia, vol. 3.: Liberalismoe democrazia, 1887-1914 / G. Sababtucci, V. Vidotto (a cura di). – Laterza, 2007
Cap. 24. L’Occidente alla conquista del mondo
24.1 Colonialismo e imperialismo
Tra il 1870 e il 1914 l’espansione coloniale occidentale non si ferma: tutto il mondo non occidentale, in forma diretta o indiretta, finisce sotto il controllo dell’una o dell’altra grande potenza.
Oltre alle storiche presenze coloniali (Regno Unito, Francia, Olanda, Russia), altri Stati, anche di recentissima formazione, si impegnano nella corsa alla conquista delle colonie (Belgio, Germania, Italia e Stati Uniti); un’antica potenza coloniale esce quasi del tutto di scena (la Spagna); mentre un astro nascente orientale si unisce alle iniziative dei più attivi Stati occidentali, dei quali ha in larga misura copiato le istituzioni (il Giappone).
La globalizzazione economica – già da secoli in atto – ne riceve una spinta ulteriore; parti intere del globo sono sotto controllo economico di imprenditori e finanzieri euro-americani.
Il dato veramente nuovo è la conquista politica e militare quasi integrale di almeno tre continenti: entro il 1914, tutta l’Oceania, tutta l’Africa (a eccezione dell’Etiopia) e tutta l’Asia (con parziali eccezioni della Penisola arabica, dell’Afghanistan, della Cina, del Tibet, della Cina, del Tibet e del Nepal) sono sotto controllo dell’una o dell’altra fra le potenze impegnate nell’espansione coloniale.
Il dominio, adesso, è veramente integrale.
Per rimarcare la novità in questi anni entra in uso il termine imperialismo.
Sembra un lemma estremamente appropriato, poiché sottolinea un’aspirazione che le classi dirigenti dell’epoca (sovrani e uomini politici) sembrano coltivare con un’intensità testimoniata dal gran numero di Stati che in questo periodo assumono il titolo di “Impero”: sono tali la Germania, l’Austria-Ungheria, la Russia, l’Impero ottomano, il Giappone.
Vittoria, regina del Regno Unito, nel 1876-77 viene proclamata imperatrice dell’India; mentre la Francia ha appena smesso di essere un impero con la caduta di Napoleone 3. nel 1870, sebbene una parte almeno della sua opinione pubblica non cessi di coltivare sogni di rivincita neoimperiale in Europa e fuori dell’Europa.
Oltre a questo aspetto formale – nient’affatto trascurabile, perché indizio palese di una mentalità corrente – il termine indica comunque il grande salto di qualità che appartiene all’espansione coloniale di fine secolo.
Certamente esso è favorito dal grandissimo divario tecnologico che si è creato dopo le due rivoluzioni industriali tra l’Occidente e il resto del mondo, e in particolare da alcune strabilianti applicazioni tecnologiche che permettono all’industria bellica occidentale di produrre in serie le mitragliatrici e le armi automatiche.
Tuttavia, se si considerano le innumerevoli – e talora gravi – tensioni interne che segnano la vita politica di tutte le potenze impegnate nell’espansione coloniale [cfr. cap. 22], può sembrare strano che le classi dirigenti trovino risorse, energie e spirito per nuove iniziative di conquista lontano dalla madrepatria.
Tutte le operazioni coloniali sono disagevoli; richiedono molti soldi e molti uomini; e sia gli uni sia gli altri sono costantemente messi a rischio, specie quando si incontrano resistenze da parte delle popolazioni dei territori che si vogliono conquistare.
Perché, dunque, imprese simili si compiono egualmente? E perché su così larga scala?
Citazione
Piuttosto paradossalmente (e significativamente) è proprio il governo liberale di Gladstone (la punta avanzata del parlamentarismo britannico) a dar ordine al suo esercito di reprimere la rivolta di Arabi Pascià e di instaurare un protettorato inglese sull’Egitto (mentre il governo francese guidato da Freycinet non ottiene dalla Camera i finanziamenti utili ad attuare un’azione militare a cui è stato sollecitato dallo stesso governo britannico)
Pag. 543
Bibliografia
L’alba illusoria: l’imperialismo europeo nell’Ottocento / R. F. Betts. – Il Mulino, 2008
Politica ed economia del colonialismo, 1870-1945 / D. K. Fieldhouse. – Laterza, 1996
Teorie dell’imperialismo: da Marx ad oggi / T. Kemp. – Einaudi, 1976
Cultura e imperialismo: letteratura e consenso nel progetto coloniale dell’Occidente / E. W. Said. – Gamberetti, 1998
Cap. 25. Alleanze e contrasti fra le grandi potenze
25.1 Uno sguardo d’insieme
Sebbene le rivalità imperiali per la conquista di territori extraeuropei siano importanti e diano luogo a crisi talora molto gravi, il sistema di alleanze internazionali che si costruisce nell’arco di tempo che va dal 1870 al 1914 non ne è sostanzialmente influenzato.
I campi di tensione che lo determinano sono altri e sono tutti interni al quadrante europeo:
a) una frattura gravissima è quella che separa in modo permanente Germania e Francia, contrapposte da una rivalità insuperabile nata con la guerra franco-prussiana e con l’annessione dell’Alsazia e della Lorena entro i territori dell’Impero tedesco (1870-71);
b) una seconda area di contrasto vede fronteggiarsi soprattutto Austria-Ungheria e Russia, sempre più direttamente in competizione per il controllo dei Balcani man mano che si aggrava la crisi dell’Impero ottomano;
c)un terzo contrasto oppone Regni Unito e Germania e nasce dal desiderio tedesco, maturato alla fine degli anni Novanta dell’Ottocento, di disporre di una marina di stazza e potenza paragonabile a quella britannica.
La rete delle alleanze si tesse per il combinarsi di questi tre campi di tensione, la cui importanza offusca l’influenza delle competizioni coloniali, tanto che alla fine del processo le maggiori rivali coloniali (Francia e Regno Unito, contrapposti in Africa; Russia e Regno Unito, contrapposti in Afghanistan) si ritrovano unite da una serie di trattati di alleanza.
Parole della storia
Curdi
Popolazione di origine iranica e di religione islamica che abita nell’Anatolia orientale e nel Kurdistan (a nord degli attuali Siria, Iraq, Iran).
Bibliografia
Le origini della prima guerra mondiale / J. Joll. – Laterza, 1999
L’Europa della grandi potenze: da Metternich a Lenin / A. J. P. Taylor. – Laterza, 1977
L’età contemporanea: dalla Grande Guerra a oggi di Alberto Maria Banti. Vol. 2
- Visite: 132
Introduzione
Niente comincia davvero nell’estate del 1914.
Niente sarà più come prima, dopo l’estate del 1914.
Perché niente comincia allora?
Perché lo scoppio della Grande Guerra ha alle spalle una lunga sequenza di processi di mutamento che prendono forma nel cosso di ciò che potremmo chiamare “il lungo Ottocento”.
E’ una fase storica che si apre con la triplice rivoluzione tardo settecentesca (industriale, americana, francese); che passa attraverso la nascita dell’ideologia nazionalista, l’esplodere dei conflitti sociali, l’emergere delle tensioni razziali e di genere; che vede acutizzare i suoi contrasti dagli anni Settanta dell’Ottocento, quando inizia a formarsi quella che, in senso proprio, può essere chiamata una “società di massa”.
E’ solo attraverso la riflessione su questi processi – di cui si dà conto nel volume sull’Ottocento di L’età contemporanea – che si aprono le ragioni lontane che portano alla grandissima tragedia della Grande Guerra.
Eppure, dopo l’estate del 1914, niente sarà come prima.
E’ lo scrittore austriaco Stefan Zweig (1881-1942) a usare le parole migliori per scandire la distanza che molti contemporanei sentono tra il “mondo di ieri”, quello che precede il 1914, e ciò che si trovano a vivere dopo il macello della Grande Guerra.
“Se tento di trovare una formula comoda per definire quel tempo che precedette la prima guerra mondiale, il tempo in cui sono cresciuto, credo di essere il più conciso possibile dicendo: fu l’età dell’oro della sicurezza […].
Oggi, per noi che abbiamo da un pezzo cancellato dal nostro vocabolario la parola “sicurezza”, è facile deridere l’illusione ottimistica di quella generazione accecata dal suo idealismo: illusione che il progresso tecnico dovesse immancabilmente avere per effetto un non meno rapido miglioramento morale.
Noi che nel nuovo secolo abbiamo imparato a non lasciarci più sorprendere da alcuno scoppio di bestialità collettiva, noi che da domani aspettiamo ancor più atroci eventi che dall’ieri, siamo ben più scettici circa la perfettibilità morale degli uomini.
Noi fummo costretti a dar ragione a Freud, allorché egli riconobbe nella nostra cultura e nella nostra civiltà solamente un sottile diaframma, che ad ogni momento può essere sfondato dagli impulsi distruttivi del mondo sotterraneo, e noi abbiamo dovuto a poco a poco abituarci a vivere senza un saldo terreno sotto i piedi, senza diritti, senza libertà, senza sicurezza.”
Stefan Zweig, Il mondo di ieri: ricordo di un europeo, Mondadori, 1979
Parole doloranti, di un pessimismo senza speranza, che ci danno bene il senso di un drammatico passaggio epocale.
Mai l’Occidente ha dovuto elaborare un lutto collettivo paragonabile a quel prodotto dalle battaglie che per cinque anni si sono combattute nelle più varie parti d’Europa.
Ma non è solo questo: strutture istituzionali consolidate da secoli (l’Impero austro-ungarico, l’Impero russo, l’Impero ottomano), scompaiono definitivamente dalla carta geopolitica d’Europa; nuove formazioni statali si creano quasi quasi dall’oggi al domani; una regressiva “brutalizzazione” della lotta politica, un trasferimento quasi inerziale della cultura di guerra al modo di pensare il conflitto politico, insanguina l’Europa dopo il 1918: guerre civili o interetniche sconvolgono per mesi, o per anni, l’Italia, la Germania, l’Ungheria, la Turchia, la Russia, più tardi la Spagna, mentre ideologie che negano gli individui e pensano solo per grandiosi etno-nazionali o sociali (il fascismo, il comunismo, il nazismo) acquistano un prestigio e una forza assolutamente straordinari, tali da metterli in condizione di realizzare piani di guerra e di morte che faranno impallidire la memoria della Grande Guerra.
E’ una tale, e talmente sconvolgente, valanga di eventi, da imporre il 1914 come una delle possibili ( e quasi inevitabili) date periodizzanti.
Certo non è il caso di fare della Grande Guerra l’origine di “tutto”.
Processi diversi hanno altre ragioni o si ricollegano ad altre configurazioni culturali.
Da un lato, formazioni politiche come il nazi-fascismo o il comunismo hanno moltissimi tratti che le riconducono alle elaborazioni sociali e concettuali dell’Ottocento europeo; oltre a ciò, aspetti importanti delle dinamiche di decolonizzazione si richiamano a profondità storiche risalenti nel tempo, sollecitate sia dalla storia culturale e religiosa di quei singoli paesi, sia dalle modalità con le quali vi si è imposto l’imperialismo occidentale.
Dall’altro lato, il Novecento è anche un grandissimo laboratorio di innovazioni e sperimentazioni, per fortuna non tutte terribili e luttuose, né tutte riconducibili, almeno in prima battuta, a esperienze passate.
Un inventario completo non ha senso, qui; ma almeno alcuni processi meritano di essere ricordati sin da ora per la loro carica di novità:
- un nuovo rispetto per le istituzioni democratiche contrassegna l’Europa post-1945, bruciata dalla violenza pianificata dei totalitarismi;
- Già negli anni Venti, e poi con più veemenza negli anni Sessanta del 20. secolo, movimenti culturali e politici spingono per una gioiosa rottura delle censure che hanno gravato fin allora sulla cura di sé, sulla libertà di espressione, sul modo di vivere le relazioni sociali, razziali, familiari, sessuali e di genere;
- una nuova paura della morte abita l’Occidente di fine 20.-inizio 21. secolo; una paura che si specchia in malinconiche fantasie di immortalità, fatte di interventi di chirurgia estetica, cure cosmetiche, isterie salutiste, narrazioni pubblicitarie, che insistono con ossessione cieca sull’idea che l’unica bellezza tollerabile sia quella di corpi giovani, sani, efficienti, in forma;
- ma la paura della morte si specchia anche in un nuovo modo di guardare alla guerra come a una sventura e alla pace come a un valore; e mai, prima degli anni del secondo dopoguerra, si è visto un movimento pacifista avere l’influenza che ha avuto negli Usa al tempo della guerra del Vietnam, o nell’Occidente post-11 settembre 2001 al tempo delle “guerre di civiltà” con l’Oriente islamico;
Persistenze e novità, dunque, si inseguono e si intrecciano nella storia del Novecento, all’interno di uno scenario che la globalizzazione rende ampio quanto l’intero pianeta: narrare gli sviluppi di questa storia, scioglierne gli intrecci, esplorarne le stratificazioni, osservare i caratteri delle formazioni culturali che lo dominano, è ciò che questo libro si propone di fare.
Un manuale di storia deve offrire un panorama di sintesi sullo svolgersi del processo storico; per questo deve contenere diversi punti di osservazione dai quali guardare al passato.
Si tratta di una scelta obbligata, poiché i percorsi di trasformazione storica sono complessi e si sviluppano a partire da un articolato intreccio che lega mentalità, pratiche sociali, scelte economiche e decisioni politiche in un rapporto profondo.
Diverse prospettive metodologiche offrono gli strumenti necessari a studiare e ricostruire queste varie dimensioni dell’esperienza storica: la storia culturale (o – nell’uso francese – la storia della mentalità) si occupa del significato che i soggetti attribuiscono al loro agire, e dei modi attraverso i quali tale significato viene identificato o costruito; la storia sociale studia i modi attraverso i quali le persone si riuniscono o si distinguono all’interno della medesima società; la storia economica esamina le ragioni e le conseguenze (individuali e collettive) delle scelte economiche; la storia politica, infine, ricostruisce le modalità dell’azione politica e le forme istituzionali all’interno delle quali essa si svolge.
Talvolta vi sono state correnti storiche che, sulla base di filosofie della storia, di ideologie politiche o di teorie sociologiche, hanno proposto una gerarchia rigida tra questi diversi approcci, e quindi tra le diverse dimensioni che vi sono sottese; vi è chi ha pensato che le scelte economiche fossero la chiave fondamentale di una corretta comprensione storica; vi è chi ha assunto una prospettiva tutta incentrata sul politico; vi è chi ha considerato le idee prodotte dagli intellettuali come l’elemento esplicativo essenziale. E così via.
In questo manuale – per quanto è stato possibile – si è abbandonata la prospettiva di una gerarchia rigida, poiché i rapporti tra mentalità-economia-società-politica non sono sempre gli stessi, ma mutano costantemente nel corso del tempo.
Ritenere che una eterna gerarchia scandisca il rapporto tra le diverse sfere dell’agire umano è affidarsi a un pensiero magico, più che a una valutazione razionale e sensibile del corso storico.
Se si vuole capire l’intera complessità degli svolgimenti storici, bisogna dunque cercare di osservare con attenzione i rapporti e le interazioni reciproche che collegano, politica, economia, società e cultura, senza privilegiare nessuno di questi ambiti.
Avendo compiuto questa scelta, e quindi avendo la sciato da parte ogni schematica gerarchia delle rilevanze, si è comunque deciso di dedicare una certa attenzione alla dimensione “culturale” degli eventi storici.
Il termine viene impiegato da una corrente storiografica che si è sviluppata soprattutto negli ultimi vent’anni e che ha preso il nome, appunto, di “storia culturale”.
Questo indirizzo di studi ha sollecitato una notevole quantità di ricerche recenti, ma si richiama anche all’esempio di grandi classici pubblicati tra fine Ottocento e inizio Novecento, come La civiltà del Rinascimento in Italia (1860), di Jacob Burckhardt; L’autunno del Medioevo (1919), di Johan Huizinga; o I re taumaturghi (1924), di Marc Bloch.
In realtà la costellazione intellettuale che può essere ricondotta al comune denominatore della “storia culturale” è assai più ampia e chi abbia la curiosità di ripercorrerla in tutta la sua interezza può ricorrere senz’altro all’agile libretto di Peter Burke, intitolato La storia culturale (Il Mulino, 2006), nel quale l’autore ne dà una descrizione chiara e generosamente inclusiva.
Ovviamente, il punto chiave di questo particolare approccio sta nella sua definizione del concetto di “cultura”.
In linea generale, il termine viene usato nel senso che è stato reso familiare dagli antropologi: “cultura” è l’insieme delle “mappe mentali” che orientano il comportamento delle persone; tali mappe mentali rinviano a sistemi di credenze e di valori trasmessi da sistemi narrativi più o meno complessi; tali sistemi narrativi sono incorporati in discorsi, testi, rappresentazioni grafiche, sistemi rituali, pratiche relazionali, con i quali gli individui, nel passato come oggi, sono chiamati a interagire, per accettarli o rifiutarli, interiorizzarli in toto o rielaborarli in forma autonoma.
E’ attraverso l’indagine di percorsi di questo tipo che si possono descrivere storicamente i modi di formazione delle singole personalità individuali ed il loro convergere nella formazione di comunità sociali, politiche, religiose, culturali.
La storia culturale, dunque, mentre osserva il processo di formazione di comunità che, nell’epoca contemporanea, sono comunità “di massa”, tende a portare in primo piano anche la dimensione soggettiva che struttura l’esperienza delle singole persone.
E così facendo, invita a includere nello spazio dell’osservazione storica momenti di vita che molto spesso sono stati trascurati dalla storiografia: le emozioni, gli affetti, le relazioni familiari, i sentimenti, l’amore, la sessualità, la concezione delle generazioni, il sentimento della morte.
Quando si dà spazio ad argomenti di questo tipo, non lo si fa certo per “completare il quadro” con qualche curiosità aneddotica.
Lo si fa, invece, per altri due motivi.
Il primo è che nella vita delle persone (del passato come del presente) la sfera degli affetti e dei sentimenti è enormemente importante, spesso altrettanto importante delle questioni che hanno a che fare con le scelte economiche o politiche; sarebbe davvero un grave impoverimento analitico se si studiassero le persone che hanno vissuto nel passato come se fossero del tutto prive di un mondo affettivo loro proprio.
Sarebbe seguire una pista del tutto sbagliata, come una grandissima quantità di fonti ci suggerisce e come ci suggeriscono anche importanti teorie della civilizzazione: i lavori di grandissimi studiosi come Sigmund Freud o Norbert Elias o Michel Foucault, della cui influenza sul pensiero contemporaneo non è lecito dubitare, si basano proprio sull’osservazione di questi aspetti.
Il secondo motivo ha a che fare con la fortissima politicità della dimensione privata: nonostante ciò che, di tempo in tempo, più di un intellettuale e più di un politico hanno sostenuto, la sessualità, la riproduzione, la struttura delle famiglie, il mondo degli affetti, la cura del proprio corpo, il modo di affrontare la morte propria e degli altri, non sono dimensioni chiuse nello spazio di un’inaccessibile privacy; al contrario, sono dimensioni che, proprio nel cuore della contemporaneità, diventano oggetto di un’azione politica e di una preoccupazione pubblica sempre più invadenti e pervasive, fino a toccare l’apice all’interno di quei regimi che cercano di costruire una biopolitica organica, che vuole decidere della vita e della morte di ogni singolo membro della comunità politica (esempi terribili nella loro efficacia ne sono il fascismo, il nazismo e il comunismo sovietico); o all’interno di questi contesti socio-politici sono dominati da narrazioni commerciali, mediche, cinematografiche, televisive, che proclamano l’eternità della giovinezza e della bellezza corporea, e che nascondono la vecchiaia, la malattia, la morte, come se fossero esperienze di cui vergognarsi (ed è ciò che connota una parte dominante della cultura occidentale degli ultimi decenni).
Rituali, simboli, emozioni, affetti sono aspetti dell’agire umano che sono regolati da un insieme di credenze, di concezioni, di idee.
Talora queste idee sono dominate da preoccupazioni metafisiche (la morte, l’aldilà, la spiritualità, la religione); talora sono dominate da preoccupazioni molto più materiali (il potere, il dominio, gli interessi economici, la libertà).
In qualche caso queste concezioni sono trasmesse da testi di grande spessore intellettuale e filosofico (tipo, per es., La Fenomenologia dello spirito di Hegel o il Capitale di Marx o L’interpretazione dei sogni di Freud o Il secondo sesso di de Beauvoir); in qualche altro caso sono trasmesse da opere concepite per divertire o istruire (per es., Il Nabucco di Versi, o Cuore di De Amicis, o Il trionfo della volontà si Riefenstahl, o 300 di Snyder); in qualche altro caso ancora, il più difficile da studiare, sono trasmesse attraverso interazioni quotidiane, in famiglia (dai genitori ai figli), in chiesa (da un parroco o un pastore ai fedeli), a scuola (dagli insegnanti agli allievi) e così via.
Questi testi, narrazioni, discorsi veicolano mappe mentali che devono essere studiate con attenzione, se si vuole capire i significati profondi delle culture che dominano nelle contemporanee società di massa.
Tale aspetto dell’analisi culturale è stato illustrato in modo magistrale da un grande antropologo, Clifford Geertz, che in un suo famoso testo ha spiegato perché il concetto di cultura dev’essere considerato “un concetto semiotico”, cioè un concetto che fa riferimento a dei sistemi di senso; scrive, dunque, Geertz:
“Ritenendo, insieme con Max Weber, che l’uomo è un animale sospeso fra ragnatele di significati che egli stesso ha tessuto, credo che la cultura consista in queste ragnatele e che perciò la loro analisi non sia una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato.
E’ una spiegazione quella che sto inseguendo: analizzando espressioni sociali enigmatiche in superficie”.
Clifford Geertz, Verso una teoria interpretativa della cultura, 1973, in; Interpretazione di culture, Il mulino, 1987
La “cultura” è come una “ragnatela di significati” che gli individui hanno tessuto: essi ci vivono dentro; sono quelle “ragnatele semiotiche” che orientano (o condizionano) i loro comportamenti.
Qualche volta esse possono sembrarci “enigmatiche”, perché molto diverse dalle nostre mappe mentali, dalle nostre “ragnatele di significati”.
Per questo, per decifrarle bisogna analizzare con attenzione le fonti documentarie che ne recano le tracce.
Lavorando con le fonti si può fare come fanno gli antropologi: cioè si può cercare di vedere le cose con gli occhi delle persone che si stanno studiando, un po’ come se “si fosse nei loro panni”, un po’ come se “si fosse lì, in mezzo a loro”.
Ma il contatto con le fonti è assolutamente essenziale per il lavoro storiografico nel suo complesso, e non solo, ovviamente, per la storia culturale: non c’è analisi economica, o sociale, o politica che possa prescindere dai documenti che ci consentono di descrivere il funzionamento e la natura dei sistemi economici, sociali, politici.
Per questa ragione in questo libro il testo incorpora fonti e documenti, che non sono collocati un un’appendice, ma sono parte integrante dell’argomentazione: con questa operazione, in primo luogo, si vuole offrire a chi legge un riscontro documentario diretto che dia sostegno e senso alle descrizioni offerte; ma si vuole anche rendere possibile un primo contatto con le fonti su cui gli storici lavorano, così che chi legge possa – almeno in una qualche misura – entrare in un rapporto meno mediato con l’atmosfera culturale e comunicativa delle società contemporanee, con le loro culture, i loro valori, i loro interessi, i loro traumi, i loro sogni, nella consapevolezza che parti significative di quelle esperienze continuano ad abitare ancora le nostre menti e a modellare ancora le nostre speranze e le nostre paure.
Cap. 1. La Grande Guerra
- Giorni d’estate
Strana estate quella del 1914.
E’ agosto, e fa caldo.
I ricchi stanno per andare in vacanza.
I poveri no, continuano a lavorare, ma sognano egualmente la fine della settimana, per andare al fiume a rinfrescarsi, o in campagna a sdraiarsi sotto un albero con gli amici e le amiche, o magari da soli con l’amore della propria vita.
Ma i giornali richiamano l’attenzione di tutti.
Grandi titoli a carattere cubitali.
Non si possono ignorare.
E poi arrivano cartoline ufficiali, dispacci, telegrammi, specie nelle case dove ci sono ragazzi che hanno trai diciotto e i venticinque anni.
L’estate è finita prima che cominci per davvero.
E’ la guerra; una guerra alla quale quasi tutti gli Stati più potenti al mondo stanno per partecipare.
Dovrebbe essere un momento di lutto, di tristezza siderale.
Eppure non è così.
Quella guerra sembra quasi non fare veramente paura.
Solo pochi politici, intellettuali o militari capiscono che la guerra che ci si sta apprestando a combattere sarà una catastrofe umanitaria senza confini.
Molti altri, invece, se la immaginano breve, forse anche sanguinosa, certo, ma comunque breve e quindi non troppo terribile.
Confortati da questa previsione, molti, specie delle classi popolari, guardano con rassegnazione agli eventi: se ci pensano con attenzione, un brivido di paura corre senz’altro lungo la loro schiena,
Ma l’idea è che, in definitiva, questa nuova guerra non sarà poi tanto peggiore delle guerre balcaniche, o di quella di Libia, o dell’anglo-boera, e così via.
Forse, se si viene richiamati al fronte, ce la si può cavare con poco.
Quasi nessuno, comunque, ha il coraggio di esprimere apertamente dubbi di questo genere, specie se si trova in una delle grandi capitali europee.
Perché lì l’estate del 1914 sembra quasi una stagione di festa e di entusiasmo.
A Londra, quando si sa dell’ingresso in guerra del Regno Unito, folle inneggianti alla grandezza patria si riversano per le strade e si fermano per giorni davanti a Buckingham Palace, la residenza del re.
A Berlino, nell’analoga circostanza, una folla festante irrompe nelle strade come un fiume che ha rotto gli argini.
A Monaco la gente riunita nell’Odeonsplatz il 3 agosto, giorno della dichiarazione di guerra alla Francia, quasi non riesce a entrare nella piazza.
A San Pietroburgo alcuni manifestanti entusiasti danno fuoco all’ambasciata tedesca.
Più compostamente, un po’ ovunque, bande militari e spettatori seri e determinati, ma per niente sconvolti, accompagnano le truppe in partenza.
Intellettuali come Rainer Maria Rilke (1875-1926) o Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) o Anatole France (1844-1924) inneggiano alla guerra e partono perfino volontari.
In India il giovane Gandhi [cfr. cap. 5.4] invita i suoi connazionali ad arruolarsi nell’esercito inglese.
Perfino Sigmund Freud si fa prendere – almeno per un momento – dalla passione patriottica: alla fine del luglio 1914 scrive ad un amico e collega: “Forse per la prima volta in trent’anni mi sento un austriaco e disposto a concedere a questo precario impero un’ultima possibilità”.
Un movimento sin allora pacifista, come quello delle suffragiste inglesi, si spezza: una parte largamente maggioritaria delle militanti segue Emmeline e Christabel Pankhurst, le quali si fanno convinte sostenitrici della guerra patriottica e della necessità che le donne diano un contributo attivo allo sforzo bellico del proprio paese.
Perfino i partiti socialisti sono travolti dalla febbre patriottica.
Fino a poco prima dello scoppio della guerra i loro dirigenti hanno professato con convinzione l’ideale internazionalista; ma, allo scoppio della guerra, tutti i partiti socialisti votano i crediti di guerra, oppure entrano in maggioranze e governi di unione nazionale, con l’unica eccezione del Partito socialista serbo e del Partito socialdemocratico russo.
Il caso più emblematico dell’ambivalenza di questi giorni è quello (tragico) del leader socialista francese Jean Jaurès: pacifista convinto, viene ucciso il 31 luglio da un nazionalista esaltato, desideroso che la Francia entri in guerra senza che qualcuno ne mini la compattezza.
Eppure lo stesso Jaurès solo pochi giorni prima di essere ucciso aveva dichiarato: “Non c’è alcuna contraddizione nel fare il massimo sforzo per assicurare la pace e, nel caso in cui la guerra scoppi nostro malgrado, nel fare il massimo sforzo per assicurare nell’orribile tormenta l’indipendenza e l’integrità della nazione”.
Come dire che, alla fine di tutto, le ragioni de nazional-patriottismo superano quelle dell’internazionalismo proletario.
Ne consegue, ovviamente, che la decisione dei vari partiti socialisti, i quali sostengono lo sforzo bellico dei rispettivi governi, porta alla crisi e allo scioglimento di fatto della Seconda Internazionale, l’organismo che aveva il compito di coordinare la solidarietà sovranazionale dei vari partiti socialisti.
Tutto ciò può apparire sconcertante, se solo si considera come va a finire.
Dal 1914 al 1918 sono in 70.000.000 a vestire l’uniforme e a partecipare alla guerra: di questi, all’incirca 10.000.000 muoiono in battaglia o per le ferite riportare.
E’ un numero terrificante, mai raggiunto da alcuna guerra precedente.
E contiene un dolore inesprimibile: dieci milioni di morti, tutto con una loro storia che irradia il lutto e sofferenza su chi resta in vita e li piange (padri, madri, figli, mogli, fidanzate, amici…).
E poi ci sono i feriti, che sono egualmente tantissimi: 30.000.000 circa tra cui 8.000.000 sono gravissimi, invalidi, mutilati, ciechi, traumatizzati, incapaci di riprendere una vita normale.
E poi c’è il fatto che tutti questi numeri, tutti questi traumi riguardano prevalentemente dei ragazzi o dei giovani uomini, persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni: dolore nel dolore per il fatto che le loro sono morti premature, “anni spezzati” come è stato suggestivamente detto.
E poi ci sono le devastazioni economiche e sociali, che si fanno sentire a lungo, anche negli anni che seguono la fine della guerra: povertà, fame, dolore, depressione per lo shock di aver combattuto, depressione per aver perduto persone amate.
Che cosa ci aiuta a capire tutto quello che è accaduto?
Che cosa ci aiuta a capire, in particolare, il contrasto fra la festosità dei giorni di agosto e la insopportabile luttuosità degli anni che seguono?
Intanto nell’agosto del 1914 non molti hanno ben chiaro che tipo di guerra sia quella che ci si sta apprestando a combattere.
Sebbene le notizie delle recenti guerre – l’anglo-boera (1899-1902) e la russo-giapponese (1904-5) – abbiano parlato di efferatezze inusitate e di nuove tecnologie enormemente distruttive, l’idea che ancora ci si fa della guerra è quella di uno scontro cavalleresco, condotto con tecniche e strategie simili a quelle impiegate dagli eserciti di Napoleone 1.: attacchi all’arma bianca contro il fronte nemico, mentre un fuoco di copertura protegge gli eroici guerrieri.
La cultura ottocentesca aiuta a fantasticare la guerra in questo modo.
Il revival medievale – fato di re Artù e di Lancillotto, di Ivanhoe e di Sigfrido, di Parsifal e di Lohengrin – fa pensare ai soldati come ad altrettanti paladini avvolti in lucenti armature, una fantasticheria che la grafica della propaganda [vedi parole della storia] bellica cerca spesso di sfruttare con la massima efficacia possibile.
Ma poi c’è qualcos’altro.
La cultura profonda dell’Occidente è una cultura bellica, una cultura che si è nutrita, e ancora si nutre, di letture che parlano con naturalezza e ammirazione, di battaglie e massacri, dalla Bibbia a Omero, da Ariosto ai romanzi storici ottocenteschi.
Inoltre la mascolinità ottocentesca si è costruita attorno all’immagine dell’uomo combattente e della donna da difendere.
Queste le figure dell’immaginario che vengono ripetute una grande quantità di volte negli articoli, nelle immagini, nelle pitture e perfino nelle fotografie o nelle cartoline che accompagnano la vita di chi combatte come di chi resta a casa.
E poi, senza alcun dubbio, ci sono gli imperativi nazional-patriottici, da cui gli stessi ideali della mascolinità bellica e del neomedievalismo cavalleresco traggono alimento.
La difesa della patria, l’onore della nazione, l’obbligo di sacrificarsi per la comunità nazionale sono doveri a cui risulta difficile sottrarsi e che spiegano la strana conversione dei socialisti europei alla guerra – riluttanti, certo, ma consapevoli dei loro obblighi nei confronti del loro paese.
Parole della storia
Genocidio
Il termine viene utilizzato per la prima volta nel 1944 da un giurista statunitense di origine polacca, Raphael Lemkin.
Quattro anni più tardi viene impiegato nella Risoluzione 230 del 9 dicembre 1948, emessa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), che ne dà questa definizione: “Per genocidio si intende uno qualunque degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale: (a) uccisione dei membri del gruppo; (b)gravi lesioni all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; (c) assoggettamento deliberato del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; (d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; (e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro.
Più tardi Frank Chalk e Kurt Jonassohn, in The history of sociology of genocide: analyses and case studies (1990), hanno proposto un’efficace ridefinizione del termine, secondo cui per genocidio deve intendersi “una forma di massacro di massa unilaterale con cui uno Stato o un’altra autorità vuole distruggere un gruppo; in queste circostanze i criteri che definiscono l’appartenenza al gruppo da distruggere sono definiti dall’aggressore”.
Propaganda.
Insieme coerente di messaggi affidati ai vari media (manifesti, volantini, film e, poi, trasmissioni radiofoniche o televisive), che cercano di influenzare le convinzioni e i comportamenti del massimo numero di persone a cui si rivolgono.
Per questo i messaggi propagandistici non puntano a fornire informazioni imparziali ma a suscitare reazioni emotive, sulla base di visioni o valutazioni unilaterali.
Pulizia etnica
L’espressione indica una pratica leggermente differente rispetto al genocidio, sebbene – di norma – non meno selvaggiamente violenta.
La si impiega per indicare operazioni messe in atto da una qualche autorità politica che vuole allontanare da un determinato territorio popolazioni che hanno caratteristiche nazionali, etniche o religiose diverse dalla propria.
L’operazione si differenzia dal genocidio perché chi mette in atto non cerca l’eliminazione fisica delle altre popolazioni: le vuole “solo” allontanare per sempre dalle loro case, dalla loro terra, in nome di una “coerenza etnica” che deve caratterizzare quel dato territorio nazionale.
L’espressione viene comunemente usata nella letteratura scientifica con questo significato (si vedano, per esempio, Norman M. Naimark, La politica dell’odio: la pulizia etnica nell’Europa contemporanea, Laterza, 2002; o Jacques Sémelin, Purificare e distruggere: usi politici dei massacri e dei genocidi, Einaudi, 2007).
Bisogna tuttavia ricordare che l’espressione deriva dal serbo-croato ed è stata impiegata per descrivere le operazioni compiute dagli Stati sorti dalla disgregazione della Jugoslavia, avvenuta nel 1992.
Rappresentazioni collettive
Insieme di immagini, narrazioni e idee condivise da una comunità più o meno ampia.
La figura del Cristo crocifisso è – per esempio – una della “rappresentazioni collettive” più importanti del sistema di credenze proprio delle comunità cristiane.
Bibliografia
La violenza, la crociata, il lutto: la grande guerra e la storia del Novecento / S. Audoin-Rouzeau, A. Becker. – Einaudi, 2002
La grande guerra e la memoria moderna / P. Fussell. – Il Mulino, 2005
La grande guerra degli italiani, 1915-1918 / A. Gibelli. – Rizzoli, 2007
La grande storia della prima guerra mondiale / M. Gilbert. – Mondadori, 2003
Il mito della grande guerra / M. Isnenghi. – Il Mulino, 2007
Terra di nessuno: esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale / E. J. Leed. – Il Mulino, 2007
Cap. 2. La Russia rivoluzionaria
2.1 Due rivoluzioni, una a febbraio e l’altra a ottobre
Sul fronte russo la guerra si è fatta sentire in modo drammatico: tra i 12.000.000 di soldati russi, i morti sono stati 1.700.000; i feriti poco meno di 5.000.000.
In termini assoluti e percentuali la Russia è il paese che denuncia il massimo di perdite.
Numeri così alti sono dovuti in parte a una condotta di guerra nella quale i capi dell’esercito (essenzialmente lo zar e lo stato maggiore) si sono preoccupati relativamente poco di mandare i loro soldati allo sbaraglio, nella convinzione di poterli comunque rimpiazzare a sufficienza; in parte sono dovuti ai pessimi armamenti in dotazione ai soldati.
Intanto la produzione agricola e industriale, assorbita dalle richieste di rifornimenti ai combattenti, non è più sufficiente a soddisfare la domanda dei mercati cittadini.
Il blocco navale inglese e le incursioni sottomarine tedesche non aiutano certi, disturbando pesantemente il commercio navale nel Mare del Nord.
Il blocco dei Dardanelli e del Bosforo, messo in atto dall’Impero ottomano che è nemico della Russia, annulla il commercio nel Mar Nero.
A peggiorare definitivamente la situazione interviene anche la cattiva annata agricola che si registra nel 1916.
I prezzi dei beni alimentari vanno alle stelle e una gran parte della popolazione non sa più come fare.
All’inizio della guerra lo zar decide che San Pietroburgo è un nome troppo “germanico” per una capitale russa e per questo ribattezza la città col nome di Pietrogrado.
La città ospita i palazzi del governo e della Duma (Il Parlamento russo).
Ospita anche diverse industrie, tra cui la Putilov, una delle principali fabbriche russe di armi.
Dall’inizio del 1917 i suoi operai, e quelli di altre fabbriche situate nei dintorni della città, sono in agitazione.
Hanno manifestato all’inizio di gennaio per commemorare la domenica di sangue che ha fatto scoppiare la Rivoluzione del 1905.
Dal 18 febbraio (data determinata sulla base del calendario giuliano) [vedi parole della storia] sono in sciopero per ottenere aumenti di salario.
Il 23 febbraio 1917 per le strade di Pietrogrado scendono anche molte donne che vogliono celebrare la Giornata internazionale della donna [vedi parole della storia].
Fa un freddo terribile.
Ma le persone per strada sono molte.
E diventano ancora di più quando le donne si uniscono agli operai della Putilov, appena informati che la direzione della fabbrica ha deciso una serrata e che non vuole pagare loro un soldo in più di salario.
Agli slogan per l’emancipazione della donna se ne mescolano altri.
Per il pane.
Contro i capitalisti.
Contro il governo.
Contro la Duma.
Contro lo zar, perfino.
Ma lo zar è lontano, al fronte: vi si è recato il 22 febbraio, lasciando Pietrogrado in treno.
Il governo è distratto dalla guerra e non dà troppo peso alla manifestazione: altre ce ne sono state, altre ce ne saranno pensano i politici.
E quindi i reparti dell’esercito di stanza a Pietrogrado hanno l’ordine di non raccogliere provocazioni e di non intervenire.
Resta il fatto che, nonostante il freddo, la gente non smette di manifestare.
Dopo due giorni (25 febbraio) sono ancora lì, in 240.000 si stima.
Il 26 febbraio il governo, sollecitato dallo zar, ordina all’esercito di intervenire.
L’esercito lo fa sparando sulla folla: 40 morti trai dimostranti.
Fatto grave, certo, ma per il governo è ancora più grave che qualche reparto dell’esercito, proprio quel giorno, abbia dato segno di non voler ubbidire agli ordini.
Il giorno seguente, il 27 febbraio, un intero reggimento si ammutina.
Soldati stanchi, giovani, di estrazione popolare, in attesa di tornare al fronte non hanno alcuna voglia di sparare sulla folla.
E allora non ascoltano i propri comandanti e nella folla si mescolano, portandosi dietro altre armi, che vengono distribuite ai dimostranti.
La manifestazione dilaga e diventa rivoluzione.
Alla fine della giornata Pietrogrado è in mano agli insorti.
Informato dei fatti, Nicola 2. cerca di tornare rapidamente a Pietrogrado per ferrovia.
Nella mattina del 1 marzo, però, quand’è già sulla via del ritorno, il suo treno speciale viene deviato, perché i binari della linea per la capitale sono occupati dai dimostranti.
Il treno va a finire a Pskov, distante dalla capitale.
Lì lo zar, lontano dall’esercito, viene raggiunto da due deputati della Duma che gli comunicano che è opinione comune, dei parlamentari e dei membri del governo, che l’unico sistema per salvare la monarchia sia un’abdicazione sua e anche di suo figlio, a favore di suo fratello, il granduca Michele.
Nicola, disorientato e isolato, accetta.
Intanto altri delegati della Duma hanno rintracciato il granduca Michele, che però ha la strana idea di dire, con decisione, che potrebbe accettare la corona solo se gli fosse offerta da un’Assemblea Costituente.
Ma l’Assemblea Costituente non c’è, per il buon motivo che nessuno l’ha convocata.
La sua dichiarazione, dunque, è interpretata come una rinuncia.
E così – in modo un po’ surreale – la dinastia dei Romanov esce politicamente di scena.
Subito si diffonde la notizia che la Russia è diventata una repubblica.
Difficile credersi, ma è così.
Nei giorni seguenti la Duma nomina un governo provvisorio che costituisce quello che era stato nominato dallo zar.
Questo nuovo ministero è un governo di coalizione, formato dai rappresentanti di diversi partiti, ed è presieduto dal principe Georgy L’vov (1861-1925), esponente del Partito costituzional-democratico.
Il nuovo governo ha il compito di rinnovare gli assetti istituzionali e di prendere decisioni intorno alla guerra.
Questo secondo problema viene risolto per primo, poiché il governo decide che la nuova Russia terrà fede ai suoi impegni e continuerà a combattere.
Non è la linea che si aspettavano molti milioni di operai e operaie, contadini e contadine.
Nella città l’insoddisfazione è raccolta dai soviet.
Comitati di operai, già formatisi nel corso della Rivoluzione del 1905, adesso vengono ricostituiti ed esprimono opinioni politiche variegate, ma unite in una richiesta: che la guerra finisca al più presto.
Il soviet di Pietrogrado è particolarmente importante; è guidato dai dirigenti socialisti menscevichi (“minoritari”), mentre i bolscevichi (“maggioritari”) non vi hanno che una debole influenza.
La sua autorità, peraltro, non dipende tanto dal colore politico della dirigenza quanto dal fatto che è riuscito ad assicurarsi il controllo della rete ferroviaria, delle poste e dei telegrafi; inoltre ha assunto il comando delle forze armate ribelli, proclamandosi soviet degli operai e dei soldati.
Per questo il governo provvisorio proprio non può ignorarne l’esistenza e deve dialogare con i suoi capi intorno a ogni singola questione rilevante.
Nelle campagne, intanto, la tradizione delle rivolte contadine viene fatta rivivere: le case signorili vengono assaltare; le proprietà terriere vengono confiscate; e le merci prodotte vengono trattenute nei magazzini per far fronte alle esigenze alimentari delle comunità contadine.
Quest’ultima mossa peggiora la situazione sui mercati urbani, dove le merci arrivano ormai col contagocce.
Ad aprile il governo tedesco decide di mettere a disposizione un treno speciale perché Lenin, dirigente dei socialisti bolscevichi, all’epoca in esilio in Svizzera, possa tornare a Pietrogrado.
Lenin è già molto noto.
E’ in esilio dal 1907, ma ha scritto libri, opuscoli e ha un suo fedele seguito tra i militanti del Partito socialdemocratico bolscevico.
E’ notoriamente favorevole all’uscita della Russia dalla guerra: e questo è il motivo della mossa compiuta dal governo tedesco, la speranza che l’influenza di Lenin possa creare le condizioni per l’effettiva uscita della Russia dal conflitto (fatto che consentirebbe a una buona parte delle truppe tedesche impegnate sul fronte orientale di spostarsi su quello occidentale).
Appena giunto a Pietrogrado, il 4 aprile Lenin rende note le sue posizioni in un discorso tenuto ai socialdemocratici, il cui contenuto è subito pubblicato dal giornale bolscevico “Pravda” (parola che significa “Verità”), sotto il titolo di Tesi di aprile.
Lenin vi delinea un programma semplice ed estremamente radicale, che prevede il rovesciamento del governo provvisorio e il trasferimento del potere ai soviet, ai quali devono poter partecipare solo operai, braccianti e contadini (una posizione che si traduce subito in uno slogan di grande effetto: “Tutto il potere ai soviet!”); prevede inoltre l’uscita delle Russia dalla guerra e la nazionalizzazione di tutte le proprietà terriere (e anche questi due punti si traducono in uno slogan molto chiaro: “Pace, terra, pane!”).
Le linee di azione proposte da Lenin nelle Tesi d’aprile allontanano lui e i bolscevichi dagli altri raggruppamenti socialisti.
D’altro canto la differenza di posizioni viene resa quasi incolmabile dalla decisione presa ai primi di maggio dai menscevichi (cioè i socialdemocratici moderati) e dai social-rivoluzionari (membri di un partito molto forte nelle campagne, perché fa della riforma agraria il suo obiettivo programmatico primario) di entrare in un nuovo governo provvisorio, presieduto come il precedente dal principe L’vov.
L’elemento chiave in tutto questo quadro è la scelta di continuare la guerra, compiuta anche da questo nuovo governo provvisorio.
Nelle condizioni della Russia del 1917 è la scelta più impopolare che possa essere presa.
Se i social-rivoluzionari conservano il loro consenso nelle campagne, nonostante la decisione di partecipare al secondo governo L’vov, nelle città la geografia politica della sinistra sta cambiando.
Nel soviet di Pietrogrado, per esempio, i menscevichi cominciano a perdere terreno, mentre i bolscevichi, con i loro slogan a effetto, iniziano ad avere un cospicuo seguito.
Inoltre Lenin sta organizzando una presente forza paramilitare bolscevica (le Guardie Rosse), composta da circa 10.000 operai di Pietrogrado, a cui il soviet ha consegnato fucili e munizioni.
Ministro della guerra del secondo governo L’vov è Aleksandr Kerenskij (1881-1970), un social-rivoluzionario.
Kerenskij pensa che, per imporsi davvero, il governo dovrebbe giocarsi il tutto per tutto: una vittoria militare è quello che ci vorrebbe, e gli altri membri del governo sono d’accordo con lui su questa linea.
Però in tal modo il governo provvisorio si infila in una strada senza uscita.
L’esercito non è più in condizioni di compiere azioni militari efficaci.
L’offensiva contro gli austriaci in Galizia, che Kerenskij pensa possa essere la mossa risolutiva, si rivela disastrosa.
L’esercito russo è disfatto.
E all’interno la situazione precipita.
Prima, a Pietrogrado, all’inizio del luglio 1917, c’è un tentativo di rivolta popolare, organizzata da soldati e operai che cercano di impedire la partenza di reparti dell’esercito al fronte.
Questo tentativo fallisce per l’intervento di truppe fedeli al governo.
In questa circostanza L’vov dà le dimissioni da Primo ministro ed è sostituito proprio da Kerenskij, il quale cerca di sfruttare la situazione che si è creata per arrestare i principali capi bolscevichi accusati di comportamenti antipatriottici.
Sebbene Lenin riesca a sfuggire all’arresto, Kerenskij pensa egualmente di aver definitivamente eliminato il problema della conflittualità a sinistra.
Sfortunatamente per lui, il generale Lavr Georgievic Kornilov (1870-1918), che lo stesso Kerenskij ha nominato comandante in capo dell’esercito, tenta un colpo di Stato, marciando con un corpo di cavalleria verso Pietrogrado (26 agosto 1917).
Per Bloccarlo Kerenskij ha bisogno di del sostegno di tutti, sinistra bolscevica compresa: dunque i capi bolscevichi in carcere vengono amnistiati e liberati e gli operai della città vengono armati, evento che i bolscevichi sfruttano per riorganizzare e perfino potenziare le loro Giardie rosse.
Il tentativo di Kornilov viene bloccato, perché le sue truppe – contattate da propagandisti mandati dal governo – si rifiutano di combattere e si disperdono; Kornilov stesso viene catturato il 2 settembre.
Il pericolo è passato.
Ma adesso i bolscevichi sono di nuovo sulla scena: il loro prestigio è alle stelle perché, avendo contribuito a fermare Kornilov nonostante Kerenskij li abbia precedentemente messi in carcere, passano per il veri salvatori della Rivoluzione.
Il governo Kerenskij si regge ancora in piedi, ma a stento ormai.
Arrivato l’autunno, Lenin e i bolscevichi capiscono che è giunto il loro momento.
L’evolversi della situazione ha ampliato il loro seguito, che è particolarmente forte e ben organizzato proprio a Pietrogrado.
Ma il vento potrebbe cambiare direzione.
Per novembre, per esempio, è prevista l’elezione dell’Assemblea Costituente (per la quale potranno votare anche le donne, che con un decreto del 20 luglio 1917 hanno ottenuto il diritto di voto): se i risultati non fossero particolarmente positivi (e i bolscevichi temono l’esito elettorale nelle campagne), le loro aspettative potrebbero svanire del tutto.
Insomma non c’è un minuto da perdere.
E così, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1917, l’insurrezione bolscevica ha inizio.
Armi alla mano, sono i soldati filobolscevichi e le Guardie rosse a compiere un vero e proprio colpo di Stato militare, espugnando e occupando il Palazzo d’Inverno, dove ha sede il governo e arrestandone i membri (sal vo Kerenskij che riesce a fuggire).
I bolscevichi formano il governo, che si chiama Consiglio dei commissari del popolo ed è presieduto da Lenin, ha Trotskij come ministro degli Esteri, Stalin come ministro per le questioni nazionali e nemmeno un ministro che non sia bolscevico.
Prima ancora di formare il governo, comunque, Lenin annuncia subito al 2. Congresso panrusso dei soviet, l’assemblea dei delegati dei soviet di tutte le province dell’ex Impero russo, allora in corso, le due misure che verranno prese al più presto: saranno avviate trattative con gli imperi centrali per arrivare a una pace senza annessioni né indennizzi; sarà varato un decreto sulla base del quale tutte le proprietà terriere dei possidenti e della Chiesa saranno confiscate; la redistribuzione di questa terra verrà eseguita sulla base delle decisioni prese dall’Assemblea Costituente che dev’essere eletta entro breve; ma è certo, assicura Lenin, che le norme faranno in modo di attribuire a ogni famiglia contadina tutta la terra che può coltivare senza dove ricorrere a braccianti salariati.
Con questa rapidissima mossa i bolscevichi realizzano il punto fondamentale del programma dei social-rivoluzionari (“la terra ai contadini”) e con ciò sperano di aver tolto loro il consenso che molti anni si sono costruiti tra le comunità rurali.
Sbagliano.
Il 25 novembre 1917, nonostante il colpo di Stato rivoluzionario, si procede egualmente alla elezioni per l’Assemblea Costituente.
E lì si vede che il bolscevichi hanno ancora parecchia strada da fare: su 715 seggi ne ottengono 175; i menscevichi e il Partito costituzional-democratico quasi escono di scena; mentre i veri trionfatori sono i social-rivoluzionari moderati, con 370 seggi, in larga misura ottenuti nelle circoscrizioni rurali.
Il problema sarebbe grave se non fosse che i bolscevichi partecipano al gioco della democrazia con le carte truccate.
Nel gennaio del 1918, forti del sostegno di reparti dell’esercito a loro fedeli, decidono infatti che l’Assemblea Costituente è durata anche troppo e la sciolgono con la forza.
Così facendo risolvono un grave problema tattico (l’essere in minoranza alla Costituente) e seguono linee strategiche già tracciate da Lenin nelle Tesi d’aprile (niente più democrazia parlamentare); così facendo pongono anche le premesse per la costruzione di un regime politico dittatoriale a partito unico.
Parole della storia
Calendario giuliano
E’ un calendario astronomico messo in vigore da Giulio Cesare (da qui il nome) nel 46 a. C.
Nel 1582, per decreto di papa Gregorio 13., viene adottato un nuovo calendario, detto appunto gregoriano, che sostituisce il calendario giuliano e posticipa di tredici giorni l’inizio dell’anno.
Poiché in Russia la Chiesa ortodossa decide di non seguire le indicazioni del pontefice di Roma, lì rimane in vigore il calendario giuliano.
Ne 1917 è ancora così.
Ciò significa che le date degli eventi rivoluzionari sono anticipate di 13 giorni rispetto alle date in vigore nel resto dell’Occidente.
Ciò spiega perché, per esempio, la Giornata internazionale della donna, che dovunque si celebra l’8 marzo, a Pietrogrado sia celebrata il 23 di febbraio.
Nel gennaio 1918 anche in Russia viene adottato il calendario gregoriano.
Giornata internazionale della donna
SI tratta di un appuntamento stabilito nel 1910 dalla Conferenza internazionale femminile – promossa dall’Internazionale socialista – su proposta della socialista tedesca Klara Zetkin (1857-1933).
L’8 marzo viene scelto come data di una giornata che dovrebbe servire ad avvicinare le donne al socialismo.
Bibliografia
Storia della Russia sovietica / E. H. Carr. – Einaudi, 1979
La Rivoluzione russa da Lenin a Stalin, 1917-1929 / E. H. Carr. – Einaudi, 1980
La mummia di Lenin e lo scheletro dello zar / C. Grottanelli. – In: Il corpo, 1999, n. 8/9
La rivoluzione russa / A. Wood. – Il Mulino, 1999
Cap. 3. Il dopoguerra dell’Occidente
3.1 Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra
Per i governi europei lo sforzo economico per finanziare la guerra è stato enorme.
Francia, Regno Unito e Italia, soprattutto, hanno contratto debiti pesanti con gli Stati Uniti: hanno avuto bisogno di denaro per comprare armi e rifornimenti per i propri eserciti.
Inoltre, i paesi europei coinvolti nella guerra hanno emesso grandi quantità di cartamoneta, al di là dei limiti consentiti dalle riserve auree.
Il risultato di questa politica è stato che negli ultimi anni di guerra e nei primi del dopoguerra una violentissima inflazione ha scosso le economie di tutti i principali paesi europei.
In Germania il fenomeno ha assunto un livello assolutamente incredibile, perché i governi tedeschi, sia durante la guerra sia dopo, non hanno voluto fronteggiare le loro esigenze finanziarie ricorrendo all’incremento del prelievo fiscale, come hanno fatto gli altri paesi, e hanno invece basato tutta la loro azione su una ingente produzione di cartamoneta: questa scelta – dovuta anche a calcoli politici di cui diremo – ha accelerato il processo di svalutazione del marco (la moneta tedesca) e il conseguente aumento dei prezzi.
Una situazione di questo tipo sembra fatta apposta per inasprire le tensioni sociali.
Industriali e commercianti (molti dei quali già arricchitisi notevolmente durante la guerra) possono far fronte all’inflazione aumentando il prezzo dei prodotti (una strategia che a sua volta incoraggia ulteriormente l’inflazione).
Ma chi percepisce redditi fissi o comunque non modificabili a breve termine (operai, impiegati, proprietari di immobili e di terreni) subisce danni gravissimi: lo stesso stipendio che preso a gennaio vale 100 in termini reali, a febbraio vale 90, a marco 80 e così via; stessa cosa si verifica per gli affitti delle case o delle terre: qui i proprietari ci perdono e gli inquilini o gli affittuari ci guadagnano, perché lo stesso affitto che a gennaio vale 100 in termini reali, a febbraio vale 90, a marzo 80 e vis dicendo.
La fine della guerra determina pure una ridislocazione della manodopera.
L’industria pesante (siderurgica, meccanica), che ha avuto ovunque un grande sviluppo sollecitato dalla richiesta di armi e attrezzature per gli eserciti, deve ora riconvertire le sue produzioni al contesto di pace.
La riconversione comporta cambiamenti organizzativi, tecnici, tecnologici che, nell’immediato, provocano una diminuzione della produzione e di conseguenza un aumento della disoccupazione.
Al tempo stesso le imprese, per favorire la conversione delle linee produttive, cercano di contenere o anche di diminuire i salari operai.
Ne consegue un notevole incremento della conflittualità sindacale, che in alcuni casi è particolarmente accentuato.
Inoltre si pone un nuovo problema.
I soldati che tornano dal fronte hanno bisogno di trovare una loro collocazione lavorativa.
Negli anni di guerra molti dei posti di lavoro rimasti vuoti per le loro partenze sono stati occupati dalle donne che li hanno sostituiti.
Adesso c’è bisogno di prendere delle decisioni: rimandare a casa le donne dalle fabbriche o dai servizi, per riassumere gli ex soldati?
Oppure conservare operaie e impiegate e lasciare i reduci ai margini del mercato del lavoro?
Nel corso degli anni Venti la soluzione adottata un po’ ovunque è quella di rimandare le donne a casa, per far nuovamente spazio al personale maschile.
Oltre a tutto ciò, alla fine della guerra appare chiaro che i rapporti economici tra le aree economicamente più avanzate sono decisamente mutati.
Cinque anni di guerra hanno terremotato i flussi commerciali.
La guerra sul mare ha reso gli scambi in certi momenti quasi impossibili.
I sistemi produttivi europei sono stati piegati a garantire i rifornimenti degli eserciti.
Le merci europee non sono arrivate più in America né in Asia.
Stati Uniti e Giappone hanno colto l’occasione.
I loro sistemi produttivi e commerciali, solo parzialmente impegnati nella produzione di armi per l’esercito, hanno potuto occupare gli spazi lasciati vuoti dagli operatori europei.
I mercati sudamericani e asiatici passano, dunque, quasi completamente sotto il controllo delle economie statunitense e giapponese.
D’altro canto gli stessi paesi più prosperi di queste aree (l’Argentina, il Brasile, l’Australia) sfruttano l’occasione per sviluppare propri sistemi produttivi, capaci di produrre beni che dall’Europa non arrivano più.
Alla fine della guerra, dunque, gli Stati europei, oltre che sommersi dall’inflazione, si trovano a dover fronteggiare una concorrenza sui mercati internazionali che è molto più forte e organizzata di prima del 1914.
Gli stessi mercati europei, almeno nell’immediato, sono del tutto squassati.
Vi sono aree che a causa delle vicissitudini della guerra e del dopoguerra sono praticamente fuori dai circuiti di mercato; è il caso della Russia rivoluzionaria, ma in una certa misura è anche il caso della Germania, totalmente piegata sotto il peso dell’inflazione.
A peggiorare ulteriormente il quadro sta il fatto che i numerosi nuovi Stati nati nel dopoguerra, per la dissoluzione dell’Austria-Ungheria o per la crisi attraversata dalla Russia, tendono ad adottare subito politiche economiche protezionistiche, nella speranza di potersi dotare di propri autonomi sistemi produttivi: e ciò, nell’immediato, rende difficile una ripresa degli scambi.
Da tutto questo contesto, gli Stati Uniti cominciano a emergere come la potenza che ha ottenuto il massimo di benefici economici dalla guerra.
Tra il 1913 e il 1920 la produzione industriale nordamericana è aumentata del 22%, mentre quella europea è diminuita del 23%.
La bilancia commerciale (cioè il rapporto tra esportazioni e importazioni) è diventata talmente favorevole che tra guerra e dopoguerra gli Stati Uniti sono in grado di immagazzinare la metà delle riserve auree mondiali.
Questa situazione ha fatto sì che i principali paesi dell’Intesa abbiano contratto pesanti debiti di guerra con le banche, con le imprese e con il governo statunitensi, che hanno accumulato le risorse per concederli.
Oltre a ciò, e per lo stesso motivo, gli Stati Uniti sono diventati i principali esportatori di capitali nel mondo: alla fine della guerra il 30% degli investimenti delle banche o delle imprese statunitensi risultano collocati in banche, imprese e società per azioni europee.
Posta questa nuova e netta centralità che l’economia statunitense si è conquistata, è piuttosto inevitabile che i suoi governi e i suoi imprenditori e finanzieri siano i protagonisti del rilancio di un sistema economico globale che la guerra ha solo cambiato ma spinto sull’orlo del tracollo.
Parole della storia
Freikorps
Sono unità militari composte da volontari (gran parte dei quali sono reduci, o studenti, o disoccupati), pagati e attrezzati a spese dello Stato.
Le ragioni per le quali vengono costituite queste unità speciali sono diverse: sono un modo per disattendere l’ingiunzione imposta dalle potenze vincitrici, secondo la quale la Germania non può tenere un esercito che superi i 100.000 uomini; e sono anche un modo per dotarsi di unità capaci di fronteggiare i numerosi tentativi insurrezionali organizzati da comunisti o da simpatizzanti del bolscevismo.
Questo spiega anche perché i militi dei Freikorps siano individui che molto spesso hanno opinioni iper-nazionaliste e radicalmente anti-bolsceviche.
Bibliografia
La donna moderna “stile americano”: gli anni Venti / N. F. Scott. – In: Storia delle donne in Occidente: il Novecento / a cura di F. Thebaud. – Laterza, 2007
I ruoli sessuali in Francia e in Inghilterra: una transizione incerta / A.-M. Sohn. - In: Storia delle donne in Occidente: il Novecento / a cura di F. Thebaud. – Laterza, 2007
Gli anni ruggenti, 1919-1929 / A. Goldmann. – Giunti, 1994
La rifondazione dell’Europa borghese: Francia, Germania e Italia nel decennio successivo alla prima guerra mondiale / C. Maier. – Il Mulino, 1999
La Germania di Weimar / E. D. Weitz. – Einaudi, 2008
La Repubblica di Weimar, 1918-1933 / H. A. Winkler. – Donzelli, 1998
Cap. 2. Il fascismo al potere
2.1 Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra.
Dopo il 1918 l’Italia deve affrontare problemi analoghi a quelli fronteggiati dagli altri Stati europei che hanno vinto la guerra: c’è una forte inflazione da contenere; problemi di riorganizzazione produttiva da risolvere; una larga inquietudine sociale da soddisfare o da sedare.
Diversamente da ciò che accade in Francia e nel Regno Unito, però, l’Italia si trova ad affrontare le questioni nel mezzo di un vero e proprio terremoto politico-sociale, che piuttosto avvicina la sua situazione a quella delle potenze che hanno perso la guerra (prima fra le quali la Germania) che non alle altre potenze dell’Intesa.
Il terremoto è favorito dall’introduzione di due nuove leggi elettorali (1918-19) che prevedono il suffragio universale maschile e la rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista: ciò significa che alle elezioni si presentano liste di candidati, divise per partiti o gruppi politici, e che a ciascun partito tocca un numero di rappresentanti che è grosso modo simile al numero di voti ottenuto.
La riforma, approvata da un Parlamento a maggioranza liberale, è intesa come un contributo alla distensione politica e come un’opportunità perché si sviluppi una maggiore partecipazione democratica.
I dirigenti liberali sono convinti di poter dominare la situazione anche con le nuove regole elettorali.
Questa convinzione si rivela infondata.
Le nuove regole favoriscono i raggruppamenti politici che hanno strutture organizzative stabili e diffuse sul territorio, capaci di condurre una propaganda capillare ed efficiente.
Ma i liberali un’organizzazione del genere non ce l’hanno.
Quando arriva il momento delle prime elezioni da tenersi con le nuove norme (novembre 1919) i liberali non sono altro che il solito raggruppamento di personalità politiche, magari autorevoli, ma prive di un partito che li sorregga.
Invece altre due formazioni politiche, una appena nata e una da tempo parte del panorama politico italiano, mostrano di possedere organizzazioni solide e ben strutturate.
La prima formazione è il Partito popolare italiano (Ppi), partito cattolico fondato nel gennaio del 1919 e guidato da un sacerdote, don Luigi Sturzo.
La composizione del Ppi è assai variegata: vi aderiscono tanto i sostenitori della “democrazia cristiana”, cioè coloro i quali ritengono che il primo degli obiettivi che i cattolici devono realizzare sia una nuova politica sociale, quanto i cattolici moderati, che si pongono la linea di continuità con l’esperienza del cattolicesimo intransigente prebellico e sono scarsamente sensibili alle tematiche relative al miglioramento delle condizioni dei lavoratori dell’industria o dei contadini piccoli proprietari o dei braccianti agricoli.
L’altra formazione dotata di un’ottima struttura organizzativa è il Partito socialista italiano (Psi).
Non è un partito nuovo, perché esiste dal 1892.
E’ tuttavia un partito enormemente rinnovato negli orientamenti del suo gruppo dirigente.
Tra tutti i partiti socialisti europei è infatti quello che ha raccolto più direttamente e con maggior convinzione il messaggio che viene dalla Russia bolscevica.
Nel suo 16. Congresso Nazionale, tenutosi a Bologna tra l’8 e il 9 di ottobre del 1919, i delegati hanno approvato quattro importanti risoluzioni:
a) la Rivoluzione sovietica viene dichiarata ufficialmente modello di azione del Psi;
b) di conseguenza il partito decide di aderire all’Internazionale comunista (la Terza internazionale)
c) si riconosce che il partito deve poter ricorrere alla violenza se ciò è necessario per il conseguimento dei suoi fini;
d) tra questi fini c’è la demolizione dello Stato borghese, la realizzazione della dittatura del proletariato e, infine, la costruzione di un “nuovo ordine comunista”.
Questo programma, chiamato “massimalista”, va chiaramente al di là delle posizioni più estremiste assunte dai socialisti italiani prima della Grande Guerra.
Adesso i socialisti partecipano alle elezioni del novembre 1919 con la dichiarata intenzione di compiere al più presto possibile una rivoluzione sovietica: per questo motivo il loro grado di lealtà nei confronti delle istituzioni del Regno d’Italia appare estremamente dubbio a tutta quella parte di opinione pubblica che non condivide il loro programma.
Così stando le cose, si capisce come i risultati elettorali, che segnano una dura sconfitta dell’area liberale, aprano scenari politici piuttosto complessi.
Il tracollo dei liberali non li mette più in grado di formare da soli una maggioranza capace di sorreggere autonomamente un governo.
Tanto il governo in carica all’epoca delle elezioni, guidato da Francesco Saverio Nitti, quanto il governo successivo, guidato da Giovanni Giolitti (in carica dal giugno 1920 al giugno del 1921), sono composti prevalentemente da liberali di vario orientamento, con una presenza di alcuni ministri del Partito popolare, che garantisce un sostegno esterno alla maggioranza liberale.
Lo schema, sperimentato per la prima volta nel 1913 col “patto Gentiloni”, nel primo dopoguerra diventa un fattore più o meno permanente del quadro politico italiano.
Ma, nonostante questo appoggio esterno, i governi liberali non hanno una maggioranza solida che li sostenga in Parlamento; sono, dunque, dai governi politicamente fragili, che nondimeno si trovano a dover gestire dei conflitti socio-politici di enorme gravità.
Parole della storia
Totalitarismo
Il termine viene impiegato da osservatori e protagonisti dell’esperienza fascista per sottolineare il carattere particolare e nuovo dell’autoritarismo politico di cui il fascismo si fa interprete.
Dal lessico politico il termine si è trasferito al linguaggio delle scienze politiche grazie all’imponente studio di Hannah Arendt sulle Origini del totalitarismo, pubblicato nel 1951 (e tradotto in italiano nel 1967).
Generalmente gli studiosi della politica contemporanea parlano di totalitarismo nel caso di sistemi politici che abbiano le seguenti caratteristiche:
a. dominio di un partito unico che si identifica con le strutture istituzionali dello Stato;
b. presenza di una ristretta élite politica, dotata di poteri quasi illimitati
c. adozione di una rigida ortodossia ideologica, che viene imposta alla popolazione con sofisticati metodi polizieschi (fino all’uso sistematico del terrore) o con l’uso intensivo del sistema educativo e dei mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, ecc.)
d. Azione politica volta alla realizzazione di un “nuovo ordine” sociale, economico, politico, morale.
L’ambizione dell’obiettivo giustifica – agli occhi dei dirigenti e dei militanti del partito dominante – il ricorso a metodi coercitivi talora particolarmente violenti
Nell’analisi di Hannah Arendt i principali esempi di totalitarismo sono l’Unione Sovietica e la Germania nazista.
Quanto al fascismo è chiaro che ha evidenti e dichiarate ambizioni totalitarie; tuttavia si è sviluppata una larga discussione tra gli storici in merito alla maggiore o minore compiutezza dei caratteri totalitari del regime fascista, che alcuni hanno ritenuto limitata dalla presenza della monarchia (che tuttavia poco interferisce con lo sviluppo del regime) e dalla presenza della Chiesa cattolica, che invece – come vedremo – conserva effettivamente una larga e significativa autonomia anche all’interno dello Stato fascista
Bibliografia
Mussolini / R. De Felice. – Einaudi, 2005-2008
Storia del Partito fascista, 1919-1922 / E. Gentile. – Laterza, 1989
La conquista del potere: il fascismo dal 1919 al 1929 / A. Lyttelton. – Laterza, 1982
La prima guerra mondiale e il fascismo / N. Tranfaglia. – Utet, 1995
Storia delle origini del fascismo: l’Italia dalla grande guerra alla marcia su Roma / R. Vivarelli. – Il Mulino, 1991
Cap. 5. Civiltà in trasformazione
5.1 Il “fardello dell’Occidente”
Nel 1899, in occasione della guerra che l’esercito degli Stati Uniti combatte nelle Filippine, dove è in corso una ribellione indipendentista, un grande scrittore inglese, Rudyard Kipling, scrive una poesia nella quale descrive il compito dei colonizzatori occidentali chiamandolo il “fardello dell’uomo bianco”, cioè il peso che grava sulle spalle dell’uomo europeo.
Con questa espressione Kipling vuole indicare il grave compito morale che spetta ai colonizzatori, mossi, secondo lui, dal dovere di civilizzare popolazioni arretrate, anche a costo di affrontare mille pericoli e mille insidie.
Col passare degli anni agli occhi dei colonizzati il “fardello dell’Occidente” è un’espressione che ha acquistato un senso diverso: non più il peso morale che grava sulle spalle dei colonizzatori, bensì il peso dei colonizzatori stessi e della loro oppressione che grava sulle spalle dei colonizzati.
L’oppressione, già denunciata e occasionalmente combattuta prima del 1914, adesso acquista un altro colore.
Molti uomini che vengono da diverse parti del mondo hanno osservato le vicende della Grande Guerra, prevalentemente combattuta sul suolo europeo.
Lo hanno fatto come giornalisti, come diplomatici, come visitatori; ma il più delle volte lo hanno fatto come soldati arruolati nei reparti coloniali.
La guerra è stata, in una certa misura, una rivelazione.
L’Occidente può forse vantare superiorità tecnologiche; ma quali superiorità etiche può esibire, visto che spende così tante risorse e così tante energie nel massacrarsi?
L’esperienza della guerra e del dopoguerra offre anche esempi di modelli politici alternativi che – pur maturati in Europa – potrebbero essere impiegati lontano dall’Europa per combattere lo stesso Occidente imperiale; il fascismo, con la sua ambizione di fare di un piccolo paese una grande potenza sono solo degli esempi che sollecitano l’interesse di molti intellettuali e politici non occidentali.
In questo senso c’è una terza accezione contenuta nella locuzione “fardello dell’Occidente”.
E’ un accezione che indica la persistente influenza che i modelli politici e culturali dell’Occidente esercitano su paesi extraoccidentali.
Ian Buruma e Avishai Margalit, in un recente libro intitolato Occidentalismo: l’Occidente agli occhi dei suoi nemici (2004), scrivono che “l’Occidente fu combattuto con idee nate in Europa”.
Intendono dire che le ideologie o i movimenti politici antioccidentali, che cominciano a diffondersi nel periodo tra le due guerre, sono il prodotto del pensiero di intellettuali o dirigenti politici giapponesi, cinesi, indiani, arabi o egiziani che hanno studiato e fatto propri modelli politici e ideologici dell’Occidente, decidendo di impiegarli contro l’Occidente.
Effettivamente questo è ciò che accade.
Ma si deve aggiungere che in nessun modo il rapporto tra Occidente e altre parti del mondo è unilaterale.
Ogni singola esperienza di opposizione politica compiuta in Asia, in Africa o in America Latina rielabora in forma autonoma idee che vengono dall’Occidente, ibridandole però con tradizioni politiche, filosofiche e religiose locali: ne emergono culture politiche nuove, a volte terribili, a volte esaltanti, quasi sempre tragiche; tutte, comunque, segnalano che in altre parti del mondo ci sono moltissime persone che del “fardello dell’Occidente” vorrebbero liberarsi una volta per tutte.
Parole della storia
Radicalismo religioso islamico, Integralismo, Fondamentalismo
Sinonimi che designano le correnti del pensiero religioso islamico secondo le quali le istituzioni e la vita di uno Stato islamico debbono fondarsi sul rispetto rigoroso delle norme contenute nella Sharia.
Sceicco
Termino arabo che può significare “saggio anziano”, “capo di una tribù o di un clan”, “autorità religiosa islamica”.
In riferimento a ‘Izz al-Din al-Qassam il termine ha quest’ultimo significato.
‘Izz al-Din al-Qassam porta, in effetti, anche il titolo di imam, cioè di guida religiosa.
Sharia (legge islamica)
E’ l’insieme delle norme etiche e di comportamento derivate dai sacri testi islamici (che sono il Corano – il testo che riporta la voce di Allah, così come è stata ascoltata dal suo profeta, Maometto; e la Suma, ovvero l’insieme di testimonianze relative a ciò che il profeta Maometto ha fatto e detto nella sua vita).
Bibliografia
Occidentalismo: l’Occidente agli occhi dei suoi nemici / I. Buruma e A. Margalit. – Einaudi, 2004
Storia dell’Asia orientale, 1850-1949 / E. Collotti Pischel. – Carocci, 2008
Storia delle società islamiche / I. M. Lapidus. – Einaudi, 2000
Storia della Cina moderna, secoli 18.-20. / J. Osterhammel. – Einaudi, 1992
Storia dell’India / D. Rothermund. – Il Mulino, 2007
Islam / M. Ruthven. – Einaudi, 2007
La Cina nel Novecento: dalla fine dell’Impero a oggi / G. Samarani. – Einaudi, 2008
Cap. 6. La crisi economica e le democrazie occidentali
6.1 La crisi del ‘29
La seconda metà degli anni Venti per l’economia statunitense segna un periodo di notevole prosperità.
Cresce la produzione industriale – soprattutto quella dei nuovi “beni di consumo durevole”, cioè beni per uso provato e domestico che hanno una certa durata, come l’automobile, il frigorifero, la radio, l’aspirapolvere o la lavatrice.
Molti consumatori li comprano avvalendosi sia del nuovo sistema dell’acquisto a rate sia dei prestiti che si contraggono con le banche.
Comunque sia il mercato ha un segno favorevole, la domanda è in aumento, la produzione cresce, e se cresce la produzione anche i profitti e i salari hanno un andamento positivo.
Però c’è un piccolo granello, che si inserisce nell’ingranaggio.
I beni “durevoli”, per l’appunto, durano nel tempo: una volta che una famiglia ha comprato un frigorifero – che è un oggetto costoso -, lo sfrutta fin che può, non lo butta via dopo un mese e neanche dopo un anno, ma lo usa quattro, cinque, dieci anni di seguito e qualche volta anche più a lungo.
Ciò significa che il mercato nordamericano in questo settore ha un ritmo di sostituzione delle merci piuttosto basso.
E’, dunque, un mercato che tende a saturarsi in fretta: esplode all’inizio, quando nessuno ha l’aspirapolvere, o l’automobile, o la radio, e tutti vogliono acquistare questi beni: ma poi la domanda per tali oggetti tende a rallentare sempre di più di man mano che le famiglie ne hanno comprato un esemplare.
Quindi il mercato dei beni di consumo durevole tende ad essere molto dinamico all’inizio ma poi si satura.
Di conseguenza il tasso di crescita delle imprese in questi settori tende a rallentare.
E questo rallentamento si ripercuote sull’economia nel suo complesso, perché le industrie che producono automobili, frigoriferi, radio ecc., chiedono meno componenti e materie prime ai settori industriali collegati.
Gli imprenditori, i finanzieri, i risparmiatori non riescono a vedere subito questa dinamica, mentre si sta realizzando.
Anzi una grande ondata di euforia, legata ai buoni risultati del sistema economico statunitense, invita chiunque abbia qualche risparmio da parte ad acquistare i titoli azionari emessi dalle imprese, il cui valore sta crescendo rapidamente col crescere della produzione.
A un certo punto, intorno al 1927-28, le dinamiche della produzione e dei valori azionari si divaricano: mentre il mercato si va saturando – la produzione si fa eccessiva rispetto alla domanda e le ordinazioni segnano il passo -, il mercato borsistico continua ad andare come un treno.
Un po’ è perché si produce un “effetto inerzia”: i risparmiatori e gli operatori continuano a dare per scontato che il valore delle azioni continuerà a crescere, così come è cresciuto fin allora.
Un po’ è perché fanno effetto le manovre speculative messe in atto dagli operatori di Borsa: costoro comprano le azioni, aspettano un po’ che tali azioni abbiano acquistato un valore maggiore e poi le rivendono, considerando che, in definitiva, il margine di differenza tra prezzo al momento dell’acquisto e prezzo al momento della vendita garantisce un guadagno superiore al dividendo che l’azienda paga sulle azioni stesse.
E’ ciò che si chiama “bolla speculativa”, processo che stimola la crescita del valore delle azioni indipendendentemente dalle condizioni economiche reali delle aziende a cui tali azioni sono collegate.
Nell’autunno del 1929 tutto questo gioco smette di funzionare.
Gli operatori si accorgono che non c’è più alcuna relazione tra l’andamento economico della produzione e delle vendite, non troppo positivo, e il valore delle azioni, che invece è follemente positivo: allora cominciano a vendere le azioni.
La valanga prende il via lentamente e poi all’improvviso accelera.
Il 21 ottobre del 1929 gli operatori di Borsa di New York (Wall Street, il nome della strada newyorkese che ospita la sede della Borsa) cominciano a vendere assai più del solito (i titoli azionari venduti quel giorno ammontano a 6.000.000 di dollari); il 24 ottobre le vendite sono il doppio di quelle effettuate tre giorni prima.
L’onda anomala delle vendite eccezionali dissemina il panico tra tutti i possessori di azioni.
Il valore delle azioni comincia a scendere a rapidità vertiginosa per effetto dell’insolito aumento delle vendite.
I risparmiatori sembrano impazziti dallo spavento: vedendo andar giù il valore delle azioni cominciano a vendere tutti insieme.
E allora il valore delle azioni crolla del tutto.
Ecco cosa succede il 29 ottobre 1929, il “martedì nero” della Borsa di Wall Street: in un colpo solo vengono venduti titoli azionari per un valore complessivo di 16.500.000 dollari; e la caduta dei valori azionari continua a rotta di collo fino al 1932.
E’ un cataclisma che si ripercuote subito sulle banche.
I portafogli azionari delle banche (cioè l’insieme dei titoli che le banche hanno acquistato come forma di investimento, e che contengono anche titoli azionari) ne sono travolti, come quelli di tutti gli altri operatori.
Qualche piccola banca si trova subito in difficoltà: i prestiti che ha concesso risultano ora di un valore superiore a quello del suo portafoglio, portafoglio che la crisi di Wall Street ha drammaticamente svalutato.
I prestiti concessi sono a medio-lungo termine, quindi nell’immediato non c’è speranza di ottenere i soldi indietro dai debitori.
La piccola banca comincia ad avere difficoltà a pagare gli interessi sui depositi, cioè sui soldi che i risparmiatori hanno messo sui loro libretti o sui loro conti correnti.
I risparmiatori, quando vedono che la banca ritarda il pagamento degli interessi, si allarmano.
Quando poi si accorgono che la banca è in difficoltà non solo a pagare gli interessi ma anche a restituire i soldi depositati, ecco che subito si creano le file davanti gli sportelli bancari, con i risparmiatori, sopraffatti dalla paura di perdere i propri risparmi, che vogliono i propri soldi indietro subito, senza ulteriori indugi.
Quando qualche banca – magari qualche piccola banca – comincia a dichiarare il fallimento, cioè dice “non possiamo più darvi indietro i vostri soldi”, il panico esplode e diventa totale; tutti i risparmiatori, anche i clienti delle banche ancora abbastanza solide, si precipitano agli sportelli per avere indietro il proprio denaro.
E’ una catastrofe, perché a quel punto le banche più solide, che pure riescono a resistere all’ondata di panico e a restituire i risparmi ai correntisti senza fallire, poi non hanno più risorse per il prestito alle imprese.
Le imprese statunitensi, che già cominciavano ad essere in difficoltà per la saturazione dei mercati, a quel punto sono messe con le spalle al muro; sia per la flessione della domanda sia per la crisi bancaria non hanno più soldi per mandare avanti la produzione, acquistare materie prime, pagare gli stipendi.
Hanno solo poche soluzioni: chiudono o rallentano fortemente la produzione; in entrambi i casi devono licenziare operai e impiegati; nel secondo caso devono diminuire le retribuzioni e abbassare i prezzi.
E qui parte un’altra spirale perversa: gli operai o gli impiegati licenziati e disoccupati non hanno più uno stipendio e quindi non possono comprare più beni di consumo, anche se tali beni adesso costano molto meno di prima.
Se poi i loro risparmi sono stati bruciati dalla crisi borsistica o dal crollo bancario, a stento riescono a far fronte alle spese primarie (l’alimentazione, il riscaldamento, il mutuo per la casa).
Ancora peggio vanno le cose nelle aree rurali.
Buone annate agricole hanno già fatto cadere i prezzi dei prodotti negli anni precedenti: adesso i prezzi si inabissano e non per l’aumento dell’offerta ma per la caduta della domanda.
I proprietari terrieri (specialmente i piccoli proprietari terrieri) o gli affittuari non sanno come fare per acquistare fertilizzanti, semi, mangime per il bestiame, macchine; se hanno contratto debiti, i loro creditori chiedono indietro il denaro o danno avvio ad azioni legali per requisire le proprietà terriere.
Insomma si tratta anche qui di un cataclisma economico sociale.
Ecco che ha inizio la “grande depressione”.
Diversamente da quella che ha avuto luogo negli anni 1873-96, questa è una vera, tremenda depressione.
Tra il 1929 e il 1932 negli Stati Uniti 100.000 aziende industriali ed esercizi commerciali falliscono; le banche che sono costrette a chiudere sono 5000 (gran parte delle quali è costituita da piccole o piccolissime banche rurali o di città di provincia); i salari sono in caduta libera; i disoccupati passano da 3 a 13 milioni.
L’economia statunitense si ritrova in ginocchio, senza quasi aver capito bene perché.
Ma molto presto anche le economie europee sono brutalmente scosse dalla crisi.
Il “contagio” degli Stati Uniti all’Europa è causato dallo stretto collegamento che nella seconda metà degli anni Venti si è creato tra il sistema finanziario statunitense e quello tedesco, e per quella via il sistema tra il sistema statunitense e quello britannico, francese, italiano e di altri paesi europei.
Come si ricorderà, il rapporto finanziario tra Stati Uniti ed Europa è attivato dal Piano Dawes del 1924, che instaura un ciclo strutturato in questo modo: finanziamenti Usa a Germania che permettono delle riparazioni tedesche a Francia, Regno Unito, Italia che pagano interessi e debiti a Usa che – e qui il circuito ricomincia – concedono finanziamenti a Germania… e così via di seguito [cfr. cap. 3.2].
La crisi, dunque, si diffonde attraverso questo circuito e arriva rapidamente in Europa.
Il processo si svolge così: le banche o i risparmiatori statunitensi smettono di investire in titoli tedeschi, perché non lo possono più fare; anzi chiedono la restituzione dei soldi prestati.
Le banche tedesche vanno in crisi, perché non sono in grado di restituire i soldi ricevuti dagli operatori finanziari, che li chiedono indietro per saldare i debiti con le banche o con i finanziatori statunitensi.
La crisi delle banche si ripercuote a sua volta sulle imprese tedesche, che non ricevono più prestiti ed anticipazioni.
Quindi, di nuovo, sebbene con un leggero ritardo temporale, anche in Germania si ripresenta al stessa sequenza che ha caratterizzato la crisi statunitense: diminuzione della produzione → aumento drammatico del tasso di disoccupazione (molti operai vengono licenziati) → diminuzione del livello delle retribuzioni (gli imprenditori abbassano i salari degli operai e gli stipendi degli impiegati che continuano a lavorare) → crollo della domanda (molti non hanno più denaro per acquistare beni di consumo, o perché sono disoccupati, o perché hanno salari o stipendi più bassi) → discesa dei prezzi, dovuta alla diminuzione dell’offerta e alla caduta della domanda.
E poi dalla Germania, il “virus” della crisi si trasmette alle economie britannica, francese, italiana, seguendo una dinamica analoga.
Come prima risposta per fronteggiare la crisi diversi governi adottano la soluzione si svalutare le monete.
Fa sensazione la svalutazione della sterlina, decisa dal governo britannico nel 1931: la sterlina fin allora è stata considerata la moneta più stabile, tanto che alla metà degli anni Venti il sistema monetario internazionale ha cominciato a basarsi su quello che si chiama il gold exchange standard, ovvero sul principio secondo il quale le banche centrali di altri paesi possono regolare l’emissione di cartamoneta sulla base della disponibilità di riserve auree e di riserve di sterline inglesi.
Ma ora neanche la sterlina regge ai colpi della crisi.
A che cosa serve la svalutazione monetaria?
Serve a far costare meno i prodotti del paese che ha svalutato, quando essi vengono esportati all’estero.
I governi sperano in questo modo di rilanciare la propria economia stimolando le esportazioni e scaricando così su altri paesi le proprie difficoltà.
Ma il gioco è troppo semplice e troppo scoperto; ed è anche molto facile da fronteggiare: tutti i governi, infatti, reagiscono alzando le tariffe doganali e quindi annullando l’impatto delle manovre di svalutazione monetaria.
Risultato finale: il commercio internazionale crolla in un modo mai visto prima (si passa da 68 miliardi di dollari di merci scambiate nel 1929 ai 24 del 1933).
L’impatto economico, psicologico, sociale della crisi è devastante.
Il numero di suicidi ha un’impennata sconvolgente: persone che il giorno prima avevano una buona condizione economica, un lavoro, una bella famiglia, il giorno dopo si ritrovano sulla strada, senza un soldo in tasca.
La paura, la rabbia, l’inquietudine si diffondono come non mai.
L’opinione pubblica vuole che i politici diano risposte; che provvedano ai loro bisogni; che scovino i “colpevoli” di questa catastrofe.
Un numero crescente di persone, specie quelle direttamente colpite dalla crisi, ha necessità di ricevere un qualche sostegno materiale; mentre tutti – anche quelli che hanno conservato il lavoro e salvato i risparmi – hanno un disperato bisogno di essere rassicurati.
Le risposte che i vari sistemi politici danno a queste domande sono molto diverse: in alcuni paesi la grande crisi sollecita un rinnovamento dei sistemi democratici; in altri paesi ne provoca la distruzione.
Bibliografia
Storia degli Stati Uniti / O. Bergamini. – Laterza, 2008
La grande depressione del mondo, 1929-1939 / C. P. Kindleberger. – Etas, 1982
Crisi tra le due guerre mondiali, 1919-1939 / R. J. – Il Mulino, 1998
Il secolo degli Stati Uniti / a. Testi. – Il mulino 2008
Il New Deal / M. Vaudagna (a cura di). – Il Mulino, 1981
Cap. 7. Nazismo, fascismo, autoritarismo
7.1 L’ascesa del nazismo
A metà degli anni Venti la Germania è riuscita a superare una crisi economica di gravità inaudita, perché l’attivazione del piano Dawes e del piano Young ha riportato un po’ di prosperità [cfr. cap. 3.2].
Ma la tranquillità non dura a lungo.
La grande crisi del ’29 colpisce la Germania con una durezza inaudita.
L’economia tedesca dipende direttamente dai finanziamento che vengono dagli Stati Uniti, e quando l’economia statunitense va in crisi il sistema economico tedesco sprofonda: la produzione industriale e quella agricola crollano; le fabbriche chiudono o licenziano un gran numero di operai.
Nel 1932 i disoccupati sono quasi 6.000.000, un numero che è pari al 30% della forza lavoro tedesca.
E’ un’enormità: vuol dire che un lavoratore su tre è disoccupato.
E per moltissimi è un vero dramma.
Molte famiglie sono in ginocchio: non hanno risparmi da parte, spazzati via in grande misura dalle crisi inflazionistiche dei primi anni Venti; e ora si ritrovano con uno o più membri della famiglia che non hanno più lavoro e non sanno assolutamente come vivere.
La disperazione si mescola alla rabbia.
E’ una rabbia che ha bisogno di trovare sollievo, conforto, sostegno.
Ma il sistema politico tedesco non sembra in grado di rispondere a queste richieste.
I governi che si succedono dal 1930 al 1932 non riescono a trovare una linea di politica economica adeguata alla gravità della situazione.
E’ in questo contesto che avviene ciò che – appena qualche anno prima – sarebbe sembrato assolutamente impossibile; il piccolo partito fondato da Hitler (la Nsdap, il partito nazionalsocialista) riscuote un consenso crescente; nelle elezioni del 1930 ottiene il 18,3% dei voti, percentuale che lo fa diventare il secondo partito dopo il Partito socialdemocratico (Spd); nelle prime elezioni del 1932 raccoglie addirittura il 37,3% dei voti, una percentuale che lo fa diventare di gran lunga il primo partito (la Spd in quelle elezioni raccoglie solo il 21,6% dei voti) ma, nonostante ciò, resta il partito più grande, col 33,1% dei voti (mentre al Spd vede calare ancora i suoi consensi e si ferma al 20,4%).
Il nazismo costruisce il suo successo su tre elementi primari: un nazionalismo estremamente aggressivo, con chiare implicazioni belliciste; un razzismo egualmente estremo; e una capacità di tradurre la sua aggressività verbale in concreti attacchi fisici a coloro a coloro che si indentificano come “nemici del popolo tedesco”.
Nel contesto della crisi dei primi anni Trenta questi tre aspetti dell’azione nazista un grande effetto su una parte significativa dell’opinione pubblica tedesca.
Il nazionalismo soffia sul fuoco del risentimento contro le condizioni imposte alla Germania dal trattato di Versailles [cfr. cap. 1.8; 3.2].
Questo è sicuramente un punto dolente delle relazioni internazionali nel decennio successivo alla Grande Guerra.
E moltissimi, in Germania, anche con un orientamento moderato, o perfino socialista, hanno pensato che l’onore della nazione tedesca sia stato profondamente offeso a Versailles: la Germania – pensano costoro – non è stata l’unica responsabile della guerra; non è nemmeno stata veramente sconfitta, , posto che nel 1918 gli eserciti alleati non sono nel suo territorio.
Perché infliggerle le innumerevoli sofferenze provocate dalla terribile inflazione del primo dopoguerra, altra conseguenza della pace?
E perché portarle via territori e colerne a tutti i costi ridimensionare le ambizioni territoriali, che altre potenze (come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti) non hanno smesso di coltivare?
Pensieri di questo genere trovano nella polemica nazista sollecitazioni e risposte forti.
Ma questa polemica diventa tanto più convincente quanto più i nazisti affermano di conoscere i “veri” responsabili delle sofferenze del popolo tedesco.
Questi responsabili non sono solo le potenze straniere e i partiti della Repubblica di Weimar, che non hanno saputo difendere adeguatamente gli interessi tedeschi, ma sono soprattutto gli ebrei e i comunisti: sono costoro – sostengono i capi nazisti – che tramano nell’ombra e non desiderano altro che la rovina del popolo tedesco.
E molti provano un certo conforto nell’ascoltare i nazisti e nell’illudersi di aver capito, grazie a costoro, chi sono i “veri” colpevoli della loro disoccupazione, della loro miseria, delle loro differenze.
L’ebreo è e rimane un tipico parassita, uno scroccone, che, come un bacillo nocivo, continua a diffondersi là dove trova un ambiente adatto.
E l’effetto della sua esistenza è proprio quello dei parassiti: dovunque si installi, il popolo che lo ospita prima o dopo muore.
Così l’ebreo in ogni tempo ha vissuto negli Stati di altri popoli, e lì ha formato un proprio Stato, che è rimasto mascherato sotto la forma della “comunità confessionale”, fino al momento in cui le circostanze non gli hanno consentito di palesare la sua vera natura.
Ma non appena si è sentito abbastanza sicuro, ha fatto cadere il velo ed è apparso per quello che è, a dispetto delle convinzioni di molti: un ebreo.
Nella vita dell’ebreo come un parassita nel corpo di altre nazioni e di altri Stati sta una caratteristica che una volta ha indotto Schopenhauer […] a definirlo “il grande bugiardo”.
L’esistenza spinge l’ebreo a mentire, e a mentire perpetuamente […].
La sua vita tra altri popoli può durare a lungo solo se egli è in grado di accreditare l’opinione secondo la quale il suo non è un popolo ma una “comunità religiosa”, sebbene di un tipo speciale.
E questa è la prima grande bugia.
Alla fine di poter vivere come un parassita in mezzo ad altri popoli, egli è costretto a negare la sua vera natura.
Tanto più intelligente è il singolo ebreo, tanto più avrà successo in questa operazione.
Di fatti, le cose possono spingersi così avanti che gran parte del popolo che lo ospita può seriamente credere che un ebreo sia davvero un francese o un inglese, un tedesco o un italiano, sebbene di una particolare fede religiosa.
Le aggressioni a comunisti, a socialdemocratici e a cittadini di confessione ebraica, compiute dalle associazioni paramilitari naziste, sono tollerate dai governi e dalle autorità di polizia: e ciò fa sì che esse abbiano, talvolta, uan micidiale efficacia.
Tragicamente, ciò aumenta il prestigio del partito nazista.
Molti simpatizzanti o elettori della Nsdap considerano le azioni dei gruppi paramilitari come una conferma del fatto che Hitler e i suoi “fanno sul serio”, cioè che vogliono davvero tener fede alla promessa di punire o cacciare coloro i quelli hanno tradito il popolo tedesco nella Grande Guerra, coloro i quali ancora vogliono una rivoluzione comunista o coloro i quelli – per una loro intrinseca “essenza razziale” – dovrebbero essere considerati estranei alla nazione tedesca.
Il profilo sociale dei militanti o dei simpatizzanti nazisti dice ancora altre due cose sulle ragioni del successo della Nsdap.
Una gran parte degli iscritti al Partito nazionalsocialista è composta da giovani o da giovanissimi; il 70% dei membri ha meno di quarant’anni; nel 1933 Hitler ha 44 anni; gli altri esponenti di primo piano del Partito nazista (o quelli che negli anni seguenti fanno carriere folgoranti) sono tutti più giovani di lui: Hermann Göring ha 40 anni; Rudolf Hess ne ha 39; Joseph Goebbels 36; Heinrich Himmler 33; Reinhard Heydrich 29; Albert Speer 28.
La loro giovinezza è apprezzata da molti e soprattutto dai loro coetanei i quali, per effetto delle trasformazioni demografiche, sono la maggioranza della popolazione tedesca (nel 1933 i tedeschi e le tedesche della fascia d’età compresa tra i 15 e i 40 anni sono più di 27.000.000, pari al 41% del totale della popolazione, mentre coloro che hanno dai 40 anni in su sono 24.195.000, pari al 37,7%).
Una buona parte degli uomini che hanno tra i 35 e i 45 anni è reduce della Grande Guerra ed è sensibile alla propaganda nazionalista dei nazisti.
Diversi tra i più giovani vedono nell’aggressività verbale e fisica dei nazisti altrettanti gesti di ribellione contro le vecchie generazioni, una rivolta generazionale per la quale provano simpatia.
D’altro canto i dirigenti politici dei principali partiti che sostengono la Repubblica di Weimar sono anziani, o molto anziani: un aspetto, questo, che gioca a favore dei nazisti, che possono presentarsi come l’”onda giovane” della politica tedesca, contro il “branco di vecchi incapaci” che guida i partiti moderati.
Un buon numero di sostenitori della Nsdap viene dalla classe operaia.
Ma il nucleo della base elettorale è composto dai ceti medi (impiegati privati e pubblici), dai liberi professionisti e dagli studenti.
Un certo numero di importanti imprenditori elargisce cospicui finanziamenti al Partito nazista, mentre i giornali posseduti da Alfred Hugenberg (1865-1951), grande imprenditore di destra che tra il 1930 e il 1932 raccoglie il 7-8% dei voti), presentano i nazisti in termini iperpositivi.
Dopo una rapida sequenza di crisi di governo, che ha luogo tra l’ottobre del 1931 e il dicembre del 1932, al presidente della Repubblica, il generale Paul von Hindenburg (1847-1934), non resta che dare l’incarico di Primo ministro a Hitler, ovvero al capo di quello che è diventato il partito di maggioranza relativa.
Il 30 gennaio 1933 Hitler riceve il mandato e forma un governo di coalizione nel quale i ministri nazisti sono tre su undici, mentre gli altri incarichi sono attribuiti a esponenti degli altri partiti della destra moderata.
Non Passa un mese che un episodio mai del tutto chiarito offre a Hitler un’occasione per raggiungere il suo vero scopo, e cioè imporre un regime politico a partito unico.
L’episodio accade nella notte del 27 febbraio 1933, quando la sede del Parlamento (il Reichstag) viene data alle fiamme.
La responsabilità viene attribuita ai comunisti e subito Hitler sfrutta l’occasione per sospendere i diritti costituzionali (libertà di stampa, di associazione, di espressione) e per ordinare alla polizia di arrestare migliaia di dirigenti e militanti comunisti.
Nel marzo del 1933 si tengono nuove elezioni, accompagnate questa volta da pesanti intimidazioni e aggressioni dei gruppi paramilitari nazisti contro comunisti, socialdemocratici e cattolici.
I nazisti ottengono un risultato trionfale (44% dei voti), che li mette in condizione di governare da soli.
Ma Hitler non vuole governare in un contesto parlamentare.
In un quadro di continue intimidazioni, col Partito comunista fuori legge e con i suoi deputati che vengono dichiarati decaduti e poi arrestati, Hitler presenta al Parlamento un decreto che gli dovrebbe concederei pieni poteri.
Il Parlamento approva.
E’ la fine della Repubblica di Weimar e la nascita del Terzo Reich nazista, l’Impero tedesco che succede al Sacro romano impero e all’Impero guglielmino.
Ma questo è un Reich nuovo, giovane, che – dicono i capi nazisti – questa volta durerà mille anni.
Parole della storia
Eugenetica
Disciplina che intende organizzare la riproduzione degli individui in modo tale da ottenere tipi umani sempre più adatti alle condizioni ambientali che sono destinati a trovare e sempre più coerenti con gli elementi fondamentali che sono propri della presunta razza di appartenenza.
Può avere applicazioni positive (politiche pronataliste selettive) o negative (politiche di sterilizzazione o di eliminazione di soggetti “inadatti”).
Eutanasia
Il termine letteralmente significa “buona morte”(dal greco eutanasia, composto da eu, “bene” e tanatos, “morte”).
Nel linguaggio odierno indica la scelta di procurare una morte breve e indolore a persone affette da malattie incurabili, con lo scopo di porre termine alle loro sofferenze.
L’eutanasia nazista non ha affatto queste finalità, poiché la soppressione dei malati vuole solo eliminare persone “razzialmente inadatte”.
Bibliografia
La Germania nazista: dalla Repubblica di Weimar al crollo del Reich hitleriano / E. Collotti. – Einaudi, 1995
Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia / E. Collotti. – Laterza, 2000
Mussolini il duce / R. De Felice. – Einaudi, 2007-2008
Il culto del Littorio: la sacralizzazione della politica nell’Italia fascista / E. Gentile. – Laterza, 2009
Hitler e l’enigma del consenso / I. Kershaw. – Laterza, 2009
Storia sociale del Terzo Reich / D. Peukert. – Sanson, 1989
L’eclissi della democrazia: la guerra civile spagnola e le sue origini / G. Ranzato. – Bollati Boringhieri, 2004
Cap. 8. L’Unione Sovietica di Stalin
8.1 Un’economia “pianificata”
Isolata nel lontano Est d’Europa, l’Unione Sovietica si riaffaccia attivamente nel contesto internazionale proprio con la guerra di Spagna.
E’ un’Unione Sovietica che, nel frattempo ha precisato e – in una certa misura – modificato le sue strutture istituzionali, politiche e sociali.
Tra il 1927 e il 1929 Stalin si è imposto come il dirigente indiscusso del Partito comunista sovietico e della stessa Unione Sovietica.
Dopo aver difeso il valore della Nuova politica economica, che – introdotta nel 1921 – ha parzialmente liberalizzato gli scambi commerciali e le attività produttive, in particolare quelle agricole [cfr. cap. 2.3]. Stalin decide di cambiare completamente linea di azione, promuovendo l’industrializzazione del sistema produttivo e la completa collettivizzazione dell’agricoltura.
Per realizzare questo progetto ricorre allo strumento della pianificazione, ovvero della definizione di obiettivi produttivi da raggiungere entro archi di tempo determinati, sotto il controllo e la guida degli organi centrali di governo.
Nel 1928 viene messo a punto il primo “piano quinquennale”, dal 1932 al 1937 entra in vigore il secondo; nel 1938 ne viene messo a punto un terzo.
Per un aspetto almeno i risultati sono strabilianti.
La produzione industriale cresce a ritmi assolutamente sorprendenti, soprattutto l’industria siderurgica, meccanica, estrattiva ed elettrica hanno uno sviluppo straordinario.
Una parte del paesaggio fisico dell’Unione Sovietica cambia aspetto.
Dal 1928 al 1940 gli occupati nell’industria passano da 4.000.000 a 11.000.000.
Vengono costruite 8000 nuove industria, alcune delle quali di dimensioni gigantesche.
Intere nuove città industriali sorgono quasi dal nulla, specie nell’area degli Urali.
Si favorisce una enorme migrazione interna, con un gran numero di famiglie contadine che si muovono dalle campagne verso le città industriali, dove trovano lavoro nelle nuove fabbriche.
Si calcola che tra il 1928 e il 1940 30.000.000 di persone si siano trasferite nelle città.
La rete stradale e ferroviaria, sulla quale viaggiano queste masse di migranti, è enormemente potenziata.
Egualmente rafforzate sono le strutture educative, specie quelle che servono alla formazione di personale tecnico da impiegare nei ruoli direttivi delle industrie.
Gli studenti – maschi e femmine – crescono dagli 8.000.000 del 1918-19 ai 35.000.000 del 1939-40.
Risultato complessivo: nel 1940 l’Unione Sovietica è diventata la terza potenza industriale del mondo, con indici produttivi che sono inferiori solo agli Stati Uniti e alla Germania.
E’ chiaro che si tratta di un risultato eccezionale.
E’ chiaro pure che i ritmi accelerati con i quali è stato ottenuto hanno richiesto costi molto pesanti.
Dal punto di vista puramente sociale tutta questa operazione si basa su un’enorme compressione del tenore di vita della popolazione.
I salari sono bassi e non si muovono al passo con l’andamento dei prezzi, che crescono più rapidamente.
Le condizioni di vita nelle città sono misere e i livelli di consumo incomparabilmente inferiori a quelli dei paesi occidentali.
Sebbene questi aspetti diano già la misura dello sforzo che l’industrializzazione accelerata costa al paese, sono assolutamente niente quando siano confrontati col trattamento riservato ai produttori agricoli.
A fianco dell’industrializzazione, infatti, Stalin e i suoi collaboratori hanno deciso di attuare una completa collettivizzazione delle aziende agricole.
Tutti i contadini – e in particolare i kulaki, cioè i proprietari terrieri che hanno raggiunto con la Nep uno stato di apprezzabile agiatezza – sono costretti ad associare le loro aziende a cooperative agricole (i kolchoz) o a cederle ad aziende possedute e gestite dallo Stato (i sovchoz).
L’operazione ha una sua razionalità economica: si vuole fare in modo che l’agricoltura produca quantitative di derrate prefissati, a un prezzo stabilito dai pianificatori, in modo da poter sorreggere l’industrializzazione che si sta realizzando nelle aree urbane; e per far questo è necessario che tutta la produzione sia sotto controllo diretto o indiretto dello Stato.
Ciò che va al di là di ogni razionalità sono i metodi utilizzati per realizzare il progetto.
Poiché molti contadini, e ovviamente i kulaki per primi, non vogliono aderire spontaneamente al piano di collettivizzazione dell’agricoltura, vi sono forzati con brutali metodi coercitivi: le aziende vengono espropriate; i proprietari vengono deportati (nel 1930-31 le famiglie di kulaki deportate in Siberia sono 381.173, per un totale di 1.800.000 persone); in molti casi chi si oppone viene giustiziato come “nemico della rivoluzione”.
Economicamente e socialmente questo aspetto dell’azione del governo sovietico si rivela un disastro: tra il 1928 e il 1937 la produzione agricola è in declino ovunque, non solo per la difficoltà di riorganizzare l’intera produzione sulla base delle nuove direttive ma anche perché molti dei contadini che sono forzatamente costretti a lavorare nel kolchoz o nei sovchoz lo fanno senza alcun entusiasmo, tanto che a metà degli anni Trenta si torna di nuovo al sistema delle requisizioni forzare dei prodotti.
Il momento più drammatico di tutta questa vicenda è quello che, nel 1932-33, travolge l’Ucraina, dove scoppia una tremenda carestia di fronte alla quale il governo non fa assolutamente niente.
Gli esiti sono terribili: si stima che i morti per fame siano stati trai 7 e i 10.000.000.
Bibliografia
L’Urss di Lenin e Stalin: storia dell’Unione Sovietica, 1914-1945 / A. Graziosi. – Il Mulino, 2007
Storia sociale dello stalinismo / M. Lewin. – Einaudi, 1988
Stalin e lo stalinismo / M. McCauley. – Il Mulino, 2004
Il radioso avvenire: mitologie culturali sovietiche / G. P. Piretto. – Einaudi, 2001
L’arcipelago Gulag: saggio di inchiesta narrativa / A. Solzenicyn. – Mondadori, 2001
Cap. 9. La seconda guerra mondiale
9.1 Dall’”Anschluss” al patto di Monaco
Non è facile trovare un singolo responsabile per la crisi che ha travolto l’Europa nel 1914: tutte le grandi potenze, quale più, quale meno, hanno contribuito a soffiare sul fuoco delle tensioni internazionali che lo stesso sistema di alleanze formatosi nei precedenti trent’anni non aveva affatto attenuato.
Non è per niente difficile, invece, individuare qual è il soggetto che dalla metà degli anni Trenta spinge sistematicamente verso la guerra: è la Germania nazista.
I suoi capi non fanno certo mistero delle loro ambizioni: rimettere in discussione gli accordi di Versailles e assicurare al Reich tedesco nuovi spazi e nuovi territori verso est.
Questi sono i capisaldi espliciti della loro politica estera.
Si tratta di una linea aggressiva che si muove in un progressivo crescendo.
I primi obiettivi sono rivendicati in nome di una “innocente” ricomposizione del popolo tedesco all’interno di un unico Stato, il Reich.
E quindi, in primo luogo, a Berlino si vuole l’Anschluss, cioè l’annessione, dell’Austria.
E’ un obiettivo caldeggiato dal Partito nazista austriaco, ma non condiviso da una larga parte del sistema politico e dell’opinione pubblica austriaci.
Un tentativo di colpo di Stato, organizzato nel 1934 in Austria dai nazisti locali, è stato represso a costo della vita dell’autoritario Cancelliere austriaco, Dolfuss [cfr. cap. 7.5]
In quella circostanza le truppe tedesche non sono intervenute anche per una decisa pressione di Mussolini, preoccupato per quella che all’epoca gli sembra solo un’esagerata espansione della Germania.
Ma dopo l’avventura in Etiopia l’Italia si avvicina alla Germania – dalla quale riceve sostegni materiali e appoggio diplomatico.
Nell’ottobre del 1936 le buone relazioni diplomatiche, si traducono in un’alleanza (l’”Asse Roma-Berlino”), rinsaldata da un ulteriore accordo del novembre 1937, che include anche il Giappone, e dalla collaborazione nella guerra di Spagna a sostegno delle truppe di Franco.
In questo mutato contesto Mussolini non ha più ragione di temere la Germania di Hitler; perciò non si oppone più all’annessione dell’Austria al Reich.
I nazisti austriaci, spalleggiati dal Reich tedesco, si adoperano per far cadere il regime guidato dal Cancelliere Schuschnigg, che ha sostituito Dolfuss alla guida dell’Austria.
I continui disordini interni promossi dai nazisti inducono Schuschnigg a tentare la carta di un referendum per verificare l’orientamento dell’opinione pubblica in merito all’annessione.
E’ una buona mossa, perché la maggioranza dell’opinione pubblica austriaca sembra favorevole alla conservazione dell’autonomia.
Proprio per questo Hitler decide di tagliar corto: schiera le sue truppe al confine, pronte ad attaccare; e Schuschnigg, a quel punto, lascia il suo posto di Cancelliere al nazista austriaco Arthur Seyss Inquart (1892-1946): costui, come primo atto di governo, apre le frontiere all’esercito tedesco, che entra a Vienna il 13 marzo 1938.
E’ l’atto di forza che conduce alla formale annessione dell’Austria alla Germania.
Tutta l’operazione avviene senza che nessun’altra potenza europea faccia alcun passo concreto per opporvisi.
In particolare il governo britannico, guidato dal conservatore Neville Chamberlain, dà la sensazione di accettare il fatto compiuto, “pro bono pacis” (“perché la pace sia conservata”).
Hitler, invece, non del tutto a torto, interpreta l’atteggiamento britannico come un gesto di debolezza e si appresta a compiere un’altra mossa, cioè annettere i Sudeti, territorio di confine tra Germania e Cecoslovacchia, incluso nei confini della Repubblica cecoslovacca ma con una popolazione in maggioranza tedesca.
Nel settembre del 1938 Hitler ingiunge al governo tedesco di cedere il territorio dei Sudeti.
Mussolini prende allora l’iniziativa di una conferenza internazionale, alla quale partecipano lui stesso, Chamberlain, in rappresentanza del Regno Unito, il primo ministro francese, Edouard Daladier (1884-1970) e Hitler.
La conferenza si tiene a Monaco il 29-30 settembre 1938; unilateralmente, senza consultare il governo cecoslovacco, Italia, Regno Unito e Francia riconoscono alla Germania il diritto di annettersi i Sudeti, diritto subordinato solo alla celebrazione di un plebiscito di annessione.
La conclusione del patto di Monaco è salutata dall’opinione pubblica occidentale come un grande risultato, perché si pensa che il successo diplomatico e l’annessione dei Sudeti basti alla Germania nazista, e che la pace sia definitivamente al sicuro.
Parole della storia
Collaborazionismo
Il termine deriva dall’affermazione fatta da Pétain il 24 ottobre 1940, quando, in un incontro con Hitler, egli dichiara che il suo governo è disposto a una “collaborazione, in linea di massima, con i nazisti”.
In realtà la collaborazione – a volte forzata, a volte attiva e partecipe – è integrale.
Il termine passa così ad indicare – per la Francia come per ogni altro paese sotto occupazione nazista – la cooperazione attiva di dirigenti o forze politiche locali con le autoritànaziste.
Einsatzgruppen (Gruppi operativi)
Si tratta di sei unità collegate alla Wehrmacht e composte da membri del Sicherheitsdienst, il servizio di sicurezza delle SS, e da membri della polizia tedesca.
Le Einsatzgruppen sono poste sotto il comando di Reinhard Heydrich e hanno il compito di eliminare fisicamente tutti gli “elementi ostili” che la Wehrmacht incontra nel suo cammino verso est.
Inizialmente si concentrano sugli oppositori politici (o presunti tali).
Nei mesi e negli anni seguenti sono impegnate sistematicamente in operazioni di rastrellamento e sterminio della popolazione tedesca.
Embargo
Sanzione economica con la quale un paese sospende i rapporti commerciali con un altro paese in occasione di una grave crisi diplomatica, vietando alle proprie aziende di svolgere attività commerciali con gli operatori del paese sottoposto a embargo.
Guerriglia
Una formazione armata che non ha la possibilità o la forza di affrontare in campo aperto un esercito nemico ricorre a tattiche di guerriglia, che consistono in imboscate o azioni di disturbo contro convogli o postazioni nemiche isolate, compiute da piccole unità mobili di combattenti.
Marines
Corpo di fanteria trasportato da mezzi anfibi, cioè da mezzi capaci sia di navigare sia di muoversi sulla terraferma.
Arrivando dal mare, i marines sbarcano sulla terraferma per operazioni di guerra
Partigiani
Il termine indica gli appartenenti a formazioni combattenti irregolari che, nei territori occupati da une esercito nemico, compiono operazioni di guerriglia contro le truppe straniere o contro i loro sostenitori locali.
In questa accezione il termine comincia a diffondersi proprio in questi anni nell’Urss occupata dai nazisti; da lì si diffonde al resto d’Europa.
Portaerei
Una portaerei è una nave da guerra di grandi dimensioni, che dispone di un’ampia piattaforma dalla quale possono decollare, e sulla quale possono atterrare, aerei da combattimento.
Il loro impiego in guerra diventa rilevante proprio nel corso della seconda guerra mondiale.
Bibliografia
Crimini e memorie di guerra: violenze contro le popolazioni e politiche del ricordo / L. Baldissara e P. Pezzino (a cura di). – L’Ancora del Mediterraneo, 2004
Guerra ai civili: occupazione tedesca e politica del massacro / M. Battini e P. Pezzino. – Marsilio, 1997
Uomini comuni: polizia tedesca e “soluzione finale” in Polonia / C. R. Browning. – Einaudi, 2004
Il sogno del ‘Grande spazio’: le politiche d’occupazione nell’Europa nazista / G. Corni. – Laterza, 2005
Mussolini l’alleato / R. De Felice. – Einaudi, 2008
I volenterosi carnefici di Hitler: i tedeschi comuni e l’Olocausto / D. J. Goldhagen. – Mondadori, 2002
La distruzione degli ebrei d’Europa / R. Hilberg. – Einaudi, 1999
L’occupazione tedesca in Italia, 1943-1945 / L. Klinkhammer. – Bollati Boringhieri, 2007
L’Olocausto nella storia / M. R. Marrus. – Il Mulino, 2000
Una guerra civile: saggio storico sulla moralità della Resistenza / C. Pavone. – Einaudi, 2006
Storia della Resistenza in Italia / S. Peli. – Einaudi, 2006
Il nuovo ordine mediterraneo: le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa, 1940-1943 / D. Rodogno. – Bollati Boringhieri, 2003
Storia della Seconda guerra mondiale / A. J. P. Taylor. – Il Mulino, 2000
Cap. 10. Dopo la guerra, 1945-50
10.1 Ombre lunghe di una guerra appena conclusa
Un’altra primavera.
E poi un’altra estate.
E’ il 1945.
Nella vita di molti milioni di persone nuovi sorrisi asciugano le lacrime, chiudono le ferite, cancellano i lutti.
Forse si può sperare ancora.
Forse non ci sono solo devastazione, morte, dolore, fame, paura.
Forse.
Se si ha ancora qualche attività da svolgere, e se si può guadagnare fortunatamente qualcosa, si riesce a comprare un quotidiano: e allora può anche darsi che quella sensazione di sollievo sia corroborata da una notizia che viene da San Francesco.
Il 25 aprile 1945 nella città californiana si riuniscono i rappresentanti di 50 nazioni che, due mesi più tardi, il 26 giugno 1945, approvano lo Statuto di un nuovo ente sovranazionale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu).
Il preambolo e l’Articolo 1 dello Statuto spiegano le finalità dell’Organizzazione.
Nel 1946 l’Onu tiene a Londra la sua prima Assemblea Generale, che accetta la proposta che viene dal Congresso degli Stati Uniti di porre a New York la sede centrale dell’Onu (dal 1952 ospitata nel Palazzo di Verto, un edificio all’epoca avveniristico, disegnato da una squadra di importanti architetti, tra cui spiccano i nomi di Le Corbusier e di Oscar Niemeyer).
L’Assemblea Generale si riunisce una volta all’anno e raccoglie i rappresentanti dei paesi membri.
Organo fondamentale è il Consiglio di Sicurezza, composto dai rappresentanti dai rappresentanti di cinque membri permanenti (Usa, Urss, Cina, Regno Unito e Francia) e di dieci membri di altri paesi, eletti per mandati temporanei.
Il Consiglio di Sicurezza ha il potere di prendere decisioni vincolanti per i paesi membri dell’Onu e in casi estremi può autorizzare l’intervento delle sue forze armate, composte da contingenti messi a disposizione dai vari paesi che fanno parte dell’Organizzazione.
I cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno comunque un diritto di veto che può bloccare ogni iniziativa, anche se sostenuta a maggioranza da tutti gli altri membri.
Dotata di altre strutture istituzionali collegate, l’Onu ha l’ambizione di proporsi come una sorta di governo mondiale e sembra in grado di svolgere un’azione assai più incisiva della Società delle Nazioni di cui ha preso il posto.
Al momento, comunque, nella primavera-estate del 1945, nessuno può sapere quale sarà il suo destino, anche se ci si rallegra egualmente che un’iniziativa del genere sia stata presa a protezione della pace appena riconquistata.
Può darsi sia questo ciò che pensa chi legge quella notizia sulla Conferenza di San Francisco.
E può darsi che ciò aiuti a sentirsi meglio.
Ma poi il cuore diventa di nuovo pesante.
Di nuovo torna quella sensazione di paura che negli anni precedenti tutti coloro i quali si sono trovati a vivere l’esperienza della guerra hanno imparato a conoscere.
Infatti se il nostro lettore gira la pagina del giornale trova altre notizie; e se non le trova sul giornale le sente raccontare in giro; o, se ha veramente sfortuna, va a finire che gli capita di esserne testimone, o peggio ancora protagonista.
Non sono belle notizie, perché dicono che è quasi coem se la guerra non volesse finire, come se volesse ancora dare un suo terribile colpo di coda.
Che cosa succede insomma?
Succede che, un po’ ovunque, la Liberazione dal nazi-fascismo e la fine della guerra sono accompagnate da violenze, vendette, esecuzioni sommarie, assassinii politici a danno dei collaborazionisti o di ex fascisti, le cui proporzioni quantitative sono decisamente impressionanti.
In Francia si calcola che al momento della Liberazione, tra agosto e settembre 1044, le uccisioni e le esecuzioni sommarie abbiano falciato tra le 17.000 e le 18.000 persone.
In Italia nella fase della Liberazione (primavera 1945) si stima che siano stati uccisi in scontri o giustiziati con esecuzioni sommarie tra i 10.000 e i 12.000 ex fascisti.
Ulteriori uccisioni continuano nei mesi seguenti, in una situazione di caos istituzionale, in cui i regolamenti di conti privati, vendette politiche, linciaggi rituali si sommano gli uni agli altri.
Uno dei luoghi in cui più si concentrano le uccisioni dei fascisti è l’Emilia-Romagna: tra aprile e maggio del 1945 nella sola provincia di Reggio Emilia – secondo l’accurata statistica redatta da Massimo Storchi – vengono uccise 435 persone che a vario titolo hanno aderito alla Repubblica sociale italiana.
Uccisioni di dimensioni paragonabili insanguinano la Valel Padana.
Osserva, al riguardo, lo storico italiano Santo Peli: “in quei giorni non solo giunge a compimento una guerra civile particolarmente sanguinosa, ma anche una guerra civile dove passioni e lutti recenti si intrecciano a memorie di violenze, uccisioni e persecuzioni risalenti a vent’anni prima; né è certamente casuale che le eliminazioni illegali perdurino più a lungo e più intensamente laddove, come in Emilia, più duro e violento era stato lo scontro tra il fascismo degli agrari e il bracciantato più organizzato e combattivo della pianura padana” (Peli si riferisce alle aggressioni delle squadre fasciste, compiute tra il 1919 e il 1922).
Le esecuzioni sommarie colpiscono soprattutto gli uomini e molto più raramente le donne.
Ma ciò non significa che in questi mesi le donne siano al riparo dalle violenze.
Tutt’altro: anch’esse sono esposte alle aggressioni e ve ne sono di quelle che le riguardano in modo particolare.
Intento ci sono gli stupri.
Studi recenti mostrano che i soldati dell’Armata Rossa entrati in Germania, oltre che a saccheggiare le abitazioni private e a maltrattare i civili – incoraggiati in questo dalle autorità sovietiche che vogliono attuare un’immediata punizione della popolazione tedesca -, si abbandonano anche a sistematiche aggressioni sessuali contro le donne tedesche.
Le stime variano molto, ma è certo che si è trattato di un fenomeno di massa: nella sola Berlino molte migliaia (forse molte decine di migliaia) di donne tedesche sono state stuprate dai liberatori sovietici.
Fenomeni simili sono accaduti in altre città della Germania.
Lo stesso è avvenuto in Italia, soprattutto a opera delle trupe coloniali francesi, composte da un corpo di spedizione di 12.000 soldati algerini e marocchini, i quali nel corso del 1944 hanno compiuto una serie impressionante di saccheggi, violenze e stupri in tutta l’area da loro percorsa, dalla Campania al Viterbese, alla Toscana (dintorni di Siena), autorizzati o tollerati dai loro comandanti.
Anche in questo caso le stime, necessariamente approssimative, parlano di diverse migliaia di stupri commessi nella grande maggioranza dei casi ai danni di donne italiane (una vicenda ricordata nel romanzo La ciociara di Alberto Moravia, del 1957, e nel film omonimo girato da Vittorio De Sica nel 1960.
In forma più occasionale sono state registrate numerose aggressioni sessuali compiute individualmente da soldati nordamericani in Italia, in Francia o in Germania; ma in questo caso non si è trattato di azioni sistematiche come quelle ricordate sopra.
Alcune donne sono vittime di altre violenze, fisicamente meno brutali, ma psicologicamente quasi altrettanto traumatiche.
Si tratta delle punizioni riservate alle donne accusate di aver collaborato con i nazisti.
Sono punizioni non legali, che tuttavia vengono organizzate in pubblico e assumono la forma di un rituale di degradazione: gruppi di partigiani, spesso accompagnati da un gran folla, individuano donne che hanno avuto relazioni con soldati tedeschi, o che sono accusate solo di averli aiutati; queste donne vengono trascinate fuori casa, vengono rasate a zero e viene loro imbrattata la faccia, in una sorta di disonorevole contro-cosmesi; poi sono costrette a sfilare in pubblico per le strade della città o del villaggio tra gli insulti e le irrisioni degli altri abitanti, molti dei quali ben conosciuti dalle vittime.
Casi di questo genere accadono in un gran numero di paesi: in Italia, Belgio, Danimarca, Norvegia, Cecoslovacchia, Polonia e Jugoslavia; in Francia sono 20.000 le donne accusate id collaborazionismo che vengono sottoposte a questo trattamento.
Se riescono a filtrare, notizie terribili arrivano anche dall’Istria, da Gorizia e da Trieste.
Il simbolo di queste violenze sono le foibe, grotte carsiche perpendicolari, alle quali si può accedere attraverso una stretta imboccatura che si apre a picco sulla cavità sottostante.
Che cosa succede in questo angolo di Europa?
In due momenti distinti si scatenano due successive ondate di violenza.
La prima ha luogo nel settembre-ottobre 1943, quando l’Istria interna, dopo la caduta del fascismo, viene occupata dal movimento partigiano comunista jugoslavo; in questa circostanza vengono giustiziati “infoibati”, cioè gettati nelle foibe, 500-600 militari italiani.
Una seconda fase, molto più grave, ha luogo nel maggio-giugno 1945, con strascichi che proseguono nei mesi successivi fino al 1946.
Teatro di questa seconda ondata di violenze sono Trieste, Gorizia e Fiume, occupate dalle truppe jugoslave che fanno parte delle truppe del movimento comunista guidato da Tito.
In questo periodo reparti delle truppe comuniste jugoslave, dell’Organ Zastite Naroda Armije (Ozna, Reparto di protezione del popolo) – la polizia politica comunista jugoslava – e della Guardia del Popolo – la polizia che dipende dalle autorità civili jugoslave – compiono violentissime azioni di repressione contro coloro che sono considerati nemici del nuovo potere comunista in via di formazione: vittime delle azioni sono militari della Repubblica sociale italiana; esponenti fascisti locali; ma poi membri non comunisti del Cln della Venezia-Giulia; membri della Guardia di finanza italiana della legione di Trieste, che hanno collaborato col Cln italiano; in qualche caso anche comunisti italiani che hanno manifestato dissensi nei confronti delle autorità italiane e poi semplici civili italiani.
Tra le vittime istriane ci sono anche – sebbene in proporzioni molto minori – sloveni e croati anticomunisti o accusati di collaborazionismo (i croati collaborazionisti, spesso ex membri delle formazioni Ustasa, giustiziati dai comunisti jugoslavi in altre parti del paese, sono molto più numerosi).
Diverse di queste persone vengono giustiziate nel corso di esecuzioni sommarie; i cadaveri sono occultati nelle foibe, di cui, talvolta, si chiudono le imboccature facendole esplodere.
Altre persone sono condotte nei campi di concentramento allestiti dalle autorità jugoslave, dove trovano la morte per maltrattamenti o per denutrizione.
Non si dispone di una statistica complessiva e attendibile dei morti, per la difficoltà di reperire documenti d’archivio che rechino traccia di queste operazioni e anche per la difficoltà di identificare tutte quante le foibe.
Nondimeno, sebbene le cifre proposte oscillino moltissimo (tra un minimo accertato di 5000 e un massimo più ipotetico di 17.000 morti), è chiaro che si tratta dell’ennesimo massacro collettivo che insanguina l’Europa di questi anni.
Per quale motivo le forze jugoslave attuano una repressione così violenta?
In parte lo fanno perché sono motivate dal desiderio di vendicarsi per l’occupazione nazifascista della Jugoslavia e per il tentativo di italianizzazione dell’Istria messo in atto dal governo fascista nei decenni precedenti; in parte l’operazione è una componente della più complessiva strategia del movimento comunista sloveno, integrato nel movimento comunista jugoslavo diretto da Tito, che vuole compiere subito un’epurazione drastica di tutti i potenziali oppositori del regime comunista in formazione; in parte c’è una netta componente nazionalista, che ha due obiettivi: ricostruire e potenziare l’identità croata e slovena; allontanare quanto più è possibile la popolazione italiana dalla regione, per assicurarne il controllo, annetterla alla Jugoslavia comunista e procedere a un ripopolamento dell’area con popolazioni slave.
L’obiettivo viene raggiunto quando la sorte del territorio italiano istriano viene definitivamente decisa con la firma del trattato di pace di Parigi, del 10 febbraio 1947.
Il trattato, siglato dai rappresentanti dell’Italia e della Jugoslavia, assegna l’Istria alla Jugoslavia.
La città di Trieste e la zona circostante vengono costituite in territorio libero di Trieste, un’area extraterritoriale, divisa in realtà in due parti: la Zona A, che include la città di Trieste, viene assegnata all’amministrazione alleata; la Zona B, a sud di Trieste, viene amministrata dalla Jugoslavia.
Nel 1954 la Zona A viene incorporata nel territorio italiano e la Zona B in quello jugoslavo; questo stato di fatto viene riconosciuto nel 1975 dal trattato di Osimo siglato da Italia e Jugoslavia.
Come effetto di tutta questa faccenda, dal 1045, e poi ancor di più dal 1947, fino agli anni Sessanta, c’è un imponente esodo di italiani che decidono di lasciare l’Istria e di trasferirsi in Italia (ma in effetti è una decisione forzata, posta l’evidente ostilità delle autorità jugoslave nei loro confronti).
Le stime più attendibili suggeriscono che l’”esodo istriano” abbia coinvolto 250.000 persone: le autorità jugoslave costringono i profughi italiani ad abbandonare tutti i beni mobili e immobili di cui sono in possesso: le case, le terre e i negozi abbandonati vengono riassegnati a famiglie croate o slovene.
L’”esodo istriano” fa parte di un quadro più generale di movimenti forzati di popolazioni, che caratterizza l’intero dopoguerra.
Come nel caso dell’Istria, anche altrove tali spostamenti sono causati da profondi cambiamenti nella carta politica dell’Europa.
Dichiariamo subito la logica di questi cambiamenti.
La trasformazione della carta politica è condotta sulla base di una spartizione dello spazio europeo attuata, sulla base di accordi formali o sulla base di azioni di forza, dalle due grandi potenze che escono davvero vincitrici della guerra, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica.
Gli Stati Uniti nel 1945 contano all’incirca 150.000.000 di abitanti.
In guerra hanno subito perdite contenute (300.000 soldati circa).
La loro economia ha prodotto armi e ogni altro tipo di strumento o risorsa per le nazioni alleate, e continua tuttora a farlo.
Ancor più che dopo la prima guerra mondiale, gli Usa adesso si impongono economicamente, tanto che, alla fine della guerra, disponendo del 6% della popolazione mondiale, gli Usa producono la metà de prodotto interno lordo globale, oltre ad essere tecnologicamente all’avanguardia e ad avere tutti gli apparati produttivi integri e in perfetta efficienza.
L’Unione Sovietica, dopo la guerra, ha all’incirca 200.000.000 di abitanti.
Le perdite che ha subito sono incredibilmente più alte di quelle sofferte dagli Usa.
I sovietici morti durante la guerra sono stati 20.000.000 circa, 15.000.000 dei quali erano civili.
L’economia sovietica ha retto allo sforzo della guerra, ma non ha l’energia dinamica di quella statunitense.
L’autorità dell’Urss dipende dal prestigio morale che il paese si è conquistato nella lotta contro i nazisti, specie tra i molti simpatizzanti della causa comunista che ci sono in tutta Europa.
Stalin, inoltre, può contare anche su un altro strumento, ben più potente del solo prestigio; un esercito determinato, alimentato dalle grandi risorse demografiche dell’Urss e motivato dai riconoscimenti per la guerra vinta ( e dalle razzie che i soldati sovietici possono compiere nei territori occupati).
E così è facile capire come la riorganizzazione della carta d’Europa dopo la guerra si strutturi intorno alla formazione di due blocchi politici principali e contrapposti, uno occidentale, che gravita intorno agli Usa, e uno orientale, che gravita intorno all’Urss.
L’avanzata dell’Armata Rossa verso Est, fino alla presa di Berlino, ha permesso all’Urss di inglobare subito entro i suoi confini l’Estonia, la Lituania e la Lettonia, che all’epoca di nuovo scompaiono come paesi indipendenti; poi viene inglobata la Carelia ex finlandese; un lembo della Slovacchia; l’intera Polonia orientale.
La Polonia viene compensata con la Slesia, la Pomerania, la Prussia e un lembo della Posnania, tutte aree che erano appartenute in precedenza alla Germania.
Il territorio della Germania viene ridotto di molto, ed è suddiviso in quattro zone.
L’intera area orientale intorno a Berlino è affidata all’amministrazione dell’Urss.
La Germania occidentale è divisa in diverse regioni affidate all’amministrazione di Stati Uniti, Regno Unito e Francia.
Lo stesso accade alla città di Berlino, che è divisa in quattro zone, una per ciascuna di queste quattro potenze.
Ciò che avviene nell’Europa di questi anni sembra un gioco da tavolo, come il Risiko, un gioco in cui ciascun partecipante mette le sue bandierine colorate su una parte del tabellone man mano che i suoi piccoli carri armati di plastica “conquistano” territori.
Ma questa operazione non è per niente un gioco e costa un altro mare di dolore.
Ogni spostamento di confine comporta che vengano spostate centinaia di migliaia di persone da una zona all’altra, quasi sempre contro la loro volontà.
In particolare da tutte le aree dell’Est vengono cacciati i tedeschi, sia che siano immigrati recenti trasferitisi in accordo con il Generalplan Ost dei nazisti [cfr. cap. 9.7] sia che abitino a Est da generazioni e generazioni.
Sono ben 12.350.000 i tedeschi – uomini, donne, bambini – che se ne devono andare, soprattutto dalla Prussia, dalla Pomerania, dalla Slesia, ma anche dall’Ungheria, dalla Cecoslovacchia, dalla Romania, dalla Jugoslavia, durante uno dei più grandi controesodi della storia.
E se ne vanno, con mezzi di fortuna, verso un paese – la Germania – dove a volte le macerie sono più dei muri che stanno dritti.
Con loro, dall’Est, arrivano anche – scheletriti, disorientati, storditi dalle sofferenze – i reduci dei campi di concentramento, soprattutto ebrei ma non solo ebrei.
Se prima della deportazione abitavano in Occidente, tentano di tornare alla loro casa, ma spesso scoprono di non possederla più: o perché è stata distrutta da qualche bombardamento; o perché - sulla base delle leggi razziali – è stata sequestrata e assegnata a qualcun altro; o perché è stata aperta, saccheggiata, devastata.
Un dolore che sembra non finire.
Ma che forse può essere almeno in parte lenito dalle iniziative che si stanno prendendo a Ovest.
Qualcuna ha un valore simbolico.
Per esempio tra l’autunno del 1945 e l’autunno del 1946 a Norimberga (città simbolo del nazismo; cfr. cap. 7.3) un Tribunale militare composto da giudici delle potenze vincitrici processa 24 alti dirigenti nazisti, cui sono attribuite tre diverse imputazioni: “crimini contro la pace”; “crimini di guerra” (violazione delle norme che regolano i rapporti tra i combattenti); “crimini contro l’umanità” (l’accusa specifica è quella di “genocidio”).
Dieci degli imputati sono condannati a morte; ; nove vengono impiccati; uno dei condannati. Göring, si suicida in carcere.
Un processo analogo, con i medesimi tipi di imputazione, si tiene anche a Tokyo dal 3 maggio 1946 al 12 novembre 1948, contro 28 alti dirigenti giapponesi; sono in sette ad essere condannati a morte e giustiziati, tra cui l’ex primo ministro Hideki Tojo.
Il processo è reso possibile dal fatto che il Giappone fino al 1951 è occupato e controllato dagli Stati Uniti.
Il generale Douglas MacArthur (1880-1964), che è il responsabile dell’amministrazione, impone nel 1946 una nuova Costituzione democratica, redatta da funzionari americani.
Altre misure hanno una concretezza molto maggiore.
Non hanno effetti immediati, ma sul più lungo periodo portano con sé notevoli benefici.
Su proposta dei governi di Stati Uniti, Canada e Regno Unito, già nel luglio del 1944 si è tenuta a Bretton Woods (New Hampshire, Usa) una conferenza internazionale con lo scopo di definire le modalità dei rapporti finanziari dopo la conclusione della guerra.
Nel corso della conferenza, cui partecipano 44 paesi, viene accolta una proposta dell’economista John Maynard Keynes [cfr. cap. 6.2] con la quale i paesi che partecipano alla conferenza accettano di basare le emissioni monetarie non solo sulle riserve auree ma anche sul dollaro americano – che in questo modo sostituisce la sterlina inglese come principale valuta internazionale.
Inoltre viene costituito l’International Monetary Fund (Imf, Fondo monetario internazionale); si tratta di un’istituzione finanziaria internazionale, a cui peraltro non aderiscono l’Urss né la Cina, che dispone delle riserve finanziarie concesse dai paesi membri in ragione del loro rispettivo peso economico; scopo del fondo è concedere aiuti ai paesi che hanno una bilancia dei pagamenti [vedi parole della storia] in grave deficit; questi aiuti prendono forma di prestiti ricavati dalle riserve finanziarie di cui il Fondo dispone.
Inoltre viene fondata la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo; costituita con lo stesso criterio del Fondo monetario internazionale, essa ha obiettivi diversi, poiché ha il compito di finanziare le ricostruzione dei paesi che hanno subito danni di guerra o di sostenere con prestiti speciali l’industrializzazione dei paesi ancora sottosviluppati.
La rete di integrazione globale, di cui queste istituzioni gettano le fondamenta, viene consolidata con la sottoscrizione del General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt, Accorso Generale sulle Tariffe e sul Commercio), avvenuta a Ginevra nel 1947.
Inizialmente al Gatt aderiscono ventitré paesi; poi seguono molti altri paesi (come del resto è avvenuto per le altre istituzioni economiche internazionali).
I paesi che aderiscono al Gatt tengono conferenze periodiche, nella quali vengono stabilite le regole generali per favorire gli scambi commerciali.
Se, nei decenni postbellici, tutte queste nuove istituzioni danno un impulso complessivo di enorme importanza allo sviluppo economico e all’incremento degli scambi commerciali internazionali, non meno rilevante, specie per i paesi europei colpiti dalla guerra, è il Piano Marshall (European Recovery Program, Erp, Programma per la ripresa europea), varato nel 1947 e durato fino al 1951.
Il Piano viene elaborato da George C. Marshall (1880-1959), segretario di Stato (cioè ministro degli esteri) del governo degli Stati Uniti presieduto dal democratico Harry Truman e prevede la concessione di prestiti, in parte in forma gratuita, in parte a lunga scadenza e a bassi tassi di interesse, ai paesi europei inclusi nel programma di aiuti (che sono Austria, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Francia, Germania Ovest, Grecia, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svizzera, Svezia e Turchia).
L’inclusione nel programma è condizionata a una piena accettazione dell’alleanza con gli Usa e a una completa adesione ai principi della democrazia e del libero mercato.
I paesi inclusi nel piano ricevono merci, attrezzature e materiali che sono pagati dalla Economic Cooperation Administration (Eca, Amministrazione della Cooperazione Economica), l’organismo istituito dall’Erp che si occupa delle forniture di beni.
Il coordinamento generale di tutta l’operazione è svolto dall’Organisation for European Economic Co-operation (Oeec, Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea).
Parole della storia
Bilancia dei pagamenti
L’espressione indica il quadro complessivo delle transazioni di un paese con i paesi esteri e con le istituzioni internazionali. Le transazioni sono distinte in due partite principali:
a) le partite correnti: vi si conteggiano il commercio visibile, cioè le esportazioni e le importazioni di beni, e il commercio invisibile, ovvero le spese – in entrata e in uscita – per i servizi bancari, per le assicurazioni, per il turismo, per i noleggi delle navi mercantili; e poi i profitti realizzati all’estero e i pagamenti degli interessi sui prestiti.
b) i movimenti di capitali: vi si conteggiano l’afflusso o il deflusso di fondi di investimento (per l’acquisto di titoli di debito pubblico, o di valori borsistici di vario tipo), di doni e prestiti internazionali.
Il calcolo di tutte queste voci alla fine dà un saldo: il saldo è attivo quando le risorse finanziarie entrate a vario titolo nel paese sono maggiori di quelle che ne sono uscite; è negativo nel caso inverso.
Un saldo molto negativo, oppure negativo per un periodo consistente di anni, segnala una sofferenza nella bilancia dei pagamenti di un paese; è in questo caso che può intervenire il Fondo monetario internazionale.
Nazionalizzazione
Passaggio di industrie o di aziende dalla gestione privata alla gestione pubblica.
Nei paesi non comunisti lo Stato che procede alla nazionalizzazione acquista dai privati quelle attività produttive o di distribuzione di servizi che sono considerate di pubblica attività.
La finalità principale è quella di assicurare tariffe eque per servizi necessari a tutti i cittadini, come sono i servizi elettrici, o i servizi che forniscono i combustibili per il riscaldamento delle abitazioni (all’epoca nel Regno Unito il carbone ha – in larga misura – questo uso), o i trasporti (ferrovie, autobus urbani, linee aeree).
Pakistan
Il nome è un’invenzione moderna che è stato coniato a Cambridge nel 1933 dal nazionalista musulmano Chaudhary Rahmat Ali: si tratta di un acronimo costruito dalle iniziali e da un suffisso che si riferiscono alle principali regioni dell’India occidentale: Punjab, Afghan Province, Kashmir, Indus, Sindh e Beluchistan.
Tassazione progressiva
Si ha quando le aliquote aumentano con l’aumentare dell’imponibile; quando invece l’aliquota è unica per tutti si parla di tassazione proporzionale.
L’imponibile è quella parte di reddito sottoposta a tassazione.
L’aliquota è il valore percentuale calcolato sull’imponibile che produce l’ammontare della tassa che dev’essere pagata.
La tassazione progressiva è un sistema di prelievo fiscale introdotto nel corso del 20. secolo con l’obiettivo di attuare una più equa distribuzione della ricchezza.
L’effetto viene raggiunto in due modi: tassando i più ricchi con aliquote più alte; destinando le risorse che se ne ricavano al finanziamento di servizi destinati soprattutto o esclusivamente ai cittadini con i redditi più bassi.
Bibliografia
Giudicare e punire: i processi per crimini di guerra tra diritto e politica / L. Baldissara e P. Pezzino (a cura di). – L’Ancora del Mediterraneo, 2005
Dopoguerra: come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi / T. Judt. – Mondadori, 2007
Storia della Palestina moderna: una terra, due popoli / I. Pappe. – Einaudi, 2005
Storia dell’Onu / A. Polsi. – Laterza, 2009
Guerra fredda e decolonizzazione / F. Romero. – In: Storia contemporanea. – Donzelli, 1998
Combattere si può, vincere bisogna; la scelta della violenza fra Resistenza e dopoguerra: Reggio Emilia, 1943-1946 / M. Storchi. – Marsilio, 1998
Cap. 11. Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 e il 1970
11.1 I “miracoli economici” dell’Occidente
Uno Degli aspetti che più colpiscono nella storia dell’Occidente dopo la seconda guerra mondiale è la rapidità con la quale le economie europee si riprendono dalla devastazione bellica.
Sia per la Germania Ovest sia per l’Italia gli anni Cinquanta sono caratterizzati da processi di crescita economica così rapidi da far parlare di “miracolo economico”.
Effettivamente sembra davvero di trovarsi davanti a un miracolo.
I due paesi sono stati distrutti (e la Germania molto più dell’Italia).
Le perdite demografiche sono state imponenti (in Germania, soprattutto, dove durante la guerra sono morte all’incirca 5.000.000 di persone – 4.000.000 delle quali erano soldati; in Italia le perdite sono state di 500.000 persone, la metà delle quali soldati); le fabbriche e le aziende agricole sono state in gran parte danneggiate.
Eppure, in un breve lasso di tempo, le economie si rimettono in movimento.
E lo stesso accade anche in altri paesi europei occidentali, egualmente colpiti dalla guerra (il Regno Unito, la Francia e altri ancora, come il Belgio e l’Olanda), sebbene talora con ritmi di crescita differenziati.
Che cosa aiuta a spiegare una ripresa economica così rapida?
Certamente un ruolo importantissimo è svolto dalla forte spinta dinamica impressa dal sistema economico statunitense a tutte le economie che gli sono collegate.
La spinta fondamentale è data senza dubbio dalla crescita della spesa statale per gli armamenti che tra il 1950 e il 1952 – in piena guerra di Corea – cresce del 200%; sul più lungo periodo, dal 1950 al 1970 cresce del 360%, passando da 15 miliardi di dollari a oltre 70 miliardi di dollari.
Un aumento così imponente ha un’enorme ricaduta economica su tutti i settori industriali, poiché le industrie che producono aerei e navi da guerra, carri armati, veicoli blindati, esplosivi, armi da fuoco dei tipi più svariati hanno intorno a loro un vasto “indotto”, cioè tutta un’ampia serie di industrie che forniscono pezzi, componenti, fonti energetiche, macchine, ecc.
Degli effetti economicamente positivi della crescita delle industrie belliche beneficia in primo luogo lo stesso sistema economico statunitense; ma effetti non disprezzabili si riverberano anche sulle economie europee, poiché una parte della domanda indotta generata da questa positiva dinamica economica di rivolge anche a industrie del Vecchio Continente.
Da sola, tuttavia, questa dinamica non potrebbe spiegare i risultati straordinariamente positivi ottenuti dalle economie europee occidentali.
Un altro elemento assolutamente essenziale è costituito dal Piano Marshall [cfr. cap. 10.2]
I crediti e le forniture di beni di varia natura che arrivano in Europa grazie al Piano Marshall hanno l’effetto di rivitalizzare sistemi economici prostrati dalle conseguenze della guerra e di rimettere in moto la domanda e gli investimenti.
Come si può vedere nella carta [pag. 294] gli importi ricevuti dai paesi europei, e in particolare da Germania, Italia, Regno Unito e Francia, sono di proporzioni assolutamente eccezionali.
Una parte dei prestiti vengono impiegati nella costruzione di edifici, strade, reti di trasporto e impianti industriali distrutti nel corso della guerra.
Anche questi investimenti hanno un loro effetto moltiplicatore, poiché si riverberano in una nuova ulteriore domanda per macchinari e materiali indirizzata verso i più svariati settori produttivi; ne risulta una crescita complessiva dell’attività economica, che si accompagna a un accelerato processo di industrializzazione.
In Italia l’industrializzazione si concentra soprattutto nelle regioni settentrionali, dove si trovano già i più importanti stabilimenti siderurgici e meccanici; ma anche in altre aree (nell’Italia centrale, per esempio, con la Toscana e le Marche in testa) si ha un notevole sviluppo di industrie di dimensioni più contenute, capaci di produrre merci di buona qualità a prezzi relativamente bassi (calzature, mobili, tessuti, ciclomotori).
Un’importante spinta alla ripresa economica viene pure dalla rete di accordi economici che fondano un primo abbozzo di Europa comunitaria.
Il rilievo della rete sta nel suo fondarsi non tanto su accordi diplomatici o economici parziali (due o tre paesi che stringono alleanze e forme di cooperazione reciproca), soluzione tipica dei decenni che precedono la guerra, quanto al tentativo di strutturare una vasta area di paesi collegati dalla comune sottoscrizione di accordi istituzionali.
Il processo ha il suo inizio il 18 aprile 1951, quando su iniziativa di Robert Schuman e di Jean Monnet, i rappresentanti di sei paesi europei (Belgio, Francia, Germania occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) si accordano per coordinare la produzione e lo scambio del carbone e dell’acciaio, fondando in tal modo la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca).
Su questa base il 25 marzo 1957 gli stessi sei paesi sottoscrivono il trattati di Roma, che fonda la Comunità economica europea (Cee): obiettivo è quello di formare un Mercato europeo comune (Mec), attraverso un abbassamento delle barriere doganali, la facilitazione della circolazione di merci e individui, il coordinamento delle politiche agricole e industriali, il sostegno delle aree depresse.
Uno dei temi al centro delle trattative per la formazione del Mercato comune è anche quello delle risorse energetiche.
Parallelamente alla costituzione della Cee i sei paesi fondatori di accordano infatti per costituire anche la Comunità europea dell’energia atomica (Ceea o Euratom), organismo collettivo che ha il compito di coordinare e incoraggiare le ricerche per l’utilizzazione dell’energia atomica a scopi civili (cioè come fonte per la produzione di energia).
La questione ha uno speciale rilievo per l’Europa, perché proprio in quegli anni negli Stati Uniti, nell’Unione Sovietica e nel Regno Unito si aprono le prime centrali nucleari impiegate per generare energia elettrica (il primo impianto sovietico è del 1954; seguono un impianto avviato nel Regno Unito nel 1956 e un aperto negli Usa nel 1957).
Da lì a pochi anni anche i paesi della Cee cominceranno a dotarsi di centrali nucleari per la produzione di maggiore energia elettrica a costi più bassi (ma – come si vedrà – con rischi ambientali di non poco conto).
Parole della storia
Droghe psichedeliche
L’aggettivo “psichedelico” deriva dalle parole greche psiche (“coscienza, anima”) e dèlos (“visibile, chiaro”) ed è coniato proprio in questi anni.
Allude alle possibilità che le droghe hanno di ampliare le capacità percettive o immaginative.
E’ proprio a partire dalla esaltazione delle “positive” qualità psichedeliche, possedute da sostanza come l’Lsd (acido lisergico) o la marijuana, che prendono impulso la nascita e la diffusione di un mercato di massa della droga in Occidente.
Oltre all’Lsd e alla marijuana si diffonde ben presto l’uso dell’eroina e della cocaina; tutte queste sono droghe la cui assunzione produce effetti enormemente dannosi e – in determinate circostanze – anche letali.
Proprio in questi anni l’uso di droghe falcia famosi musicisti rock, come Brian Jones (1942-1969), che faceva parte del complesso dei Rolling Stones, o Janis Joplin (1943-1970), mentre grandi consumatori di droghe sono la gran parte delle stelle del rock così coem moltissimi musicisti jazz.
Neorealismo italiano
L’espressione indica una tendenza cienmatografica (e letteraria) diffusa nell’Italia del dopoguerra, animata da autori che vogliono descrivere la realtà del paese in tutti i suoi aspetti.
Tra i registi e gli autori più significativi di questa tendenza di possono ricordare Roberto Rossellini (1906-1977), Vittorio De Sica (1901-1974), Cesare Zavattini (1902-1989).
Nouvelle Vague (“nuova onda”)
L’espressione indica un gruppo di registi francesi, o di una generazione successiva ai neorealisti italiani.
Vicini alla rivista “Cahiers du cinema”, sostengono la necessità di realizzare una “politique des auteurs” (politica degli autori), consistente nel riconoscere a film la dignità di opera d’arte, e ai registi lo status di veri artisti.
Tra i registi più importanti del gruppo si ricordano Jean-Luc Godard(nato nel 1930), François Truffaut (1932-1984), Claude Chabrol (nato nel 1930), Eric Rohmer (nato nel 1920).
Settore terziario
Il termine vuole indicare quel settore che non include le attività agricole, né le attività industriali, e che include, invece, tutte le attività commerciali, o professionali, o impiegatizie.
E così, per fare un esempio, possono appartenere al “settore terziario” sia un bottegaio, sia un medico ospedaliero, sia un impiegato comunale.
Sistema uninominale a doppio turno
In questo sistema i partiti presentano un solo candidato ciascuno nei singoli collegi.
Se uno dei candidati ottiene subito, al primo turno, più del 50% dei voti, vince il seggio parlamentare.
Altrimenti i due candidati che hanno ottenuto i primi due migliori risultati si ripresentano al secondo turno (che si tiene una o due settimane più tardi), sfidandosi in uno scontro diretto.
In un sistema di questo genere è essenziale che un partito abbia la possibilità di stringere alleanze politiche a vasto raggio in vista di un possibile secondo turno.
Partiti forti, ma isolati, com’è, per esempio, in questi anni il Partito comunista francese, ottengono un numero di seggi molto inferiore al numero di voti.
L’inverso vale per il Partito gollista, l’Unr.
Bibliografia
La società dei consumi: i suoi miti e le sue strutture / J. Baudrillard. – Il Mulino, 2008
Storia del miracolo economico: culture, identità, trasformazioni tra gli anni Cinquanta e Sessanta / G. Crainz. – Donzelli, 2005
L’impero irresistibile: la società dei consumi americana alla conquista del mondo / V. de Grazia. – Einaudi, 2006
Il Sessantotto / M. Flores, A. De Bernardi. – Il Mulino, 2003
Storia della guerra in Vietnam: la tragedia in Asia e la fine del sogno americano / M. Frey. – Einaudi, 2008
Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi / P. Ginsborg. – Einaudi, 2006
L’Urss dal trionfo al degrado: storia dell’Unione Sovietica, 1945-1991 / A. Graziosi. – Il Mulino, 2008
Le voci degli hippies / J. Hopkins (a cura di). – Laterza, 1969
Comprare all’americana: le origini della rivoluzione commerciale in Italia, 1945-1971 / E. Scarpellini. – Il Mulino, 2001
Cap. 12. I mondi postcoloniali
12.1 Uno sguardo d’insieme
Dal 1950 in avanti il processo di decolonizzazione, avviatosi subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, prosegue su scala planetaria.
In questa fase più niente resta delle vecchie colonie occidentali.
E sembra perfino che eventuali ambizioni neoimperialiste siano destinate ad infrangersi contro la nuova vitalità dei mondi postcoloniali.
La lunga e sanguinosa guerra combattuta dall’esercito statunitense nel Vietnam è vista sotto questa luce: il fatto che in questa guerra la massima potenza occidentale sia sconfitta da un esercito di guerriglieri asiatici (per quanto sia un esercito sostenuto dalla potenza cinese) sembra la più straordinaria testimonianza della irresistibile forza del processo di autonomizzazione dall’Occidente, che ormai è in atto un po’ ovunque.
Peraltro non sempre le cose vanno così: in Africa, In America Latina o nel Medio Oriente le maggiori potenze occidentali (e in primo luogo gli Stati Uniti) non cessano di nutrire ambizioni neoimperiali e non di rado riescono anche a imporle in forme indirette (attraverso il controllo economico o attraverso il sostegno finanziario e militare a gruppi interni all’uno o all’altro paese).
D’altro canto, coem abbiamo già ricordato attraverso le osservazioni di Ian Buruma e Avishai Margalit [cfr. cap. 5.1], i mondi postcoloniali sono profondamente condizionati dai modelli di organizzazione economica e politica occidentale, che le élite dei paesi nuovi, nati dal processo di decolonizzazione, hanno da tempo imparato a conoscere e utilizzare.
E così da un lato lo Stato-nazione – una formazione politica sperimentata in Europa prima che in ogni altro luogo – sembra l’unica forma statuale in grado di garantire alle aree postcoloniali una qualche organica strutturazione internazionale.
Dall’altro le ideologie che animano i processi di decolonizzazione sono anch’esse in larga misura derivate da matrici concettuali occidentali: il nazionalismo, il comunismo o la democrazia rappresentativa sono i principali modelli di riferimento che condizionano in forma diretta la fase id costruzione degli Stati postcoloniali, sebbene poi quei modelli vengano adattati alle culture e alle tradizioni proprie delle società nelle quali trovano applicazione.
Anche l’universo islamico postcoloniale sembra aderire a questo schema: tra anni Cinquanta e anni Sessanta nell’area dei paesi islamici si formano Stati laici, dominati prevalentemente da élite militari, che optano per regimi autoritari, di orientamento vagamente socialisteggiante; ma sotto questa tendenza, di evidente derivazione occidentale, continuano a diffondersi correnti di pensiero e movimenti politici – nati già nei decenni precedenti – che aspirano a un netto allontanamento dall’Occidnete e dalla sua storia.
Parole della storia
Dalai Lama
E’ la massima autorità spirituale del buddismo tibetano e la massima autorità temporale (cioè politica) del Tibet.
Un Dalai Lama viene scelto dalla comunità dei monaci buddisti sulla base di segni che lo indicano come la reincarnazione dei precedenti Dalai Lama.
Sino al 1959 il Dalai Lama ha vissuto a Lhasa, capitale del Tibet, uno Stato semifeudale, dominato da un’aristocrazia di proprietari terrieri e di monaci buddisti.
Dopo l’annessione del Tibet alla Cina, le precedenti strutture socio-economiche e religiose tibetane sono state totalmente trasformate e molti monasteri o luoghi di culto buddisti sono stati distrutti o gravemente danneggiati.
Il Tibet è diventato una regione autonoma della Repubblica cinese; negli organi di governo siedono cinesi – in rappresentanza di Pechino – e tibetani.
Dal 1959 il quattordicesimo Dalai Lama – Tenzin Gyatso (nato nel 1935) – vive in India, insieme col governo tibetano in esilio.
Nel 1989 ha ricevuto il Premio Nobel per a pace, per la sua opposizione non violenta all’occupazione cinese del Tibet.
Bibliografia
India / D. Amirante. – Il Mulino, 2007
La decolonizzazione / R. F. Betts. – Il Mulino, 2007
Storia del jiad: da Maometto ai giorni nostri / D. Cook. – Einaudi, 2007
Il mito del Che: storia e ideologia dell’utopia gueveriana / A. Filippo. – Einaudi, 2007
Il conflitto israelo-palestiniano: cent’anni di guerra / J. L. Gelvin. – Einaudi, 2007
Cap. 13. L’Occidente dal 1970 a oggi
- 1 La stagflazione
Agli inizi degli anni Sessanta si interrompe il lungo ciclo economico positivo che ha avuto inizio dopo la seconda guerra mondiale.
I segnali di difficoltà vengono, in primo luogo, dal sistema dei cambi monetari.
Le regole dei cambi sono state fissate dagli accordi di Bretton Woods del 1944 [cfr. cap. 10.1]: da allora il dollaro statunitense è diventato la moneta di riferimento per gli scambi internazionali, poiché la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ne assicura la convertibilità in oro.
Così le banche centrali di altri paesi possono immagazzinare nelle loro riserve dollari invece di oro, sicure della possibile convertibilità di quella moneta.
Nei decenni che seguono Bretton Woods, gli accordi internazionali hanno fatto sì che la moneta statunitense abbia cominciato a circolare in tutto il sistema finanziario internazionale; di tempo in tempo le banche nazionali – quando ne hanno avuto bisogno – hanno chiesto la conversione del dollaro in oro; di conseguenza, le riserve auree statunitensi tra il 1948 e il 1970 si sono ridotte della metà.
Per di più in tutto questo periodo le importazioni nordamericane di materie prime e beni strumentali sono cresciute costantemente, finché nel 1970 hanno superato le esportazioni.
E anche questo deficit nella bilancia commerciale ha fatto sì che le riserve monetarie siano uscite dal circuito economico statunitense, mettendo ulteriormente a repentaglio la consistenza delle riserve auree nordamericane.
A questo punto il governo statunitense, guidato da Richard Nixon, decide di intervenire e nel 1971 sospende la convertibilità del dollaro in oro.
La decisione ha effetti notevoli: provoca una immediata svalutazione del dollaro e una svalutazione riflessa delle monete dei paesi economicamente collegati agli Usa, il che ha come ulteriore conseguenza una ripresa dell’inflazione: giacché le monete vengono svalutate – cioè, in sostanza, valgono di meno -, i prezzi dei beni tendono a salire.
Inoltre la rottura degli accordi di Bretton Wood apre una fase di incertezza nei cambi monetari, che non hanno più una solida base di riferimento, in precedenza assicurata al dollaro.
Questa dinamica è significativa e importante, ma non è niente rispetto all’impatto esercitato dall’aumento dei prezzi del petrolio, deciso nel 1973 dai paesi dell’Opec.
Da quell’anno fino al 1980 i prezzi del petrolio greggio crescono ininterrottamente, passando da 1,60$ al barile nel 1970 a 3$ al barile nel 1973, a 9$ al barile nel 1975, a 18$ al barile nel 1980.
Questo evento economico ha un effetto enormemente più forte della turbolenza sul mercato dei cambi, che al confronto sembra una tempesta in un bicchier d’acqua.
La crisi dallo “shock petrolifero” ha caratteri assolutamente inediti.
Di solito, nei decenni precedenti, una depressione economica era caratterizzata dalla stagnazione (diminuzione della produzione e aumento della disoccupazione) e dalla caduta dei prezzi (determinata dalla diminuzione dell’offerta dei beni sul mercato).
Adesso la combinazione di eventi che coinvolge tutti i principali paesi dell’Occidente industrializzato, che sono grandi importatori di petrolio, è molto diversa.
Da un lato l’aumento del prezzo del petrolio fa aumentare follemente sia i costi dei trasporti collegati direttamente o indirettamente al petrolio; e questa dinamica genera una complessiva spinta inflazionistica (cioè un netto aumento dei prezzi).
Dall’altro, però, questa fortissima inflazione fa anche flettere la domanda dei beni, poiché i consumatori tendono a comprare con più cautela merci che all’improvviso costano molto più di prima.
La flessione della domanda si riverbera sulla produzione: le imprese cominciano a produrre meno e licenziano gli operai.
Ma diversamente da ciò che accadeva in precedenza, la diminuzione della produzione non fa diminuire i prezzi, perché la minore offerta di beni sul mercato è più che compensata dal costante aumento del prezzo del petrolio; e quindi, nonostante tutto, l’inflazione continua a crescere a velocità notevole.
Questa doppia tendenza – alla stagnazione economica (diminuzione della produzione, aumento della disoccupazione) e all’inflazione (incremento dei prezzi) – viene definita stagflazione (un termine che nasce dalla combinazione di “stagnazione” e “inflazione”).
Il fenomeno si abbatte su un Occidente che, per più di un verso, si trova in una fase di difficoltà politica; e le tensioni sociali che ne derivano, ne risultano, in una certa misura, esasperate.
Parole della storia
Concussione
E’ il reato compiuto da un pubblico ufficiale che costringa o induca a dargli dei soldi in cambio di un favore o addirittura in cambio del compimento di un atto dovuto.
Corruzione
E’ il reato compiuto da un pubblico ufficiale (cioè un politico che riveste una carica pubblica, o da un funzionario, o da un impiegato) che riceva dei soldi per compiere un atto che favorisca illegalmente il corruttore.
Elezioni primarie
Sono elezioni attraverso le quali i militanti o i simpatizzanti di un partito eleggono il candidato-leader per le elezioni successive, oppure – come nel caso delle primarie dei Pd – individuano il leader del partito.
Le elezioni primarie sono state impiegate negli Stati Uniti sin dal tardo Ottocento per la nomina dei candidati alla presidenza dei vari partiti politici.
Estorsione
È il reato commesso da chi – con la minaccia e con la violenza – costringe qualcun altro a pagargli somme di denaro che non gli sono dovute
Qualunquismo
Il termine, che ha un valore decisamente negativo, indica un atteggiamento di distacco e di critica nei confronti di tutti i partiti, sia di destra, sia di sinistra.
La parola deriva dal Fronte dell’Uomo Qualunque, un partito fondato nel 1946 dal giornalista e scrittore Guglielmo Giannini (1891-1960).
Il partito ottenne il 5,3% nelle elezioni per l’Assemblea Costituente, tenutesi il 2 giugno 1946.
Negli anni seguenti perse rapidamente consensi, processo che condusse al suo rapido scioglimento.
Il Fronte dell’Uomo Qualunque criticava tanto il fascismo quanto il comunismo es esprimeva anche un giudizio negativo sui partiti di massa; al sistema dei partiti il dirigente del Fronte, Giannini, avrebbe preferito uno Stato puramente amministrativo, non connotato ideologicamente, e caratterizzato dal minimo grado di intervento nella società civile.
Referendum abrogativo
È una consultazione popolare attraverso la quale si chiede al corpo elettorale di esprimere un parere sull’abolizione di una legge o di parte di una legge.
Se – com’è nel caso dell’ordinamento della Repubblica italiana – l’esito del referendum ha un valore “vincolante”, gli organi legislativi devono obbligatoriamente tenerne conto: quindi nel caso in cui la maggioranza degli elettori voti a favore della cancellazione di una legge, essa dev’essere cancellata; nel caso in cui, invece, la maggioranza degli elettori voti contro la cancellazione di una legge, essa dev’essere conservata.
Tangenti
E’ il termine di uso corrente che indica le somme che vengono illegalmente pagate in caso di corruzione e concussione.
Da questa parola deriva il termine che designa giornalisticamente la crisi politicò-giudiziaria scoppiata nel 1992: “tangentopoli” (che significa “città delle tangenti”, con riferimento a Milano, dove sono stati commessi la maggior parte dei reati oggetto dell’inchiesta giudiziaria).
Tribunale internazionale per i crimini di guerra della ex Jugoslavia
Si tratta di un tribunale speciale istituito il 25 maggio 1993 dall’Onu e ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi; ha il compito di perseguire e giudicare i responsabili delle stragi e dei crimini di guerra commessi nelle guerre combattute in Croazia (1991-95), in Bosnia-Erzegovina (1992-95) e in Kosovo (1998-99).
Bibliografia
La costituzione del soggetto femminile: il femminismo negli anni ‘60/’70 / Y. Ergas. – In: Storia delle donne in occidente. – Laterza, 2007
L’Italia del tempo presente: famiglia, società civile, Stato, 1980-1996 / P. Ginsborg. – Einaudi, 2007
Berlusconi: ambizioni patrimoniali di una democrazia mediatica / P. Ginsborg. – Einaudi, 2003
Berlinguer e la fine del comunismo / S. Pons. – Einaudi, 2006
Cap. 14. Desideri e paure
14.1 Il dominio dei monitor
Sessant’anni fa, subito dopo la seconda guerra mondiale, in Europa non erano poi molti quelli che sapevano parlare inglese.
Chi era stato fortunato e possedeva ancora una casa, perché i bombardamenti o le azioni di guerra gliel’avevano risparmiata, forse possedeva anche una radio.
Solo in pochi avevano un televisore.
La sera quelli che non avevano voglia di ascoltare la radio potevano uscire e fare un giro al bar per giocare a carte o per parlare con gli amici.
La declinazione al maschile è d’obbligo: difficile che le donne uscissero la sera da sole.
Ma i tempi cambiano.
Sessant’anni dopo sono molti quelli che sanno parlare inglese.
E chi non lo sa parlare, conosce almeno un centinaio di vocaboli inglesi di indispensabile uso quotidiano.
La radio si ascolta meno: forse in macchina, mentre si viaggia; o in ufficio, mentre si lavora (se il capufficio e i colleghi lo permettono).
Invece domina la potenza ipnotica dei monitor, quelli dei televisori e quelli dei computer.
Certo i monitor non sono abbastanza potenti da spezzare il rito del fine settimana, specie per i giovani.
Il sabato sera, la domenica sera sono giornate consacrate all’uscita di gruppo: giovani uomini e giovani donne escono da soli o insieme con altri e si recano nelle enoteche, nelle pizzerie, nei ristoranti, nelle discoteche.
Più tardi di esce e meglio vanno le cose; più tardi si torna e meglio sono andate.
Nel resto della settimana, invece, tutti incantati davanti al video: a guardare un qualunque spettacolo televisivo, a giocare con qualche nuovo videogioco, a navigare in internet o a “chattare” con qualcuno via mail, messanger, Facebook o in qualunque altra forma.
I tempi cambiano.
Una persona che fosse stata ibernata nel 1945 e si fosse risvegliata nel 2009 una frase così, con queste parole (videogioco, internet, chattare, mail, messanger), non la capirebbe proprio: magari penserebbe a un messaggio in codice, roba da servizi segreti…
Dal punto di vista delle comunicazioni i tempi cominciano a cambiare davvero dagli anni Sessanta del 20. secolo, quando la televisione si impone dovunque: prima invade le case delle famiglie statunitensi ed euroccidentali; poi dilaga nell’Europa orientale, infine nei più prosperi dei paesi extraoccidentali.
In Occidente dagli anni Sessanta in avanti si moltiplicano le stazioni televisive.
Inizialmente, in Europa, le televisioni pubbliche (quelle possedute dagli Stati) offrono un certo numero di canali.
Poi al loro fianco nascono e si impongono emittenti televisive private, sul modello del sistema statunitense di telecomunicazioni.
Negli anni Ottanta e Novanta la tecnologia televisiva esplode: le reti si moltiplicano, mentre nascono i canali satellitari a pagamento.
Gli Stati Uniti segnano la strada nel mostrare modelli organizzativi che poi l’Europa adotta.
E non è solo la struttura organizzativa americana a imporsi, ma sono gli stessi programmi prodotti negli Usa che invadono le televisioni dell’Occidente, o perché se ne acquistano i format (cioè l’impostazione dei programmi, specie quelli di intrattenimento), o perché le varie emittenti dei paesi europei acquistano direttamente film televisivi prodotti negli Stati Uniti.
La vera americanizzazione della cultura europea ha luogo ora e avviene in questo modo.
Da un lato, quando si guarda la televisione in qualche paese europeo (ma in Italia in modo particolare), sembra proprio di essere nel cinquantunesimo Stato degli Stati Uniti: si ha la sensazione di conoscere New York, Miami o Los Angeles meglio di Palermo, di Ancona o di Torino; e di conoscere il funzionamento dei sistemi legali, dei metodi di indagine poliziesca, degli ospedali, dei modi di studiare e di vivere nei college e nelle università americane meglio di quanto non si conoscano quelli del proprio paese (anche se di recente in Europa è in atto una significativa controtendenza con produzioni autoctone che si concentrano su studenti o studentesse, carabinier, poliziotti, pompieri, medici, commesse, avvocati, ecc.).
E poi c’è il cinema, con il trionfo definitivo dagli anni Ottanta in avanti, delle megaproduzioni spettacolari che vengono dagli Stati Uniti.
Da quegli anni le cinematografie nazionali conservano piccoli spazi di mercato, normalmente un mercato molto locale (per esempio in Italia i film comici dei fratelli Vanzina, di Neri Parenti o, su un piano diverso, di Verdone o di Moretti, autori i cui film mantengono un loro spazio, ma non escono affatto dai confini nazionali).
Viceversa la parte preponderante del mercato cinematografico è occupato dai film statunitensi, con un dominio che è raddoppiato dalle videocassette e dai dvd.
Il processo è rafforzato dall’imporsi, a ogni livello, dall’inglese come lingua dominante.
E’ un egemonia che deborda in ogni direzione.
Anche se ci sono produzioni di musica o di letteratura di autori europei di straordinaria qualità, l’ingresso in un negozio di dischi o in una libreria di una qualunque città europea dà la sensazione di esser davanti all’”invasione degli ultracorpi”: la grandissima maggioranza dei libri tradotti proviene dall’inglese, spesso anche indipendentemente dalla qualità dell’opera.
Successi planetari come quelli del Codice da Vinci (romanzo scritto dall’americano Dan Brown e pubblicato nel 2003) o di Harry Potter (saga narrativa scritta dall’inglese Joanne Rowling e composta da sette volumi pubblicati tra il 1997 e il 2007) ben difficilmente possono essere ottenuti da un’opera italiana, o greca, o turca, o norvegese, anche se sono del più eccezionale valore: perché le lingue italiana, o greca, o turca, o norvegese sono scarsamente conosciute fuori dai rispettivi confini nazionali; perché i costi di traduzione diventano, di conseguenza, più alti; e perché le case editrici anglo-americane non hanno moltissimi motivi per tradurre libri da altre lingue (specie da lingue “marginali” come queste), disponendo già di un esercito di scrittori/scrittrici in lingua inglese che assicurano testi di buon livello o con le caratteristiche giuste per diventare degli smash hits.
Comunque non sono i libri lo strumento di comuncazione più potente, ma la televisione e il cinema.
Questi sono mezzi che, se modellano profondamente i confini dell’immaginario attraverso programmi di intrattenimento o prodotti di fiction (film che raccontano storie inventate), incidono fortemente anche sui sistemi di informazione.
Le immagini e i servizi “sull’attualità” sono l’essenza del giornalismo televisivo, che ha progressivamente marginalizzato l’importanza – almeno quantitativa – del giornalismo stampato (dei giornali quotidiani, ecc.).
Dal Vietnam in avanti, le guerre si seguono in diretta televisiva, o quasi.
Non necessariamente le “guerre in diretta” sono descritte in modi del tutto attendibili, del tutto ben documentati.
Ma l’effetto di realtà è incredibile: gli spettatori hanno sempre la sensazione di essere in mezzo agli eventi.
Mai il mondo è stato piccolo come ora.
Accanto all’onda televisiva, un altro tsunami tecnologico sconvolge il mondo delle comunicazioni da quando i computer sono diventati strumenti alla portata della maggior parte dei consumatori.
L’evoluzione tecnologica nel settore informatico è stata molto rapida.
Nel 1943 i servizi segreti britannici hanno usato un primo prototipo di computer, chiamato Colossus, per decifrare i messaggi in codice inviati dai militari e dai diplomatici nazisti: era un computer gigantesco, lentissimo, rumorosissimo.
Da allora il processo di miglioramento tecnologico ha condotto verso una straordinaria miniaturizzazione delle componenti e verso un loro incredibile potenziamento tecnologico.
Negli anni Sessanta e Settanta, per dimensioni e costi, i computer sono ancora strumenti che solo enti pubblici o grandi aziende private possono permettersi.
Ma dai primi anni Ottanta sono immessi sul mercato modelli che hanno – grosso modo – le dimensioni degli attuali computer fissi e un prezzo abbordabile anche per i privati.
Negli anni Novanta, poi, diventano disponibili computer fissi e portatili con prestazioni eccezionali a prezzi relativamente bassi.
E’ un grande cambiamento nelle modalità di elaborazione di dati.
E tale cambiamento diventa una vera e propria rivoluzione quando – dagli inizi degli anni Novanta – internet (il sistema integrato di interconnessione tra computer che permette la trasmissione di informazioni a livello mondiale) diventa un sistema perfettamente efficiente e disponibile per tutti coloro che si dotino di un modem a connessione telefonica, o di connessioni dirette a fibre ottiche.
A quel punto la metafora del “villaggio globale” diventa molto più di una metafora: con l’uso della posta elettronica o del web, si può entrare in contatto con ogni punto del globo, anche il più sperduto e lontano, e tutto ciò in tempo reale.
Parole della storia
Aids
E’ l’acronimo di Acquired Immune Deficiency Syndrome o, in italiano, Sindrome da immuno-deficienza acquisita.
La malattia è causata dal virus HIV e si trasmette per contatto sessuale, per contatto con sangue infetto e da madre infetta al figlio da lei concepito.
L’infezione provoca un crollo del sistema immunitario dell’individuo affetto dalla malattia e ha un’evoluzione letale.
Amnesty International
È un’organizzazione internazionale fondata nel 1961 e impegnata nella difesa dei diritti umani nel mondo
Consiglio d’Europa
È un’organizzazione internazionale fondata nel 1949, il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell’uomo e l’identità culturale europea.
Bibliografia
La vita privata: il Novecento / P. Aries, G. Duby (a cura di). – Laterza, 2001
Storia della famiglia in Europa: il Novecento / M. Barbagli, D. I. Kertzer (a cura di). – Laterza, 2005
La terza età / S. de Beauvoir. – Einaudi, 2008
La solitudine del morente / N. Elias. – Il Mulino, 2005
La trasformazione dell’identità: sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne / A. Giddens. – Il Mulino, 2008
La politica della vita: biomedicina, potere e soggettività nel 21. secolo / N. Rose. – Einaudi, 2008
Cap. 15. Scenari della globalizzazione
15.1 Uno sguardo di lungo periodo
Nel 16. secolo hanno iniziato a formarsi circuiti di mercato integrati su scala planetaria: è da allora che prende avvio il processo di globalizzazione.
Per quattro secoli il processo segue – nelle sue linee essenzialissime – tre direttrici di sviluppo:
a) un’integrazione sempre più stretta e diretta dei mercati e delle strutture produttive occidentali con diversi mercati extraoccidentali
b) una sistematica superiorità economica, tecnologica e produttiva dell’Occidente sul resto del mondo
c) una superiorità che è anche di carattere militare.
Nel corso del 20. secolo il processo precisa meglio il suo profilo geografico.
La globalizzazione è, infatti, parziale o almeno si svolge con gradi di intensità diversi di una macroarea geografica all’altra: riguarda soprattutto i mercati e le economie che appartengono all’emisfero Nord (America del Nord; Europa; Asia meridionale e sud-orientale); restano ai margini del processo buona parte dell’America Latina e soprattutto l’Africa sub-sahariana; l’integrazione dei paesi del mondo islamico viene resa più complessa da problemi di natura culturale e politica.
Nelle macroaree dell’emisfero nord, ove il processo di globalizzazione si impone con maggior forza, le trasformazioni degli ultimi trent’anni comportano tre ulteriori sviluppi:
d) l’integrazione dei mercati si intensifica;
e) la superiorità economica dell’Occidente, invece, si attenua, poiché vi sono aree emergenti che cominciano a mostrare una dinamicità pari se non superiore a quella posseduta dalle economie nordamericane ed europee;
f) la superiorità politica e militare dell’Occidente subisce sfide significative.
Nel complesso, dunque, processi demografici, economici, sociali e politici si intrecciano in un contesto mondiale in cui la sfida all’Occidente, iniziata con la decolonizzazione, ha avuto sviluppi nuovi e – in certi momenti – assolutamente drammatici.
Parole della storia
Khmer
Il nome indica il gruppo etnico dominante in Cambogia (il 90% della popolazione è khmer).
Il gruppo possiede una lingua propria ed è di religione buddista.
Bibliografia
Hamas: storie di militanti, martiri e spie / Z. Chehab. – Laterza, 2008
Il fondamentalismo islamico / R. Guolo. – Laterza, 2002
Storia della globalizzazione / J. Osterhammel, N. P. Petersson. – Il Mulino, 2005
Talebani: Islam, petrolio e il grande scontro in Asia centrale / A. Rashid. – Feltrinelli, 2002
Una sociologia della globalizzazione / S. Sassen. – Einaudi, 2008
Storia contemporanea: Il Novecento di Sabbatucci/Vidotto
- Visite: 137
Cap. 1 La prima guerra mondiale
Parola chiave
Propaganda
Il termine propaganda deriva dalla locuzione latina “de propaganda fide” (sulla fede da diffondere) con la quale la Chiesa designa la Congregazione che si occupa dell’attività di proselitismo e di diffusione dei principi cattolici in tutto il mondo.
Nel linguaggio contemporaneo per “propaganda” si intende la diffusione deliberata e sistematica di informazioni e messaggi volti a fornire un’immagine, positiva o negativa, di determinati fenomeni – o avvenimenti o istituzioni o persone -, ma anche a far apprezzare un prodotto commerciale (in questo caso propaganda è sinonimo di pubblicità).
Praticata per la prima volta su vasta scala dai partiti socialisti, la propaganda politica è presto divenuta una componente essenziale della società di massa: soprattutto a partire dal primo conflitto mondiale, quando furono le autorità statali a impadronirsi dei metodi e delle tecniche propagandistiche per rendere popolare presso l’opinione pubblica la causa della guerra.
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa (la radio e il cinema, poi la televisione) ha dato alla attività di propaganda nuove dimensioni e nuova capacità di penetrazione.
Di queste possibilità si sono avvalsi largamente i regimi totalitari che, controllando direttamente i canali di informazione, hanno potuto realizzare forme di persuasione e di indottrinamento molto più efficaci e sofisticate di quelle attuate in passato (quando la propaganda era affidata essenzialmente alla stampa o, tutt’al più, ai manifesti e ai volantini).
Anche in seguito a queste esperienze il termine “propaganda” ha finito con l’assumere una connotazione negativa, legata all’idea di manipolazione, o quanto meno di informazione unilaterale e distorta
Sommario
L’evento scatenante della prima guerra mondiale fu l’uccisione, a Serajevo, il 28 giugno ’14, dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono degli Asburgo.
Un mese dopo, l’Austria dichiarò guerra alla Serbia, mobilitò il suo esercito provocando la reazione della Germania, alleata dell’Austria.
Il 3 agosto la Germania dichiarò guerra alla Russia e alla Francia sua alleata.
Il 5, dopo che le truppe tedesche ebbero invaso il Belgio neutrale, anche la Gran Bretagna scese in campo contro gli imperi centrali.
Allo scoppio del conflitto, e alla sua successiva estensione su scala mondiale, concorsero una serie di tensioni preesistenti, ma anche errori e scelte avventate commesse dai capi politici e militari dei paesi interessati.
Le scelte dei governanti furono del resto appoggiate da una forte mobilitazione dell’opinione pubblica.
Gli stessi partiti politici si schierarono, nella maggior parte dei casi, su posizioni patriottiche.
Gli eserciti scesi in campo nell’estate del ’14 non avevano precedenti per dimensioni e novità di armamenti.
Ma le condizioni strategiche rimanevano legate alle esperienze ottocentesche.
I tedeschi, in particolare, puntavano sull’ipotesi di una rapida guerra di movimento.
Ma, dopo essere entrati in territorio francese, furono bloccati sulla Marna.
Già alla fine del ’15 il conflitto assunse dunque i caratteri di guerra di posizione e di guerra di logoramento.
Allo scoppio del conflitto, l’Italia si dichiarò neutrale.
Successivamente, però, le forze politiche e l’opinione pubblica si divisero sul problema dell’intervento in guerra contro gli imperi centrali.
Erano interventisti: i gruppi della sinistra democratica e alcune frange eretiche del movimenti operaio, i nazionalisti, alcuni ambienti liberal-conservatori.
Erano neutralisti: la maggioranza dello schieramento liberale, che faceva capo a Giolitti, il mondo cattolico, i socialisti.
Contrarie alla guerra erano le masse operaie e contadine, mentre i ceti borghesi e gli intellettuali erano per lo più a favore dell’intervento.
Ciò che determinò l’entrata in guerra (maggio 1915) fu la convergenza fra la pressione della piazza e la volontà del sovrano, del capo del governo e del ministro degli esteri.
Nel 1915-16 la guerra sui fronti italiano e francese si risolse in una immane carneficina, senza che nessuno dei due schieramenti riuscisse a conseguire risultati significativi.
Più alterne furono le vicende sul fronte orientale, dove gli imperi centrali ottennero alcuni importanti successi.
Sul piano tecnico, la trincea fu la vera protagonista del conflitto: la vita monotona ma pesante che si svolgeva era interrotta solo, di quando in quando, da grandi e sanguinose offensive, prive di risultati decisivi.
Da ciò, soprattutto nei soldati semplici, uno stato d’animo di rassegnazione e apatia che a volte sfociava in forme di insubordinazione.
Altra novità fu l’utilizzazione di nuovi armi: gas, aerei, carri armati, sottomarini.
Il conflitto trasformò profondamente la stessa vita civile, dei paesi coinvolti.
In campo economico si dilatò enormemente l’intervento statale, teso a garantire le risorse necessarie allo sforzo bellico.
Il potere dei governi fu enormemente condizionato da quello dei militari e, in genere, tutta la società fu soggetta a un processo di “militarizzazione”.
Col protrarsi del conflitto si rafforzarono i gruppi socialisti contrari ad esso, divisi però tra il pacifismo dei riformisti e la proposta dei rivoluzionari di utilizzare la guerra come occasione per la rivoluzione.
Il 1917 fu l’anno più difficile della guerra, soprattutto per l’Intesa: molti furono i casi di manifestazioni popolari contro il conflitto e di ribellione fra le stesse truppe.
Questo clima di stanchezza (espresso anche dall’iniziativa di pace lanciata senza successo dal papa) si riscontrava anche in Italia.
La stanchezza e la demoralizzazione delle truppe favorirono la vittoria degli austro-tedeschi dell’ottobre ’17 (Caporetto), dovuta comunque anzitutto ad errori dei comandi italiani.
Sempre nel 1917 si verificarono due avvenimenti di decisiva importanza.
In Russia dopo la caduta dello zar, in marzo, iniziò un processo di dissoluzione dell’esercito; dopo la rivoluzione di novembre, il paese si ritirò dal conflitto.
In aprile gli Stati Uniti entrarono in guerra con l’Intesa, dando al conflitto, per volontà del presidente Wilson, una nuova connotazione ideologica “democratica”.
Anche grazie alla superiorità militare conseguita con l’intervento americano, nel novembre 1918 la guerra terminava con la vittoria dell’Intesa: un esito ciu contribuirono in larga misura la dissoluzione interna dell’Austria-Ungheria (causata dal distacco delle varie nazionalità) e la rivoluzione scoppiata in Germania.
Alla conferenza della pace, che si tenne a Versailles, il compito dei vincitori si rivelò difficilissimo.
Nelle dure condizioni imposte alla Germania risultò evidente il contrasto fra l’ideale di una pace democratica e l’obiettivo francese di una pace punitiva.
La carta dell’Europa fu profondamente mutata, soprattutto in conseguenza della dissoluzione dell’Impero asburgico, che permise la nascita di nuovi Stati.
L’ideale wilsoniano di un organismo internazionale che potesse evitare guerre future in sostanza non si realizzò: la Società delle nazioni nacque minata da profonde contraddizioni (anzitutto la mancata adesione degli Stati Uniti).
Bibliografia
Le origini della seconda guerra mondiale / J. Joll. – Laterza, 1985
La prima guerra mondiale, 1914-1918 / B. H. Liddell Hart. – Rizzoli, 1968
La decadenza dell’Europa occidentale / M. Silvestri. – Einaudi, 1978
La grande storia della prima guerra mondiale / M. Gilbert. – Mondadori, 1998
La prima guerra mondiale: una storia politico-militare / J. Keegan. – Carocci, 2000
Assalto al potere mondiale: la Germania nella guerra, 1914-1918 / F. Fischer. – Einaudi, 1965
I militari e la politica nella Germania moderna / G. Ritter. – Einaudi, 1967-73
Rischio 1914: come si decide una guerra / G. E. Rusconi. – Il Mulino, 1987
Requiem per un impero defunto / F. Fejto. – Mondadori, 1990
Storia politica della grande guerra, 1915-1918 / P. Melograni. – Laterza, 1969
La grande guerra degli italiani, 1915-1918 / A. Gibelli. – Sanson, 1998
La grande guerra, 1914-1918 / G. Rochat. – La Nuova Italia, 1999
Caporetto / M. Silvestri. – Mondadori, 1984
Soldati e prigionieri italiani nella grande guerra / G. Procacci. – Editori Riuniti, 1994
L’Italia nella prima guerra mondiale / G. Rochat. – Feltrinelli, 1976
Terra di nessuno: esperienza bellica e identità personale nella prima guerra mondiale / E. J. Leed. – Il Mulino, 1985
La Grande Guerra e la memoria moderna / P. Fussell. – Il Mulino, 1984
Il mito della grande guerra da Marinetti a Malaparte / M. Isnenghi. – Laterza, 1970
La grande guerra: esperienza, memoria, immagini / a cura di D. Leoni e C. Zadra. – Il Mulino, 1986
L’officina della guerra: la grande guerra e le trasformazioni del mondo mentale / A. Gibelli. – Bollati Boringhieri, 1991
Cap. 2. La rivoluzione russa
Parola chiave
Soviet
Il termine “Soviet” altro non è che il corrispettivo russo di “consiglio” e indica quegli organismi rivoluzionari, espressi direttamente dai lavoratori, che, sorti a Pietroburgo durante la rivoluzione russa del 1905, avrebbero dovuto poi costituire, almeno in teoria, la struttura fondamentale dello Stato nato dalla rivoluzione bolscevica dell’ottobre ’17: Stato che avrebbe preso appunto il nome di Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (o Unione Sovietica).
Nel primo dopoguerra, l’esperienza dei soviet rappresentò per tutta la sinistra rivoluzionaria un esempio da seguire e un mito cui ispirarsi.
In tutti i maggiori paesi europei si formarono, all’interno delle organizzazioni tradizionali del movimento operaio, gruppi “consiliari” (in Italia il più importante fu quello che faceva capo ad Antonio Gramsci e alla rivista torinese “Ordine Nuovo”), poi in buona parte confluiti nei partiti comunisti.
Questi gruppi contestavano le forme tradizionali di rappresentanza politica e sindacale e vedevano nei consigli un organo di democrazia diretta (i cui delegati dovevano essere espressi dalle assemblee e potevano essere revocati in qualsiasi momento) e al tempo stesso la cellula attraverso cui realizzare la gestione dei processi produttivi da parte dei lavoratori.
La fortuna delle ideologie consiliari (o “soviettiste”) declinò rapidamente nel corso degli anni ’20: sia per il riflusso generale dell’ondata rivoluzionaria seguita alla fine della guerra; sia per le vicende stesse dell’Urss, dove i soviet furono ben presto ridotti a una funzione puramente simbolica e di facciata (mentre il potere reale era assunto dalle organizzazioni di partito).
Una ripresa delle tematiche consiliari si ebbe in Europa molto più tardi, per opera dei movimenti di contestazione studentesca e operaia del 1968 (vedi cap. 13.6 e 16.4): movimenti che impostarono le loro lotte sul primato dell’assemblea e sul rifiuto della “democrazia delegata”.
Sommario
Nel marzo ’17, la rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado provocò la caduta dello zar e la formazione di un governo provvisorio dominato dalle forze liberal-moderate.
Nel maggio si formò un secondo governo provvisorio cui parteciparono tutti i partiti, a eccezione dei bolscevichi.
Frattanto, accanto al potere “legale” del governo veniva crescendo il potere parallelo dei soviet, i consigli eletti direttamente dagli operai e dai soldati.
Col ritorno di Lenin in Russia, i bolscevichi accentuarono la loro opposizione al governo provvisorio, chiedendo la pace immediata, la socializzazione della terra e il passaggio di tutti i poteri ai soviet.
Il contributo da essi dato alla sconfitta del tentativo di colpo di Stato di Kornilov rafforzò ulteriormente la loro posizione.
A questo punto, grazie alla determinazione di Lenin, decisero di conquistare il potere con la forza.
La fulminea presa del potere da parte dei bolscevichi (7 novembre 1917) e il governo rivoluzionario incontrarono l’opposizione della maggioranza delle forze politiche.
In dicembre i socialisti rivoluzionari riportarono un grande successo nelle elezioni per l’assemblea costituente; questa, però, fu subito sciolta dai bolscevichi, che in tal modo rompevano con la tradizione democratica occidentale.
L’uscita della Russia dalla guerra (trattato di Brest-Litovsk del marzo ’18) provocò l’intervento militare dell’Intesa in appoggio alle armate bianche costituite dalle truppe ribelli al governo.
La gravità della situazione spinse i bolscevichi ad instaurare una vera e propria dittatura.
Grazie alla riorganizzazione dell’esercito operata con la costituzione dell’Armata rossa, il governo rivoluzionario riuscì a prevalere.
Nata ufficialmente nel 1919, ma di fatto effettivamente operante solo dal ’20, l’Internazionale comunista estese a tutto il movimento operaio europeo la frattura fra comunismo e socialdemocrazia che si era verificata in Russia.
I partiti comunisti dei vari paesi nacquero strettamente dipendenti dalle direttive dell’Internazionale, controllata dai russi, e non riuscirono ad ottenere l’adesione della maggioranza della classe operaia.
Nel 1918 il governo bolscevico attuò una politica economica più energica e autoritaria (“comunismo di guerra”), basata sulla centralizzazione delle decisioni e sulla statizzazione di gran parte delle attività produttive.
Questa politica ebbe tuttavia scarsi risultati, finendo con l’alimentare il malcontento di contadini e operai.
Nel marzo 1921 co fu un mutamento di rotta con la Nep (Nuova politica economica).
Basata su una parziale liberalizzazione delle attività economiche, la Nep stimolò la ripresa produttiva, ma ebbe anche effetti non previsti e non desiderati (crescita dei contadini ricchi, degli imprenditori e degli affaristi).
Le condizioni della grande industria di Stato – e degli operai in essa impiegati – non migliorarono sensibilmente.
Nel 1922 nacque l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (Urss).
La nuova costituzione comportava di fatto la dittatura del Partito comunista, l’unico del quale fosse consentita l’esistenza.
Il bolscevichi si proposero anche di trasformare cultura e valori tradizionali: da ciò la lotta contro la Chiesa ortodossa, nuove norme sulla famiglia e i rapporti tra i sessi, l’impegno nell’istruzione e nell’educazione dei giovani.
In campo culturale, i primi anni ’20 furono una stagione dk fioritura delle avanguardia artistiche.
Con l’ascesa di Stalin alla segreteria del partito (aprile ’22) e la malattia di Lenin (morto nel gennaio ’24) si scatenò una dura lotta all’interno del gruppo dirigente bolscevico.
Stalin riuscì dapprima a emarginare Trotzkij (fautore di un continuo sviluppo e di una continua estensione del processo rivoluzionario), contrapponendogli la teoria del “socialismo in un solo paese”.
Quindi si sbarazzò dell’”opposizione di sinistra” (Zinov’ev, Kamenev), che chiedeva la fine della Nep e l’accelerazione dello sviluppo industriale.
Si affermava sempre più il suo potere personale.
Bibliografia
L’Urss di Lenin: storia dell’Unione Sovietica, 1914-1945 / A. Graziosi. - Il Mulino, 2007
La tragedia di un popolo: la rivoluzione russa, 1891-1924 / O. Figes. – Corbaccio, 1997
La rivoluzione russa / R. Pipes. – Mondadori, 1995
Storia dell’Unione Sovietica / G. Boffa. – Mondadori, 1976
Storia della Russia sovietica / E. H. Carr. – Einaudi, 1964-80
La rivoluzione russa: da Lenin a Stalin, 1917-1929
/ E. H. Carr. – Einaudi, 1980
Lenin e il suo tempo / A. B. Ulam. – Vallecchi, 1967
Le internazionali operaie / A. Agosti. – Loescher, 1973
Storia del pensiero comunista / M. L. Salvadori. – Mondadori, 1984
Cap. 3. L’eredità della grande guerra
Parola chiave
Inflazione
Col termine “inflazione” (dal latino inflatio, ossia gonfiamento) si intende la perdita di potere d’acquisto della moneta che si verifica quando la moneta stessa circola in quantità, e con velocità, superiore quella richiesta dai bisogni del mercato.
Il tasso di inflazione, per lo più calcolato su base annua, indica l’entità di questo deprezzamento: si parla dunque di inflazione al 5, al 10 o al 50 per cento se in un anno diminuisce di quella percentuale la quantità di beni che si possono acquistare con una determinata quantità di denaro.
Mentre un’inflazione minima è considerata fisiologica, anzi segno di buona salute dell’economia, un’inflazione elevata produce danni economici e sociali rilevanti e mina la credibilità del paese che la subisce.
Se il vocabolo è entrato nell’uso corrente negli Stati Uniti ai tempi della grande secessione, il fenomeno è antico quanto la moneta.
Quest’ultima, infatti, è anch’essa una merce e dunque è soggetta alla legge della domanda e dell’offerta: se ne circola troppa, il suo valore scende sino ad annullarsi.
L’innesco di un processo inflazionistico è ovviamente diventato più facile da quando la moneta cartacea ha sostituito quella metallica (che ha comunque un valore intrinseco ed è più difficile da riprodurre).
Le autorità statali, per soddisfare esigenze improvvise (è il caso delle guerre) o semplicemente per guadagnare consenso, possono essere infatti indotte a stampare banconote senza rispettare alcun limite: operazione che spesso si risolve in un sequestro di risorse ai danni dei cittadini che hanno prestato soldi allo Stato acquistando titoli del debito pubblico.
Un’altra conseguenza dell’inflazione è la rapida, spesso traumatica, redistribuzione di redditi e patrimoni fra diverse categorie di cittadini, che penalizza i debitori rispetto ai creditori, i percettori di redditi fissi (più lenti ad adeguarsi al costo della vita) rispetto ai commercianti e ai possessori di beni reali.
Anche per evitare le turbolenze sociali e politiche che in genere accompagnano questi processi, i governi dei paesi industrializzati, dopo le disastrose esperienze dei due conflitti mondiali, hanno cercato con alterna fortuna di controllare e limitare i processi inflazionistici, peraltro ancora diffusi nel mondo (si pensi al caso di molti paesi dell’America Latina negli anni ’70 e ’80 del ‘900).
Un’ulteriore azione di vigilanza è quella esercitata dalle autorità sovranazionali: il controllo dell’inflazione può essere condizione per ottenere prestiti o sussidi o anche per fare parte di una determinata quantità, come nel caso dell’euro all’interno dell’Unione europea.
Sommario
La guerra era stata un’esperienza di massa senza precedenti e fece sentire i suoi effetti in ogni campo della vita sociale: tutti i valori tradizionali ne furono scossi.
Il problema maggiore che i governi si trovarono di fronte fu quello dell’inserimento dei reduci.
La politica si fece sempre più fenomeno di massa.
Dappertutto si diffondevano le aspirazioni al cambiamento, sia di tipo rivoluzionario, sia sotto forma di generiche aspirazioni alla pace e alla giustizia sociale.
La prima guerra mondiale segnò una tappa importante nella trasformazione del ruolo delle donne: nei campi, nelle fabbriche, negli uffici presero il posto degli uomini arruolati nell’esercito.
L’esercizio di mestieri fino ad allora considerati esclusivamente maschili e la crescente consapevolezza della propria capacità trasformarono l’immagine stessa della donna.
Questo processo di emancipazione ebbe nel dopoguerra un parziale riconoscimento sul piano dei diritti, ma suscitò anche forti resistenze nei gruppi più conservatori.
Negli anni ’20 e ’30, in molti paesi ci fu una vera e propria ondata di conservatorismo ideologico che cercò di riportare le donne ai loro compiti tradizionali.
Più tardi l’esperienza della seconda guerra mondiale accelerò ovunque i processi già inviati durante il primo conflitto.
Tranne gli Stati Uniti, tutti i paesi belligeranti uscirono dal conflitto in condizioni di dissesto economico.
L’inflazione modificava la distribuzione della ricchezza, mentre la nuova situazione del commercio internazionale vedeva ridotto il ruolo dell’Europa.
Fu necessario nei vari paesi, di fronte ai problemi posti dal ritorno all’economia di pace, tenere ancora in piedi le strutture statali di intervento nell’economia.
A un’iniziale e artificiale espansione economica seguì, nel 1920-21, una fase di crisi.
Tra la fine del ’18 e l’estate del ’20 (il “biennio rosso”) il movimento operaio europeo fu protagonista di una grande avanzata politica che assunse anche tratti di agitazione rivoluzionaria, sulla scia del mito della rivoluzione russa.
L’ipotesi rivoluzionaria fallì ovunque, mentre si accentuò, entro il movimento operaio, la divisione tra riformisti e rivoluzionari, con la fondazione del Comintern e la nascita di partiti comunisti.
Dopo l’armistizio e la caduta dell’Impero, la Germania si trovava in una situazione simile a quella della Russia nel ’17.
Ma la socialdemocrazia – che era il partito più forte e controllava il governo repubblicano – si oppose decisamente a esperienze di tipo sovietico, trovando un terreno di obiettiva convergenza con la vecchia classe dirigente.
L’insurrezione tentata nel gennaio ’19 dai comunisti “spartachisti” fu repressa nel sangue.
Le elezioni per l’Assemblea costituente, che si tennero poco dopo, videro l’affermazione della socialdemocrazia e del Centro cattolico.
L’Assemblea, riunita a Weimar, elaborò una costituzione democratica fra le più avanzate dell’epoca.
Nel 1920 i socialdemocratici subirono una sconfitta elettorale e dovettero lasciare la guida del governo.
Simili furono le vicende politiche dell’Austria: dopo che i socialdemocratici governarono nella fase di trapasso di regime, il potere passo nelle mani del Partito cristiano-sociale.
In Ungheria, nel 1919, dopo una breve esperienza comunista, il potere u fu conquistato da Horthy che instaurò un regime autoritario.
Il biennio russo si concluse con un riflusso delle agitazioni operaie e una ripresa delle forze moderate.
La Francia degli anni ’20 vide sul piano politico un’egemonia delle forze moderate (tranne la breve parentesi del “cartello delle sinistre” nel ’24-25); alla stabilizzazione politica si accompagnò – nella seconda metà del decennio – una sensibile ripresa economica.
Più difficile fu la situazione dell’economia britannica, caratterizzata da una fase di ristagno per tutti gli anni ’20.
In questo periodo il Partito laburista si affermò come secondo partito del paese (nonostante la secca sconfitta subita dal movimento sindacale nel ’26).
La situazione politica della Repubblica di Weimar era caratterizzata da una forte instabilità politica: l’opinione pubblica borghese, in particolare, nutriva diffidenza per un sistema democratico che considerava indissolubilmente associato alla sconfitta.
Il problema delle riparazioni alimentò questo stato d’animo, provocando, sul piano economico, una gravissima crisi del marco.
All’inizio del ’23 Francia e Belgio occuparono la Ruhr, regione vitale per l’economia tedesca.
In Germania la crisi precipitò e l’inflazione raggiunse livelli impensabili.
Vi furono tentativi insurrezionali da parte dell’estrema sinistra (Amburgo) e dell’estrema destra (putsch di Monaco, capeggiato da Hitler, nel novembre ’23).
A partire dall’estate il governo Streseman avviò una politica di stabilizzazione monetaria e di riconciliazione con la Francia.
Grazie al piano Dawes del 1924, la Germania poté fruire di prestiti internazionali (soprattutto statunitensi), che le avrebbero consentito una rapida ascesa economica.
Con il piano Dawes iniziava una fase di distensione internazionale, confermata dagli accordi di Locarno del 1925, che normalizzavano i rapporti franco-tedeschi.
Questa fase si interruppe alla fine del decennio in coincidenza con la crisi economica internazionale.
Bibliografia
La grande guerra e la memoria moderna / P. Fussell. – Il Mulino, 1984
Le guerre mondiali: dalla tragedia al mito dei caduti / G. L. Mosse. – Laterza, 1990
Il lutto e la memoria: la grande guerra nella storia culturale europea / J. Winter. – Il Mulino, 1998
La violenza, la crociata, il lutto: la grande guerra e la storia del Novecento / A. Becker. – Einaudi, 2002
La rifondazione dell’Europa borghese / C. Maier. – Il Mulino, 1999
La rivoluzione nell’Europa centrale, 1918-1919 / F. L. Carsten. – Feltrinelli, 1978
Socialismo europeo e bolscevismo, 1919-1921 / A. S. Lindemann. – Il Mulino, 1977
Storia della Repubblica di Weimar, 1918-1933 / E. Eyck. – Il Mulino, 1987
La Repubblica di Weimar: la Germania dal 1917 al 1933 / H. Schulze. – Il mulino, 1987
La Repubblica di Weimar, 1918-1933: storia della prima democrazia tedesca / H. A. Winkler. – Donzelli, 1998
La crisi di Weimar: crisi di sistema e sconfitta operaia / G. E. Ruaconi. – Einaudi, 1977
La Repubblica di Weimar / W. Laqueur. – Rizzoli, 1977
La cultura di Weimar / P. Gay. – Dedalo, 1978
Storia dell’Inghilterra contemporanea / A. J. P. Taylor. – Laterza, 1968
Storia della Francia nel Novecento / J. F. Sirinelli…et al. – Il Mulino, 2003
Cap. 4. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
Problemi del dopoguerra
Con la vittoria l’Italia aveva superato la prova più impegnativa della sua storia unitaria, ma restava alle prese con i mille problemi che la grande guerra aveva ovunque lasciato dietro di sé.
L’economia presentava i tratti tipici della crisi postbellica: sviluppo abnorme di alcuni settori industriali (con conseguenti problemi di riconversione), sconvolgimento dei flussi commerciali, deficit gravissimo del bilancio statale, inflazione galoppante.
Tutti i settori della società erano in fermento.
La classe operaia, tornata alla libertà sindacale dopo la compressione degli anni di guerra e infiammata dagli echi di quanto stava accadendo in Russia, non solo chiedeva miglioramenti economici, ma reclamava maggior potere in fabbrica e manifestava, almeno in alcune frange, tendenze rivoluzionarie.
I contadini tornavano dal fronte con una accresciuta consapevolezza dei loro diritti, insofferenti dei vecchi equilibri sociali, decisi a ottenere dalla classe dirigente l’attuazione delle promesse fatte nel corso del conflitto.
I ceti medi, che erano stati fortemente coinvolti nell’esperienza della guerra – e fortemente colpiti dalle sue conseguenze economiche – tendevano ad organizzarsi e a mobilitarsi più che in passato per difendere i loro interessi e i loro ideali patriottici.
Questi problemi erano in parte comuni a tutti gli Stati usciti dal conflitto.
Ma si presentavano in forma più acuta in un paese come l’Italia, dove, rispetto all’Inghilterra e alla Francia, el strutture economiche erano meno avanzate e le istituzioni politiche meno profondamente radicate nella società.
Il processo di democratizzazione era appena agli inizi, anche perché il suffragio universale maschile era stato applicato per la prima volta nel 1913.
Il modo stesso in cui era stato deciso l’intervento – contro l’orientamento delle masse popolari e della maggioranza parlamentare – aveva provocato gravissime fratture e in seno alla classe dirigente liberale.
A guerra finita, questa classe dirigente si trovò sempre più contestata e isolata, non si mostrò in grado di dominare i fenomeni di mobilitazione di massa che il conflitto mondiale aveva suscitato e finì così col perdere l’egemonia indiscussa di cui aveva goduto fin allora.
Risultarono invece favorite quelle forze, socialiste e cattoliche, che si consideravano estranee alla tradizione dello Stato liberale, che non erano compromesse con le responsabilità della guerra e che, inquadrando larghe masse, potevano meglio interpretare le nuove dimensioni assunte dalla lotta politica.
Parola chiave.
Il termine “squadrismo” entrò nel linguaggio politico italiano nel primo dopoguerra in riferimento alle azioni di violenza organizzata e pianificata condotte dalle formazioni paramilitari fasciste (le squadre d’azione) contro le sedi e le persone fisiche dei loro avversari politici: in primo luogo contro le organizzazioni socialiste delle campagne padane (per questo si parla di squadrismo agrario).
Le origini e gli sviluppi dello squadrismo italiano, come di fenomeni analoghi manifestatisi in altri paesi europei (si pensi soprattutto alla Germania dei “corpi franchi” e delle SA naziste), si collegano strettamente all’esperienza della grande guerra: sia per le modalità organizzative delle squadre (per lo più comandate da ex-ufficiali), sia per i rituali e i simboli attuati.
E certamente all’esperienza bellica vanno fatti risalire la violenza spesso efferata e il diffuso disprezzo della vita umana che furono orgogliosamente esibiti come tratti caratterizzanti dell’attività squadristica.
Negli anni del suo massimo sviluppo, tra la fine del 1920 e l’estate del 1922, il fascismo squadrista, quello che aveva le sue roccaforti nelle province padane e faceva capo ai “ras” locali, fu considerato da molti cosa diversa dal fascismo politico, a base essenzialmente urbana, impersonato soprattutto da Mussolini, al quale in una breve fase si contrappose esplicitamente.
In realtà i “due fascismi” erano le facce di una stessa realtà, nessuna delle quali avrebbe potuto prescindere dall’altra.
In molti casi le squadre erano nate prima dei fasci: e un Partito nazionale fascista si costituì solo nel novembre 1921, assorbendo e inquadrando i gruppi paramilitari: fu così proposto un nuovo modello di formazione politica, quello che più tardi il politologo francese Maurice Duverger avrebbe definito partito milizia (diverso sia dal modello ottocentesco del “partito elettorale” sia da quello del più moderno partito di massa a forte radicamento territoriale, inventato dai socialisti).
Sarebbe dunque riduttivo vedere nello squadrismo un semplice braccio armato del fascismo o della reazione padronale.
Le squadre furono invece non solo il nucleo costitutivo dell’intero movimento, ma anche le depositarie dei suoi rituali (le bandiere, le sfilate, il culto dei caduti), le custodi della sua anima “rivoluzionaria” e della sua vocazione totalitaria.
In quanto fenomeno politico rilevante, lo squadrismo si esaurì con la trasformazione del fascismo in regime e sparì con la morte dei regimi fascisti.
Da allora si parla genericamente di squadrismo per definire, e stigmatizzare, azioni di violenza compiute in gruppo, e per motivi politici, contro persone e cose riconducibili a uno schieramento avverso.
Citazione
In questa delicata fase Mussolini giocò, come al solito, su due tavoli.
Da un lato intrecciò trattative con tutti i più autorevoli esponenti liberali in vista della partecipazione fascista a un nuovo governo; rassicurò la monarchia sconfessando le passate simpatie repubblicane; si guadagnò il favore degli industriali annunciando di voler restituire spazio all’iniziativa privata.
Dall’altro lasciò che l’apparato militare del fascismo si preparasse apertamente alla presa del potere mediante un colpo di Stato.
…
In effetti, nel generale disfacimento dei poteri statali (il ministero Facta si dimise proprio il 27 ottobre), fu l’atteggiamento del re a risultare decisivo.
Vuoi perché non si curò della lealtà dei vertici militari, vuoi perché deciso a evitare a ogni costo una guerra civile.
, Vittorio Emanuele 3. rifiutò, la mattina del 28 ottobre, di firmare il decreto per la proclamazione dello stato d’assedio (cioè il passaggio dei poteri alle autorità militari), che era stato preparato in tutta fretta dal governo già dimissionario.
Pag. 84
Sommario
I problemi del dopoguerra erano aggravati, in Italia, dalla debolezza delle strutture democratiche e dalla crisi della classe dirigente liberale.
I cattolici si organizzarono politicamente con il Partito popolare (1919).
A sinistra, la crescita del Partito socialista corrispondeva ad una prevalenza, in esso, delle correnti rivoluzionarie.
La nascita del fascismo (1919) introdusse nella vita politica un nuovo stile aggressivo e violento.
In relazione alle vicende della conferenza di Parigi, si diffuse tra l’opinione pubblica un atteggiamento di risentimento verso gli ex-alleati (la “vittoria mutilata”) e il governo.
Clamorosa fu la protesta attuata da D’Annunzio con l’occupazione di Fiume (settembre ’19).
Sul piano interno, il ’19-20 fu una fase di acute agitazioni sociali: moti contro il caro-viveri, scioperi operai e agrari, occupazione delle terre.
Le elezioni del novembre ’19, tenute col sistema proporzionale, segnarono la perdita del controllo del Parlamento da parte delle forze liberali, nonché un successo di socialisti e popolari.
Nel giugno 1920 Giolitti tornò al potere con un programma molto avanzato.
Durante il suo governo fu risolta la questione di Fiume (trattato di Rapallo e fine dell’impresa dannunziana).
Tuttavia il disegno giolittiano di ridimensionare le spinte rivoluzionarie del Psi attraverso un’apertura riformista fallì.
Il maggior episodio di conflittualità del periodo fu l’occupazione delle fabbriche (settembre ’20), al cui conclusione accentuò le divisioni del movimento socialista e diffuse in tutta la borghesia un desiderio di rivincita.
Al congresso socialista di Livorno del gennaio ’21, la corrente di sinistra guidata da Bordiga e Gramsci si scisse dal Psi e fondò il Partito comunista.
Tra la fine del ’20 e l’inizio del ’21 il fascismo, abbandonando gli originari caratteri radical-democratici si qualificò decisamente in senso antisocialista.
Le azioni squadristiche colpirono sedi ed esponenti del movimento operaio e contadino del Centro-Nord, in particolare le leghe rosse nella Valle Padana.
Le cause della repentina crescita del fascismo agrario furono varie: forza “militare”, connivenza con i pubblici poteri, tentativo di Giolitti di usare il fascismo pe ridurre alla ragione socialisti e popolari, ma anche consensi in quelle categorie contadine (piccoli proprietari, mezzadri, piccoli affittuari) che mal sopportavano il controllo esercitato dalle organizzazioni socialiste nelle campagne.
L’inserimento nel “blocchi nazionali” (elezioni del maggio ’21) diede al fascismo una completa legittimazione.
Profittando della debolezza dei governi liberali (Bonomi e Facta), il fascismo si rese protagonista di imprese sempre più clamorose, culminate nella risposta allo sciopero “legalitario” dell’agosto ’22, estremo tentativo socialista di arginare le violenze squadristiche.
Mentre trattava con i principali leader liberali per una partecipazione al governo, Mussolini lasciò che le milizie fasciste si preparassero per un colpo di Stato.
Il successo della marcia su Roma (28 ottobre ’22) fu reso possibile solo dal rifiuto del re a firmare lo stato d’assedio.
Il nuovo governo Mussolini – lungi dal rappresentare, come parve a molti, un ritorno alla normalità – preparava la fine dello Stato liberale.
Una volta al potere, Mussolini attuò una politica autoritaria (soprattutto contro il movimento operaio) e creò nuovi istituti (il Gran consiglio del fascismo e la Milizia) incompatibili con i principi liberali.
Allo stesso tempo continuò a promettere la “normalizzazione” e a collaborare con forze politiche non fasciste.
Oltre all’appoggio di liberali e cattolici, Mussolini poteva valersi di quello del potere economico, nonché del sostegno alla Chiesa, che vedeva nel fascismo un baluardo contro la minaccia socialista.
Un ulteriore rafforzamento il fascismo ottenne con le elezioni del ’24, tenute secondo la legge maggioritaria: da esse le opposizioni uscirono notevolmente ridimensionate.
Nel giugno ’24 il deputato socialista Matteotti – che aveva denunciato alla Camera i brogli e le violenze commesse dai fascisti in occasione delle elezioni – fu assassinato da un gruppo di squadristi.
L’ondata di sdegno che ne seguì fece vacillare il potere di Mussolini.
Ma le opposizioni, che abbandonarono la Camera (secessione dell’Aventino), erano troppo deboli per mettere in crisi al governo.
Col duro discorso del 3 gennaio ’25, Mussolini riacquistò il controllo della situazione.
Tra il ’25 e il ’26 si consumò la fine dello Stato liberale: “fascistizzazione” della stampa, persecuzione degli antifascisti, rafforzamento dei poteri del capo del governo, legge “per la difesa dello Stato” (che, tra l’altro, istituiva il Tribunale speciale), scioglimento di tutti i partiti (tranne quello fascista).
Bibliografia
Nascita e avvento del fascismo / A. Tasca. – La Nuova Italia, 1995
Lezioni di Harvard: l’Italia dal 1919 al 1929 / G. Salvemini. – In: Scritti sul fascismo. – Feltrinelli, 1961
Storia delle origini del fascismo / R. Vivarelli. – Il Mulino, 1991
Fascismo e antifascismo: i partiti italiani fra le due guerre / E. Gentile. – Le Monnier, 2000
Storia del socialismo italiano, 1892-1926 / G. Arfé. – Einaudi, 1965
Il partito socialista italiano dal 1919 al 1946 / L. Guerci. – Cappelli, 1969
Il movimento cattolico in Italia: il Partito popolare italiano / G. De Rosa. – Laterza, 1966
Storia del Partito fascista, 1919-1922 / E. Gentile. – Laterza, 1989
Le origini dell’ideologia fascista, 1918-1925 / E. Gentile. – Il Mulino, 1996
Cap. 5. La grande crisi: economia e società negli anni ‘30
5.1 Crisi e trasformazione
Alla fine degli anni ’20 l’Europa e il mondo sembravano avviati a superare i traumi e le ferite del primo conflitto mondiale.
I rapporti fra le maggiori potenze attraversavano una fase di distensione.
Il problema tedesco – punto critico dell’assetto europeo – sembrava avviato a una soluzione equilibrata, che garantiva gli interessi delle potenze vincitrici e assicurava al tempo stesso il reinserimento pacifico della Germania fra i protagonisti della politica internazionale.
L’economia dell’Occidente capitalistico, trainata dalla spettacolosa espansione produttiva degli Stati Uniti, aveva ripreso a svilupparsi con discreta regolarità dopo le convulsioni del primo quinquennio postbellico.
In questo quadro di apparente stabilità e di diffusa prosperità si abbatté una crisi economica tanto imprevista quanto catastrofica.
Scoppiata negli Stati Uniti nell’autunno del ’29 e prolungatasi per buona parte degli anni ’30, la “grande crisi” – come ancora oggi viene chiamata – fece sentire i suoi effetti anche sulla politica e sulla cultura, sulle strutture sociali e sulle istituzioni statali, segnando una netta cesura – che si sovrappose a quella creata dalla grande guerra – nello sviluppo storico delle società occidentali.
Sconvolse i vecchi assetti e accelerò trasformazioni già in atto.
Diede un’ulteriore, decisiva spinta alla decadenza dell’Europa liberale.
Compromise seriamente gli equilibri internazionali, mettendo in moto una catena di eventi che avrebbe portato, nel giro di un decennio, a un nuovo conflitto mondiale.
Nel corso degli anni’30 vennero inoltre in primo piano i problemi e tematiche destinati a improntare di sé la società del secondo dopoguerra: la compenetrazione fra apparati statali ed economia (già venuta in evidenza durante la grande guerra) e l’affermarsi di forme di capitalismo diretto (ossia programmato dall’alto); lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa (radio e cinematografo); la crescita delle classi medie (in particolare dei ceti impiegatizi), in rapporto allo sviluppo continuo del settore terziario; la radicalizzazione dei conflitti ideologici e il loro trasferimento su scala internazionale.
Si tratta di processi molto diversi da loro, né tutti possono essere collegati in senso stretto alla grande crisi: questa tuttavia, in quanto fenomeno dominante di un intero decennio e origine di profonde trasformazioni, ha assunto nella ricostruzione storica il rilievo di un evento periodizzante.
Parola chiave
Ceto medio
L’espressione “ceto medio” (o “classe media”) indica genericamente quegli strati sociali che occupano una posizione intermedia nella distribuzione della ricchezza, del potere e del prestigio in una società che si presume divisa secondo uno schema bipolare (aristocrazia-popolo, poveri-ricchi, borghesia-proletariato).
Già nel tardo ‘700 si parlava di ceto medio in riferimento al “terzo stato”, cioè alla borghesia.
Più tardi, con lo sviluppo del capitalismo e col delinearsi di un antagonismo “primario” fra borghesia e proletariato, l’espressione è diventato sinonimo di “piccola e media borghesia” ed è passata a designare un arco molto ampio e variegato di classi e gruppi sociali.
Rientravano sotto questa definizione tutti quei gruppi che non potevano essere assimilati alla borghesia propriamente detta (imprenditori e proprietari), ma si distaccavano dalle classi popolari per cultura, mentalità e orientamenti politici, oltre che per condizioni economiche: piccoli proprietari e piccoli commercianti, ma soprattutto impiegati pubblici e privati.
Le trasformazioni economiche e sociali intervenute nel ‘900 – in particolare la crescita degli apparati statali e lo sviluppo del settore dei servizi – hanno gonfiato numericamente questi strati (che invece, secondo lo schema marxista, erano destinati a scomparire o a “proletarizzarsi”) e ne hanno progressivamente aumentato il peso politico.
Nel periodo fra le due guerre mondiali furono soprattutto le inquietudini e le oscillazioni del ceto medio (fin allora considerato come una garanzia di stabilità sociale e come la base più sicura delle istituzioni liberal-democratiche) a determinare le più profonde trasformazioni politiche.
I regimi autoritari e fascisti, in particolare, trovarono il loro principale sostegno di massa proprio nel ceto medio: mentre i partiti operai pagarono spesso duramente l’errore di aver sottovalutato la forza e di averlo giudicato fatalmente subalterno alle scelte della grande borghesia.
Nel secondo dopoguerra, tutti i partiti di massa, compresi quelli di sinistra, hanno riservato un’attenzione crescente alle esigenze di questo strato sociale (da cui, fra l’altro, provengono in gran parte i quadri dirigenti dei partiti stessi) e hanno cercato di guadagnarne i consensi.
Ciò è apparso tanto più necessario in relazione ai redenti sviluppi delle società industrializzate (innalzamento generale dei livelli di vita, crescita del settore terziario): sviluppi che, se da un lato hanno ulteriormente dilatato la consistenza numerica del ceto medio, dall’altro hanno reso meno netta la distinzione, in termini di reddito e di status sociale, fra classe operaia e piccola borghesia.
Oggi si parla sempre più spesso, nei paesi economicamente avanzati, di una progressiva scomparsa delle classi tradizionalmente intese: o meglio di un loro assorbimento in un unico, grande, ceto medio che comprende ormai la maggioranza della popolazione, lasciando fuori solo alcune consistenti sacche di “nuova povertà” (non più coincidenti col proletariato industriale) e alcune esigue minoranze di ricchissimi e privilegiati.
Sommario
Gli anni ’20 furono per gli Stati Uniti un periodo di prosperità economica che influì sulla stessa vita quotidiana degli americani (con la diffusione dell’automobile e delgi elettrodomestici).
Dal punto di vista politico fu incontrastata l’egemonia del Partito repubblicano, sostenitore di un indirizzo conservatore e liberista.
Si diffondevano, tra l’opinione pubblica, tendenze conservatrici e pregiudizi raziali.
La borghesia americana cercava facili guadagni nella speculazione borsistica, inconsapevole delle fragili basi dell’espansione economica di quegli anni.
Il crollo della Borsa di New York (ottobre 1929) fu a un tempo la spia di un malessere economico preesistente e la causa di ulteriori episodi di crisi.
Negli Stati Uniti molte aziende dovettero chiudere.
Le misure protezionistiche adottate subito negli Usa – e poi negli altri paesi – provocarono una brusca contrazione del commercio internazionale.
La recessione economica – cui si accompagnò un altissimo numero di disoccupati – si diffuse in tutto il mondo.
In Europa una grave crisi finanziaria culminò nella sospensione della convertibilità della sterlina.
Scarso successo ebbero le politiche di austerità perseguite dai governi dei paesi industrializzati, che finirono con l’aggravare la recessione in corso e col ripercuotersi negativamente sugli equilibri politici e sociali.
Nel 1932 divenne presidente degli Stati Uniti il democratico F. D. Roosvelt.
La sua politica (New Deal) si caratterizzò per un energico intervento dello Stato nell’economia e per alcune iniziative di riforma sociale.
Il New Deal, se rappresentò un’importante innovazione, non riuscì a determinare una piena ripresa dell’economia americana, che si sarebbe verificata solo con la guerra.
Un po’ in tutti i paesi la grande crisi finì col far adottare nuove forme di intervento dello Stato in campo economico, che giunsero a configurare una forma di capitalismo “diretto”.
Quanto i governo fecero solo empiricamente fu teorizzato dall’economista Keynes che, in particolare, sottolineò il ruolo della spesa pubblica ai fini dell’incremento della domanda e del raggiungimento della piena occupazione.
Nei paesi europei si verificò proprio durante la grande crisi uno sviluppo di quei consumi di massa che si erano affermati negli Usa negli anni ’20.
Grande diffusione ebbero la radio e il cinema, che divennero elementi caratteristici della società di massa: mezzi di svago, di informazione ma anche di propaganda, essi contribuirono ad accentuare il lato spettacolare della politica.
Negli anni ’20 e ’30 vennero fatte alcune scoperte scientifiche destinate a segnare la storia del 20. secolo: anzitutto quella dell’energia nucleare (che avrebbe portato alla costruzione della bomba atomica).
Sul piano delle applicazioni belliche della scienza, sono da ricordare i grandi sviluppi dell’Aeronautica.
Nella cultura europea si accentuarono alcuni fenomeni di disgregazione e di perdita dell’unità, tanto che nessuna delle correnti del periodo può essere assunta, da sola, come particolarmente rappresentativa.
Furono anni, per gli intellettuali, di grandi contrapposizioni ideologiche (liberismo-comunismo, democrazia-fascismo) e di impegno politico.
L’emigrazione degli intellettuali tedeschi durante il nazismo provocò un impoverimento culturale dell’Europa.
Bibliografia
Il grande crollo / J. K. Galbraith. – Boringhieri, 1972
La grande depressione nel mondo, 1929-1939 / C. P. Kindleberger. – Etas, 1982
La grande trasformazione / K. Polanyi. – Einaudi, 1974
L’età dell’ansia: gli Stati Uniti dal 1920 al 1940 / M. E. Parrish. – Il Mulino, 1992
L’età di Roosvelt / A. Schlesinger, jr. – Il Mulino, 1959-65
Roosvelt e il New Deal, 1932-1940 / W. E. Leuchtenburg. – Laterza, 1968
Il New Deal / a cura di M. Vaudagna. – Il Mulino, 1981
Storia del cinema / G. Fofi…et al. – Garzanti, 1988
Storia del cinema italiano / G. Brunetta. – Editori Riuniti, 1993
Storia del cinema e del film / D. Bordwell, K. Thompson. – Il Castoro, 1998
Storia della radio e della televisione / P. Albert. – Dedalo, 1983
Storia della radio e della televisione in Italia: un secolo di costume, società e politica / F. Monteleone. – Marsilio, 2003
Da sponda a sponda: l’emigrazione degli intellettuali europei e lo studio della società contemporanea, 1930-65 / H. S. Hughes. – Il Mulino, 1977
Cap. 6. L’età dei totalitarismi
Citazione
Ai giovani in cerca di avventura, agli intellettuali bisognosi di certezze, ai piccolo-borghesi delusi dalla democrazia e spaventati dall’alternativa comunista il fascismo pareva offrire una prospettiva nuova ed emozionante: la sensazione di appartenere ad una comunità e di riconoscersi in un capo, la convinzione di essere inseriti in una gerarchia basata sul merito (e non sulla ricchezza o sui privilegi di nascita), l’identificazione certa di un nemico.
Pag. 112
Parola chiave
Totalitarismo
Il termine “totalitarismo” fu inventato, a quanto sembra, dagli antifascisti italiani già nella prima metà degli anni ’20.
Successivamente, furono gli stessi fascisti, a cominciare da Mussolini, a usarlo “in positivo” per definire la loro aspirazione, peraltro mai pienamente realizzata, a una identificazione totale fra Stato e società.
Nel secondo dopoguerra, il termine fu adottato dalla scienza politica e dalla pubblicistica dei paesi occidentali per designare quella particolare forma di potere assoluto, tipica della società di massa, che non si accontenta di controllare la società, ma pretende di trasformarla dal profondo in nome di un’ideologia onnicomprensiva, di pervaderla tutta attraverso l’uso combinato del terrore e della propaganda: quel potere, insomma, che non solo è in grado di reprimere, grazie a un imponente apparato poliziesco, ogni forma di dissenso, ma cerca anche di mobilitare i cittadini attraverso il monopolio dell’educazione e dei mezzi di comunicazione di massa.
Il concetto di totalitarismo – così come lo ha definito la scienza politica, da Hannah Arendt a Carl J. Friedrich e Zbigniew K. Brzezinsky – è modellato sulla concreta esperienza del nazismo tedesco e del comunismo staliniano.
Più discussa è la sua applicabilità al caso del fascismo italiano (che pure, come abbiamo visto, si autodefiniva totalitario) o a quella dei regimi comunisti imposti all’Europa dell’Est nel secondo dopoguerra.
Certamente scorretto è parlare di “totalitarismo” in riferimento a regimi autoritari più “tradizionali” come il franchismo e il salazarismo.
Per molto tempo la categoria del totalitarismo è stata rifiutata, o quanto meno guardata con sospetto, dalla cultura di sinistra (in particolare da quella marxista) perché, prescindendo da qualsiasi riferimento alla base sociale dei regimi, accomunava fenomeni giudicati incomparabili come il nazismo e lo stalinismo.
Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, il termine si è largamente affermato nel linguaggio politico corrente (e anche in quello della sinistra).
Oggi il termine “totalitarismo” rischia di essere addirittura “inflazionato”.
Lo si usa infatti comunemente – e impropriamente – come sinonimo di “autoritarismo” o di “dittatura” o di “tirannia”.
Citazione
Il ministero Brüning continuò a governare per altri due anni grazie all’appoggio concessogli, in mancanza di alternative, dalla Spd e soprattutto grazie al sostegno del presidente Hindenburg, che si valse sistematicamente dei poteri straordinari previsti dalla costituzione nei casi di emergenza.
Pag. 115
Sommario
Dopo la crisi del ’29 si diffuse in tutta Europa il fenomeno della disaffezione verso la democrazia.
Parallelamente si affermarono, negli anni ’30, regimi antidemocratici, sia di tipi tradizionale sia di tipo “moderno” (cioè ispirati al fascismo e al nazismo).
La novità del fascismo e del nazismo si evidenziò nel campo dell’organizzazione del potere, con quella della ricerca di un controllo totale sui cittadini (comune al regime staliniano) che ha fatto coniare il termine “totalitarismo”.
Il successo del nazismo è strettamente collegato alle conseguenze della grande crisi.
Fu allora che la maggioranza dei tedeschi perse ogni fiducia nella Repubblica di Weimar e nei partiti democratici e prestò ascolto in misura crescente alla propaganda del nazismo, che prometteva il ritorno della Germania alla passata grandezza, indicando nelle sinistre e negli ebrei i responsabili delle difficoltà del paese.
Il partito di Hitler, rimasto fin allora ai margini della vita politica, vide crescere i suoi consensi nelle numerose elezioni che si tennero fra il ’30 e il ’32, fino a diventare il primo partito tedesco.
Nel gennaio ’33 Hitler fu chiamato dal presidente Hindenburg a guidare il governo.
La trasformazione della Repubblica tedesca in dittatura avvenne nel giro di pochi mesi.
Nel ’33, traendo pretesto dall’incendio del Reichstag, Hitler assunse i pieni poteri e annientò le opposizioni.
L’anno seguente si sbarazzò dell’ala estremista del nazismo (quella che faceva capo alla milizia armata delle SA) e, morto Hindenburg, si fece nominare capo dello Stato.
Tra i principi-base del nazismo stava il particolare rapporto del capo (Führer) e le masse (inquadrate nel partito unico e nei suoi programmi collaterali).
Dalla “comunità di popolo” in cui il nazismo voleva trasformare tutti i tedeschi erano esclusi gli ebrei, che una massiccia propaganda additava a bersaglio dell’odio popolare e che vennero legalmente discriminati con le leggi di Norimberga (1935).
Le azioni violente contro di essi si sarebbero trasformate, durante la guerra, nella politica dello sterminio.
Non vi fu, durante il nazismo, alcuna forma di opposizione politica.
La Chiesa cattolica e quelle luterane finirono con l’adattarsi al regime.
L’efficienza dell’apparato repressivo spiega la mancanza di un esplicito dissenso, non l’estensione notevole del consenso al regime.
Tale consenso ebbe varie cause: i successi in politica estera, la ripresa economica (dovuta a una politica di riarmo e lavori pubblici), il raggiungimento della piena occupazione e il miglioramento dei servizi sociali; ma anche l’uso molto abile che il nazismo seppe fare delle cerimonie pubbliche e dei mezzi di comunicazione di massa.
Già nel corso degli anni ’20 regimi autoritari si erano affermati in molti paesi: nell’Europa centro-orientale (Ungheria, Polonia), nei Balcani (Bulgaria, Jugoslavia) e nella penisola iberica (Spagna, Portogallo).
L’avvento del nazismo in Germania provocò una ulteriore diffusione di questi regimi (Austria, Grecia e Romania) e una loro radicalizzazione.
In Urss, alla fine degli anni ’20, Stalin pose fine alla Nep, dando inizio all’industrializzazione forzata.
Le attività agricole vennero collettivizzate (e i kulaki, di fatto, sterminati).
Parallelamente fu varato, nel 1928, il primo piano quinquennale che segnò una strepitosa crescita della produzione industriale (questo suscitò diffusa ammirazione nel mondo occidentale, che subiva le conseguenze della grande crisi).
Il nuovo indirizzo ebbe costi umani assai elevati e si accompagnò ad un clima di forte mobilitazione ideologica.
Gli anni ’30 videro anche il continuo rafforzamento della dittatura personale di Stalin, che eliminò tutti i suoi possibili rivali (in pratica l’intero gruppo dirigente bolscevico).
Col 1934 ebbe inizio la stagione delle “grandi purghe” e del terrore indiscriminato, funzionale al rafforzamento del potere di Stalin.
Quello che si consumò in Urss negli anni dello stalinismo fu un vero e proprio sterminio di massa.
Le prime iniziative hitleriane in politica estera (ritiro dalla Società delle Nazioni, appoggio al tentativo dei nazisti austriaci di impadronirsi del potere) rappresentarono una minaccia all’equilibrio internazionale).
A partire dal 1935 la causa della sicurezza collettiva trovò un sostegno nella nuova politica espera sovietica, ispirata alla lotta al fascismo come principale nemico, che incoraggiò la formazione di alleanze tra comunisti e forze socialiste e democratiche-borghesi.
Nel ’36 governi di Fronte popolare sorsero in Spagna e Francia.
In Spagna, alla vittoria del Fronte popolare (febbraio ’36) seguì una ribellione militare.
I militari, guidati dal generale Franco, ebbero il decisivo aiuto di Italia e Germania, mentre i repubblicani poterono contare solo su rifornimenti sovietici e sui reparti di volontari antifascisti.
La sconfitta dei repubblicani fu dovuta anche alle profonde divisioni esistenti al oro interno soprattutto fra comunisti e anarchici.
Nel 1939 la guerra civile terminava con la vittoria di Franco.
Negli stessi anni della guerra di Spagna, la politica di arrendevolezza (appeasement) praticata da Francia e Inghilterra nei confronti della Germania finì con l’incoraggiare la politica espansionistica del nazismo.
Nel 1938 avveniva l’annessione dell’Austria (Anschluss); subito dopo Hitler avanzava mire sul territorio cecoslovacco abitato da popolazione tedesca (Sudeti).
Gli accordi di Monaco (settembre ’38) sembrarono conservare la pace ma – accettando le richieste tedesche – finirono con lo spianare la strada ad un nuovo conflitto mondiale.
Bibliografia
Le origini del totalitarismo / H. Arendt. – Comunità, 1967
Il totalitarismo / S. forti. – Laterza, 2001
Il totalitarismo / E. Traverso. – Bruno Mondadori, 2002
Da Weimar a Hitler / M. Broszat. – Laterza, 1986
La dittatura tedesca / K. D. Bracher. – Il Mulino, 1973
Storia sociale del Terzo Reich / D. Peukert. – Sansoni, 1989
Lo Stato nazista / N. Frei. – Laterza, 1992
Il Terzo Reich / H. U. Thamer. – Il Mulino, 1993
Hitler e l’enigma del consenso / I. Kershaw. – Laterza, 1997
Hitler / J. C. Fest. – 1974
Hitler, 1889-1945 / I. Kershaw. – Bompiani, 1999-2001
La nazionalizzazione delle masse / G. L. Mosse. – Il Mulino, 1975
Germania: un passato che non passa / a cura di G. E. Rusconi. – Einaudi, 1987
Che cos’è il nazismo/ I. Kershaw. – Bollati Boringhieri, 1995
Il fascismo in Europa / a cura di S. J. Wolf. – Laterza, 1968
Storia del sistema sovietico / F. Benvenuti. – Nis, 1995
Storia della Russia contemporanea, 1853-1996 / F. Benvenuti
Lo stalinismo / R. Medvedev. – Mondadori, 1972
Il fenomeno Stalin nella storia del 20. secolo / G. Boffa. – Laterza, 1982
Lo stalinismo / A. Romano. – Brino Mondadori, 2002
Il lungo terrore / F. Bettanin. – Editori Riuniti, 1999
Storia del Gulag / O. V. Chlevnjuk. – Einaudi, 1996
Storia del pensiero comunista / M. L. Salvadori. – Mondadori, 1984
Il passato di un’illusione: l’idea comunista nel 20. secolo / F. Furet. – Mondadori, 1995
Nazionalsocialismo e bolscevismo: la guerra civile europea, 1917-1945 / E. Nolte. – Sansoni, 1989
Storia della guerra civile spagnola / H. Thomas. – Einaudi, 1963
La guerra civile spagnola / P. Preston. – Mondadori, 1999
L’eclissi della democrazia / G. Ranzato. – Bollati Boringhieri, 2004
Le ombre dell’Europa: democrazie e totalitarismi nel 20. secolo / M. Mazower. – Garzanti, 2000
Crisi fra le due guerre mondiali, 1919-1939 / R. Overy. – Il Mulino, 1998
Guerra e rivoluzione in Europa, 1905-1956 / A. Graziosi. – Il Mulino, 2001
Cap. 7. L’Italia fascista
Parola chiave
Consenso
Nel linguaggio politico moderno, il termine “consenso” indica l’accordo tra i membri di una comunità su alcuni valori e principi fondamentali o su alcuni obiettivi specifici che la comunità stessa si pone attraverso l’azione dei suoi gruppi dirigenti.
Nei sistemi democratici e pluralisti, un certo grado di consenso sui principi e sulle istituzioni è considerato indispensabile alla vita dello Stato: ma sulle scelte dei governanti il dissenso è ammesso e in qualche misura istituzionalizzato attraverso meccanismi che permettono il ricambio della classe dirigente.
Invece nei sistemi autoritari – e soprattutto in quelli totalitari [parola chiave cap. 6] – il dissenso è represso o nascosto, mentre il consenso è dato per scontato, sulla base di una arbitraria attribuzione al capo, o al partito dominante, della capacità di rappresentare il popolo e di interpretarne i bisogni.
Questo non significa che anche i regimi autoritari non possano godere di autentico consenso popolare.
Il problema, per gli storici, è di verificare e misurare questo consenso, in assenza di indicatori attendibili (poiché tali non sono i risultati delle consultazioni elettorali “plebiscitari” e le manifestazioni di massa organizzate dai regimi stessi).
Nel caso del fascismo italiano, ad esempio, si è discusso e si continua a discutere sulla natura e sulle dimensioni del consenso di cui il regime godette.
Negli anni ’70 il più autorevole storico del fascismo, Renzo de Felice, autore di una grande biografia di Mussolini, ha sostenuto che, per la maggioranza della popolazione, questo consenso fu ampio e stabile, soprattutto nella prima metà degli anni ’30 (prima che cominciasse la fase delle guerre e dell’avvicinamento alla Germania nazista).
Altri studiosi hanno contestato sia le conclusioni di De Felice, sia l’attendibilità delle fonti da lui prevalentemente utilizzate (la stampa, le carte di Mussolini, i rapporti della polizia); e hanno affermato che il grosso della popolazione diede al regime niente più che un consenso “passivo”, un’accettazione rassegnata (salvo che in alcuni momenti particolari, come la conquista dell’Etiopia o al conferenza di Monaco).
Oggi la maggior parte degli storici tende a riconoscere al fascismo una certa base di consenso, soprattutto fra i ceti medi.
Anche se ci si rende conto della difficoltà di valutarne la natura (come si può distinguere il consenso “attivo” da quello “passivo”?) e di misurarne con precisione l’entità
Citazione
Per dare una risposta sintetica agli interrogativo circa il reale grado di fascistizzazione del paese, si può quindi concludere che questo fenomeno fu ampio, ma riguardò essenzialmente gli strati intermedi della società, toccando solo parzialmente le classi popolari e l’alta borghesia, che il regime riuscì a cambiare, in maniera anche vistosa, i comportamenti pubblici e le forme di partecipazione collettiva, ma non a trasformare nel profondo schemi mentali e strutture sociali
Pag. 147
L’obiettivo di “quota novanta” fu raggiunti in poco più di un anno, in virtù di una serie di provvedimenti che limitavano drasticamente il credito con l’aiuto di un cospicuo prestito concesso allo Stato italiano da grandi banche statunitensi
Pag. 151
Nei nuovi enti parastatali e nella stessa Banca d’Italia (che nel 1926 ottenne il monopolio dell’emissione di moneta e vide i suoi poteri ulteriormente rafforzati da una riforma bancaria nel 1936) si formò così una “burocrazia parallela” destinata a svolgere un ruolo di primo piano nell’Italia postfascista.
Pag. 153
Se si volesse tracciare un bilancio del movimento antifascista in base ai suoi scarsi successi immediati, si dovrebbe concludere che la sua incidenza sulla situazione italiana di quegli anni fu poco più che nulla.
Per molto tempo gli antifascisti attesero invano un grande sommovimento popolare che abbattesse il regime.
Si illusero che lo scossone potesse venire dalla grande crisi e dall’avventura etiopica, dovendo poi constatare che il fascismo era uscito rafforzato dall’una e dall’altra.
Quando infine scoppiò la guerra, si trovarono nella difficile posizione di chi è costretto ad augurarsi la sconfitta del proprio paese; e solo nell’ultima fase del conflitto, a disfatta ormai avvenuta, ebbero l’occasione di combattere il fascismo con le armi e sul suolo italiano.
Eppure il movimento antifascista svolse, fra il ’26 e il ’43, un ruolo di grande importanza politica oltre che morale.
Testimoniò con la sua sola presenza l’esistenza di un’Italia che non si piegava al fascismo e ad essa diede voce e rappresentanza politica, rese possibile il sorgere, dopo il ’43, di un movimento di resistenza armata al nazifascismo (movimento che invece mancò del tutto in Germania); anticipò con le sue riflessioni teoriche e i suoi dibattiti molti tratti della futura Italia democratica: un’Italia che gli antifascisti non sempre seppero immaginare quale poi sarebbe stata in realtà, ma che certo contribuirono più d’ogni altro a rifondare.
Pag. 159
Sommario
Nel regime fascista l’organizzazione dello Stato e quella del partito venivano a sovrapporsi.
Fu la prima però – per volere di Mussolini – ad avere sempre la prevalenza, mentre le funzioni del Pnf, sempre più burocratizzato, fu quella di “occupare” la società civile, soprattutto attraverso le sue organizzazioni collaterali.
Un primo limite ai propositi totalitari del regime era rappresentato dal peso della Chiesa, la cui influenza venne espressamente riconosciuta con i Patti lateranensi (1929).
I Patti rappresentarono anche un successo politico per il fascismo, sancito dal plebiscito di quello stesso anno.
Altro limite ai propositi totalitari era costituito dalla presenza del re quale massima autorità dello Stato.
Negli anni del fascismo, nonostante l’aumento dell’urbanizzazione e degli addetti all’industria e ai servizi, la società italiana restava notevolmente arretrata.
La “fascistizzazione” perseguita dal regime – portatore di un’ideologia tradizionalistica, ma aspirante anche alla creazione di un “uomo nuovo” – poté realizzarsi solo in parte: il fascismo riuscì ad ottenere il consenso della piccola e media borghesia, ma solo in misura limitata e superficialmente quello dell’alta borghesia e delle classi popolari (queste ultime videro diminuire i loro salari e i loro consumi).
Il regime cercò in modo particolare di esercitare uno stretto controllo nell’ambito della scuola e della cultura.
Soprattutto si impegnò nel campo dei mezzi di comunicazione di massa, essendo consapevole della loro importanza ai fini del consenso.
La radio e il cinema furono, così, sia strumenti di propaganda sia mezzi di semplice intrattenimento.
Il fascismo non costruì un nuovo sistema economico: il modello corporativo rimase infatti sulla carta.
Sul piano della politica economica, si passò nel ’25 da una linea liberista ad una protezionistica e di maggior intervento statale.
La “battaglia del grano” doveva servire al raggiungimento dell’autosufficienza cerealicola; la rivalutazione della lira (“quota novanta”) aveva il compito di dare al paese un’immagine di stabilità monetaria.
Di fronte alla crisi del ’29, il regime reagì attraverso una politica di lavori pubblici (“risanamento” di Roma, bonifica della paludi pontine) e di intervento diretto dello Stato in campo industriale e bancario.
Con l’Iri lo Stato diventò proprietario di alcune fra le maggiori imprese italiane.
Superata la crisi, il fascismo indirizzò l’economia verso la produzione bellica.
Fino ai primi anni ’30 le aspirazioni imperiali, connaturate all’ideologia del fascismo, rimasero vaghe.
L’aggressione all’Etiopia (1935) mutò bruscamente la posizione internazionale del regime.
Se l’impresa indubbiamente costituì per Mussolini un grosso successo politico, vista l’adesione della maggioranza dell’opinione pubblica, rappresentò anche una rottura con le potenze democratiche.
Questa rottura fu accentuata dall’intervento nella guerra civile spagnola e dal riavvicinamento alla Germania (sancito nel ’36 dall’asse Roma-Berlino).
Tale riavvicinamento era concepito da Mussolini come un mezzo di pressione su Francia e Inghilterra: si risolse invece – con la firma del “patto d’acciaio” (1939) – in una subordinazione alle scelte di Hitler.
In Italia la maggioranza degli antifascisti – soprattutto ex-popolari e liberali – rimasero in una posizione di silenziosa opposizione.
I comunisti invece si impegnarono, benché con scarsi risultati, nell’agitazione clandestina; sulla stessa linea si mosse il gruppo di “Giustizia e Libertà”, di indirizzo liberal-socialista.
Gli altri gruppi in esilio all’estero (socialisti, repubblicani, democratici, federati nel ’27 nella Concentrazione antifascista) svolsero soprattutto un’opera di elaborazione politica in vista di una sconfitta del regime che l’antifascismo non era in grado di provocare.
Nonostante questa debolezza, l’importanza dell’antifascismo risiedette nella funzione di testimonianza e di preparazione dei quadri e delle piattaforme politiche della futura Italia democratica.
Il consenso ottenuto dal regime cominciò ad incrinarsi dopo l’impresa etiopica.
La politica dell’”autarchia” – finalizzata all’obiettivo dell’autosufficienza economica in caso di guerra – ottenne solo parziali successi e suscitò un diffuso malcontento.
Soprattutto l’avvicinamento alla Germania e alla politica discriminatoria nei confronti degli ebrei suscitarono timori e dissensi nella maggioranza della popolazione.
Soltanto fra le nuove generazioni il disegno mussoliniano di trasformare in senso fascista la vita e la mentalità degli italiani ottenne qualche successo.
Bibliografia
L’organizzazione dello Stato totalitario / A. Aquarone. – Einaudi, 1965
La via italiana al totalitarismo / E. Gentile. – Nis, 1995
Fascismo e antifascismo: i partiti italiani fra le due guerre / E. Gentile. – Le Monnier, 2000
Il fascismo: la politica in un regime totalitario / S. Lupo. – Donzelli, 2000
L’economia italiana nel periodo fascista / a cura di P. L. Ciocca e G. Toniolo. – Il Mulino, 1976
L’economia dell’Italia fascista / G. Toniolo. – Il Mulino, 1980
Fascismo e politica di potenza / E. Collotti. – La Nuova Italia, 1999
Hitler e Mussolini: la difficile alleanza / J. Petersen. – La Nuova Italia, 1975
La fabbrica del consenso: fascismo e mass media / P. V. Cannistraro. – Laterza, 1975
Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista: l’organizzazione del dopolavoro / V. De Grazia. – Laterza, 1981
L’opinione degli italiani sotto il regime / S. Colarizi. – Laterza, 2000
Il culto del littorio / E. Gentile. – Laterza, 1993
L’educazione dell’italiano / M. Isnenghi. – Cappelli, 1979
L’interventismo della cultura: intellettuali e riviste del fascismo / L. Mangoni. – Laterza, 1974
L’autarchia della cultura / G. C. Marino. – Editori Riuniti, 1983
Il ventennio degli intellettuali / G. Belardelli. – Laterza, 2005
L’ideologia del fascismo / P. G. Zunino. – Il Mulino, 1985
Storia dei fuoriusciti / A. Garosci. – Laterza, 1953
L’Italia antifascista dal 1922 al 1940 / a cura di S. Colarizi. – Laterza, 1976
I nemici di Mussolini / C. F. Delzell. – Einaudi, 1966
Storia della Concentrazione antifascista / S. Fedele. – Feltrinelli, 1976
Storia degli ebrei italiani durante il fascismo / R. De Felice. – Einaudi, 1961
Gli ebrei nell’Italia fascista: vicende, identità, persecuzione / M. Sarfatti. – Einaudi, 2000
Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia / E. Collotti. – Laterza, 2003
Cap. 8. Il tramonto del colonialismo: l’Asia e l’America Latina
Parola chiave
Non violenza
La pratica della non violenza come strumento politico fu adottata sistematicamente e resa popolare presso l’opinione pubblica mondiale da Mohandas Karamchand Gandhi e dai suoi seguaci nella lotta per l’indipendenza dell’India, negli anni fra le due guerre mondiali.
Secondo la strategia gandhiana, gli indiani dovevano rispondere alla violenza della dominazione inglese non con la forza delle armi (secondo il modello delle rivoluzioni europee, da quella francese a quella russa), ma con la resistenza passiva, col digiuno volontario, col rifiuto di obbedire alle leggi ingiuste, con lo sfruttamento dei margini legali consentiti dalle leggi esistenti, con la non collaborazione con i dominatori e con il boicottaggio dei prodotti dell’industria europea : una scelta, quest’ultima, che significava anche difendere le strutture tradizionali della società e dell’economia locale, basata sull’agricoltura e sull’artigianato.
Del resto la pratica non violenta, se da un lato riprendeva spunti già presenti nel pensiero occidentale (il pacifismo dell’ultimo Tolstoj o la “disobbedienza civile”, teorizzata a metà dell’800 dal filosofo statunitense Henri David Thoreau), si collegava, nel pensiero di Gandhi, alla cultura e alla spiritualità induista, tutta volta alla trasformazione interiore dell’uomo, premessa necessaria per qualsiasi trasformazione politica.
Tutto questo non significava dunque rassegnarsi all’ingiustizia, ma combatterla adottando una strategia nuova e particolarmente rischiosa, in quanto non escludeva la risposta violenta degli avversari.
Questa strategia fece proseliti in tutto il mondo, in contesti molto diversi fra loro.
Il movimento per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti, guidato dal pastore Martin Luther King, la fece propria e la applicò con coerenza negli anni ’60 del ‘900.
In Italia il maggiore teorico della non violenza fu il filosofo Aldo Capitini, autore già nel 1937, in pieno ventennio fascista, di un libro (Elementi di una esperienza religiosa) in cui cercava di dimostrare come il ricorso alla forza, anche per i più nobili scopi, aprisse sempre la strada all’ingiustizia e come fosse necessario, per sperare in una società migliore, spezzare il circolo vizioso adottando la non violenza come un fine a sé.
Nell’Italia repubblicana, furono soprattutto i movimenti pacifisti e antimilitaristi, sia cattolici che laici (a partire soprattutto dagli anni ’60 e ancora in tempi recenti), a far propria la lezione gandhiana nella lotta contro gli armamenti nucleari o in quella a favore dell’obiezione di coscienza.
Ma sono stati soprattutto i radicali di Marco Pannella a servirsi di strategie non violente (dal digiuno alla disobbedienza civile) per condurre le loro battaglie sui temi più svariati: dall’aborto alla pena di morte, dall’informazione alla condizione carceraria.
Sommario
Il contributo, in uomini e materie prime, dato dalle colonie inglesi e francesi durante la grande guerra, le suggestioni della rivoluzione russa e dell’ideologia wilsoniana avevano alimentato le aspirazioni all’indipendenza delle colonie europee.
I movimenti indipendentisti erano stati spesso strumentalizzati durante la guerra, soprattutto in Medio Oriente, dove l’appoggio inglese al nazionalismo arabo contrastava in realtà con la contemporanea spartizione della regione tra Gran Bretagna e Francia e con il riconoscimento dei diritti del movimento sionista in Palestina.
In Turchia la sconfitta subita dall’Impero ottomano nella grande guerra suscitò un movimento di riscossa nazionale promosso dalle forze armate e guidato da un generale, Mustafà Kemal.
Dopo aver sconfitto la Grecia, che occupava la zona di Smirne, Kemal proclamò la repubblica e avviò una politica di modernizzazione e la laicizzazione del paese.
La Gran Bretagna cercò di venire incontro ad alcune delle aspirazioni delle sue colonie: concesse l’indipendenza all’Egitto e creò, con il Commonwealth, una libera associazione degli Stati ad essa soggetti.
Più difficile fu per gli inglesi affrontare il problema indiano, dove il movimento indipendentista si sviluppò soprattutto per opera di Gandhi; in India la Gran Bretagna alternò interventi repressivi a concessioni di autonomia.
Negli anni fra le due guerre la Cina fu teatro di una lunga guerra civile.
Fino alla metà degli anni ’20 il contrasto fu tra nazionalisti del Kuomintang – alleati con i comunisti – e il governo centrale.
Negli anni successivi si scatenò una dura lotta tra il Kuomintang, alla cui testa era ora Chang Kai-Skek, e i comunisti.
Sconfitto il governo centrale, Chang proseguì nella sua lotta contro i comunisti, relegando in secondo piano quella contro i giapponesi che, nel ’31, avevano invaso la Manciuria.
Il Partito comunista cinese, guidato da Mao Tse-Tung, estese la sua presenza tra i contadini e, nel ’34, con la “lunga marcia” riuscì, nonostante notevoli perdite, a salvare il gruppo dirigente.
Un accordo tra comunisti e nazionalisti in funzione antigiapponese non riuscì ad impedire di lì a poco che il Giappone invadesse il paese e ne occupasse un’ampia zona (’37-39).
In Giappone gli anni tra le due guerre videro un notevole sviluppo economico e l’affermarsi di una spinta imperialistica, in coincidenza col lo sviluppo del movimento di destra e con un crescente autoritarismo del sistema politico.
In America Latina la grande crisi ebbe conseguenze fortemente negative, ma stimolò comunque in alcuni paesi un processo di diversificazione produttiva.
Sul piano politico, molti Stati latino-americani videro l’affermarsi di dittature personali o di governi più o meno autoritari.
In alcuni casi (Brasile, Messico e, più tardi, Argentina), questi regimi assunsero un indirizzo populista e godettero dell’appoggio dei lavoratori urbani.
Bibliografia
Storia del Medio Oriente, 1798-2005 / M. Campanini. – Il Mulino, 2006
Storia dell’India / P. Spear. – Rizzoli, 1970
Storia dell’India / M. Torri. – Laterza, 2000
Storia della rivoluzione cinese / M. Collotti Pischel. – Editori Riuniti, 1972
La Cina contemporanea / J. Chesneaux. – Laterza, 1975
Stella rossa sulla Cina / E. Snow. – Einaudi, 1965
Storia del Giappone moderno / W. G. Beasley. – Einaudi, 1969
Storia del Giappone contemporaneo / J. Halliday. – Einaudi, 1979
Storia dell’America Latina / T. Alperin Donghi. – Einaudi, 1982
Al’America latina nel 20. secolo / M. Plana e A. Trento. – Ponte alle Grazie, 1992
Cap. 9. La seconda guerra mondiale
Parola chiave
Genocidio
“Genocidio” (dal greco génos, stirpe) è lo sterminio deliberato di tutto un popolo, a prescindere dall’età, dal sesso, dalle opinioni politiche e dalle credenze religiose dei suoi membri.
Il termine fu coniato nel 1946, durante il processo di Norimberga contro i dirigenti nazisti, per indicare la più orribile delle colpe che venivano addebitate agli imputati: il massacro degli israeliti nei paesi occupati dall’esercito tedesco.
Quello messo in atto dai nazisti contro gli ebrei non fu certo l’unico massacro indiscriminato compito nella storia ai danni di un intero popolo.
Riferendosi ai secoli passati, si è parlato di genocidio in relazione ad alcune guerre di religione del Medioevo (per esempio la crociata contro gli Albigesi) o la decimazione degli Incas e degli Aztechi a opera dei colonizzatori spagnoli.
Per restare al ‘900, basterà ricordare lo sterminio di oltre un milione di armeni perpetrato dai turchi durante la grande guerra (vedi cap. 1.7); la deportazione – che comportava un vero e proprio “sterminio di classe” – di milioni di contadini (ma anche di intere popolazioni considerate infide, sulla base di discriminanti etniche) decisa da Stalin nel corso degli anni ’30 e ’40; infine il trasferimento forzato, risoltosi in una vera e propria strage, di tutta la popolazione urbana della Cambogia sotto la dittatura comunista di Pol Pot nel ’75-76 (vedi cap. 15.7).
Sul problema dell’”unicità” di quello che impropriamente viene chiamato l’olocausto, ossia il sacrificio del popolo ebraico (e che gli ebrei preferiscono chiamare shoah, in ebraico sciagura, catastrofe) si è sviluppato in tempi recenti un acceso dibattito.
Certo è difficile, e forse inutile, stabilire una graduatoria fra stermini di massa tutti caratterizzati dal fatto di coinvolgere intere popolazioni inermi e di non risparmiare nemmeno i bambini.
Si può tuttavia osservare che nessuno di questi stermini ebbe il carattere sistematico e pianificato della “soluzione finale” progettata da Hitler, che aveva lo scopo di cancellare tutti gli ebrei dalla faccia della terra e aveva l’aggravante di compiersi nel cuore della civilissima Europa.
A maggior ragione appare improprio usare il termine “genocidio” – come spesso si è fatto negli ultimi decenni – per denunciare il carattere di indiscriminata crudeltà (soprattutto nei confronti della popolazione civile) di alcune guerre condotte contro movimenti di guerriglia partigiana (per esempio, dagli americani in Vietnam o dai sovietici in Afghanistan) o per richiamare l’attenzione sull’oppressione di minoranze etniche e su episodi particolarmente sanguinosi di repressione politica.
Sommario
La distruzione della Cecoslovacchia (marzo ’39) determinò una svolta nella politica anglo-francese verso la Germania.
In risposta alle mire tedesche sulla Polonia, Francia e Inghilterra conclusero un’alleanza con questo paese.
Decisivo divenne a quel punto l’atteggiamento dell’Urss: ma, per reciproche diffidenze, le trattive tra sovietici e anglo-francesi si arenarono.
Garantitosi a est con il patto di non aggressione con l’Urss (agosto), Hitler poté attaccare subito dopo la Polonia (1 settembre 1939).
Francia e Inghilterra dichiararono guerra alla Germania mentre l’Italia – che da poco aveva concluso il “patto d’acciaio” con i tedeschi – annuncio la “non belligeranza”.
La conquista tedesca della Polonia fu rapidissima, grazie al nuovo tipo di “guerra lampo” praticato dai tedeschi (uso congiunto di aviazione e mezzi corazzati).
Nei primi mesi la guerra si svolse in pratica solo al nord: la Russia attaccò la Finlandia, la Germania occupò la Danimarca e Norvegia.
Nel maggio-giugno 1940 l’offensiva tedesca sul fronte occidentale si risolse in un travolgente successo: la parte centro-settentrionale della Francia fu occupata dai tedeschi, mentre la sovranità francese si esercitava si quella meridionale (La Repubblica di Vichy), di fatto subordinata alla Germania.
Il 10 giugno 1940, convinto che la guerra stesse ormai per finire, Mussolini annunciò l’intervento dell’Italia a fianco dell’alleato nazista.
Ma l’esercito italiano fornì una pessima prova sia contro i francesi, sia – in Africa e nel Mediterraneo – contro gli inglesi.
I successivi insuccessi in Grecia e nel Nord Africa obbligarono gli italiani a chiedere l’aiuto dei tedeschi: finiva così l’illusione di una “guerra parallela”.
Rimasta sola a combattere contro le potenze fasciste, l’Inghilterra, sotto la guida energica del primo ministro Churchill, riuscì a respingere il tentativo tedesco di invadere le isole britanniche.
La battaglia d’Inghilterra dell’estate ’40 – combattuta soprattutto nell’aria – segnò così per la Germania la prima battuta d’arresto.
Nel 1941 il conflitto entrò in una nuova fase, divenendo effettivamente mondiale.
Nell’estate la Germania invase l’Urss, riportando notevoli successi ma finendo con l’immobilizzare su quel fronte, in una guerra di usura, gran parte del proprio esercito.
In dicembre gli Stati Uniti – che già sostenevano economicamente lo sforzo bellico inglese – entrarono anch’essi in guerra dopo l’attacco che la loro flotta subì a Pearl Harbor ad opera del Giappone (unito alle potenze dell’Asse dal “patto tripartito”).
Nella primavera-estate del 1942 le potenze del Tripartito raggiunsero la loro massima espansione.
Nelle zone occupate, il Giappone e la Germania cercarono di costruire un “nuovo ordine” fondato sulla supremazia della nazione “eletta”.
I tedeschi, in particolare, miravano a ridurre i popoli slavi in condizioni di semi schiavitù.
La persecuzione si concentrò, però, soprattutto contro gli ebrei: dai 5 ai 6 milioni ne furono sterminati nei lager.
Soprattutto dopo l’attacco tedesco all’Urss, si svilupparono in Europa movimenti di resistenza (pur attraversati da divisioni tra comunisti e non comunisti).
In molti paesi controllati dai nazisti una parte della popolazione e della classe dirigente accettò di collaborare con gli occupanti.
Nel 1942-43 si ebbe la svolta della guerra.
I giapponesi subirono alcune sconfitte nel Pacifico.
Sul fronte russo la lunga e sanguinosa battaglia di Stalingrado si risolse in una sconfitta dei tedeschi.
Sul fronte nordafricano gli alleati fermarono le forze dell’Asse a El Alamein e le costrinsero a ritirarsi.
Nel luglio ’43 gli anglo-americani sbarcarono in Sicilia.
Gli insuccessi militari ormai drammatici furono all’origine della caduta di Mussolini (25 luglio ’43).
L’8 settembre veniva annunciato l’armistizio tra Italia e gli anglo-americani.
Mentre il re e Badoglio fuggivano a Brindisi, i tedeschi occupavano l’Italia centro-settentrionale: prive di chiare direttive, le forze armate italiane si sbandarono.
A quel punto il paese era diviso in due: lo Stato monarchico sopravviveva nel Sud occupato dagli alleati.
Al Nord Mussolini costituiva la Repubblica Sociale Italiana, del tutto soggetta al controllo dei tedeschi.
Alla fine del ’43 si formarono le prime bande partigiane.
Tra la fine del ’42 e l’estate del ’43 si erano ricostituiti i partiti antifascisti, che nel settembre ’43 diedero vita al Comitato di liberazione nazionale.
La contrapposizione tra Cln e governo Badoglio si sbloccò per l’intervento di Togliatti, che propose di accantonare ogni pregiudiziale contro il re o Badoglio.
Nell’aprile ’44 si formò il primo governo di unità nazionale, con il partiti del Cln.
Dopo la liberazione di Roma il re trasmise i propri poteri al figlio Umberto e si costituì un nuovo governo (con alla testa Bonomi), più direttamente legato al movimento partigiano che si andava sviluppando in tutta l’Italia settentrionale.
Mentre gli anglo-americani erano impegnati in Italia, tra il ’43 e il ’44 l’Urss iniziava una lenta ma inarrestabile avanzata.
Nel giugno ’44 gli alleati sbarcavano in Normandia e, di lì a poco, liberavano la Francia.
Frattanto, nelle conferenze di Mosca (ottobre ’44) e di Yalta (febbraio ’45), russi, americani e inglesi si accordavano sulla futura sistemazione dell’Europa.
Nel 1945 i tedeschi dovettero arretrare su entrambi i fronti, sotto la pressione di anglo-americani e russi.
Il 25 aprile, mentre la Resistenza proclamava l’insurrezione generale, l’Italia era liberata dalle forze alleate (Mussolini fu allora giustiziato dai partigiani).
Pochi giorni dopo, entrati i russi a Berlino, la Germania capitolava.
La guerra proseguiva, a quel punto, solo nel Pacifico contro il Giappone; terminò il 2 settembre, dopo l’esplosione di due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki.
Bibliografia
Storia militare della seconda guerra mondiale / B. H. Liddell Hart. – Mondadori,
Storia della seconda guerra mondiale / H. Michel. – Mursia, 1977
La seconda guerra mondiale / A. Hillgruber. – Laterza, 1987
Storia della seconda guerra mondiale / A. J. P. Taylor. – Il Mulino, 1991
La decadenza dell’Europa occidentale / M. Silvestri. – Einaudi, 1982
La seconda guerra mondiale / W. Churchill. – Mondadori, 1948
La strana disfatta: testimonianza del 1940 / M. Bloch. – Einaudi, 1995
Storia d’Italia nella guerra fascista / G. Bocca. – Laterza, 1969
Una nazione allo sbando / E. Aga Rossi. – Il Mulino, 2003
Soldati: le forze armate italiane dall’armistizio alla liberazione / C. Vallauri . – Utet, 2003
Il sogno del ‘grande spazio’: le politiche d’occupazione nell’Europa nazista / G. Corni. – Einaudi, 1955
Il nazismo e lo sterminio degli ebrei / L. Poliakov. – Einaudi, 1955
La soluzione finale / A. J. Mayer. – Mondadori, 1990
La soluzione finale: come e perché si è giunti allo sterminio degli ebrei / H. Mommsen. – Il Mulino, 2003
Auschwitz, 1940-1945 / F. Sessi. – Rizzoli, 1999
Uomini comuni / Ch. R. Browning. – Einaudi, 1995
I volenterosi carnefici di Hitler / D. J. Goldhagen. – Mondadori, 1997
La guerra dell’ombra: la Resistenza in Europa / H. Michel. – Mursia, 1973
Storia della Resistenza in Europa, 1938-1945 / G. Vaccarino. – Feltrinelli, 1981
Vichy / R. O. Paxton. – Net, 2002
Storia della Resistenza italiana / R. Battaglia. – Einaudi, 1964
Storia dell’Italia partigiana / G. Bocca. – Laterza, 1966
Una guerra civile: saggio storico sulla moralità nella Resistenza / C. Pavone. – Bollati Boringhieri, 1991
La Resistenza in Italia / S. Peli. – Einaudi, 2004
La Repubblica di Mussolini / G. Bocca. – Laterza, 1977
Storia della Repubblica di Salò / F. W. Deakin. – Einaudi, 1963
La repubblica delle camicie nere / L. Ganapini. – Garzanti, 1999
Cap. 10. Il mondo diviso
Le conseguenze della seconda guerra mondiale
Alla seconda guerra mondiale si guarda oggi come a un grande spartiacque storico, al quale sono riconducibili molte fra le cause delle trasformazioni, dei conflitti e delle tensioni della società contemporanea.
Certo, il mondo attuale è anche il prodotto di processi cominciati molto prima della guerra (come il declino europeo o lo sviluppo della società di massa) e di altri successivi (come i mutamenti nell’economia, nelle tecniche e nel costume degli ultimi decenni).
Tuttavia pochi avvenimenti come la seconda guerra mondiale hanno avuto conseguenze così vaste e profonde sugli assetti internazionali, sulla vita dei singoli paesi, sulla stessa psicologia individuale e di massa.
La guerra non solo segnò la liquidazione del nazifascismo e il trionfo delle democrazie, non solo cambiò la carta territoriale del vecchio continente; ma portò al suo drammatico epilogo quella crisi dell’Europa delle grandi potenze già iniziata col primo conflitto mondiale.
La Germania era stata sconfitta (e si avviava a perdere la sua unità statale); ma anche la Francia, generosamente riammessa dagli alleati al tavolo dei vincitori, e la stessa Gran Bretagna vittoriosa uscivano dalla guerra gravemente indebolite, incapaci di mantenere i loro imperi coloniali (che infatti sarebbero stati smantellati nel giro di pochi anni) e di conservare il loro ruolo di potenze mondiali.
Due soli Stati potevano ormai aspirare a quel ruolo: gli Stati Uniti, forti di un’indiscussa superiorità economica e di un’altrettanto netta supremazia militare (esaltata dal monopolio dell’arma atomica) e l’Unione Sovietica, che usciva dalla guerra dissanguata sul piano economico e demografico, ma restava potenzialmente fortissima ed era già padrona di mezza Europa.
Le due superpotenze erano entrambe entità continentali e multietniche, molto diverse dai vecchi Stati-nazione, entrambe dotate di enormi risorse naturali e di un massiccio apparato industriale; entrambe avevano interessi di dimensione mondiale; ciascuna, infine, era portatrice di una propria cultura, di un proprio messaggio globale, radicalmente contrapposto a quello dell’altra, sul modo di assicurare il benessere e il progresso dei popoli.
Il messaggio americano era quello dell’espansione della democrazia liberale, in regime di pluralismo politico, di concorrenza economica e di ampia libertà personale, in base a un’etica del successo a sfondo individualistico.
Il messaggio sovietico era invece quello della trasformazione dei vecchi assetti politico-sociali in nome del modello collettivistico, fondato sul partito unico e sulla pianificazione centralizzata, nonché su un’etica anti-individualista della disciplina e del sacrificio.
Proprio per effetto di questa contrapposizione globale fra Usa e Urss, si giunse a un nuovo sistema mondiale essenzialmente bipolare, con influenze determinanti sulla vita dei singoli Stati: questo era evidente soprattutto in Europa, dove la linea divisoria fra area “socialista” e area “capitalistica” rispecchiava, in larga misura, le posizioni raggiunte alla fine delle ostilità dai due maggiori eserciti occupanti.
Sul piano psicologico e morale, il secondo conflitto mondiale conferì certamente una nuova dimensione all’orrore per la guerra, non solo per l’entità del massacro (50 milioni di morti, per oltre due terzi civili) ma anche per la sua inedita e sconvolgente “qualità”.
I bombardamenti indiscriminati sulle città, le carestie, la frequente violazione di ogni regola umanitaria, lo sviluppo dei mezzi di distruzione di massa: tutto questo entrò durevolmente, da allora, nella coscienza collettiva, gettando una nuova luce sulla natura stessa della guerra nella nostra epoca.
A ciò si aggiunse, alla fine del conflitto, un duplice trauma morale: da un lato quello rilevante dalle agghiacciante rivelazioni sui crimini nazisti e sul genocidio degli ebrei; dall’altro quello provocato dall’apparizione della bomba atomica, cioè di un’arma non solo dotata di capacità distruttive senza precedenti, ma addirittura capace di minacciare la sopravvivenza stessa dell’umanità.
Questa terribile lezione produsse allora un diffuso bisogno di cambiamento, un generale desiderio di rifondare si basi più stabili il sistema delle relazioni internazionali e di mutarne le regole.
Il fatto che di lì a poco il mondo si sia ritrovato nella morsa di nuove tensioni (quelle della cosiddetta “guerra fredda”) non toglie nulla ai tentativi che allora si fecero da parte delle grandi potenze, per porre riparo agli errori del passato ed evitarne il ripetersi: in particolare, la gestione della pace da parte americana fu complessivamente più generosa e lungimirante di quella messa in atto dall’Intesa nel primo dopoguerra.
Un altro aspetto importante fu, come vedremo fra poco, il tentativo di dare nuova fisionomia e nuovi poteri all’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Infine, si intraprese un’opera di codificazione e di aggiornamento del diritto internazionale, includendovi per la prima volta un vero e proprio settore “penale”, applicato nel Processo di Norimberga (1945-46) contro i capi nazisti (e poi in quello di Tokyo contro i dirigenti giapponesi).
Il processo – che si concluse con la condanna a morte di alcuni fra i principali collaboratori di Hitler – destò grande scalpore in tutto il mondo e costituì un precedente di notevole rilievo, nonostante i numerosi problemi politici e morali suscitati da un procedimento intentato e condotto dai vincitori nei confronti dei vinti.
A farsi promotori e garanti del progetto di un nuovo sistema mondiale furono, in virtù della loro posizione egemonica, soprattutto gli Stati Uniti.
Come già nel primo dopoguerra, e in misura maggiore di allora, gli Usa diventarono per l’Europa occidentale il principale punto di riferimento non solo materiale (per la ricostruzione e per la difesa), ma anche ideale e “culturale” in senso lato.
Da allora l’imitazione dei modelli di vita d’oltreoceano, della musica e dello spettacolo, dell’abbigliamento, del linguaggio, dei moduli artistici (basti pensare al cinema e alla narrativa) costituì l’elemento caratterizzante di un rapporto complesso e ambivalente, ma comunque intenso, fra le sue sponde dell’Atlantico.
Con il mito americano che prese forma in quegli anni, l’egemonia materiale degli Usa sembrò assumere anche i connotati di un primato ideale: gli Stati Uniti apparivano, all’indomani della più terribile delle guerre, come l’unici paese in grado di dispensare speranze e gioia di vivere anche a tanti europei che erano tornati alla pace senza ottimismo, orfani dei vecchi valori e bisognosi di nuove certezze.
Parola chiave
L’energia nucleare – o, meno propriamente, “atomica” – è quella contenuta nel nucleo dell’atomo e liberata mediante processi di reazione (scissione o fusione) provocati artificialmente.
Le prime applicazioni dell’energia nucleare furono indirizzate a fini bellici.
Furono le “bombe atomiche” (basate sulla scissione del nucleo di materiali radioattivi come l’uranio o il plutonio) fatte esplodere dagli americani a Hiroshima e Nagasaki nell’agosto ’45 a porre fine al secondo conflitto mondiale.
Pochi anni più tardi (1952) sarebbero state sperimentate le più potenti bombe all’idrogeno (o termonucleari), in cui l’energia è sviluppata dalla fusione di atomi all’idrogeno o dei suoi isotopi (deuterio e tritio).
L’apparizione delle bombe nucleari – col loro enorme potenziale distruttivo e con i loro disastrosi effetti di lungo periodo sugli equilibri naturali – aprì una nuova fase nella storia delle relazioni internazionali, portò un elemento di sconvolgente novità nella strategia militare e influì profondamente sugli stessi modi di pensare dei contemporanei.
Espressioni come “era nucleare” (o “era atomica”), “logica nucleare”, “equilibrio nucleare” sono entrate stabilmente nel linguaggio politico e militare.
Da un lato, l’affermarsi di due superpotenze nucleari, ciascuna delle quali dotata di arsenali nucleari capaci di distruggere l’avversario, ha dato una notevole stabilità al quadro internazionale e ha fatto apparire più remota l’eventualità di un conflitto generale.
D’altro canto, la stessa esistenza di armi capaci di alterare in modo irrimediabile gli equilibri naturali, di compromettere la salute delle generazioni future e, al limite, di distruggere ogni forma di vita sul pianeta ha introdotto un fattore di angoscia permanente che è tipico della nostra epoca (ed è sostanzialmente diverso dalla semplice paura della guerra e della morte).
L’incubo della morte nucleare ha dato argomenti e spazio alle tematiche pacifiste e, successivamente, ha costituito uno degli argomenti centrali delle campagne dei movimenti ecologisti, che nell’energia nucleare hanno contestato anche gli usi pacifici.
Le numerose centrali nucleari, costruite a partire dagli anni ’50 in molti paesi industrializzati per assicurare la produzione di energia elettrica a costi inferiori a quelli delle centrali “termiche” (alimentate da derivati del petrolio), presentano infatti alcune inquietanti incognite, legate sia al problema dell’eliminazione delle scorie radioattive sia al rischio di guasti o di errori umani.
Incidenti come quello accaduto nel ’79 nella centrale statunitense di Three Mile Island o quello, più grave, verificatosi nell’86 nella centrale sovietica di Chernobyl, destarono allarme in tutto il mondo e determinarono la rinuncia alla tecnologia nucleare da parte di alcuni paesi, fra cui l’Italia.
Sommario
La seconda guerra mondiale sancì la crisi definitiva della supremazia europea e l’emergere di due superpotenze, Usa e Urss.
Nasceva così un nuovo equilibrio internazionale di tipo bipolare.
Gli orrori della guerra, le rivelazioni sullo sterminio degli ebrei, lo spaventoso potere distruttivo della bomba atomica colpirono profondamente l’opinione pubblica e spinsero le potenze vincitrici a cercare basi più stabili e regole nuove per i rapporti internazionali.
La creazione dell’Onu (1945) rappresentò il risultato più importante del tentativo di dare vita a un nuovo ordine internazionale capace di scongiurare nuovi conflitti.
La creazione del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale (1944), gli accordi commerciali Gatt (1947), il primato del dollaro come valuta internazionale furono gli strumenti della ripresa economica occidentale.
La “grande alleanza” fra le potenze vincitrici aveva cominciato a incrinarsi già prima della fine della guerra, in relazione al problema del futuro della Germania e al controllo dell’Urss sui paesi dell’Europa orientale. La conferenza della pace (Parigi, luglio-ottobre 1946) lasciò irrisolto il problema tedesco.
Nel ’46-47 i contrasti fra le due superpotenze si accentuarono dando inizio a quella contrapposizione tra i due blocchi che fu definito “guerra fredda”.
La maggior tensione si ebbe nel ’48-49, quando i sovietici chiusero gli accessi a Berlino; questa crisi si risolse con la nascita della Repubblica federale tedesca (che inglobava le zone sotto il controllo di americani, inglesi e francesi), cui l’Urss rispose con la creazione della Repubblica democratica tedesca.
Il patto atlantico (1949) e il Patto di Varsavia (1955) completarono la divisione dell’Europa in due blocchi.
In Urss si ebbe nel dopoguerra un’accentuazione dei caratteri autoritari del regime.
La ricostruzione economica avvenne rapidamente, privilegiando l’industria pesante e comprimendo i consumi della popolazione.
L’Urss diventò una grande potenza militare, dotandosi anch’essa della bomba atomica.
La ricostruzione del paese avvenne anche grazie a massicce riparazioni imposte ai paesi dell’Est, ex-nemici.
Tutti questi paesi furono trasformati, nella seconda età degli anni ’40, in “satelliti” dell’Urss, politicamente ed economicamente dipendenti dalle decisioni della potenza egemone e modellati secondo il sistema sovietico.
Un’eccezione fu la Jugoslavia di Tito, la cui autonomia dai sovietici portò nel ’48 a una vera e propria rottura.
Negli Stati Uniti si esaurì, durante la presidenza Truman, la spinta progressista del New Deal e si diffuse, nei primi anni ’50, una campagna anticomunista il cui protagonista fu il senatore McCarthy.
L’Europa occidentale, nell’immediato dopoguerra, fu attraversata da una forte spinta riformista.
Il caso più emblematico fu quello dell’Inghilterra, dove nel ’45-51 i laburisti attuarono un vasto programma di riforme sociali, che segnava la nascita del Welfare State.
In Francia – dove nel ’46 fu varata una nuova costituzione democratico-parlamentare (Quarta Repubblica) – la coalizione fra i partiti di massa resse fino al 1947, quando i comunisti furono esclusi dal governo.
Grazie anche agli aiuti americani la Germania federale si risollevò rapidamente dalle disastrose condizioni della fine della guerra e fu protagonista di un vero e proprio “miracolo economico”.
Un altro miracolo economico fu quello del Giappone, dove gli Stati Uniti imposero una trasformazione in senso democratico-parlamentare senza tuttavia intaccare il potere delle grandi concentrazioni industriali.
Negli anni successivi il Giappone si affermò come una della maggiori potenze economiche mondiali.
La vittoria dei comunisti sui nazionalisti e la fondazione della Repubblica popolare cinese (1949) segnarono la nascita della Cina come Stato indipendente e, insieme, un allargamento del “campo socialista”.
L’anno successivo la dimensione mondiale del confronto tra i due blocchi si manifestò con la guerra di Corea, originata dall’invasione del Sud del paese da parte delle truppe del Nord comunista appoggiate dai sovietici.
All’intervento americano contro l’invasione rispose quello cinese, finché la crisi coreana si concluse nel ’53 col ritorno alla situazione precedente la guerra.
Negli anni successivi alla fine della presidenza Truman (1952) e alla morte di Stalin (1953) si affermò progressivamente un nuovo rapporto meno conflittuale tra le due superpotenze.
L’equilibrio fra i due blocchi si basava essenzialmente sul reciproco riconoscimento delle rispettive sfere di influenza.
Nel febbraio ’56, nel corso del 20. Congresso del Pcus, il leader sovietico Kruscev fece una clamorosa denuncia dei crimini di Stalin.
Il processo di “destalinizzazione” avviato in Urss alimentò nei paesi dell’Est la speranza di un allentamento del controllo sovietico.
Diffusi movimenti di protesta si verificarono in Polonia (giugno-ottobre ’56) e in Ungheria (ottobre-novembre).
Mentre le agitazioni polacche portarono a una cauta liberalizzazione, l’insurrezione ungherese fu stroncata dall’intervento dell’Armata rossa.
Negli anni ’50 e ’60, mentre l’economia britannica visse un prolungato ristagno, in tutti i paesi dell’Europa occidentale si verificò una crescita economica sostenuta.
Rapida fu soprattutto la ripresa della Germania favorita anche da una notevole stabilità politica.
Il definitivo ridimensionamento politico dell’Europa, conseguenza del conflitto mondiale, favorì l’integrazione economica dei vari Stati, dapprima con la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) e poi con l’istituzione, nel 1957, della Comunità economica europea (Cee).
La Francia attraversò negli anni ’50 una grave crisi istituzionale, legata al problema algerino.
Nel ’58 De Gaulle assunse la guida del governo, varando una nuova costituzione (con cui nasceva la Quinta Repubblica) e concedendo l’indipendenza all’Algeria.
In politica estera De Gaulle seguì una politica finalizzata alla creazione di un’Europa indipendente dai due blocchi ed egemonizzata dalla Francia.
Bibliografia
Le conseguenze della seconda guerra mondiale: l’Europa da Yalta a Praga / A. Gambino. - Laterza, 1972
Storia della guerra fredda / A. Fontaine. – Il Saggiatore, 1968
Cinquant’anni di guerra fredda / R. Crockatt. – Salerno, 1997
La guerra fredda / M. Del Pero. – Carocci, 2001
Gli Stati Uniti e l’origine della guerra fredda / a cura di E. Aga Rossi. – Il Mulino, 1984
Il mondo contemporaneo, 1945-1980 / E. Galli Della Loggia. – Il Mulino, 1982
Il secolo breve / E. J. Hobsbawm. – Rizzoli, 1995
Ascesa e declino delle grandi potenze / P. Kennedy. – Garzanti, 1989
L’America da Roosvelt a Reagan / G. Mammarella. – Laterza, 1984
Storia d’Europa dal 1945 ad oggi / G. Mammarella. – Laterza, 2000
Dopoguerra: com’è cambiata l’Europa dal 1945 ad oggi / T. Judt. – Mondadori, 2007
Grande storia della Germania / H. A. Winkler. – Donzelli, 2004
De Gaulle e il gollismo / Il Mulino, 2003
L’Europa ricostruita / D. W. Ellwood. – Il Mulino, 1994
Storia delle democrazie popolari / F. Fejto. – Bompiani, 1977
La Cina dal 1949 ai giorni nostri / M.-C. Bergere. – Il Mulino, 2003
La guerra di Corea / S. H. Lee. – Il Mulino, 2003
Cap. 11 La decolonizzazione e il Terzo Mondo
Parola chiave
Neocolonialismo
Di “neocolonialismo” si cominciò a parlare intorno alla metà del ‘900, parallelamente al processo di decolonizzazione.
Numerosi osservatori sostennero che all’acquisita indipendenza politica delle ex colonie asiatiche e africane non corrispondeva una piena autonomia economica: la fine del dominio “formale” era accompagnata dal persistere, con nuove modalità, di rapporti di dipendenza e di alcuni aspetti caratteristici del vecchio colonialismo.
Secondo le teorie sul neocolonialismo, le ricchezze nazionali delle ex colonie continuavano ad essere sfruttate a vantaggio del capitale estero in collusione con le classi dirigenti locali, spesso corrotte e prive di reale autonomia, in quanto dipendenti dal sostegno economico, militare e finanziario dei governi occidentali e delle grandi multinazionali dell’industria e della finanza.
Anche lo sfruttamento dei lavoratori (bassi salari e scarse tutele) poteva essere perseguito più facilmente e in misura maggiore nelle aree arretrate, dove non esistevano forze in grado di opporsi e dove lo Stato sosteneva i capitalisti stranieri.
L’iniqua distribuzione delle risorse e il più elevato sfruttamento dei lavoratori sarebbero a loro volta stati sorretti da una visione eurocentrica del mondo, fondata sulla convinzione della superiorità economica-culturale dell’Occidente.
Molte teorie sul neocolonialismo si basavano sul concetto di scambio ineguale: da un lato, l’arretratezza economica e tecnologica, le marcate disuguaglianze, la diffusa povertà e l’accentuata preminenza della produzione di materie prime o di raccolti poco remunerativi portava gli Stati di nuova indipendenza a indirizzare l’economia verso l’esportazione e non alla creazione di un mercato interno; dall’altro, la netta predominanza economica, tecnologica, diplomatica e militare avrebbe permesso alle economie occidentale di imporre rapporti contrattuali a loro molto più favorevoli, riuscendo così a determinare l’andamento degli scambi commerciali e a ottenere prezzi più bassi.
Ciò avrebbe comportato un trasferimento di ricchezza dai paesi poveri a quelli ricchi.
Elaborate da studiosi marxisti e da movimenti indipendentisti asiatici e africani negli anni ’50 e ’60, le teorie sul neocolonialismo esprimevano la delusione per le difficoltà incontrate dal processo di decolonizzazione e per il fatto che la nascita di nuovi Stati non si traduceva in piena indipendenza politica né dava luogo a uno sviluppo economico.
All’accusa rivolta alle imprese multinazionali e ai governi occidentali di attuare politiche finalizzate a perpetuare le disuguaglianze e la subordinazione dei paesi sottosviluppati si saldò la denuncia del ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali (soprattutto il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale), considerate una diretta emanazione degli interessi delle economie più avanzate, in particolare quella statunitense.
A partire dagli anni ’70 la crescita dell’economia e dell’autonomia politica di alcuni paesi sottosviluppati ha prodotto una forte differenziazione all’interno del Terzo Mondo, modificando pure il rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri: ciò ha indotto a una profonda revisione delle teorie e delle analisi elaborate sin allora.
Sommario
La seconda guerra mondiale sancì la definitiva crisi del colonialismo e l’affermazione, a livello internazionale, del principio di autodeterminazione.
La decolonizzazione avvenne in forme relativamente indolori nei possedimenti inglesi, mentre la Francia applicò nelle sue colonie una politica di forte resistenza nei confronti dei movimenti indipendentisti.
Solo assai di rado i nuovi Stati indipendenti avrebbero avuto regimi democratici, prevalendo in generale governi autoritari o militari.
L’Asia precedette di quasi dieci anni il continente africano nella liberazione dal dominio coloniale.
La prima e più importante tappa fu l’indipendenza dell’India (1947).
Al raggiungimento dell’indipendenza seguirono spesso aspri contrasti entro i nuovi Stati, come quello fra indù e musulmani in India e quello fra nazionalisti e comunisti in vari paesi del sud-est asiatico.
Particolarmente lungo il processo di emancipazione del Vietnam, ove la lotta contro i francesi si concluse nel ’54 con la divisione del paese in due Stati, l’uno comunista e l’altro filo-occidentale.
In Medio Oriente, già all’inizio del secolo si era sviluppato un movimento nazionalista arabo: la seconda guerra mondiale accelerò il processo di emancipazione.
Nel 1948, con il ritiro degli inglesi dalla Palestina e la nascita dello Stato d’Israele (cui seguiva immediatamente la prima guerra arabo-israeliana) nasceva il problema palestinese.
Il regime di Nasser in Egitto, nato dopo una rivolta di ufficiali che rovesciò la monarchia (1952), diede a quel paese una posizione di preminenza nella regione, soprattutto dopo la crisi di Suez del ’56 (quando inglesi e francesi, che avevano occupato il canale, furono costretti a ritirarsi dalle pressioni Usa e Urss).
In Libia, nel 1969, una rivoluzione portò al potere al colonnello Gheddafi, artefice di un esperimento di “socialismo islamico” e, sul piano internazionale, di una politica che avrebbe alimentato le tensioni nell’area mediorientale.
Particolarmente drammatico e cruento fu il processo di emancipazione dell’Algeria, per la presenza di oltre un milione di coloni francesi tenacemente avversi all’indipendenza.
Fu De Gaulle a capire l’inevitabilità della rinuncia all’Algeria, che ottenne nel ’62 l’indipendenza.
A sud del Sahara, nell’Africa nera, il processo di decolonizzazione si compì fra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60.
Fu un processo generalmente pacifico tranne in casi come quelli della Rhodesia del Sud o del Congo.
Le vicende del Congo furono particolarmente rappresentative dei conflitti intestini che agitavano spesso le colonie, costituitesi in Stati secondo gli artificiali confini della dominazione europea.
Le stesse istituzioni politiche, ricalcate sui modelli europei, avrebbero mostrato una particolare fragilità, lasciando spesso il posto a regimi militari.
Un caso a sé fu quello del Sud Africa, dove la consistenza minoranza bianca (presente nel paese da tre secoli) riuscì a conservare il potere praticando una politica di discriminazione (apartheid) ai danni della maggioranza nera.
Sul piano della politica internazionale, i paesi di nuova indipendenza cercarono una piattaforma comune (a partire dalla piattaforma di Bandung del ’55) nel “non allineamento”.
Progressivamente, però, tale neutralismo rispetto al contrasto Est-Ovest lasciò il campo, nella realtà, allo schieramento di molti paesi non allineati in senso filo-comunista o filo-occidentale.
Sul piano economico, il Terzo Mondo era accomunato dalla realtà del sottosviluppo, ovvero dall’incapacità a risolvere i problemi dell’arretratezza economica resi ancora più gravi dall’aumento assai rapido della popolazione.
I paesi dell’America Latina godevano da tempo dell’indipendenza politica ma si trovavano tuttavia in condizioni di dipendenza economica degli Stati Uniti (che esercitavano una sorta di tutela su tutto il continente).
L’instabilità politica dell’America centrale e meridionale si caratterizzò nell’oscillazione tra liberalismo, populismo e autoritarismo.
Fra le esperienze più significative, quella del regime populista-autoritario stabilito da Peron in Argentina.
Di grande rilievo, per l’attrazione che esercitò in tutta l’America Latina, fu la rivoluzione cubana guidata da Castro (1959) che diede al nuovo regime un orientamento comunista.
Bibliografia
Decolonizzazione e Terzo Mondo / G. Calchi Novati. – Laterza, 1979
La decolonizzazione / R. Betts. – Il Mulino, 2003
Storia dell’India / P. Spear. – Rizzoli, 1970
Storia dell’India / M. Torri. – Laterza, 2000
La rivoluzione algerina / G. Calchi Novati. – Dall’Oglio, 1969
Storia della guerra d’Algeria, 1954-1962 / A. Horne. – Rizzoli, 1980
Israele e il rifiuto arabo / M. Rodinson. – Einaudi, 1969
La costruzione del Medio Oriente / B. Lewis. – Laterza, 1998
Il settimo milione: come l’olocausto ha segnato la storia di Israele / T. Segev. – Mondadori, 2001
Vittime / B. Morris. – Rizzoli, 2001
Storia dell’Africa nera / J. Ki-Zerbo. – Einaudi, 1977
L’Africa nera dal 1800 ai giorni nostri / C. Coquery-Vidrovitch, H. Moniot. – Mursia, 1977
Storia dell’Africa / J. Fage. – Sei, 1995
Capitalismo e sottosviluppo in America Latina / A. Gunder Franck. – Einaudi, 1969
Sociologia della modernizzazione / G. Germani. – Laterza, 1971
Storia dell’America Latina / T. Halperin Donghi. – Einaudi, 1972
Militari e potere in America Latina / G. Pasquino. – Il Mulino, 1974
L’America Latina nel 20. secolo / M. Plana, A. Trento. – Ponte alle Grazie, 1992
Storia di Cuba, 1762-1970 / H. Thomas. – Einaudi, 1973
Cap. 12. L’Italia dopo il fascismo
Parola chiave
Qualunquismo
Il “qualunquismo” come atteggiamento di diffidenza nei confronti dei partiti e in genere della politica (che si vorrebbe risolta nella buona amministrazione), come esaltazione dei valori dell’individuo e della tradizione contro le tendenze stataliste, come protesta contro la fiscalità, esiste da molto prima che qualcuno pensasse di dargli un nome, o addirittura di fondare su di esso un vero e proprio partito.
In questo senso, tendenze qualunquiste sono sempre state presenti nei regimi parlamentari, anche se non avevano un’espressione politica autonoma, in quanto si risolvevano nell’adesione ai partiti conservatori o, più coerentemente, nell’astensione dal voto.
Nel periodo fra le due guerre mondiali, queste tendenze confluirono in larga parte nei movimenti fascisti o parafascisti, che proclamavano la loro avversione nei confronti della politica tradizionale e ne proponevano una nuova, basata sul drastico accentramento dei processi decisionali.
Solo nel secondo dopoguerra, alcuni abili quanto improvvisati leader pensarono di isolare e di coltivare il virus della sfiducia nella politica, per farne la base di inediti movimenti di massa.
Il primo di questi movimenti fu quello fondato in Italia nell’immediato dopoguerra dal commediografo Guglielmo Giannini, col nome di “Fronte dell’uomo qualunque” (donde il termine “qualunquismo” vedi cap. 12.2).
Una vicenda molto simile fu quella dell’”Unione per la difesa dei commercianti e degli artigiani”, fondata in Francia nel 1953 dal cartolaio Pierre Poujade (in francese il termine poujadisme corrisponde all’italiano “qualunquismo”).
Nato come gruppo di pressione extrapartitico e poi trasformatosi in movimento politico vero e proprio, sull’onda del rigurgito nazionalista seguito alla crisi dell’impero coloniale francese (vedi cap. 10.12), l’Unione ebbe il 10% dei voti nelle elezioni del ’56 e mandò cinquanta deputati alla Camera.
Ma, due anni dopo, la sua base era stata già erosa dalla crescita del movimenti gaullista.
Negli ultimi decenni, quasi tutte le democrazia industriali dell’Occidente hanno conosciuto fenomeni che, pur non potendosi definire qualunquisti in senso stretto, hanno non pochi punti di contatto col qualunquismo “storico”.
Dai gruppi che si richiamavano alla cosiddetta “maggioranza silenziosa” (termine coniato negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60) e che esprimevano le esigenze di “legge e ordine” delle classi medie spaventate dalle agitazioni operaie o studentesche, ai movimenti “antitasse”, nati nella seconda metà degli anni ’70 in Europa e negli Stati Uniti, nel quadro del rilancio delle ideologie liberiste e della crisi dello “Stato assistenziale” (vedi cap. 15.1).
Anche in Italia si è assistito in questi ultimi anni al crescere di nuove e diffuse forme di protesta contro un fisco ritenuto troppo esoso, ma anche contro una classe politica accusata in blocco di eccessiva invadenza nei confronti della società civile.
Se queste forme di protesta si possano o meno definire “qualunquiste” (termine che, nel linguaggio della classe politica, porta con sé una certa connotazione spregiativa), è un tema di discussione ancora aperto.
Sommario
Le condizioni in cui versava l’Italia alla fine della guerra erano gravissime: se le industrie non erano state eccessivamente danneggiate, era però stata fortemente colpita l’agricoltura: ingenti anche i danni subiti dall’edilizia e dai trasporti; elevatissima l’inflazione.
La maggioranza della popolazione risentiva della scarsità di cibo e di abitazioni e dell’alta disoccupazione.
I problemi dell’ordine pubblico erano gravi: difficoltà nella smobilitazione dei partigiani, occupazione delle terre, separatismo e banditismo in Sicilia.
Il ritorno della democrazia determinò una crescita della partecipazione politica.
La Democrazia cristiana si presentava come perno del fronte moderato, in quanto era l’unico partito in grado di competere con socialisti e comunisti sul piano dell’organizzazione di massa.
Molto minor seguito avevano i liberali, i repubblicani e il Partito d’azione.
A destra il movimento dell’”Uomo qualunque” ebbe, per breve tempo, un notevole successo.
La Confederazione generale italiana del lavoro fu ricostituita nel ’44 su basi unitarie.
Il primo governo dell’Italia liberata, basato sulla coalizione fra i partiti del Cln, fu presieduto da Ferruccio Parri, capo partigiano ed esponente del Partito d’Azione.
Nel novembre ’45 la guida del governo passò al democristiano De Gasperi.
L’avvento di De Gasperi segnò una svolta moderata nella politica italiana e la fine delle prospettive di radicale rinnovamento sociale.
Il 2 giugno ’46 un referendum popolare sancì la vittoria della repubblica e la caduta della monarchia.
Nello stesso giorno si tennero le elezioni per l’Assemblea costituente, che videro il successo dei tre partiti di massa, e soprattutto della Dc che divenne il partito di maggioranza relativa.
Nel ’46-47 i contrasti fra i partiti della coalizione si approfondirono.
Le accresciute tensioni interne e internazionali provocarono, nel gennaio ’47, la scissione del Partito socialista: l’ala guidata da Saragat, contraria alla stretta alleanza col Pci, fondò il Partito socialista dei lavoratori italiani (poi Partito socialdemocratico).
Nel maggio De Gasperi estromise i socialisti e comunisti dal governo e formò un ministero “monocolore”.
I contrasti tra i partiti non impedirono il varo della nuova Costituzione repubblicana (che entrò in vigore dal 1. gennaio 1948).
La Costituzione affiancava agli istituti tipici di un sistema democratico-parlamentare alcuni importanti principi di tipo sociale (diritto al lavoro, libertà sindacale, ecc.).
La campagna per le elezioni del 18 aprile ’48 – dalle quali doveva uscire il primo Parlamento - vide una forte contrapposizione tra socialisti e comunisti (uniti nel Fronte popolare), da un lato e Dc e partiti laici minori dall’altro.
I democristiano ebbero un grande successo, anche grazie all’appoggio della Chiesa e degli Stati Uniti.
Dopo le elezioni De Gasperi diede vita ad una coalizione “centrista”, che vedeva la Dc alleata con liberali, repubblicani e socialdemocratici.
Sul piano della politica economica, ebbero sempre il sopravvento le forze moderate, che seguirono una politica di “restaurazione liberista”, rifuggendo da un uso incisivo degli strumenti di intervento statale nell’economia.
Tale politica si affermò pienamente, dopo l’estromissione delle sinistre dal governo, ad opera del ministro del Bilancio Einaudi: il successo della sua linea di risanamento finanziario ebbe comunque forti costi sociali, soprattutto in termini di disoccupazione.
Il trattato di pace, che comportava la rinuncia alle colonie e secondarie rettifiche di confine a favore della Francia, fu firmato dall’Italia nel ’47.
Restava aperta con la Jugoslavia la questione di Trieste, riunita all’Italia solo nel ’54.
L’appartenenza dell’Italia al blocco occidentale ottenne una sanzione sul piano militare con l’adesione, nel 1949, al Patto atlantico.
Negli anni del “centrismo” (’48-53) la politica dei governi De Gasperi non fu priva di interventi sociali, come la riforma agraria e l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.
La politica di austerità finanziaria e contenimento dei consumi perseguita dal governo suscitò numerose proteste di piazza cui le forze dell’ordine risposero con durezza.
In questa situazione la Dc cercò di rendere più stabile la propria maggioranza con una riforma del meccanismo elettorale (“legge truffa”), al cui approvazione suscitò vivaci proteste a sinistra e fu comunque priva di risultati pratici nelle elezioni del ’53.
Gli anni ’53-58 furono un periodo di transizione.
Alle novità sul piano economico (“piano Vanoni”, ministero delle Partecipazioni statali) e istituzionali (insediamento della Corte costituzionale) si affiancarono mutamenti entro i partiti, che avrebbero reso poi possibile l’allargamento della maggioranza ai socialisti.
Nella Dc si affermò con la segreteria Fanfani (1954) uan nuova generazione, più attenta all’intervento dello Stato nell’economia e più sensibili ai problemi sociali.
Il Psi, soprattutto a partire dal ’56, andava allontanandosi dai socialisti.
Bibliografia
Storia del dopoguerra: dalla Liberazione al potere Dc / A. Gambino. – Laterza, 1978
Le paure e le speranze degli italiani, 1943-1953 / E. Di Nolfo. – Mondadori, 1986
Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi / P. Ginsborg. – Einaudi, 1989
La repubblica dei partiti / P. Scoppola. – Il Mulino, 1991
Storia dell’Italia repubblicana: l’economia, la politica, la cultura: la società dal dopoguerra agli anni ’90 / S. Lanaro. – Marsilio, 1991
L’Italia contemporanea, 1943-1992 / G. Mammarella. – Il Mulino, 1993
Storia della prima repubblica / A. Lepre. – Il Mulino, 1995
La politica economica della ricostruzione, 1945-1949 / C. Daneo. – Einaudi, 1975
Stato e industria nella ricostruzione / M. Salvati. – Feltrinelli, 1982
Storia costituzionale della repubblica / F. Bonini. – Nis, 1993
La Costituente: un problema storico-politico / P. Pombeni. – Il Mulino, 1995
Storia dei partiti nell’Italia repubblicana / S. Colarizi. – Laterza, 1994
Partito e antipartito: una storia politica della prima repubblica, 1946-1978 / S. Lupo. – Donzelli, 2004
L’Uomo qualunque, 1944-1948 / S. Setta. – Laterza, 1975
Storia del Partito d’azione / G. De Luna. – Feltrinelli, 1982
Il partito cristiano al potere / G. Baget Bozzo. – Vallecchi, 1974
Il partito italiano: la Democrazia cristiana dal 1942 al 1994 / A. Giovagnoli. – Laterza, 1996
De Gasperi / P. Craveri. – Il Mulino, 2006
Storia del Partito comunista italiano / R. Martinelli. – Einaudi, 1995
Storia del Partito comunista italiano / G. Gozzini. – Einaudi, 1998
Storia del Psi / M. Degl’Innocenti. – Laterza, 1993
L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992 / A. Varsori. – Laterza, 1998
L’Italia e il trattato di pace del 1947 / S. Lorenzini. – Il Mulino, 2007
Cap. 13. La società del benessere
Parola chiave
Multinazionali
Si dicono “multinazionali” quelle grandi imprese che posseggono stabilimenti e reti di distribuzione commerciale in diversi paesi e che, pur conservando il quartier generale (ossia gli uffici direttivi) nel paese d’origine, trasferiscono all’estero quote importanti della loro attività.
Diversi sono i motivi che possono spingere le imprese a dislocare la propria produzione fuori dai confini nazionali, anziché limitarsi ad esportare i loro prodotti: tagliare i costi per il trasporto delle merci nei paesi di destinazione, aggirare eventuali restrizioni al commercio o limiti all’importazione, penetrare stabilmente in un mercato per imporvi il proprio marchio, ma soprattutto risparmiare sul costo del lavoro, che è in genere più basso nei paesi poveri, tanto più se sprovvisti di tutele sindacali.
Da tempo, dunque, le grandi imprese (e a volte anche le medie) tendono a “delocalizzare” il grosso della produzione, concentrando nei paesi avanzati solo le lavorazioni a più alto contenuto tecnologico.
La crescita delle multinazionali, in numero, dimensione e peso, ebbe inizio negli anni ’60 del ‘900, per poi diventare uno dei dati caratterizzanti dell’”età della digitalizzazione” (vedi cap. 17.4).
Ma il fenomeno aveva origini più antiche.
Già alla fine dell’800 alcune grandi imprese avevano cominciato a trasferire all’estero parti importanti della loro produzione.
Si trattava, all’inizio, soprattutto di imprese britanniche, cui si aggiunsero (e in parte si sostituirono) quelle statunitensi (celebre il caso della United Fruit Company, che possedeva immense piantagioni di frutta in tutta l’America Latina) e, in una fase successiva, quelle giapponesi.
Presenti e attive su mercati vastissimi, le multinazionali sono giunte a gestire bilanci, e ad accumulare poteri, pari o superiori a quelli di Stati di media grandezza.
Nel 1999, ad esempio, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, l’americana General Motors superava, in termini di dimensioni di bilancio, la Grecia (o la Norvegia o il Sudafrica).
Con i loro enormi profitti, le multinazionali rappresentano una fonte di ricchezza per gli Stati di origine, che spesso sono impegnati a difenderne gli interessi, ma anche un’occasione di sviluppo per i paesi che le ospitano e in qualche caso ne subiscono il condizionamento.
Per questo rapporto squilibrato con i paesi del Terzo Mondo, ma anche per la loro capacità di sottrarsi alle decisioni politiche degli Stati o di influenzarle pesantemente, le multinazionali sono state oggetto di aspre contestazioni, rilanciate in anni recenti dai movimenti “no global”.
Sommario
Negli anni ’50 e ’60 l’economia dei paesi industrializzato attraversò una fase di intenso sviluppo, che ebbe tra le sue cause: crescita della popolazione (da cui un aumento della domanda); innovazione tecnologica e razionalizzazione produttiva; espansione del commercio mondiale; politiche statali in sostegno alla crescita.
L’applicazione delle scoperte scientifiche alla produzione divenne velocissima.
Nel campo della chimica si svilupparono le materie plastiche e le fibre sintetiche.
In medicina c’è da segnalare la produzione di nuovi farmaci (antibiotici, ormoni, psicofarmaci, anticoncezionali, ecc.) e i grandi progressi della chirurgia.
Le conseguenze dello sviluppo tecnologico si fecero sentire in modo decisivo nel campo dei trasporti (motorizzazione privata, sviluppo dell’aviazione civile), contribuendo a modificare radicalmente le abitudini di vita.
Nel 1957, col lancio del primo satellite artificiale sovietico, iniziava la conquista dello spazio (del ’69 è il primo sbarco dell’uomo sulla luna), che avrebbe determinato una “ricaduta” di tecnologia in tutti i settori produttivi.
Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa (anzitutto della televisione) ha rappresentato, tra i prodotti dello sviluppo tecnologico, quello che più di ogni altro ha condizionato la vita quotidiana e i modelli di comportamento delle società industrializzate (e in parte anche quelle meno sviluppate).
Una caratteristica dei decenni del dopoguerra è il forte aumento della popolazione, concentrato però soprattutto nel Terzo Mondo, dove il calo della mortalità si è accompagnato un tasso di natalità notevolmente elevato.
Nei paesi industrializzati l’aumento demografico è stato invece molto contenuto e in alcuni di essi si è giunti ormai alla “crescita zero” della popolazione.
La notevole espansione dei consumi “superflui” è ormai caratteristica fondamentale delle società avanzate, ove ha suscitato fenomeni estesi di rifiuto ideologico, nonché di critica da parte di alcune correnti intellettuali (soprattutto quella che si richiama alla “Scuola di Francoforte”).
Alla fine degli anni ’60 si verificò un’esplosione della protesta giovanile contro la “società del benessere”: protesta iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi nell’Europa occidentale e in Giappone.
L’episodio più clamoroso della contestazione studentesca fu la rivolta parigina del maggio ’68.
La fase della ribellione giovanile lasciò un segno profondo nelle società occidentali, soprattutto nel campo dei valori e dei modelli di comportamento.
Negli stessi anni si sviluppava un nuovo femminismo che – raggiunta ormai la parità dei sessi sul piano dei diritti politici – criticava la divisione dei ruoli tra uomo e donna nella famiglia e nel lavoro, e più in generale rifiutava i valori “maschilisti” dominanti nelle società industrializzate.
Di fronte alla nuova realtà della società del benessere, la Chiesa cattolica – pur ribadendo la sua critica al diffondersi di valori materialistici e di comportamenti contrari alle sue dottrine – tentò un proprio rinnovamento interno e un’apertura ai problemi del mondo contemporaneo.
Tale nuovo corso iniziò col pontificato di Giovanni 23. (1958-63) con il Concilio Vaticano 2.
Bibliografia
Storia economica e sociale del mondo / P. Leon. – Laterza, 1979
La società opulenta / J. K. Galbraith. – Comunità, 1963
Il nuovo Stato industriale / J. K. Galbraith. – Einaudi, 1968
I persuasori occulti / V. Packard. – Einaudi, 1958
Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teoria della cultura di massa / U. Eco. – Bompiani, 1964
Gli strumenti del comunicare / M. McLuhan. – Il Saggiatore, 1961
Storia delle nuove sinistre in Europa, 1956-1976 / M. Teodori. – Il Mulino, 1976
Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America / P. Ortoleva. – Editori Riuniti, 1988
Il Sessantotto / M. Flores, A. De Bernardi. – Il Mulino, 1998
Esclusa dalla storia / S. Rowbotham. – Editori Riuniti, 1977
Fra mito della cristianità e secolarizzazione: studi sul rapporto Chiesa-società nell’era contemporanea / G. Miccoli. – Marietti, 1985
La Chiesa nella società contemporanea / G. Verucci. – Laterza, 1988
Cap. 14. Distensione e confronto
Parola chiave
Dissenso
In senso generico, il termine “dissenso” indica semplicemente l’espressione di un disaccordo: dunque un fenomeno del tutto normale, in politica come nella vita quotidiana.
Il dissenso diventa un problema politico solo nei regimi autoritari, dove il consenso sulle scelte dei vertici è obbligatorio e in qualche misura scontato e in qualsiasi organizzazione (per esempio militare o religiosa) basata sulla gerarchia e sull’obbedienza.
A partire dagli anni ’60, il termine è stato usato soprattutto in riferimento a due realtà fra loro molto diverse: l’atteggiamento di quei gruppi cattolici (detti appunto “del dissenso”) che, pur rimanendo all’interno della Chiesa, ne contestavano l’organizzazione interna e in qualche caso la stessa dottrina (vedi cap. 13.8); e l’attività di quei gruppi minoritari, formati per lo più da scrittori, scienziati e in genere intellettuali, che alimentavano, in Urss e nelle “democrazie popolari” dell’Europa orientale, una corrente di critica ai regimi comunisti, sfruttando gli scarsi spazi di libertà che di tanto in tanto si aprivano e usando soprattutto canali di comunicazione clandestini per tenersi in contatto fra loro e per far giungere i loro scritti in Occidente: il principale di questi canali era il samiszdat (in russo “autoedizione”), ovvero il dattiloscritto fatto passare di mano in mano.
Fu in relazione a questi gruppi che, a partire dagli anni ’60, si parlò di un “dissenso nei paesi dell’Est”, di “intellettuali del dissenso”, di “repressione del dissenso” e così via.
Inizialmente, l’emersione di fermenti critici fu favorita dalle parziali aperture tipiche della fase della destalinizzazione: il primo romanzo di Aleksandr Solzenicyn (Una giornata di Ivan Denisovic, del 1962, che descriveva l’esperienza dei campi di concentramento), fu pubblicato col consenso delle autorità sovietiche.
Ma il successivo blocco di ogni evoluzione in senso liberale del sistema – già negli ultimi anni di Kruscev e poi con i suoi successori - ricacciò quei fermenti nell’area della clandestinità.
Un punto di svolta in questo senso fu, nel 1966, il processo ai due scrittori dissidenti Andrej Sinjavskij e Julij Daniel, entrambi condannati a sei anni di carcere.
A volte tollerati, più spesso sottoposti a misure restrittive (dal carcere, all’esilio, al manicomio), sempre rigidamente controllati dagli apparati di regime, i dissenzienti dell’Est si rifacevano a diverse correnti di pensiero: dal tradizionalismo a sfondo religioso alla liberal-democrazia di modello occidentale, dalla critica “di sinistra” di marca trotzkista che denunciava il tradimento degli ideali rivoluzionari al riformismo di chi si batteva per una democratizzazione del sistema dall’interno (come quella tentata invano con la “primavera di Praga”).
Nell’insieme essi svolsero un ruolo importante nel tenere viva in Occidente l’attenzione nei confronti degli aspetti più oppressivi del sistema sovietico e di quello dei paesi satelliti.
Basti pensare all’eco suscitata in Europa e negli Stati Uniti dalla pubblicazione, nel 1973, di Arcipelago Gulag di Solzenicyn (espulso dall’Urss nel 1974) o dall’instancabile campagna per i diritti civili condotta dal fisico Andrej Sacharov (insignito del premio Nobel per la pace nel 1975).
Fu anche grazie alle loro denunce, e a quelle di tanti altri dissidenti, se il comunismo sovietico non poté più godere, nella fase del suo tramonto, di quei diffusi consensi, soprattutto negli ambienti intellettuali, che lo avevano circondato (e indubbiamente aiutato) sia nelle fasi più buie dello stalinismo, sia negli anni del “disgelo” krusceviano.
Sommario
Negli Usa la presidenza Kennedy (durata dal ’60 al ’63, quando Kennedy fu assassinato) fu improntata ad un indirizzo riformistico.
In politica estera, la grande crisi legata alla presenza di missili nucleari sovietici a Cuba (1962) si risolse infine con un successo americano e non compromise la distensione (nel ’63 Usa e Urss firmarono un trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari nell’atmosfera).
In Urss Kruscev accentuò i caratteri pacifici del confronto con l’Occidente.
Ma nel 1964 fu destituito anche per il fallimento dei suoi piani economici.
In Cina, l’insuccesso della politica di sviluppo agricolo lanciata nel ’58 (“grande balzo in avanti”) favorì sul piano internazionale la definitiva rottura con l’Urss, mentre sul piano interno diede spazio alle componenti “moderate” del gruppo dirigente comunista.
Fra il ’65 e il ’68, per scalzare il potere di queste ultime, Mao stimolò un movimento di contestazione giovanile (la rivoluzione culturale) che portò alla defenestrazione di molti dirigenti, finché fu frenato dallo stesso Mao.
In politica estera, soprattutto per opera del primo ministro Chou En-Lai, la Cina attuò, all’inizio degli anni ’70, un clamoroso avvicinamento agli Stati Uniti.
A partire dalla metà degli anni ’60 si sviluppò progressivamente l’intervento militar americano nel Vietnam del Sud, dove era attivo un movimento di guerriglia che godeva del diretto appoggio dei nordvietnamiti.
Dopo il ritiro delle truppe americane (1973), avvenuto anche in seguito alla forte opposizione che quella guerra aveva suscitato negli Stati Uniti, il governo sudvietnamita fu sconfitto nel 1975.
Nello stesso anno si ebbe la vittoria dei partigiani comunisti in Cambogia e Laos.
La segreteria Breznev (1964-82) mutò più lo stile che la sostanza della politica sovietica: si accentuò, in particolare, la repressione dei dissidenti.
In politica estera l’Urss, se accettò la moderata autonomia conquistata dai rumeni, represse duramente il tentativo riformatore dei comunisti cecoslovacchi (“primavera di Praga”), intervenendo militarmente nell’estate del ’68.
Per le democrazie dell’Europa occidentale gli anni ’60 e i primi anni ’70 furono un periodo di stabilità economica e di mutamenti politici.
In Italia, Germania federale e Gran Bretagna entrarono al governo i socialisti.
In Germania il socialdemocratico Brandt inaugurò una politica estera di conciliazione con i paesi dell’Est.
Nel 1972 la Cee si allargò con l’ingresso di Inghilterra, Irlanda e Danimarca.
Il Medio Oriente fu teatro in questi anni di due successive guerre: la “guerra dei sei giorni” del ’67 e la “guerra del Kippur” del ’73.
In seguito alla guerra del ’67 Israele occupò nuovi territori arabi, riacutizzando il problema palestinese.
La guerra del ’73 fu all’origine del blocco petrolifero proclamato dai paesi arabi e del successivo aumento del prezzo del petrolio.
L’aumento del prezzo del petrolio del ’73 (che si inseriva in una fase di instabilità monetaria internazionale inaugurata nel ’71 dalla sospensione della convertibilità del dollaro) generò una crisi economica internazionale di vaste proporzioni.
A differenza delle crisi del passato, la crescita della disoccupazione di sommava a un elevato tasso di inflazione.
La gravità della crisi indusse ad interrogarsi sui fondamenti stessi della civiltà nata con la rivoluzione industriale.
Bibliografia
La Germania da Adenauer ad oggi / G. Mammarella. – Laterza, 1979
Storia d’Europa: l’Europa oggi. – Einaudi, 1993
Storia della guerra del Vietnam / S. Karnow. –Rizzoli, 1985
La guerra del Vietnam / M. K. Kall. – Il Mulino, 2003
Storia del conflitto arabo israeliano / G. Codovini. – Bruno Mondadori, 1999
Storia della Palestina moderna / I. Pappe. – Einaudi, 2005
Cap. 15. Anni di crisi
Parola chiave
Monetarismo
Il monetarismo è una corrente di pensiero economico sviluppatasi a partire degli anni ’60 del ‘900 e legata soprattutto al nome dell’economista statunitense Milton Friedman e alla cosiddetta Scuola di Chicago, la sede universitaria in cui Friedman insegnò.
Alla base delle teorie monetariste c’è l’importanza attribuita alla quantità di moneta come elemento regolatore dell’attività economica.
Secondo i monetaristi è l’ammontare di moneta resa disponibile dalla banca centrale a determinare, almeno nel lungo periodo, il livello dei prezzi e della produzione.
Regolando il quantitativo di moneta in circolazione, soprattutto attraverso la manovra del tasso di sconto (il tasso di interesse richiesto dalla banca centrale alle altre banche), le autorità pubbliche di uno Stato possono intervenire efficacemente sull’andamento generale dell’economia.
Infatti un’economia della moneta determina un aumento della domanda complessiva, che a sua volta stimola un incremento della produzione e dei prezzi.
Una riduzione, naturalmente, produce l’effetto opposto.
Se il governo e la banca centrale limitano la quantità di moneta in circolazione, i datori di lavoro ne hanno di meno a disposizione per acquistare nuovi macchinari, per assumere nuovi lavoratori o per aumentare i salari: la produzione e i consumi ne soffrono, ma l’inflazione viene bloccata.
L’equilibrio si ottiene con una politica che commisuri l’offerta di moneta al tasso di crescita dell’economia.
Secondo i monetaristi l’intervento sulla moneta non è solo il più efficace, ma anche l’unico compatibile con politiche che riducano al minimo l’ingerenza dello Stato nell’economia e interferiscano il meno possibile col funzionamento del mercato.
La concezione monetarista si contrappone dunque frontalmente alle teorie di John Maynard Keynes (vedi cap. 5.6) – che prevedono interventi mirati dello Stato per ridurre la disoccupazione e per stimolare il ciclo produttivo – e alle politiche ad essa ispirate, largamente praticate da molti governi nel secondo dopoguerra.
Il monetarismo si è perciò di fatto identificato con le posizioni neoliberiste, favorevoli a una maggiore libertà di mercato e dell’iniziativa privata.
Negli anni ’70 e ’80 di fronte alla difficoltà di controllare una spesa pubblica in continua crescita, molti governi occidentali adottarono politiche monetariste; e una prospettiva analoga fu fatta propria dalle organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, che la imposero ai paesi che fruivano dei loro aiuti.
Ne nacque un acceso dibattito, sia perché quelle politiche non furono coronate da un pieno successo (non sempre si riuscì a controllare la quantità di moneta in circolazione), sia per i costi sociali derivanti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, dalla riduzione dell’intervento dello Stato.
Sommario
L’aumento del prezzo del petrolio del ’73 (che si inseriva in una fase di instabilità monetaria internazionale inaugurata nel ’71 dalla sospensione della convertibilità del dollaro) generò una crisi economica internazionale di vaste proporzioni.
A differenza delle crisi del passato, la crescita della disoccupazione si sommava a un elevato tasso di inflazione.
La gravità delle crisi indusse ad interrogarsi sui fondamenti stessi della civiltà nata con la rivoluzione industriale.
Nei paesi occidentali si manifestò nei tardi anni ’70 una crisi delle ideologie di sinistra, sia riformiste che rivoluzionarie, e la tendenza all’abbandono dell’impegno politico per un ritorno al privato o ai valori tradizionali (il cosiddetto “grande riflusso”).
Nello stesso periodo esplose il fenomeni del terrorismo politico.
Dopo un periodo di incertezza economica e politica, gli Stati Uniti inaugurarono, con la presidenza Reagan (1980-88) e poi di Bush, un nuovo corso basato sulla scelta liberista in economia e su una politica estera più dura nei confronti dell’Urss e dei regimi integralisti del Medio Oriente (Iran, Libia).
Negli ultimi anni dell’età di Breznev, l’Urss, pur non avendo risolto i suoi problemi interni, allargò la sua sfera di influenza mondiale.
Particolarmente costoso, anche da un punto di vista umano, fu l’intervento militare in Afghanistan (1979).
Con l’avvento di Gorbacev (1985) fu avviata una radicale svolta sia in politica estera sia in politica interna (riforme economiche e istituzionali, maggiore libertà di informazione); svolta che suscitò, però non poche difficoltà all’interno dell’Urss.
In seguito a una serie di incontro fra i leader sovietici e statunitensi, si instaurò, dopo l’85, un nuovo clima di distensione internazionale che consentì alcuni accordi fra le superpotenze sulla limitazione degli armamenti e si riflesse positivamente anche sulle prospettive di soluzione dei conflitti locali.
Sul piano dell’economia, l’Europa perse terreno, negli anni ’70 e ’80, rispetto a Usa e Giappone e il processo di unificazione non fece grandi passi in avanti.
Sul piano politico le principali novità furono: la vittoria dei conservatori di Margaret Thatcher in Gran Bretagna; il ritorno al potere dei cristiano-democratici in Germania federale; la vittoria del socialista Mitterand in Francia; il ritorno alla democrazia di Portogallo, Grecia e Spagna (entrati poi a far parte della Cee).
In America Latina gli anni ’70 e ’80 videro la prima massima espansione delle dittature militari (come quelle affermatesi in Cile nel ’73 e in Argentina nel ’76), poi il graduale ritorno alla democrazia politica.
Il processo di democratizzazione fu però ostacolato quasi ovunque da gravi problemi economici.
Il Sud-Est asiatico, dopo la partenza degli americani, vide l’esplodere di conflitti fra paesi comunisti.
Nel ’78, dopo essere stata teatro del sanguinoso esperimento rivoluzionario di Pol Pot, la Cambogia fu invasa dal Vietnam.
In Cina l’ascesa di Deng Xiaoping portò a un processo di riforme interne e liberalizzazione economica che diede buoni risultati in termini di sviluppo produttivo, ma non si accompagnò alla democratizzazione.
Il Giappone, già protagonista nel secondo dopoguerra di un “miracolo economico”, divenne, all’inizio degli anni ’80, la seconda potenza industriale e finanziaria del mondo, senza peraltro svolgere in campo internazionale un ruolo adeguato alla sua forza economica.
Bibliografia
Storia del Giappone contemporaneo / J. M. Bouissou. – Il Mulino, 2003
L’età del terrorismo / W. Lacqueur. – Rizzoli, 1987
Cap. 16. L’Italia dal miracolo economico alla crisi della prima repubblica
Parola chiave
Mafia
La parola “mafia” (o “maffia”), termine dall’etimologia incerta, fece la sua comparsa nel dialetto siciliano, e poi nella lingua italiana, intorno alla metà dell’800, per indicare una rete di associazioni legate da stretti vincoli gerarchici e da un codice d’onore fondato sull’omertà, che praticavano la violenza e l’intimidazione per trarne guadagni e vantaggi per i propri membri, ma anche per imporre, a livello locale, un proprio ordine, alternativo a quello dello Stato.
In questo senso la parola ha poi goduto di larghissima fortuna, ben al di là dei confini nazionali (si è parlato, fra l’altro, di mafia russa e turca, cinese e giapponese), e viene oggi comunemente usata, assieme a derivato “mafioso”, per indicare la tendenza a prevaricare, a sostituire il proprio potere a quelli istituzionali, valendosi di una rete di amicizie e complicità inconfessabili.
Storicamente, le radici del fenomeno sono state individuate nella Sicilia semifeudale del ‘700-‘800: nelle “compagnie d’armi” al servizio dei signori, ma anche nelle corporazioni artigiane di Palermo e soprattutto nell’azione dei grandi affittuari (gabellotti) per il controllo del mondo contadino nella parte centro-occidentale dell’isola.
Dopo l’unità d’Italia, l’associazionismo mafioso si estese e si rafforzò anche come reazione alla più forte presenza dello Stato, diventando subito oggetto di studi e inchieste.
Ma fu soprattutto dopo il 1893, con l’assassinio del direttore del Banco di Sicilia Raffaele Notarbartolo e il successivo processo che vide imputato come mandante il deputato Raffaele Palizzolo (sospettato di legami con la mafia), che il fenomeno assunse rilevanza nazionale, svelando i suoi stretti intrecci con la politica.
Questi legami si intensificarono all’inizio del ‘900, mentre la mafia varcava l’Oceano, inserendosi, tramite le comunità emigrate, nel “gangsterismo” nordamericano.
Nel 1926 il nascente regime fascista affrontò la questione, inviando a Palermi il prefetto Cesare Mori e investendolo di poteri straordinari per debellare la rete mafiosa, che fu in effetti colpita e decapitata, ma non del tutto estirpata.
Quando molti esponenti della mafia italo-americana sbarcarono in Sicilia nel luglio 1943 insieme alle truppe statunitensi (e forse con l’appoggio delle autorità alleate), la rete fu rapidamente ricostituita e, nell’immediato dopoguerra, fu largamente usata come strumento della reazione padronale contro il movimento contadino.
Un ulteriore “salto di qualità” si ebbe a partire dagli anni ’60, quando la mafia, originariamente espressione di una società contadina, si inserì, sfruttando anche i suoi collegamenti politici, nella speculazione edilizia per poi applicarsi con profitto al traffico internazionale degli stupefacenti, senza per questo rinunciare alle attività tradizionali, come il taglieggiamento delle attività commerciali (il “pizzo”) richiesto come contropartita a una protezione imposta con la forza.
L’estendersi degli interessi mafiosi scatenò una serie di cruente lotte interne all’organizzazione, da cui uscì vincitore il gruppo del “corleonesi” (così chiamati dal loro paese di origine), guidato da Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.
Questi, a partire dalla fine degli anni ’70, di fronte ai primi segnali di reazione da parte dei poteri pubblici, dopo anni di interventi scarsamente incisivi, reagirono scatenando una autentica guerra allo Stato, che provocò molte vittime illustri, culminando nel 1982 nell’uccisione del prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa e, dieci anni dopo, nell’assassinio del magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Da allora l’azione repressiva di polizia e magistratura ha fatto registrare non pochi successi, a cominciare dall’arresto di Riina (1993) e di Provenzano (2006).
Ma la mafia, in quanto fenomeno radicato nel territorio e dotato di estesi collegamenti internazionali, è ancora ben lontana dall’essere definitivamente estirpata.
Sommario
Lo sviluppo dell’economia italiana si fece particolarmente intenso negli anni 1958-63.
Fu questo il cosiddetto “miracolo economico” che – nonostante il tasso di sviluppo si riducesse dopo la crisi del ’63-64 – mutò definitivamente in senso industriale il volto del paese.
Al boom nell’industria si accompagnarono due importanti fenomeni sociali: l’esodo dal Sud al Nord e la crescita dell’urbanizzazione.
Entrambi si svolsero in modo caotico, creando notevoli problemi.
In quegli anni, con la televisione si ebbe per la prima volta un’unificazione linguistica e nei modelli di comportamento.
Altro simbolo dell’Italia del miracolo economico fu l’automobile, che ebbe una diffusione di massa.
I mutamenti economici e sociali si accompagnarono, all’inizio degli anni ’60, a una svolta politica, con l’ingresso dei socialisti nell’area della maggioranza.
L’inserimento fu graduale e molto contrastato.
Nell’estate del ’60, dopo la crisi del ministero Tambroni (che aveva tentato, suscitando violente proteste, di governare con l’appoggio determinante del Msi), si formò un governo Fanfani che si reggeva grazie all’astensione (poi trasformata in appoggio parlamentare) dei socialisti.
Nel ’63 si formò il primo governo di centro-sinistra “organico”, presieduto dal leader della Dc Moro.
In questa fase furono varati due importanti provvedimenti: la nazionalizzazione dell’industria elettrica e l’istituzione della scuola media unica.
A partire dal ’63, il centro-sinistra venne esaurendo la sua spinta riformatrice, anche per le preoccupazioni suscitate nella Dc dal peggioramento della congiuntura economica e dall’ostilità dei gruppi moderati.
Nelle elezioni del ’63 e in quelle del ’68 sia la Dc sia il Psi ottennero risultati deludenti.
Nel ’68 esplose anche in Italia la contestazione studentesca, con caratteri di particolare radicalità dovuti alla forte tradizione marxista presente nella cultura italiana.
Nacquero, tra il ’68 e il ’70, i gruppo extraparlamentari.
Il ’69 fu segnato da acute agitazioni operaie (l’”autunno caldo”), protagonisti delle quali furono soprattutto i lavoratori immigrati al Nord.
Le lotte operaie si conclusero con forti aumenti salariali e con un rafforzamento delle confederazioni sindacali.
A queste agitazioni la classe dirigente seppe rispondere in modo adeguato.
Furono approvati tuttavia alcuni importanti provvedimenti (Statuto dei lavoratori, istituzione delle regioni, divorzio).
Gli anni ’70 furono segnati dalle manifestazioni del terrorismo di destra e di sinistra, cui il governo non seppe reagire adeguatamente.
Gli equilibri politici cominciarono a modificarsi dopo il successo del referendum (1974) che confermò il divorzio contro le posizioni della Chiesa e della Dc, testimoniando il profondo cambiamento della società.
La nuova politica del compromesso storico, annunciata dal segretario della Dc Berlinguer (1973), favorì le vittorie elettorali dei comunisti (’75-76).
Dopo il distacco dei socialisti dal governo (’75) si giunse – di fronte alla necessità di affrontare i problemi suscitati dalla crisi economica e dall’accentuarsi del terrorismo di sinistra – al governo di “solidarietà nazionale”, nel 1978.
Proprio allora le Brigate rosse compirono la loro azione più clamorosa: il rapimento e l’assassinio di Moro.
Nonostante alcune leggi di contenuto sociale (equo canone e riforma sanitaria) il programma riformatore del governo di solidarietà nazionale non riuscì a realizzarsi, mentre si accentuarono le divisioni tra le forze politiche.
Negli anni ’80, esauritasi l’esperienza della solidarietà nazionale, si ebbero per la prima volta governi a guida non democristiana (con Spadolini e poi con Craxi).
Tra i problemi maggiori affrontati dall’esecutivo vi furono quelli dell’espansione abnorme della spesa pubblica e della malavita organizzata (mentre il terrorismo, dopo la legge sui “pentiti”, risultava sostanzialmente sconfitto).
I contrasti interni alla maggioranza “pentapartita” portarono, nell’87, alla crisi del governo Craxi e a nuove elezioni anticipate, che segnarono un progresso del Psi e un calo del Pci.
Dopo le elezioni, la coalizione si ricostituiva, dando vita a tre successivi governi a guida democristiana (Goria, De Mita, Andreotti).
Si accentuarono frattanto nell’opinione pubblica la critica alle disfunzioni del sistema politico e l’attesa delel riforme istituzionali.
Bibliografia
Storia del miracolo italiano / G. Crainz. – Donzelli, 1996
Il paese mancato: dal mracolo economico agli anni ottanta / G. Crainz. – Donzelli, 2003
Le classi sociali negli anni ’80 / P. Sylos Labini. – Laterza, 1986
Italiani/e: dal miracolo economico a oggi / V. Vidotto. – Laterza, 2005
Il potere dei partiti: la politica in Italia dagli anni Sessanta ad oggi / P. Ignazi. – Laterza, 2002
Storia e cronaca del centro-sinistra / G. Tamburrano. – Feltrinelli, 1973
La cruna dell’ago: Craxi, il Partito socialista e la crisi della Repubblica / S. Colarizi, M. Gervasoni. – Laterza, 2005
Il caso Moro: una tragedia repubblicana / A. Giovagnoli. – Il Mulino, 2005
Il sistema politico italiano / a cura di P. Farneti. – Il Mulino, 1973
Il sistema politico italiano / a cura di G. Pasquino. – Laterza, 1985
Il sistema politico italiano / C. Guarnieri. – Il Mulino, 2006
Il terrorismo italiano, 1970-1980 / G. Bocca. – Rizzoli, 1981
Terrorismi italiani / D. Della Porta. – Il Mulino 1984
Il terrorismo di sinistra / D. Della Porta. – Il Mulino 1990
Cap. 17. Società postindustriale e globalizzazione
Parola chiave
Ecologia
Si chiama “ecologia” (dal greco oikos, dimora) la scienza che studia i rapporti fra gli esseri viventi e l’ambiente fisico in cui vivono.
Pur essendo da sempre una componente importante di tutte le scienze naturali, solo di recente l’ecologia – chiamata così per la prima volta dallo scienziato e filosofo positivista Ernst Haeckel in un libro del 1966 – ha acquistato uno status di disciplina autonoma.
E’ stata soprattutto la crisi petrolifera del 1973-74 a far riflettere sui pericoli che potrebbero derivare all’umanità da un uso indiscriminato delle risorse naturali.
Ma, più in generale, sono stati gli sviluppi della civiltà dei consumi che, portando all’estremo alcuni fenomeni tipici delle società industrializzate, hanno costretto l’opinione pubblica e i governi a preoccuparsi dei problemi ambientali più di quanto non fosse mai avvenuto in passato.
L’estensione spesso abnorme dei centri urbani; la motorizzazione di massa; la moltiplicazione dei consumi, con conseguente accumulo di rifiuti solidi; l’uso crescente di prodotti non biodegradabili (ossia non riassorbibili nel ciclo naturale), come i contenitori di plastica o alcuni detersivi; gli scarichi delle industrie chimiche nell’atmosfera o nei corsi d’acqua: questi e altri fenomeni hanno non solo contribuito al degrado ambientale dei grandi agglomerati urbani, ma hanno anche influito sugli equilibri ecologici delle aree non industrializzate.
Negli ultimi anni la comunità scientifica ha richiamato l’attenzione su altri e ancor più inquietanti fenomeni, anch’essi riconducibili agli effetti dello sviluppo industriale: come l’assottigliarsi dello strato di ozono che protegge la terra dalle radiazioni ultraviolette; o come il formarsi di una cappa di anidride carbonica che, provocando un innalzamento della temperatura (“effetto serra”), rischierebbe, secondo molti scienziati, di compromettere gli equilibri ecologici dell’intero pianeta.
I temi dell’ecologia sono diventati così oggetto di discussione e di mobilitazione in tutti i paesi industriali.
Soprattutto negli anni ’70 sono sorti un po’ ovunque associazioni e gruppi – ricordiamo in particolare l’associazione internazionale Greenpeace, ecologista e pacifista, nata nel ’71 mentre il WWF (World Wildlife Fund, Fondo mondiale per la natura) era attivo già negli anni ’60 – che si propongono di lottare contro l’inquinamento atmosferico e marino, per la tutela degli spazi verdi e del territorio in generale, per la difesa delle specie animali minacciate di estinzione.
Oggi l’esigenza di una più attenta tutela dell’ambiente è riconosciuta da tutti.
Ma esiste ancora una profonda spaccatura fra gli ecologisti “puri”, spesso attivi nei movimenti “verdi”, e quelli che potremmo definire “industrialisti”.
I primi ritengono la difesa dell’ambiente naturale un obiettivo assolutamente prioritario, contestano il principio dello sviluppo ad ogni costo e mettono sotto accusa la logica stessa della società industriale.
Gli altri non intendono sacrificare alla causa dell’ecologia le ragioni del progresso economico e tecnologico e affidano proprio a questo progresso la speranza di risolvere in modo equilibrato anche il problema del rapporto fra uomo e il suo ambiente.
Sommario
Dopo la crisi petrolifera la prospettiva di una crescita illimitata cominciò ad apparire a molti non solo irreale, ma anche dannosa, in quanto portava con sé la tendenza allo spreco energetico e alla dissipazione delle risorse naturali.
Del resto il degrado dell’ambiente aveva assunto i caratteri di una vera e propria emergenza e già alla metà degli anni ’70 appariva necessario utilizzare fonti energetiche alternative ai combustibili fossili.
I governi promossero politiche di risparmio energetiche e cominciò ad affermarsi il concetto di “sviluppo sostenibile”.
Gli ultimi decenni del ‘900 hanno segnato nuove trasformazioni nell’economia, che hanno avuto il loro centro propulsore nelle crescenti applicazioni dell’elettronica (computer) e delle scienze ad essa collegate (informatica, cibernetica, robotica, telematica).
La rivoluzione elettronica ha trasformato il sistema delle comunicazioni di massa: da una parte sono aumentati i mezzi di trasmissione, dall’altra è cresciuta l’integrazioen fra i diversi canali.
La digitalizzazione ha consentito di unificare i linguaggi e di far circolare informazioni di diversa natura sugli stessi canali di comunicazione.
Una delle più importanti novità dell’ultimo decennio del ‘900 è stato lo sviluppo di Internet: la rete ha contribuito a modificare i modi di espressione e gli orizzonti culturali di milioni di persone.
Gli sviluppi della rivoluzione elettronica hanno avuto effetti anche sull’industria culturale: si sono moltiplicate le imprese multimediali e si è accentuata la tendenza alla standardizzazione dei prodotti culturali di massa.
Gli sviluppi dell’elettronica hanno accelerato la transizione verso una società “postindustriale”, caratterizzata dalla prevalenza del terziario, dalla fine della centralità della fabbrica, dal ruolo crescente dell’informazione.
Cambia anche la natura dei conflitti, meno condizionati dai sistemi di produzione e più legati alle differenze di cultura, di età, di genere.
L’accresciuta velocità delle informazioni e la maggiore facilità di spostamento sono all’origine di una sempre maggiore integrazione economica e finanziaria a livello planetario.
Questa tendenza ha provocato da un lato il tentativo degli Stati più ricchi di coordinare meglio le loro economie, dall’altro un moto di protesta mondiale contro gli effetti della globalizzazione, in nome della difesa delle identità locali e di una più equa distribuzione delle ricchezze.
Nell’ultimo trentennio del ‘900 la popolazione mondiale ha continuato ad aumentare, ma il ritmo di crescita di sta lentamente riducendo.
Il tasso di fertilità è sceso sotto la soglia della “crescita zero” in Europa e ha cominciato a diminuire anche negli altri continenti: più lentamente in Africa, più rapidamente in America Latina e in Asia.
Questa tendenza è dovuta a volte a politiche demografiche attuate dai governi centrali, , altre volte a fenomeni spontanei (benessere, nuovi modelli culturali, urbanizzazione).
In Europa occidentale la “crescita zero” ha creato non pochi problemi proprio in relazione al mantenimento dei livelli di benessere raggiunti.
Alla fine del ‘900 c’è stato un considerevole incremento dei flussi migratori.
Si cominciò a emigrare da tutte le aree povere del mondo verso tutte quelle ricche e la scelta delle destinazioni seguiva una complessa rete di itinerari.
All’inizio del 21. secolo la portata di questo flusso imponente non è facilmente quantificabile perché in parte considerevole le migrazioni si svolgono in forma clandestina.
Lo sviluppo di una società multietnica ha dato luogo a reazioni di diverso segno.
Da un lato si è manifestata la tendenza a cogliere gli aspetti positivi dell’immigrazione, dall’altro ci sono state reazioni di ansia e di ripulsa.
Solo all’inizio degli anni ’80 in tutti i paesi occidentali fu legalmente sancita l’uguaglianza civile tra uomini e donne.
Per quanto riguarda l’emancipazione economica, invece, i progressi furono evidenti già negli anni ’50: il tasso di attività tra le donne cominciò a crescere rapidamente e, dalla fine degli anni ’60, iniziò progressivamente a ridursi la differenza salariale fra i sessi.
Ancora oggi, però, permangono ritardi e disparità tra i sessi.
Limitati, invece, sono stati i progressi nelle condizioni di vita della popolazione femminile in molti paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina.
Al di là della mancanza di un riconoscimento legale dell’uguaglianza tra i sessi, risulta poco diffusa l’idea di un diritto della donna all’autorealizzazione personale.
All’inizio del 21. secolo la religione resta ancora il riferimento culturale fondamentale per buona parte dei popoli del pianeta.
La Chiesa di Roma, in particolare, ha guadagnato posizioni nelle tradizionali terre di missione, Africa e Asia, compensando così quella tendenza all’abbandono della pratica dei sacramenti che si registra in molti paesi europei.
Un ruolo importante nel rilancio planetario del cattolicesimo è stato svolto dal papa polacco Karol Woytila, salito al soglio pontificio nel 1978 col nome di Giovanni Paolo 2.
Una altro fenomeno caratteristico di questo periodo è l’espansione della religione musulmana al di là delle sue aree tradizionali di insediamento.
Questo rilancio dell’Islam ha preso spesso le forme dell’integralismo, che ha assunto un notevole peso dopo la rivoluzione iraniana del 1979.
L’integralismo, peraltro, rappresenta solo una componente minoritaria del mondo musulmano e non è una prerogativa esclusiva dell’Islam: correnti fondamentaliste sono attive da sempre nell’ambito delle Chiese cristiane e nel mondo ebraico.
Ai progressi della medicina nella cura delle più diffuse malattie, ha fatto riscontro negli ultimi decenni la comparsa di nuovi virus, fra cui quello che provoca la Sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids).
Gli sviluppi della medicina e della genetica hanno aperto nuovi problemi nei rapporti fra scienza ed etica.
I limiti degli interventi sulla natura e sulla vita costituiscono il campo di riflessione della bioetica.
Bibliografia
Storia verde del mondo / C. Ponting. – Sei, 1992
Energia: storia e scenari / U. Colombo. – Donzelli, 1996
Qualcosa di nuovo sotto il sole: storia dell’ambiente nel 20. secolo / J. R. McNeil. – Einaudi, 2002
Internet: viaggio nel cyberspazio / J. C. Guedon. – Electa-Gallimard, 1996
Il mondo digitale: introduzione ai nuovi media / F. Ciotti, G. Roncaglia. – Laterza, 2000
La fine del lavoro / J. Rifkin. – Baldini & Castoldi, 1995
Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone / Z. Bauman. – Laterza, 2001
Globalizzazione dal basso: economia mondiale e movimenti sociali / M. Pianta. – Manifestolibri, 2001
La globalizzazione e i suoi oppositori / J. E. Stiglitz. – Einaudi, 2003
Migranti, coloni, rifugiati: dall’emigrazione di massa alla fortezza Europa / S. Sassen. – Feltrinelli, 2000
La rinascita islamica / B. Lewis. – Il Mulino, 1991
La rivincita di Dio: cristiani, ebrei, musulmani alla riconquista del mondo / G. Kepel. – Rizzoli, 1991
Intransigenza e modernità: la Chiesa cattolica verso il terzo millennio / A. Riccardi. – Laterza, 1996
Il secolo biotech: il commercio genetico e l’inizio di una nuova era / J. Rifkin. – Baldini & Castoldi, 2000
Cap. 18. La caduta dei comunismi
Parola chiave
Pulizia etnica
Di “pulizia etnica” si cominciò a parlare in Europa a proposito dei conflitti interetnici seguiti alla dissoluzione della Jugoslavia e protrattisi per tutti gli anni ’90 del secolo scorso.
L’espressione serve a designare una pratica di persecuzione o di violenza fisica compiuta da una popolazione ai danni di un’altra per terrorizzarla o costringerla ad abbandonare un territorio conteso.
In questo senso, quindi, “pulire” un’area geografica significa renderla forzatamente omogenea, eliminandone tutti gli appartenenti alle etnie minoritarie.
In Jugoslavia, per esempio, il leader serbo Slobodan Milosevic tentò di allontanare in questo modo gli albanesi che risiedevano in Kosovo (e lo stesso fecero, in quegli anni, i serbi contro i croati e i croati contro i serbi nelle aree miste da essi controllate).
L’espressione è stata utilizzata anche a proposito degli scontri tra hutu e tutsi in Ruanda.
Ma può essere anche usata in riferimento a moltissimi episodi del passato, che videro intere popolazioni costrette ad abbandonare le loro terre.
E oggi viene utilizzata dai mass-media per denunciare casi di politiche discriminatorie contro minoranze etniche indesiderate all’interno di una nazione.
In questo senso la “pulizia etnica” si distingue dal genocidio propriamente detto (parola chiave cap. 9): in quest’ultimo, infatti, il fine che ci si propone è l’annientamento fisico di un popolo, mentre la pulizia etnica ha come obiettivo il suo allontanamento, indipendentemente dai mezzi usati per ottenerlo.
In realtà la giurisprudenza internazionale non ha ancora trovato una soluzione chiara riguardo all’eventuale corrispondenza tra genocidio e pulizia etnica.
Alcuni studiosi hanno suggerito una versione molto ristretta del concetto di genocidio: in questa prospettiva solo la Shoah potrebbe essere considerata in questi termini, poiché rimane l’unico caso in cui risulta evidente l’intenzione di distruggere completamente un gruppo, gli ebrei, indipendentemente dal luogo dove vivevano.
Una definizione simile distinguerebbe dunque automaticamente la pulizia etnica dagli atti del genocidio.
Ciò non esclude, tuttavia, che un’accezione più ampia di genocidio possa ricomprendere anche episodi di pulizia etnica.
E’ importante comunque sottolineare che la definizione di genocidio, contenuta nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) e ripresa nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998), pone come requisito l’esistenza di un progetto per distruggere in tutto o in parte un determinato gruppo.
Sommario
Il declino dell’Urss, e in generale dei sistemi comunisti, manifestatosi già negli anni ’70, conobbe una brusca accelerazione nel decennio successivo.
Decisivo , nel determinare la crisi, fu il fallimento del tentativo di Gorbacev di avviare un processo di parziale liberalizzazione aprendo limitati spazi di pluralismo nel sistema sovietico e nei rapporti con i paesi satelliti.
La Polonia aveva anticipato questi mutamenti già all’inizio degli anni ’80, con la nascita del sindacato indipendente Solidarnosc.
Il processo, interrotto nel 1981 da un colpo di Stato militar-comunista, riprese dopo l’avvento di Gorbacev, portando, nell’89, alle prime elezioni libere in un regime di “democrazia popolare”.
I mutamenti in Unione Sovietica ebbero immediati riflessi sui paesi dell’Europa orientale, provocando la crisi dell’intero blocco comunista.
Processi di liberalizzazione furono avviati prima in Polonia – dove già all’inizio degli anni ’80 si era affermato il sindacato indipendente Solidarnosc – e in Ungheria, poi in Germania orientale, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania – l’unico paese in cui il trapasso di regime avvenne in forma violenta.
Mentre in Romania e in Serbia i gruppi “neocomunisti” riuscirono a mantenere il potere, negli altri Stati i partiti comunisti furono completamente travolti.
Nella Repubblica Democratica Tedesca la caduta del muro di Berlino e la vittoria dei cristiano-democratici aprirono la strada alla riunificazione con la Repubblica federale, che fu portata a termine nell’ottobre 1990.
Fra il 1989 e il 1991 gli equilibri mondiali subirono un radicale sconvolgimento.
Nel vuoto aperto dalla crisi dell’Urss e dall’assenza di un nuovo ordine internazionale, si inserì una generale ripresa dei movimenti nazionalisti.
L’evento centrale di questa nuova fase fu la crisi dell’Urss.
Il processo di disgregazione avviato con le riforme di Gorbacev si accelerò dopo un fallito colpo di Stato tentato nell’agosto 1991 dai rappresentanti del vecchio regime.
Alla fine del ’91 l’Unione sovietica cessò di esistere e Gorbacev diede le dimissioni.
Negli anni ’90 l’Europa ex-comunista attraversò momenti difficili dal punto di vista economico e politico.
La Jugoslavia si divise in diversi Stati – Federazione Jugoslava, comprendente Serbia e Montenegro, Croazia, Slovenia, Bosnia e Macedonia – e, dal 1991, fu teatro di una spietata guerra fra le nazionalità: particolarmente sanguinoso il conflitto in Bosnia, concluso da un precario accordo solo nel 1995.
Fra il 1998 e il 1999 esplose la crisi del Kosovo, dove la repressione attuata dai serbi nei confronti della popolazione albanese venne bloccata dall’intervento militare della Nato.
Nel 1997 anche l’Albania conobbe una drammatica crisi interna, risolta solo con l’intervento dell’Onu.
Bibliografia
1989: riflessioni sulla rivoluzione in Europa / R. Dahrendorf. – Laterza, 1990
Le rovine dell’impero: Europa centrale, 1980-1990 / T. Garton Ash. – Mondadori, 1992
La fine delle democrazia popolari / F. Fejto. – Mondadori, 1994
La caduta dei comunismi / B. Bongiovanni. – Garzanti, 1995
Dall’Urss alla Russia: storia di una crisi non finita / G. Boffa. – Laterza, 1995
Le guerre jugoslave, 1991-1999 / J. Pirjevec. - Einaudi, 2001
Capire la Germania / G. E. Rusconi. – Il Mulino, 1990
Diario berlinese, 1989-1990 / R. Darnton. – Einaudi, 1992
Il crollo: la crisi del comunismo e la fine della Germania Est / C. S. Maier. – Il Mulino, 1999
Grande storia della Germania / H. A. Winkler. – Donzelli, 2004
Cap. 19. Il nodo del Medio Oriente
Parola chiave
Fondamentalismo
Si definisce “fondamentalismo” l’atteggiamento di chi si batte per un ritorno ai “fondamenti” della religione: dunque per una interpretazione letterale dei testi sacri posti alla base della propria confessione (si tratti della Bibbia, del Vangelo o del Corano) e per un’applicazione integrale dei precetti in essi contenuti, che dovrebbero informare di sé le leggi dello Stato, e dunque la politica, la cultura, la vita sociale e l’economia (in questo senso si parla anche di integralismo: un termine che però ha un significato più vago e un campo di applicazione più ampio).
I movimenti fondamentalisti si considerano i legittimi detentori delle verità religiose originarie, inquinate dai processi di modernizzazione.
Per imporsi, si inseriscono nelle fasi di crisi, offrendone una spiegazione unica e al tempo stesso una soluzione semplice e immediata: il ritorno, appunto, alle antiche tradizioni e alle certezze del credo religioso.
Essi forniscono, inoltre, ai propri aderenti un’organizzazione e una comunità da cui sono esclusi i non credenti e i dissidenti, considerati come nemici da combattere.
Se l’atteggiamento fondamentalista è antico quanto le religioni, il termine si è imposto soprattutto nel 20. secolo.
I primi a usarlo furono quei gruppi di protestanti conservatori americani che si riconoscevano nei Fundamentals, una raccolta di testi ricavata dalla Bibbia che doveva costituire la base per il rinnovamento spirituale della società.
In ambito islamico, le origini del fondamentalismo contemporaneo vanno fatte risalire al movimenti dei Fratelli musulmani, nato in Egitto alla fine degli anni ’20 del ‘900 per iniziativa di un insegnante, Hasan al-Banna, con lo scopo di reagire all’occidentalizzazione della società in nome di una totale adesione ai precetti coranici.
Ma la diffusione del fenomeno su vasta scala risale alla fine degli anni ’70, in coincidenza con la rivoluzione khomeinista in Iran e con la resistenza dei combattenti afghani all’occupazione sovietica.
Il carattere militante e aggressivo di un certo islamismo radicale – manifestatosi in forma emblematica soprattutto con gli attentati dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New York (vedi cap. 22.4) – ha fatto sì che il fondamentalismo islamico venisse avvertito in Occidente (e in molti degli altri paesi musulmani) come una minaccia permanente e come l’emergenza prioritaria del nostro tempo.
Ciò non deve tuttavia far dimenticare che il fondamentalismo in quanto tale non è un carattere esclusivo dell’islamismo.
Esiste un fondamentalismo evangelico, forte soprattutto negli Stati Uniti, legato alla destra conservatrice e impegnato nella battaglia contro le teorie evoluzioniste e contro la pratica dell’aborto.
Esiste un fondamentalismo cattolico, che si batte contro le innovazioni del Concilio Vaticano 2.
Esistono gruppi fondamentalisti ebraici, diffusi sia in Israele sia negli Stati Uniti.
Esiste un fondamentalismo induista, che in India si è spesso scontrato con la minoranza musulmana.
Si tratta, in ognuno di questi casi, di fenomeni minoritari e non necessariamente violenti, che però testimoniano la presenza di vaste aree di disagio e di reazione tradizionalista, che i processi di modernizzazione hanno allargato e acuito.
Sommario
Negli ultimi decenni del ‘900 la centralità strategica del Medio Oriente si accentuò per l’accentuarsi di tre fattori di tensione: l’accresciuto interesse per il petrolio, il prolungarsi del conflitto arabo-israeliano, la diffusione del fondamentalismo islamico.
La pace fra Israele e Egitto stipulata nel 1978 da Sadat e Begin con la mediazione degli Stati Uniti non bastò a favorire un accordo globale nella regione.
In Iran, nel 1979, una rivoluzione rovesciò la monarchia e instaurò una repubblica di stampo teocratico e fondamentalista guidata dall’ayatollah Khomeini.
Violentemente antioccidentale, il nuovo regime entrò subito in contrasto con gli Stati Uniti.
Nel 1980 l’Iran fu attaccato dall’Iraq: la guerra durò otto anni e si risolse in un’inutile carneficina.
Negli anni ’80 si accentuò il conflitto fra Israele e i palestinesi sulla sorte dei territori occupati nel 1967.
A partire dall’87 i palestinesi dei territori diedero vita a una rivolta (intifada) contro Israele che reagì duramente.
I riflessi dell’irrisolto nodo palestinese si erano intanto fatti sentire anche in Libano che, dalla metà degli anni ’70, era entrato in uno stato di cronica guerra civile.
La situazione si aggravò dopo che l’esercito israeliano invase il paese per cacciarne le basi dell’Olp.
L’invasione del Kuwait di Saddam Hussein nel 1990 provocò, nel ’91, la risposta di una coalizione militare guidata dagli Stati Uniti che agiva sotto la bandiera dell’Onu.
La campagna fu rapida e vittoriosa, ma il regime di Saddam rimase in piedi.
La sconfitta dell’Iraq favorì il rilancio del processo di pace, che portò nel 1993 a un accordo fra Israele e i palestinesi dell’Olp.
L’accordo era tuttavia minacciato sia dall’affermazione delle forze nazionaliste in Israele, dopo l’attentato che nel 1995 costò la vita al premier laburista Rabin, sia dalla recrudescenza del terrorismo palestinese inversione fondamentalista.
Nel 2000, dopo un fallito tentativo di giungere a un accordo generale, gli scontri e gli attentati ripresero con rinnovata violenza.
Nemmeno il ritiro israeliano da Gaza, nel 2005, servì a riportare la pace, mentre cresceva l’influenza del movimento integralista Hamas.
Sull’onda della rivoluzione iraniana, le correnti fondamentaliste si diffusero in tutto il mondo islamico e, nel ’96-97, trovarono una base in Afghanistan sotto il regime dei talebani.
L’ondata fondamentalista toccò anche paesi di tradizione laica, come la Turchia e soprattutto l’Algeria.
Qui la reazione dei gruppi fondamentalisti all’annullamento delle elezioni del ’92 provocò una serie di spaventosi massacri.
Bibliografia
Storia del Medio Oriente, 1798-2005 / M. Campanini. – Il Mulino, 2006
Cap. 20. L’Unione europea
Parola chiave
Europeismo
L’europeismo è un movimento politico e di idee che tende a promuovere l’avvicinamento tra gli Stati nazionali europei, fino alla costruzione di un’Europa politicamente unita.
Esso si richiama alle fondamentali affinità culturali e storiche che legano tra loro i popoli d’Europa, al di là dei mutevoli e controversi confini geografici che dividono il continente, e al sentimento di appartenenza a un destino comune.
Richiami a una civiltà europea intesa come unità culturale erano già presenti in epoca pre-rinascimentale, soprattutto in riferimento al lascito della tradizione cristiana medievale.
Il tema della unicità della civiltà europea ritornò in auge nel ‘700 (con Voltaire e Kant) e nell’800 (con Mazzini), non più inteso soltanto nei suoi aspetti culturali ma declinato anche come concreta opzione politica.
Il tema, però, rimase per decenni patrimonio di una ristretta élite.
Spazi per un movimento politico europeista sembrarono aprirsi dopo la fine della prima guerra mondiale: le tragiche conseguenze cui aveva condotto il nazionalismo dei diversi Stati e la crisi del tradizionale equilibrio confermavano le ragioni di chi si poneva l’obiettivo di un superamento delle divisioni interne al continente.
Negli anni ’20 del ‘900, un politico austriaco, Richard Coudenhove-Kalergi, fondò l’Unione paneuropea, finalizzata alla promozione dell’unione politica tra gli Stati del vecchio continente (escluse Russia e Inghilterra); furono anche elaborate alcune proposte federaliste, come il progetto del ministro francese Aristide Briand, di istituire gli Stati Uniti d’Europa.
L’ascesa al potere dei nazisti, le tensioni e i conflitti degli anni ’30 e poi la seconda guerra mondiale dimostrarono che i tempi non erano ancora maturi.
La fine della guerra ebbe come risultato la divisione politica dell’Europa tra Est e Ovest e, con l’emergere delle superpotenze Usa e Urss, il ridimensionamento del continente nello scenario mondiale.
Fu in questo contesto che l’idea di un’Europa unita – rilanciata durante la guerra da varie forze antifasciste – divenne un tema all’ordine del giorno del dibattito politico e culturale.
Essa fu sostenuta da politici di diverso orientamento: socialisti come il francese Leon Blum e il belga Paul-Henri Spaak, cattolici come il tedesco Konrad Adenauer, l’italiano Alcide De Gasperi e il francese Robert Schuman, conservatori come Winston Churchill.
Importante fu poi l’azione di alcuni gruppi europeisti, il principale dei quali fu il Movimento federalista europeo (ispirato al Manifesto per l’Europa libera e unita, redatto nel 1941 dagli antifascisti italiani Ernesto Rossi e Altiero Spinelli durante il confino a Ventotene, e guidato dallo stesso Spinelli), sorto intorno all’obiettivo della costituzione degli Stati Uniti d’Europa.
Se l’idea di un avvicinamento tra le nazioni del continente fu largamente condivisa, profonde divergenze si registrarono – e in parte continuano a registrarsi - sulle forme che avrebbe dovuto assumere il processo d’integrazione.
L’europeismo assunse diverse declinazioni: al modello federalista si contrapposero quello confederalista (basato sulla cooperazione tra i governi e sulla conservazione delle sovranità statali) di cui si fece assertore, tra gli altri, Charles De Gaulle con la sua “Europa delle patrie”, e quello funzionalista, cioè che puntava al superamento della sovranità statale assoluta attraverso accordi settoriali, portato avanti in particolare dal politico francese Jean Monnet.
Le idee europeiste, nel loro insieme, diedero un notevole impulso all’avvio del processo di integrazione.
Il percorso seguito a partire dalla costituzione della Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 1951) e, soprattutto, della Cee (Comunità economica europea, 1957), sino ai più recenti sviluppi, è stato contrassegnato da un prevalere del modello funzionalista, evidente soprattutto nella scelta di far precedere l’integrazione economica a quella politica, nel tentativo di aggirare le forti resistenze degli Stati nazionali.
Sommario
Dopo i trattati di Roma del 1957, il cammino verso l’integrazione politica dell’Europa si arrestò.
Solo nella seconda metà degli anni ’70 si ebbero due novità importanti: l’elezione a suffragio diretto del parlamento europeo e l’istituzione dello Sme, un sistema di cambi fissi fra le monete dei paesi membri.
Nel decennio successivo, il processo di integrazione fu rilanciato dalla firma dell’Atto unico europeo (1995) e del trattato di Maastricht (1992), che diede vita all’Unione europea e stabilì le condizioni per entrarvi.
I firmatari si impegnarono fra l’altro a realizzare entro il 1999 il progetto di una Unione monetaria europea, con una moneta unica (euro) e una Banca centrale (Bce).
A partire dal gennaio 2002 l’euro sostituì le monete nazionali (tranne la Gran Bretagna).
Il dibattito sull’Unione europea ( e sui vincoli che essa poneva alle politiche nazionali) si intrecciò con le vicende dei singoli paesi, che videro in questi anni una regolare alternanza tra forze moderate e forze di orientamento socialista.
All’inizio del nuovo secolo, l’Unione accolse le richieste di adesione di quali tutti i paesi ex-comunisti dell’Europa orientale.
Fu così cancellata la frattura creatasi con la guerra fredda.
Segnò invece il passo il processo di integrazione politica, soprattutto dopo la bocciatura, nel 2005, da parte dell’elettorato francese e olandese, del progetto di Costituzione europea elaborato, tra il 2001 e il 2003, da una apposita commissione
Bibliografia
Storia dell’idea di Europa / F. Chabod. – Laterza, 2001
Storia di un’idea e di un’identità / H. Mikkeli. – Il Mulino, 2002
Storia d’Europa dal 1945 a oggi / G. Mammarella. – Laterza, 2000
L’Europa difficile: storia politica dell’integrazione europea, 1948-2000 / B. Olivi. – Il Mulino, 2000
Storia dell’integrazione europea / L. Rapone. – Carocci, 2002
L’integrazione economica europea, 1947-2006 / F. Fauri. – Il Mulino, 2006
La costituzione dell’Europa / J. H. H. Weiler. – Il Mulino, 2003
Cap. 21. Sviluppo e disuguaglianza
Parola chiave
Debito estero
Si intende per “debito estero” un debito pubblico a scadenza pluriennale contratto da uno Stato con creditori privati, governi ed enti pubblici di altri paesi e rimborsabile in valuta straniera, merci e servizi.
Il debito estero di un paese si forma se il fabbisogno di fondi per finanziare la spesa privata in investimenti e la spesa pubblica è maggiore dei capitali disponibili all’interno dello Stato.
Prendere a prestito fondi dalle economie più avanzate, o semplicemente più ricche di capitali, è pratica normale per quegli Stati che debbano affrontare speciali emergenze (guerre, ricostruzioni, opere di modernizzazione) e in genere per ogni paese che intenda scommettere sulla propria crescita.
In particolare, negli anni ’70 del ‘900, i paesi in via di sviluppo acquisirono ingenti prestiti dall’estero al fine di avviare la propria industrializzazione.
E’ dunque in quel periodo che si registrò un rilevante aumento del volume del debito.
Già nel decennio successivo, per molti paesi in via di sviluppo, il debito estero divenne un problema drammatico.
Infatti, alla fine degli anni ’70, la rivalutazione del dollaro, provocata dalla necessità di contrastare gli effetti del caro petrolio, determinò un brusco aumento dei tassi di interesse sui prestiti internazionali e una crescita dello stesso ammontare dei debiti.
Molti paesi debitori entrarono allora in difficoltà: è stato calcolato che tra il 1978 e il 1981 il peso reale degli interessi, al netto dell’inflazione, passò da un fattore negativo (-20%) a uno positivo (+20%).
Questo incremento innescò una seria crisi economica nelle aree meno sviluppate del pianeta.
Nel 1982 il Messico dichiarò una moratoria sul debito estero, ovvero una sospensione temporanea dei pagamenti, e successivamente molti altri Stati presentarono richieste di rinvio delle scadenze e appelli per una rinegoziazione.
Il debito estero, infatti, si rivelò un peso insostenibile per le fragili economie di molti paesi, soprattutto dell’Africa e dell’America Latina.
Intervenne allora il Fondo monetario internazionale come garante di nuovi accordi di rinegoziazione tra paesi debitori e paesi creditori.
Questo coinvolgimento del principale organismo finanziario internazionale inaugurò una nuova politica dei prestiti, che vennero sempre più vincolati a riforme economiche da realizzare nei paesi beneficiari.
Lo scopo era quello di cercare di stabilizzare la situazione economica negli Stati debitori al fine sia di ridurre i rischi di insolvenza sia di promuovere l’espansione del mercato mondiale.
Ma questa strategia, che provocò una severa compressione dei consumi in paesi già poveri, divenne oggetto di molte critiche.
Alla fine degli anni ’80 il Fondo monetario internazionale cambiò approccio e divenne promotore di interventi di rilancio economico nei paesi in via di sviluppo, appoggiando l’avvio di una riduzione volontaria del debito su basi bilaterali.
Da allora molti Stati si giovarono dell’annullamento di una parte del debito e di una serie di significativi condoni.
Il che non impedì il prolungarsi dello stato di crisi in molti paesi e il verificarsi di casi di insolvenza, come quello di cui fu protagonista l’Argentina nel 2000-1
Sommario
Nonostante i grandi mutamenti verificatisi in alcune aree del Terzo Mondo – fra i produttori di petrolio, nei paesi di nuova industrializzazione del Sud-Est asiatico, in India e in Cina – alla fine del ’900 il divario fra i paesi ricchi e i paesi poveri complessivamente si approfondì.
In Africa si registrarono vere e proprie tragedie della fame, mentre il problema del debito estero si faceva sempre più pressante.
In Asia, negli anni ’80 e ’90, lo straordinario sviluppo economico non fu accompagnato da un significativo progresso della democrazia.
In Cina gli eredi di Deng riuscirono a inserire il paese in un mercato internazionale da cui era rimasto isolato per decenni.
In Giappone, dopo un lungo periodo di sviluppo sostenuto, esplose negli anni ’90 una crisi economica aggravata da una serie di difficoltà politiche.
In India ci fu un consolidamento delle istituzioni rappresentative, mentre in Pakistan portarono al potere i militari.
In Indonesia finì la dittatura di Suharto, ma il paese rimase instabile per una proliferazione di conflitti etnico-religiosi.
Alla fine del ‘900 il modello di sviluppo asiatico, fondato sulla flessibilità e sui bassi salari, fu in parte incrinato da una grave crisi finanziaria.
Non s’interruppe però la crescita della Cina, cui si aggiunse quella dell’India.
Negli anni ’90 l’Africa nera vide i suoi mali aggravati da una lunga serie di colpi di Stato e di guerre civili che, in alcuni paesi, giunsero a distruggere ogni autorità centrale.
Le note incoraggianti vennero soprattutto dal Sudafrica, dove si concluse la lunga stagione dell’Apartheid.
Un conflitto che trovò soluzione fu anche quello tra gli indipendentisti eritrei e lo Stato etiopico: nel 1993, infatti, nacque lo Stato indipendente dell’Eritrea.
La Somalia divvenne teatro di una spietata guerra fra clan e bande rivali, che non venne arrestata nemmeno da una missione di pace dell’Onu.
Più tardi fu il Ruanda a essere dilaniato da una crudelissima guerra, fra le etnie degli hutu e dei tutsi, che ebbero tragiche conseguenze anche in Zaire.
In America Latina, negli anni ’80, si assisté alla caduta delle dittature militari e al conseguente ritorno a una sia pur precaria vita democratica.
Questo processo di democratizzazione, però, incontrò numerosi ostacoli di natura economica, politica e sociale.
Quasi tutti i paesi furono travagliati dall’inflazione e da un pesantissimo carico di debiti con l’estero.
Gli inizi degli anni ‘9’ segnarono l’inizio di una ripresa e la tendenza alla creazione di aree economicamente integrate (Nafta, Mercosur).
Per i maggiori paesi del Sud America una nuova crisi si profilò a partire dal 1998: il Brasile riuscì a superare il momento difficile, mentre l’Argentina precipitò in una gravissima crisi finanziaria.
Negli anni successivi, in alcuni paesi latino-americani (Venezuela, Bolivia, Ecuador) si alternarono regimi populisti di sinistra
Bibliografia
Globalizzazione e disuguaglianze / L. Gallino. – Laterza, 2007
Il leone e il cacciatore: storia dell’Africa subsahariana / A. M. Gentili. – Il Mulino, 1995
Il secolo cinese / F. Rampini. – Mondadori, 2005
Cap. 22. Nuovi equilibri e nuovi conflitti
Parola chiave
Multiculturalismo
Questo termine, elaborato originariamente nell’ambito delle discipline antropologiche, indica il riconoscimento della pari dignità delle espressioni culturali di tutti i gruppi e comunità che convivono in una società.
E’ un concetto che si fonda sull’idea che ciascun essere umano ha diritto a crescere dentro la propria cultura e la propria tradizione e non deve essere costretto ad assimilarsi a quella della maggioranza.
La parola “multiculturalismo” cominciò a circolare con insistenza negli Stati Uniti e in Canada durante gli anni ’70 del ‘900, per poi diffondersi altrove nel decennio successivo.
Inizialmente, il termine faceva riferimento soprattutto alla convivenza all’interno della società di etnie e culture diverse.
Decisiva, al riguardo, era stata, negli Stati Uniti, la mobilitazione degli afro-americani per il riconoscimento dei diritti civili negli anni ’60.
E altrettanto importante era stata la decisione del governo canadese di avviare, all’inizio degli anni ’70, una politica federale multiculturale per soddisfare le richieste delle minoranze, soprattutto di quella francofona.
Ma presto si affermò un’accezione più ampia del concetto di multiculturalismo, che faceva riferimento a tutte le differenze presenti in una società.
A ispirarla fu soprattutto l’esperienza dei movimenti collettivi degli anni ’60, in particolare del femminismo, che rivendicava il riconoscimento della differenza “di genere”.
A quest’ultima si aggiunsero poi le differenze di preferenze sessuali, di stili di vita, di credenze spirituali.
Oggi il tema del multiculturalismo è al centro del dibattito pubblico nelle società occidentali, non solo in quelle profondamente trasformate dall’immigrazione.
E costituisce il principio legittimante di tutte le politiche di affirmative action (azione affermativa), destinate cioè a garantire pari opportunità e quote di presenze (nelle università, in politica o negli uffici pubblici) a donne e minoranze culturali.
La questione risulta strettamente intrecciata all’idea che lo Stato debba trattare con rispetto non solo il cittadino in quanto entità astratta, ma anche la persona col suo patrimonio di esperienze e di culture: ovvero che le istituzioni pubbliche debbano valorizzare anche ciò che rende diversi gli individui.
Questa idea, però, pone a sua volta problemi nuovi, resi evidenti negli ultimi decenni soprattutto dalla crescita e dalla riscossa identitaria delle comunità islamiche immigrate in Occidente.
Ci si chiede in particolare se l’ideale del rispetto per l’identità culturale di ogni singola comunità (comunitarismo) possa entrare in contrasto con i valori dello Stato di diritto e della stessa democrazia basata sull’uguaglianza dei cittadini, o quantomeno rendere più difficile il funzionamento di leggi e istituzioni che dovrebbero valere per tutti, al di là dei confini comunitari.
Sommario
Dopo il crollo dell’Urss gli equilibri mondiali subirono un radicale sconvolgimento.
Nel vuoto aperto dalla crisi dell’Urss e dall’assenza di un nuovo ordine internazionale, si inserì una generale ripresa dei movimenti nazionalisti e fu lanciata la sfida al fondamentalismo islamico.
Negli Stati Uniti, le difficoltà economiche provocarono, nel ’92, la sconfitta del presidente americano Bush, che pure aveva riportato notevoli successi in politica internazionale e l’elezione del democratico Clinton.
Dopo le iniziali incertezze (dovute anche alle difficoltà inerenti al nuovo ruolo degli Usa, diventati l’unica super potenza mondiale), Clinton accrebbe la sua popolarità grazie soprattutto alla notevole congiuntura economica e fu rieletto nel ’96.
Nonostante i buoni risultati ottenuti da Clinton nel suo secondo mandato, le presidenziali del 2000 furono vinte di strettissima misura dal repubblicano George W. Bush.
La Federazione russa, sotto la guida di Eltsin, cercò di ereditare il ruolo dell’Urss, ma si trovò in condizioni di grave dissesto economico e di cronica instabilità politica, aggravata dal conflitto con i separatisti della Cecenia.
Una parziale stabilizzazione fu avviata a partire dal 2000, con l’elezione di Putin alla presidenza.
Questi rilanciò la guerra in Cecenia e avviò una politica estera con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Russia.
L’11 settembre 2001 il terrorismo integralista mise a segno un clamoroso attentato contro le Twin Towers a New York e contro il Pentagono a Washington.
L’intero Occidente ne fu sconvolto.
La reazione degli Stati Uniti e dei loro alleati si indirizzò contro l’Afghanistan, che ospitava il presunto capo dei terroristi, Osama bin Laden: l’oppressivo regime dei talebani fu spazzato via dai bombardamenti americani e dall’offensiva delle forze d’opposizione.
Dopo l’Afghanistan gli Stati Uniti volsero la loro attenzione all’Iraq di Saddam Hussein, accusato di nascondere armi di distruzione di massa.
Dopo un infruttuoso negoziato tra Onu e Iraq, Stati Uniti e Gran Bretagna cominciarono a preparare un’operazione militare.
Su questa decisione la comunità internazionale si divise: da una parte Stati Uniti, Gran Bretagna e Spagna, determinati all’uso della forza; dall’altra Francia, Germania, Russia, Cina e Stati arabi, favorevoli a una soluzione diplomatica.
Il 20 marzo 2003 i primi missili statunitensi colpirono Baghdad.
Nei giorni seguenti le truppe anglo-americane cominciarono ad avanzare in Iraq.
Il regime di Saddam Hussein si sfaldò all’istante ma la pacificazione del paese si rivelò lenta e difficile.
Bibliografia
L’impero riluttante / a cura di S. Romano. – Il Mulino, 1992
Verso il 21. secolo / P. Kennedy. – Garzanti, 1993
America senza rivali? / G. J. Ikenberry. – Il Mulino, 2004
Colossus: ascesa e declino dell’impero americano / N. Ferguson. – Mondadori, 2006
Occidentalismo: l’Occidente agli occhi dei suoi nemici / I. Buruma, A. Margalit. – Einaudi, 2004
Cap. 23. La seconda repubblica
Parola chiave
Proporzionale / Maggioritario
A partire dalle elezioni per l’Assemblea costituente e fino ai due referendum del 9-10 giugno 1991 e del 18 aprile 1993, gli italiani hanno eletto i loro rappresentanti politici in Parlamento con un sistema proporzionale plurinominale basato sullo scrutinio di lista: nei collegi elettorali venivano presentate liste di partiti, ciascuna contrassegnata da un simbolo e composta da un numero di candidati pari ai seggi in palio; gli elettori esprimevano la loro opzione per una lista ed eventualmente per uno o più candidati (voto di preferenza).
Ad ogni partito veniva assegnato un numero di seggi proporzionale ai voti raccolti.
Il sistema proporzionale assicura un’esatta raffigurazione delle scelte dell’elettorato, ma spesso indebolisce la stabilità del governo.
Viene infatti incoraggiata e moltiplicata la frammentazione politica, garantendo rappresentanti in Parlamento a piccoli gruppi o partiti con basse percentuali di voti: tutti così sono incoraggiati a partecipare alla corsa elettorale, anche se la differenza tra formazioni affini è limitata.
Perciò difficilmente in un sistema proporzionale un partito conquista la maggioranza assoluta: per formare un governo è spesso necessaria una vasta coalizione di partiti, dove ogni forza tende a sottolineare le differenze rispetto agli alleati per accrescere il proprio consenso, indebolendo l’attività del governi.
Inoltre, in un regime parlamentare privo di altre cariche direttamente elette dal popolo (come il capo dello Stato o il capo del governo), questo sistema elettorale contribuisce ad assegnare ai partiti un ruolo determinante nelle decisioni politico-istituzionali, a scapito degli elettori: con il voto nell’urna viene indicato soltanto il partito preferito, mentre la formazione del governo, l’elaborazione del programma, la scelta dei ministri sono il risultato di trattative tra le forze politiche dopo le elezioni.
Per questo, in alcuni casi, il metodo proporzionale viene corretto con l’introduzione di un premio di maggioranza, ovvero di una quota supplementare di seggi, allo scopo di favorire la stabilità.
In altri casi (come quello della Repubblica federale tedesca dopo la seconda guerra mondiale) lo stesso obiettivo viene perseguito attraverso una soglia di sbarramento (in Germania è del 5%): chi non la supera è escluso dalla rappresentanza parlamentare.
Con il sistema maggioritario uninominale, invece, il territorio elettorale è diviso in un numero di collegi pari ai rappresentanti da eleggere (dunque molto più piccoli rispetto a quelli del sistema proporzionale e tali da favorire un contatto più diretto tra eletto ed elettori), dove si raffrontano i candidati, uno per ciascun partito o coalizione di partiti (da cui “uninominale”): chi ottiene il maggior numero di voti (anche se non necessariamente la maggioranza assoluta) ha diritto al seggio.
Esistono molte versioni del sistema uninominale: le più note sono l’inglese e la francese.
Nel primo caso la votazione avviene in un unico turno: è così possibile conquistare il seggio anche con una maggioranza relativa molto bassa di voti.
Nel secondo caso, invece, qualora nessun candidato si sia aggiudicata la maggioranza assoluta al primo turno, viene svolto un secondo turno elettorale (detto ballottaggio) tra i candidati più votati, consentendo eventualmente agli elettori dei candidati esclusi di votare per l’esponente politicamente più vicino tra quelli rimasti in gara.
Il sistema maggioritario uninominale elimina la corrispondenza proporzionale tra voti e seggi: generalmente chi ottiene la maggioranza relativa di voti conquista un numero di seggi superiore a quanti gliene spetterebbero in proporzione.
Viene così garantita una semplificazione del panorama politico, che tende ad evolvere verso il bipartitismo (nel caso del turno unico) o verso il bipolarismo (nel caso del doppio turno), poiché i piccoli gruppi con un consenso limitato sono incoraggiati a fondersi o allearsi con le formazioni più vicine.
In Italia la legge elettorale per il Parlamento, approvata dopo il referendum del 1993, era diversa dai modelli descritti: per evitare gli effetti traumatici del maggioritario puro su un sistema politico abituato al proporzionale, era previsto un unico turno maggioritario per i tre quarti dei seggi, mentre era mantenuto il proporzionale per il restante quarto.
Le conseguenze furono contraddittorie: per un verso i partiti erano incoraggiati ad aggregarsi in cartelli elettorali per conquistare i seggi uninominali, per l’altro tendevano a differenziarsi per ottenere consensi nella quota proporzionale.
Alla fine del 2005, la maggioranza di centro-destra attuò una nuova riforma, che reintroduceva il criterio proporzionale con liste bloccate (ossia decise dai partiti, senza voto di preferenza), correggendolo con un premio di maggioranza per la coalizione vincente (su base nazionale alla Camera, regionale al Senato) e con una clausola di sbarramento fissata al 4%.
Il risultato ambiguo delle elezioni dell’aprile 2006 e la difficile governabilità che ne seguì convinsero le maggiori forze politiche (compresi alcuni fra i promotori della riforma) dell’opportunità di un ulteriore intervento legislativo, sollecitato anche da una nuova proposta referendaria che mirava a semplificare il sistema attribuendo il premio alla lista, anziché alla coalizione, vincente.
Il tema della riforma elettorale tornava così ancora una volta al centro del dibattito politico.
Citazione
Il Presidente della Repubblica designò allora, come figura indiscussa al di sopra delle parti, il governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi, per formare il nuovo governo.
Ciampi costituì il nuovo governo, muovendosi al di fuori delle logiche partitiche e delle maggioranze precostituite, richiamando ministri del precedente gabinetto, ma inserendo tecnici ed esponenti di altre aree.
Pag. 447-48
L’impegno di un nuovo esecutivo era rivolto in primo luogo a favorire il varo di una nuova legge elettorale per le due Camere che recepisse il principio maggioritario indicato dal referendum per il Senato.
Si proponeva inoltre di continuare sulla via delle privatizzazioni, della riduzione della spesa pubblica e delle riforme fiscali.
L’intento, infine, di contenere o diminuire la disoccupazione sembrava contraddetto dalla recessione economica e dall’obiettivo di ridurre la spesa.
Pag. 449-50
Per un insieme di fattori dipendenti dall’alto numero di collegi dell’Italia settentrionale e dal sistema elettorale uninominale i candidati eletti della Lega Nord furono più numerosi di quelli di Forza Italia, nonostante il movimento di Berlusconi avesse ottenuto percentualmente il maggior numero di voti in tutta Italia (21%) e superato la Lega persino in Lombardia.
Il Pds si assestò come secondo partito (20,3%) seguito da Alleanza nazionale (13,5%) e dal Ppi (11,1%).
Pag. 452
Sommario
Nel linguaggio corrente è ormai consuetudine indicare con l’espressione “seconda repubblica” il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli anni 1992-94.
I primi anni ’90 vedevano aggravarsi i fattori di crisi, sia sul terreno dell’economia (aumento del deficit pubblico, rallentamento della produzione, svalutazione della lira), sia su quello della convivenza civile (ripresa dell’offensiva mafiosa, dilagare della corruzione).
Sul piano politico, le maggiori novità furono la trasformazione del Pci in Partito democratico della sinistra e l’emergere di nuovi movimenti ostili al sistema dei partiti (verdi, Lega, Rete).
Dopo le elezioni del 5 aprile 1992, che segnavano la sconfitta delle forze tradizionali e mettevano in crisi i vecchi equilibri, il governo presieduto da Giuliano Amato ottenne alcuni successi nell’affrontare l’emergenza economica e quella dell’ordine pubblico.
Ma il ceto politico, delegittimato dalle inchieste della magistratura, non riusciva a trovare un accorso sulle riforme istituzionali.
Il referendum dell’aprile 1993 imponeva il passaggio al sistema maggioritario uninominale, passaggio confermato dalle nuove leggi elettorali.
Dopo le dimissioni di Amato (aprile) il governo Ciampi affrontava la crisi economica e occupazionale del paese, mentre le forze politiche si preparavano a un nuovo confronto elettorale.
Le elezioni del marzo 094, tenutesi col nuovo sistema maggioritario uninominale (che poneva le premesse per instaurare un meccanismo di alternanza tra maggioranza e opposizione), portarono al governo una precaria maggioranza di centro-destra guidata dall’imprenditore Silvio Berlusconi.
Costretto dopo solo sette mesi a dimettersi per i contrasti sopraggiunti all’interno della maggioranza, gli succedeva un ministero di tecnici presieduto da Lamberto Dini e sostenuto da uno schieramento di forze di centro-sinistra.
Nuove elezioni anticipate (aprile ’96) vinte dalla coalizione di centro-sinistra, inauguravano una nuova fase di governo diretta dal leader dell’Ulivo Romano Prodi.
Il governo di centro-sinistra affrontò il problema del deficit di bilancio riuscendo a ridurlo nel corso del 1997 e quindi a rientrare nei parametri indicati nel trattato di Maastricht per l’ingresso nell’Unione monetaria.
Fra i problemi politici del paese rimanevano aperti quello dei correttivi al Welfare e quello relativo alle riforme istituzionali, in presenza di una perdurante instabilità politica.
Nel 1998 il governo Prodi cadde e fu sostituito da un nuovo centro-sinistra guidato da D’Alema.
Nel 1999 l’Italia partecipò con gli altri paesi della Nato all’intervento militare in Kosovo.
Nel 2000, dopo la sconfitta elettorale nelle regionali, a D’Alema succedette un altro governo di centro-sinistra presieduto da Amato.
Alla fine della legislatura la maggioranza approvò un’importante legge costituzionale che ampliava i poteri degli enti locali.
Le trasformazioni sociali dell’Italia si misuravano ormai con i comportamenti demografici che registravano una spiccata denatalità e un invecchiamento della popolazione.
L’omologazione dei consumi non riusciva a nascondere differenze sociali basate soprattutto sulla disuguaglianza dei redditi e dei livelli culturali.
Le elezioni politiche del maggio 2001 diedero una netta vittoria alla Casa delle libertà, al coalizione guidata da Berlusconi, che nel giugno successivo formò il nuovo governo di centro-destra.
La grande riforma istituzionale voluta dalla maggioranza e approvata nel 2005, fu respinta dal successivo referendum di conferma.
Le elezioni dell’aprile 2006, tenute con una nuova legge elettorale, segnarono la sconfitta, con stretto margine, del centro-destra.
Dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, il diessino Giorgio Napolitano, Romano Prodi formò, in maggio, il nuovo governo di centro-sinistra.
Ma, due anni dopo, le divisioni interne alla maggioranza provocarono una nuova crisi di governo.
Alle elezioni anticipate dell’aprile 2008 si presentarono schieramenti largamente rinnovati: il Popolo della libertà, la nuova formazione politica creata da Berlusconi, prevalse nettamente sul Partito democratico, guidato da Walter Veltroni.
E Berlusconi riassunse la guida del governo
Bibliografia
La grande slavina / L. Cafagna. – Marsilio, 1993
Terra incognita: le radici geopolitiche della crisi italiana / L. Caracciolo. – Laterza, 2001
Dal Pci al Pds / P. Ignazi. – Il Mulino, 1992
La Lega / I. Diamanti. – Donzelli, 1993
La popolazione italiana: dall’espansione al contenimento / E. Sonnino. – In: Storia dell’Italia repubblicana, Vol. 2, t. 1. – Einaudi, 1995
I mutamenti della stratificazione sociale / M. Paci. - In: Storia dell’Italia repubblicana, Vol. 3, t. 1. – Einaudi, 1996
L’Italia del tempo presente: famiglia, società civile, Stato / P. Ginsborg. – Einaudi, 1998
Italiani/e: dal miracolo economico a oggi / V. Vidotto. – Laterza, 2005
Sottocategorie
Pagina 1 di 2