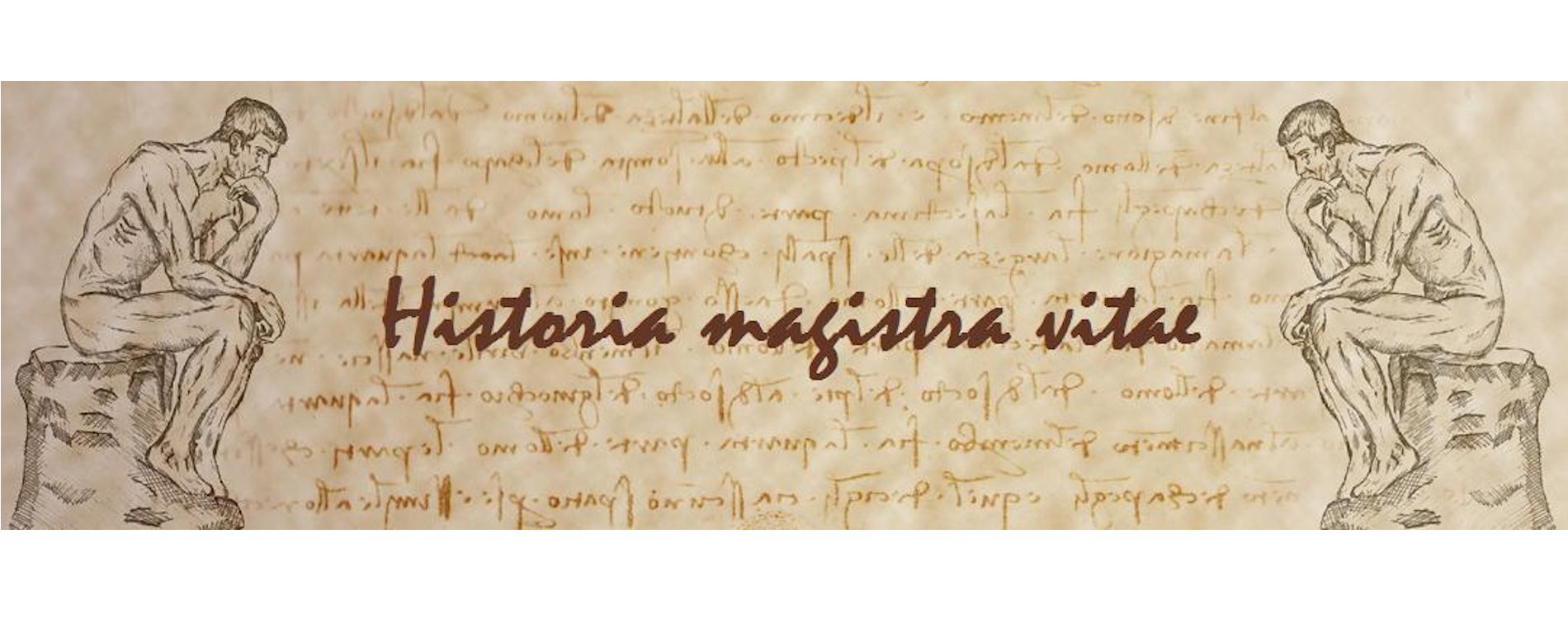Cap. 1. Mussolini di fronte alla realtà del regime fascista e alle sue prospettive alla svolta del decennale
Verso la metà del 1929 il regime fascista era ormai per l’Italia una realtà con caratteri e contorni precisi e, per più di un aspetto, definitivi. La Conciliazione e il “plebiscito” avevano infatti concluso a tutti gli effetti la prima fase del fascismo al governo e avevano sancito, appunto, il completamento del processo di strutturazione del regime vero e proprio. In poco meno di sette anni di governo fascista l’assetto politico del paese era profondamente mutato e, comunque si giudicasse questo mutamento, nulla seriamente autorizzava a pensare che il regime potesse scadere a breve scadenza. Nonostante le latenti contraddizioni che caratterizzavano l’equilibrio tra le sue componenti, esso infatti godeva di una indiscutibile solidità, basata in primo luogo su un consenso di massa vasto e che non si sarebbe a lungo incrinato e sul quale, per ogni evenienza, vigilavano costantemente sia il PNF sia la polizia. Un consenso, oltre tutto che – per quanto paradossale possa sembrare – diventava sempre più effettivo e vasto via via che, invece di politicizzarsi, si depoliticizzava e affondava le sue radici sempre meno nell’adesione al PNF (che ogni giorno perdeva prestigio e suscitava maggiori insofferenze) e sempre più nel mito di Mussolini e dell’Italia finalmente “in cammino”. Né la situazione internazionale e, a quest’epoca, la politica estera fascista poteva far pensare alla possibilità che il regime cadesse per cause esterne. Al contrario, proprio in questo periodo l’Italia fascista cominciava a vedere aumentare all’estero le simpatie verso di sé e ad essere considerata un elemento non trascurabile del giuoco internazionale
P. 3
Riassumendo al massimo, si può dire che la cultura di Mussolini poggiava su tre elementi costitutivi principali, un positivismo elementare, un volontarismo neoidealista con forti coloriture pragmatiche e un relativismo assoluto, sui quali – a loro volta – si innestavano abbastanza coerentemente varie suggestioni particolari tratte dalla lettura di autori come Nietzsche (per quel che riguardava la funzione della personalità e la sua potenza creativa e il concetto di civiltà), Sorel, Pareto, Renan (il Renan dei Dialogues et fragments philosophiques, che ha rinunciato alle giovanili idee demcratiche e responge la caratterizzazione indusriale ed egalitaria che ha assunto la società moderna).
P. 32
- Mazzetti ha scritto che “il conformismo antifascista ha la setssa natura, la stessa carica di impersonalità, di inautenticità, di equivoco morale e intellettuale, di sostanziale menzogna di se a se stesso, di sostanziale ipocrisia che ebbe il conformismo fascista”.
Quale umanesimo? Ipotesi su Croce, Gentile, Ugo Spirito / R. Mazzetti. – Roma, 1966
P. 35
In un certo senso si potrebbe addirittura sostenere che proprio solo grazie al concetto spengleriano di “cesarismo” i vari elementi psicologici e culturali contribuivano a determinare l’”idea morale” che in questi anni animò la politica di Mussolini trovarono il loro cemento; così come è assai probabile (ed è significativo che ciò sia confermato da un riscontro sul periodo in cui una certa tematica divenne in Mussolini più presente ed addirittura insistente) che il concetto spengleriano di “cesarismo” abbia in qualche misura contribuito anche ad accentuare sino all’esasperazione in Mussolini l’esaltazione della romanità e della funzione di Roma come affermatrice nel mondo di una nuova civiltà (che, non a caso, non era mai quella repubblicana, ma quella dell’età cesariana e augustea). E volendo, si potrebbe forse giungere sino al punto di chiedersi – almeno in via di ipotesi – se il profilo di Giulio Cesare tratteggiato da Spengler non abbia avuto qualche influenza sul comportamento di Mussolini, sul suo modo di trattare gli affari di politica internazionale.
P. 44
Citazione da Mussolini a Ludwig:
“La massa ama gli uomini forti. La massa per me non è altro che un gregge di pecore, finché non è organizzata. Non sono affatto contro di essa. Soltanto nego che essa possa governarsi da sé. Ma se la si conduce, bisogna reggerla con due ordini: entusiasmo e interesse. Chi si serve solo di uno dei due, corre pericolo. Il lato mistico e politico si condizionano l’un altro. L’uno senza l’altro è arido, questo senza quello si disperde nel vento delle bandiere. Non posso pretendere dalla massa la vita incomoda: essa è solo per pochi. Musiche e donne sono il lievito della folla e la rendono più leggera. Il saluto romano, tutti i canti e le formule, le date e le commemorazioni sono indispensabili per conservare il pathos ad un movimento. Così è già stato nell’antica Roma.. Solo la fede smuove le montagne, non la ragione. Questa è uno strumento ma non può essere mai la forza motrice della massa. Oggi meno di prima. La gente ha oggi meno tempo di pensare. La disposizione dell’uomo moderno a credere è incredibile… Tutto dipende da ciò, dominare come un artista.
P. 50
Quanto siamo venuti dicendo, ci pare dimostri come sarebbe sbagliato ritenere che alla fine degli anni trenta Mussolini mancasse ormai di una prospettiva politica di fondo e fosse sostanzialmente in grado solo di arroccarsi su una politica di ordinaria amministrazione che non teneva conto delle aspirazioni, dei ripensamenti, degli stati d’animo che, invece, caratterizzavano l’atteggiamento della classe dirigente e del partito fascista. E ancora più sbagliato sarebbe dedurre da questo errato convincimento la spiegazione del fatto che in questo periodo Mussolini cominciò ad impegnare sempre di più l’Italia nel campo della politica internazionale, stabilendo così un esplicito rapporto tra la presunta stasi dell’iniziativa del duce in politica interna e il suo nuovo interesse per quella estera; quasi, insomma, che questo fosse dettato essenzialmente dalla necessità di creare una serie di diversivi che distogliessero gli italiani dai problemi interni e, al tempo stesso, dessero nuovo lustro all’ormai appannatasi figura del duce. Poiché della politica estera mussoliniana tratteremo ampiamente nei prossimi capitoli, è inutile anticipare qui le ragioni del nostro rifiuto ad accettare la seconda di queste due presunte spiegazioni. Quanto alla prima – dopo quello che siamo venuti dicendo e poiché alle vicende interne degli anni ’29-34 è dedicato tutto il prossimo capitolo – ora ci interessa mettere in rilievo solo i caratteri d’insieme, generali, che in questo periodo Mussolini avrebbe voluto imprimere e in parte impresse alla sua politica interna; caratteri che se appaiono a prima vista poco chiari ed evidenti ciò è dovuto a due ragioni ben precise: a) alle difficoltà di fondo che l’iniziativa politica mussoliniana incontrava nel dispiegarsi sul terreno politico-sociale per il perdurare, nonostante il progressivo rafforzarsi del regime, della precarietà dell’equilibrio politico-sociale realizzatosi tra fascismo e la preesistente classe dirigente italiana con il compromesso che aveva contribuito a rendere possibile il consolidamento al potere di Mussolini dopo la crisi Matteotti; b)All’aggiungersi a queste difficoltà di fondo di quelle, assai gravi, provocare all’economia italiana e, per riflesso, in una certa misura anche al regime, dalla “grande crisi” americana del ’29 e dal suo estendersi anche all’Italia, come del resto a tutta l’Europa e a gran parte dei paesi extraeuropei.
Contrariamente alle prime apparenze, in realtà Mussolini – conclusa con la Conciliazione e il plebiscito una ben precisa fase dei suo governo – aveva per gli anni immediatamente futuri una sua politica, a suo modo anche ben definita. Solo che essa non va ricercata sul terreno immediatamente o anche mediatamente (quello del corporativismo per esempio) politico. Su questo terreno, infatti, Mussolini si poneva solo obiettivi che erano sostanzialmente quelli di mantenere e perfezionare lo status quo; anche se ciò non significava una rinuncia a priori a sfruttare eventuali possibilità offertegli dalla situazione, e, ancor più, a erodere, se se ne fosse presentata l’occasione, i margini di autonomia e di potere che le altre componenti del regime si erano assicurate. Il terreno di attuazione dell’iniziativa politica mussoliniana in questa nuova fase era un altro, direttamente o indirettamente connesso alla nuova dimensione, ai nuovi tempi, alla nuova prospettiva nei quali Mussolini andava ormai collocando se stesso e il fascismo: era quello della politica agraria, della politica demografica, di quella dei lavori pubblici e soprattutto dell’educazione nazionale della gioventù e della cultura popolare di massa per gli italiani in genere. Rispetto a questi, tutti gli altro problemi, per importanti che fossero, in questo momento per Mussolini passavano sostanzialmente in secondo piano.
Il 16 settembre 1929 Mussolini trasferì la sua sede ufficiale di capo del governo da palazzo Chigi (che rimase sede del ministero degli Affari esteri, così come il Viminale era rimasto sede del ministero dell’Interno quando egli si era trasferito a Palazzo Chigi) a palazzo Venezia. Talvolta degli atti in se semplici, addirittura banali, assumono – come si sa – un valore particolare, simbolico. Non vi è dubbio che trasferendosi a palazzo Venezia Mussolini volle compiere un gesto che marcasse l’inizio di un nuovo periodo del suo governo: Mussolini si sentiva ormai sotto tutti i profili il duce, l’individuo cesareo che determinava la storia della nuova Italia; anche la sua sede ufficiale doveva essere storica – per il passato e per il presente – isolata e al tempo stesso a contatto diretto con le vestigia di quella Roma dei Cesari che Mussolini voleva emulare. E, a ben vedere, in questo periodo Mussolini non solo mutò la propria sede ufficiale, ma cercò, se non proprio di mutare, certo di modificare la sua stessa figura. Sino allora gli italiani lo avevano conosciuto soprattutto come l combattente, come il capo del fascismo, come il politico sicuro e lungimirante. D’ora in poi a questa immagine se ne venne progressivamente sovrapponendo un’altra, quella del costruttore di una nuova civiltà, di Mussolini, per dirla con un famoso titolo di uno dei più tipici libri dell’apologetica mussoliniana della seconda metà degli anni trenta, motore del secolo.
P. 51-53
Cap. 2. Gli anni del consenso: il paese.
Citazione da G. Germani:
“Il primo stadio corrisponde al periodo di lotta per instaurare il regime. In questo periodo il grado di impegno politico della gioventù è naturalmente più alto del normale (in riferimento al livello prevalente in ogni cultura politica nazionale), e la popolazione (compreso ai giovani) sarà fortemente orientata in favore o contro il nascente movimento fascista. Nel secondo stadio, una volta che il regime si è consolidato e stanno venendo fuori le prime generazioni politicamente socializzate sotto il nuovo ordine, la propensione all’impegno politico tenderà ad essere molto minore, di fatto la depoliticizzazione può prevalere. A questo livello di potere il regime si guarderà dal creare una leale e dinamica élite. Invece recluterà sempre più burocrati e giovani, motivati solo da ambizioni personali. Nel terzo stadio, mentre vengono fatti sforzi per ricreare lo “spirito” originario del movimento in modo da dare nuove motivazioni al leale e attivo sostegno dei giovani, il giovane politicamente impegnato tenderà verso qualche forma di “deviazionismo”. Infine, nel quarto stadio, la gente si rende conto una volta di più che il regime non può essere cambiato dal “didentro”, la minoranza dei giovani con alta propensione per la politica si svolgerà sempre più verso un totale rifiuto e un’attiva opposizione al sistema”.
“Per assicurare la continuità del regime, il partito favoriva una partecipazione creativa dei giovani e promuoveva l’emergere di una autentica élite politica (cioè, non soltanto una burocrazia di arrivisti); i meccanismi fondamentali usati per questo scopo comprendevano due elementi principali. Da una parte la speranza di una “evoluzione” sociale del regime in termini di giustizia sociale e di cambiamenti drastici nella sfera economica, dall’altra la promessa fatta alle nuove generazioni di esercitare un ruolo innovatore attraverso la critica, la “circolazione delle idee” e un effettivo cambiamento delle istituzioni e degli uomini. Ma queste componenti – il cambiamento sociale e la liberalizzazione – erano in profondo contrasto con gli scopi fondamentali del regime. Il persistere della sua iniziale “ragion d’essere”, la difesa e la conservazione dei principali interessi acquisiti nel sistema sociale esistente e la smobilitazione delle classi inferiori bloccavano il cambiamento sociale. Una volta eliminata questa possibilità, ogni “liberalizzazione” sarebbe apparsa la fonte di deviazioni pericolose e un ostacolo immediato alla stabilità del regime. La politica del partito nei riguardi dei giovani non riuscì perciò mai durante la sua storia a sfuggire a questa intima contraddizione. Più questi meccanismi dinamici avevano successo e più il partito era costretto a limitarli o a eliminarli. Le nuove generazioni scoprirono successivamente che il futuro promesso in realtà non esisteva e si preoccuparono di questi limiti inerenti; allora il loro “lungo viaggio attraverso il fascismo” giunse al termine: il conformismo passivo o l’aperta ribellione erano i risultati di questo processo, e la via scelta dipese dall’azione reciproca delle circostanze personali e delle esteriori condizioni storiche”.
La socializzazione politica dei giovani nei regimi fascisti: Italia e Spagna / G. Germani. – In: Quaderni di sociologia, genn.-giu. 1969
P. 102-104
Citazione da A. Carocci:
“Non vorrei essere frainteso. Non intendo dire che Solaria”, rivista di letteratura, svolse un’attività di opposizione politica al regime, e neppure un’attività di opposizione sul piano ideologico. Sarebbe attribuirle dei meriti che essa non ha avuto. Essa, molto più più modestamente, e con l’accettare l’isolamento in cui la letteratura ufficiale la relegava (i lettori di Solaria furono sempre quattro gatti; la sua tiratura non raggiungeva le 70 copie; né ricordo che essa ricevesse mai l’onore di essere citata dai giornali del tempo) svolse tutt’al più una funzione di obiettore di coscienza. La letteratura ufficiale celebrava il genio italico, il primato d’Italia, la gloria della stirpe; e tutte le pagine di Solaria manifestavano la persuasione che la letteratura italiana contemporanea non era che una provincia della più vasta letteratura europea, e neanche la provincia più splendida. La letteratura ufficiale affermava che in seno all’Italia esistevano tutte le premesse e tutti i risultati ai quali una cultura moderna poteva ambire; e Solaria riconosceva umilmente che le espressioni più originali della letteratura moderna erano fiorite altrove, si chiamassero esse Proust o Joyce o Kafka, e affermava si che anche gli scrittoti italiani erano voci degne di considerazione, ma che erano parte e Soltanto parte di un più vasto colloquio europeo.”
P. 111
Se non si ha ben presente – oltre al quadro politico generale del paese e internazionale – questa situazione particolare della cultura, è difficile ricostruire e comprendere l’atteggiamento degli intellettuali italiani negli anni tra il ’29 e il ’34 e si finisce, assai spesso, per esprimere giudizi ingiusti e storicamente non validi. In particolare, non si capisce perché in quegli anni l’opposizione al regime fosse anche tra gli intellettuali relativamente limitata e circoscritta, mentre più diffusa era – specie negli ambienti dell’alta cultura – un atteggiamento che potremmo definire, per un verso, di non opposizione e, per un altro verso, largamente caratterizzato da due convinzioni o speranze a seconda dei casi: che fosse possibile preservare la cultura da una eccessiva politicizzazione in senso fascista e trasmettere ai giovani il rispetto per alcuni suoi valori fondamentali e che non fosse opportuno lasciare il campo culturale (e, per riflesso, almeno per alcuni, quello politico) nelle mani del fascismo più intransigente e rozzo, ma, al contrario, fosse opportuno appoggiare quella parte del fascismo in cui certi valori culturali non erano stati sopraffatti dall’impegno politico. In questo atteggiamento, minoritario ma piuttosto diffuso, della cultura del tempo oggi noi possiamo certamente cogliere tutta una serie di spunti per un discorso più ampio sui caratteri e i limiti del ceto intellettuale di allora; la sua individuazione è però in questa sede indispensabile soprattutto ai fini di un altro discorso, assai più importante per comprendere la realtà del tempo: quello sull’atteggiamento e al funzione che ebbero, in questo periodo ma anche negli anni successivi, lungo tutto l’arco del regime, Benedetto Croce e il gruppo della Critica, sia in quanto gruppo di opposizione politico-culturale al fascismo con una propria fisionomia e una propria attività, sia in quanto punto di riferimento, consapevolmente o no, per quegli intellettuali non fascisti ma neppure antifascisti di cui abbiamo parlato, al cui posizione e soprattutto la successiva evoluzione nella seconda metà degli anni trenta fu in larga misura influenzata e talvolta determinata proprio dall’esistenza di questo punto di riferimento, quasi come una sorta di coscienza morale e culturale.
P. 111-12
Citazione da G. Salvemini:
“Gli italiani – scrisse Salvemini nel febbraio 1946 in occasione di una vivacissima polemica con Croce – non dovrebbero mai dimenticare la gratitudine che debbono a Croce per la sua resistenza al fascismo dal 1925 al 1943. Ogni altra voce in Italia era soffocata nelle carceri, sequestrata a domicilio coatto, costretta a stare in esilio. Lo stesso suo silenzio era una protesta. Resistenza e silenzio venivano dalla stratosfera, senza dubbio. Ma il loro effetto era potente. Molti giovani furono confortati dal suo insegnamento e dal suo esempio a credere nella libertà, per quanto ognuno intendesse la libertà in modo proprio e in forme che Croce non approvava. Ma quel che importava era che quella libertà non era il fascismo. Quel che importava era che Mussolini trovasse il maggior numero possibile di resistenze invincibili, anche se passive. Molte di queste resistenze furono dovute all’atteggiamento e all’esempio di Croce. Questo merito gli spetta, e nessuno dovrebbe dimenticarlo neanche oggi quando è necessario dissentire da lui”
Che cos’è un “liberale” italiano nel 1946 / G. Salvemini. – In: Benedetto Croce, Boston, 1946
P. 112
Citazione da G. Lombardo Radice:
“La verità è che nei tempi di calma i pratici curano la pratica e gli studiosi gli studi. Nei tempi di crisi i pratici si smarriscono o sono eliminati; e gli uomini di studi assumono la parte di critici ed educatori per l’avvenire”.
P. 113
Citazione da B. Croce:
“…l’odierno antistoricismo è tutto sfrenatezza di egoismo o durezza di comando, e par che celebri un’orgia o un culto satanico… L’antistoricismo odierno, dunque, par che sia non già un rovescio e un simbolo negativo di nuova sanità, ma impoverimento mentale, debolezza morale, eretismo, disperazione, nevrosi e, insomma, un’infermità, da superare con la pazienza e con la costanza, come tutte le infermità. Di questo suo carattere d’infermità può recare conferma l’altro fatto che, insieme con l’antistoricismo, accade di osservare e che, intrinsecamente, forma tutt’uno con esso; la decadenza dell’ideale liberale, la quale in alcuni paesi ha avuto anche per effetto la formazione di regimi antiliberali, ma che si nota un po’ dappertutto nelle parole e negli atti, nei libri e nei metodi politici, e più ancora negli irrequieti desideri. Sentimento storico e sentimento liberale sono, in verità, inscindibili, tanto che della storia non si è potuto dare altra migliore definizione che di “storia della libertà”, perché solo da questa essa ottiene un senso e solo per essa si fa intelligibile. Senza dubbio, nella storia si vedono altresì regimi autocratici e regimi autoritari, regimi di violenza e reazioni e controriforme e dittature e tirannie; ma quel che solo e sempre risorge e si svolge e cresce è la libertà, la quale, ora in quelle varie forme si foggia i suoi mezzi, ora le piega a suoi strumenti, ora delle apparenti sue sconfitte si vale a stimoli della sua stessa vita… Per noi, filosofi e storici, lo storicismo – che vuol dire civiltà e cultura – è il valore che ci è stato confidato e che abbiamo il dovere di difendere, tenere forte e ampliare: lo storicismo, nodo del passato con l’avvenire, garanzia di serietà del nuovo che sorge, blasfemato come libertà, ma che, come libertà, ha sempre ragione di chi gli si rivolge contro”
P. 113-14
Citazione da A. Gramsci, Lettere dal carcere:
“Mentre tanta gente perde la testa e brancola tra sentimenti apocalittici di panico intellettuale, Croce diventa un punto di riferimento per attingere forza interiore per la sua incrollabile certezza che il male metafisicamente non può prevalere e che la storia è razionalità. Bisogna tener contro inoltre che a molti il pensiero di Croce non si presenta come un sistema filosofico massiccio e di difficile assimilazione come tale. Mi pare che la più grande qualità di Croce sia sempre stata questa: di far circolare non pedantescamente la sua concezione del mondo in tutta una serie di brevi scritti nei quali la filosofia si presenta immediatamente e viene assorbita come buon senso e senso comune. Così le soluzioni di tante quistioni finiscono col circolare divenute anonime, penetrano nei giornali, nella vita di ogni giorno e si ha una grande quantità di “crociani” che non sanno di esserlo e che magari non sanno neppure che Croce esista”.
P. 116
Il panorama della situazione italiana negli anni tra la fine del ’29 e quella del ’34 può dirsi a questo punto pressoché completo, almeno nei suoi aspetti più significativi e, in particolare, per quel tanto che può servire, a dare una idea d’insieme dell’atteggiamento delle varie componenti della società italiana rispetto al regime. Nel prossimo capitolo esamineremo quale fu, nello stesso periodo, la politica fascista e potremo così valutare l’influenza che essa ebbe nel determinare meglio questo atteggiamento. Anticipando un solo problema a mo’ di esempio, è infatti fuori di dubbio che, accanto a quanto si è già detto, una influenza tutt’altro che scarsa nel determinare quel clima di consenso che si stabilì in questi anni attorno al regime non poco contribuì il grande impegno, propagandistico ma anche effettivo, che questo mise nella politica d’intervento e di presenza nella vita economica e sociale del paese e soprattutto dei lavori pubblici e di bonifica: la bonifica dell’Agro pontino, la creazione di Littoria e di Sabaudia furono per Mussolini e il regime successi di cui non si deve assolutamente sottovalutare l’importanza. Così come non si può sottovalutare l’influenza che sul prestigio interno del regime ebbe, sempre in questo periodo, la politica estera mussoliniana, della quale parleremo nel quarto capitolo. Pur con tutte le sue contraddizioni e un certo suo innato avventurismo (che, per altro, solo raramente trasparivano e potevano essere colti dalla gran maggioranza degli italiani), in questi anni essa fu sostanzialmente una politica di prestigio, ma di pace: la più adatta, cioè, a trovare consenso popolare. Né va sottovalutato il fatto che, se l’avvento al potere di Hitler in Germania alla fine del gennaio ’33 suscitò in un primo momento timori e perplessità tra gli italiani anche per quel che riguardava i futuri rapporti tra i due regimi, la cautela con cui Mussolini si mosse nelle sue relazioni con la Germania nel ’33 e nella prima metà del ’34 e la fermezza, poi, con la quale fronteggiò nell’estate del ’34 le mire nazionalsocialiste sull’Austria trovarono il consenso unanime – ben lo si può dire, degli italiani. E non solo dei fascisti, dei fiancheggiatori, della massa socializzata e inquadrata dal regime, ma anche di buona parte di coloro che in varie forme erano all’opposizione.
P. 123-24
Cap. 3. Gli anni del consenso: il regime
Sotto il profilo costituzionale l’Italia fu governata dal ’22 al ’43 da un unico “ministero Mussolini” che subì però durante un ventennio tanti rimpasti (o, come si preferì allora definirli, tante “rotazioni ministeriali”) che, di fatto, si può parlare di vari ministeri presieduti ininterrottamente da Mussolini. Se si accetta tale criterio di distinzione interna, si può affermare che tra tutti questi ministeri quello nato dal rimpasto del 12 settembre 1929 fu assai probabilmente non solo il più ricco di titolari effettivi dei vari dicasteri, ma anche quello più significativo e autorevole per il prestigio politico e le competenze tecniche dei suoi componenti.
P. 127
In questa prospettiva, il significato che il rimpasto governativo (a cui, non lo si dimentichi, avrebbe fatto da pendant nelle settimane immediatamente successive il riassetto del PNF, realizzato – come si è visto – con il nuovo statuto del partito e la modifica della legge sul Gran Consiglio) aveva per Mussolini può, grosso modo, essere così riassunto: a) sottolineare il carattere fascista del governo anche attraverso la sua composizione e in particolare la presenza di ben tre quadrunviri; b) dare sempre più ala figura del duce il carattere di quella del capo, liberandola di quasi tutte le responsabilità particolari che era venuta via via assumendo (il fatto che Mussolini mantenesse il ministero dell’Interno può essere visto come una manifestazione della sua volontà di controllare direttamente quello che in tutti i regimi autoritari è il dicastero chiave, ma anche come la conseguenza di una preoccupazione più politica: far si che in caso di contrasti tra partito e Stato, come ai tempi di Farinacci e Federzoni, questo fosse rappresentato dal primo dei fascisti e non si ponesse, quindi, neppure la questione di chi dovesse avere l’ultima parola), in modo da far si che, anche formalmente, Mussolini non rassomigliasse più in nulla al vecchio presidente del consiglio dell’età liberale, che era solo un primus inter pares; c) decentrare e responsabilizzare più direttamente, in base alle loro funzioni e competenze ministeriali, quelli che sino allora erano stati i principali collaboratori in sottordine di Mussolini nei dicasteri da lui nominalmente retti; d) assicurare anche formalmente la continuità della direzione di quei dicasteri (Giustizia e Finanze, ché la permanenza di Ciano alle Comunicazioni aveva probabilmente un altro significato, quello di mantenere nel governo il successore in pectore del duce) che non avevano ancora esaurita la realizzazione del programma politico loro assegnato nella precedente fase del regime; e) sottolineare (sia mutando sin il nome di alcuni ministeri e assegnando loro nuovi titolari, sia creando nuovi sottosegretari ad hoc, come quello per la Bonifica integrale e quello per l’Educazione fisica e giovanile) l’importanza e i nuovi compiti attribuiti d’ora in poi alla politica agricola e a quella verso le giovani generazioni; f) riconfermare il principio dell’autogoverno tecnico della forze armate e della separazione istituzionale da esse della MVSN; g) dimostrare che il fascismo faceva effettivamente “largo ai giovani” anche nelle più importanti cariche dello Stato (Balbo aveva 33 anni, Bottai 34).
P. 132-34
Da qui, sempre secondo Mussolini, la necessità di una trasformazione delle caratteristiche di base e della dinamica di sviluppo della società italiana, da realizzare (oltre , ovviamente, che sul piano della “formazione” negli italiani e soprattutto nelle nuove generazioni di una “vera” “coscienza fascista” e di una “sana” “consapevolezza rurale) attraverso: a) il potenziamento e lo sviluppo massiccio dell’agricoltura sotto tutti i profili, della superficie coltivata, degli addetti, della meccanizzazione, degli investimenti, della produzione, anche se questa ultima avesse dovuto perdere di valore (“io sono per l’abbondanza dei prodotti anche se costeranno – come è fatale – di meno. L’abbondanza è sempre una fortuna se è vero, e sin qui fu sempre vero, che la carestia è sinonimo di fame e miseria); b) il ridimensionamento dell’industria, fondato, da un lato, su un sano sviluppo di quella piccola e media (specialmente di quella collegata all’agricoltura: “una agricoltura ricca costituisce nella nazione un incentivo allo sviluppo dell’industria, essendo questa, in molte sue branche [meccanica, chimica, tessile ecc.] legata a quella; c) la creazione di una economia mista, nella quale una vasta agricoltura incentivasse e al tempo stesso regolasse lo sviluppo industriale e l’industria curasse più il mercato interno che quello estero.
P. 147-48
Insomma, ruralizzando, Mussolini tendeva a risolvere assieme tutti i problemi della “vecchia” Italia e tutte le aspirazioni della “nuova” Italia; ruralizzare – per quanto la cosa possa apparire a noi assurda, anacronistica e antistorica, un confuso miscuglio, tipicamente piccolo borghese, di motivi e di suggestioni diversissime – voleva dire per lui trasformare alla radice le caratteristiche stesse più intime della società italiana, quelle economiche come quelle morali, e, al tempo stesso, gettare le premesse (“il numero è potenza”) di un nuovo ruolo e di una nuova potenza dell’Italia nel mondo.
P. 149-50
Il primo settore era quello più direttamente e immediatamente agricolo: l’agricoltura doveva beneficiare del massimo delle agevolazioni e di interventi da parte dello Stato, in modo da estendere al massimo la produzione, modernizzarsi e diventare economicamente più redditizia. Il secondo settore era quello della bonifica integrale e, a integrazione di essa, dell’edilizia rurale e dei lavori pubblici: si trattava, attraverso questo complesso di opere, di dilatare la superficie coltivabile, di permettere nuove colture, di migliorare le condizioni di vita dei ceti agricoli e, quindi, di rendere possibili sempre nuovi stanziamenti, sia nelle zone bonificate sia, in genere, in quelle agricole. Il terzo settore era quello delle migrazioni: in attesa del rilancio dell’agricoltura e di poter colonizzare le zone bonificate, bisognava impedire che la popolazione rurale continuasse ad essere attratta dalle grandi città, dalle industrie e, addirittura, bisognava sollecitare un processo di disurbanizzazione e di ritorno alla terra. Il quarto settore, infine, era quello demografico: bisognava porre fine alla diminuzione della natalità (più sensibile a mano a mano che si passava dalle zone agricole ai grandi centri urbani( e, anche qui, bisognava invertire la tendenza, in maniera di accrescere la popolazione, soprattutto quella agricola e dei centri medi e piccoli. In realtà un po’ per il sopraggiungere della “grande crisi”, un po’ per la sproporzione (anche se questa non fosse sopravvenuta) tra gli obiettivi che si volevano raggiungere e i mezzi di cui si poteva effettivamente disporre e, soprattutto, per l’anacronismo e l’intima assurdità (sia sotto il profilo economico sia, ancor più, sotto quello umano) dell’obiettivo finale che si voleva realizzare, in nessuno di questi quattro settori il regime riuscì a conseguire un successo e, tanto meno, Mussolini poté veder realizzate anche solo le premesse della tanto bramata realizzazione dell’Italia.
P. 151-52
Questo – nelle grandi linee – il bilancio della politica di ruralizzazione. Un bilancio che la propaganda del regime riuscì parzialmente a far apparire in attivo (soprattutto valorizzando al massimo l’aspetto delle bonifiche e in particolare di quella pontina) e che sotto il profilo sociale ed economico presenta certo alcuni aspetti parzialmente positivi, ma che sotto il profilo degli obiettivi di fondo che Mussolini si era proposto di realizzare deve essere considerato assolutamente negativo: è infatti indiscutibile che non solo la politica di ruralizzazione non riuscì a trasformare le caratteristiche di base e la dinamica di sviluppo della società italiana nel senso voluto da Mussolini, ma, al contrario, avvenne “questo fatto singolare: che l’Italia divenne paese industriale proprio durante gli anni della ruralizzazione fascista”.
P. 156
Questi successi della politica confindustriale non vanno – lo ripetiamo – sottovalutati. E’ però un fatto – e l’Abrate, sempre acuto e realista, lo ha messo bene in luce – che proprio in questi anni se i gruppi industriali più potenti poterono rafforzare la propria posizione economica e fronteggiare con successo i pericoli che temevano potessero venir loro dal corporativismo, non riuscirono però ad impedire un sempre crescente intervento diretto (non corporativo cioè) dello Stato nel campo dell’economia e, a ben vedere, finirono per pagare ciò che ottenevano (spesso solo settorialmente o addirittura individualmente) sul terreno economico con una notevole perdita di autonomia e di coesione, cioè di potere sul terreno politico.
P. 158
In questo contesto tutt’altro che rari erano le critiche e gli attacchi più o meno espliciti contro la grettezza conservatrice delle grandi forze economiche, il loro parassitismo e “antifascismo” e – sul versante opposto – contro l’assenza di una coerente e consapevole prospettiva di politica economica al vertice del fascismo. Tra i leader fascisti chi si fece portavoce a livello politico di queste idee e di questi fermenti – almeno sino al ’32, quando le polemiche suscitate dal convegno di Ferrara prima e il suo allontanamento dal governo poi lo indussero ad un atteggiamento più cauto – fu Bottai, attorno al quale del resto si era raccolta – come si è detto – buona parte di quei fascisti che auspicavano un nuovo corso politico e soprattutto sociale del regime e che la “grande crisi” aveva contribuito potentemente ad orientare in senso più o meno esplicitamente anticapitalista.
P. 159
Citazione da Bottai:
“Il Consiglio nazionale delle corporazioni – disse al Senato il 27 maggio ’30, in occasione della discussione del bilancio del Ministero delle corporazioni – ha, secondo la legge 20 marzo 1930, la sua cabina di comando nell’istituto del Capo del Governo; ma ha il suo apparecchio motore, ha tutte le leve del suo funzionamento, nel Ministero delle corporazioni, dimodoché questo si collega, attraverso la presidenza del Capo del Governo, ad una posizione di centralità nell’amministrazione generale dello Stato. L’economia nazionale, quindi, trova il suo centro nel Ministero e assume, attraverso di esso, un’impostazione di carattere politico. Onde il Ministero è un Ministero economico, non nel senso tecnico ma nel senso politico della parola. E’ – come già si disse testé alla Camera – il Ministero della politica economica del regime. L’economia trova riflessi importantissimi e svariati in tutti gli altri ministeri e in alcuni singolarmente, che rispecchiano problemi particolarmente importanti dal punto di vista economico. Ma non vi è problema dell’economia italiana che, pur facendo capo ai vari ministeri dal punto fi vista della tecnica, non faccia poi capo alla competenza politica del Ministero delle corporazioni”.
P. 161
Quanto abbiamo detto ci pare spieghi perché Mussolini parlasse relativamente poco della politica di intervento dello Stato nell’economia e quando ne parlava lo facesse in termini abbastanza generici, con motivazioni fumosamente sociali e nazionali e soprattutto come di una pratica sostanzialmente straordinaria e provvisoria, imposta dalla gravità della situazione; ma, al tempo stesso, praticasse una politica di progressiva espansione dell’intervento statale. Non spiega, però, da un lato, la scarsa organicità di questa politica e, da un altro lato, perché gli interventi più significativi non fossero inseriti in alcun modo nel contesto dell’ordinamento corporativo, che in quello stesso periodo si andava faticosamente cercando di delineare e che, logicamente, avrebbe dovuto innanzi tutto estendere la propria competenza ai settori dell’economia nazionale a vario titolo controllati dallo Stato in modo da farne il banco di prova della funzione rinnovatrice del sistema corporativo e il volano dello sviluppo economico nazionale.
La spiegazione di questo aspetto della politica di Mussolini è, a nostro avviso, in parte politica e in parte psicologica. E’ politica laddove va ricercata nella volontà del duce a) di evitare che i provvedimenti di intervento che venivano attuati potessero – se affidati per la loro realizzazione agli organi corporativi – essere considerati non straordinari e provvisori ma rispondenti alla logica corporativa e, quindi, potessero turbare vieppiù il mondo economico (già abbastanza preoccupato per i propositi corporativi del fascismo, per i primi passi del relativo ordinamento e per la tendenza e le pressioni di alcuni ambienti fascisti a considerare certi “salvataggi” come le premesse per realizzare una politica di pianificazione corporativa) e provocarne un ulteriore irrigidimento; b) di assicurare ai provvedimenti adottati quella funzionalità, tempestività ed elasticità di attuazione che Mussolini pensava potessero venir loro dall’essere affidati, a seconda dei casi, o a istituzioni creati ad hoc o alla burocrazia delle amministrazioni tradizionali dello Stato (dipendenti esclusivamente dal potere centrale e gelose delle proprie prerogative), mentre temeva che - affidati agli organi corporativi (per di più ancora non ben definiti ed organizzati) – la loro attuazione sarebbe stata probabilmente non solo meno pronta ed efficace, ma minacciata dal pericolo che in essi di producessero paralizzanti conflitti di interessi; c) di non dare un effettivo ed eccessivo potere, dal suo punto di vista, agli organi corporativi e gettare così le premesse di uno svuotamento dello Stato fascista a favore dello Stato corporativo, un dualismo che avrebbe diminuito i poteri centrali a favore di istituzioni e di interessi periferici e settoriali; d) di impedire la nascita anche in Italia di una tecnocrazia (sub specie corporativa), che avrebbe inevitabilmente teso a riassumere nelle proprie mani le redini dello Stato.
La spiegazione è, invece, più propriamente psicologica quando si considera che su queste motivazioni di ordine politico giuocava però anche una sostanziale, anche se ovviamente non dichiarata, incertezza di Mussolini sull’effettivo significato che nella struttura del regime avrebbe dovuto assumere l’ordinamento corporativo (e, quindi, su come realizzarlo e sui poteri da dargli) e, ancora più in genere, sulle linee di fondo da imprimere alla nuova politica economica del regime.
P. 172-74
Distinguere nettamente nella politica mussoliniana l’incidenza di queste motivazioni psicologiche e di quelle, invece, più propriamente politiche è ovviamente impossibile. Non ci pare però azzardato vederne il riflesso in varie manifestazioni più caratteristiche di essa; per fare tre casi maggiori, ci pare per esempio che se ne possa vedere il riflesso: a) nel sostanziale rifiuto di Mussolini di definire i caratteri dell’ordinamento corporativo e nell’insistenza nell’affermare che quanto veniva fatto in materia corporativa era sperimentale; b) nella cura da lui posta nel fare della figura del capo del governo la chiave di volta dell’ordinamento corporativo stesso – almeno come esso si venne delineando dal ’30 al ’34 – così da darle il massimo di poteri, di controllo e di assenso (per esempio per quel che concerneva la normazione in materia economica) sui principali atti corporativi; c) nel progressivo mettere da parte tutti quei fascisti che in materia corporativa ed economica avevano una propria precisa posizione e godevano di un prestigio personale (Turati nel ’30, Rocco e Bottai nel ’32, Arpinati nel ’33) e nell’utilizzare invece uomini di indubbio valore, ma che certo non puntavano essenzialmente ad uno sviluppo della politica corporativa (tipici i casi di Jung e Beneduce) e che, in quanto “puri tecnici”, Mussolini pensava avrebbero diretto l’economia italiana secondo criteri puramente tecnici, lasciando a lui (che non a caso quando liquidò Bottai riassunse in prima persona il ministero delle corporazioni) il compito di orientare come le circostanze politiche e le esigenze del suo potere avrebbero meglio richiesto la politica corporativa.
P. 175
Per formare le nuove generazioni era pur sempre necessario (lasciamo stare altre considerazioni altrettanto di fondo ma che non rientravano nella sensibilità e nella logica mussoliniana) poter disporre di una classe dirigente che, bene o male, rispondesse alle esigenze dell’impresa, vi credesse e, quindi, potesse assumersi in prima persona e con una certa dose di convinzione e di entusiasmo il compito di educare i giovani secondo una visione morale, culturale e politica e uno “stile di vita” veramente fascisti. Di una simile classe dirigente, però, il fascismo sostanzialmente mancava e, quel che era peggio, la prova dei fatti dimostrava che il regime – nonostante tutti i suoi sforzi – non solo non era capace id crearla, ma era esso stesso la causa, principale e quindi ineliminabile, di questa incapacità. Da qui il dramma del regime e la sua più intima ed effettiva condanna alla autodistruzione, ancor prima e a prescindere da quelle che furono poi le cause “esterne” della sua fine (che esse anticiparono nel tempo e resero più drammatica ma che, se non fossero sopravvenute, non sarebbe stata con ciò evitata, ma sarebbe solo avvenuta in forme diverse); da qui, ancora, il progressivo e crescente affannarsi del regime per uscire da questa situazione, ricorrendo a soluzioni e a provvedimenti che, invece, la aggravavano sempre di più e la rendevano più precaria anche sotto il profilo del consenso. E da qui, infine, la necessità in sede storica di rendersi conto del perché, pur essendo favorito dall’esistenza di un indubbio, sia pur superficiale, consenso di massa e dalla disponibilità di tutti gli strumenti atti, da un lato, a stimolare la crescita di questo consenso e, da un altro lato, a stroncare o almeno a circoscrivere entro misure non preoccupanti il dissenso attivo, il regime non riuscì a concretizzare sul piano della creazione di una propria classe politica questa situazione a lui apparentemente tanto favorevole e – a ben vedere – finì sostanzialmente per fallire assai prima sul terreno di quei ceti borghesi che avrebbero dovuto essere il suo punto di forza che non sul terreno dei ceti operai e contadini.
P. 180-81
Specie se riferito alla politica mussoliniana, un discorso sul segretariato di Starace non può però limitarsi alla mera recezione di un simile giudizio.
Che Starace fosse un uomo di scarsa intelligenza, animato da una mentalità grettamente militaresca e niente affatto politica, che lo portava a scambiare la forma esteriore, l’apparenza delle cose con la loro sostanza è pacifico. Da qui il suo appagarsi ed entusiasmarsi per risultati apparentemente grandiosi ma in realtà effimeri, quali un inquadramento di massa si anno in anno sempre più numerose ma organizzate con criteri essenzialmente burocratici, una partecipazione di esse alla vita del regime solo su basi emotive e coreografiche (in parte coattive), uno “stile di vita” che – mancando di contenuti veramente sentiti ed espressi dall’intima consapevolezza di operare per una società nuova e di poter contribuire al suo formarsi con un proprio apporto creativo – era quasi sempre il frutto solo di un generico adattamento, esteriore, superficiale e spesso opportunistico, ad un rituale, ad una retorica, ad una pianificazione dall’alto dei successi gradi del cursus fascista, che, pertanto, erano sentiti come qualcosa di estraneo e di imposto e suscitavano, a seconda dei casi, noia, insofferenza, scetticismo, irrisione. Ugualmente è fuori dubbio che la presenza di un tale uomo a capo del PNF incise alla lunga su tutto il tessuto morale del regime ed ebbe su di esso una influenza indubbiamente negativa. Su questo tipo di valutazione non è possibile non concordare con i critici anche più radicali di Starace. Per rilevante che sia stato questo aspetto dell’”era Starace”, bisogna però constatare che più importante è il fatto che durante gli anni Trenta il regime subì alcune trasformazioni – forse a prima vista non evidenti, ma certamente sostanziali – che ne modificarono addirittura gli equilibri interni e – contrariamente alle apparenze – non a favore di Mussolini; trasformazioni rispetto alle quali non è possibile, come si è detto, limitarsi a recepire il giudizio di coloro che ne hanno attribuito sic et simpliciter la responsabilità a Starace.
P. 216-17
Liquidando politicamente il PNF Mussolini – lo si è detto – indebolì notevolmente il regime e, in prospettiva, il suo stesso potere personale e si autocostrinse ad una politica sempre più attivistica e sempre più condizionata dalla ricerca e dal conseguimento del successo. Allargando per un momento il nostro orizzonte a tutto l’arco storico del regime, ci pare però evidente che con la sua scelta – della quale del resto abbiamo già visto le motivazioni psicologiche e politiche, sia remote sia recenti – Mussolini non fece altro che affrettare i tempi della crisi, così come – in ultima analisi – avrebbero fatto la partecipazione alla Seconda guerra mondiale a fianco della Germania e la sconfitta militare. La vera ed unica ragione della crisi del regime, quella che, anche senza gli errori di Mussolini, anche senza la causa traumatica della sconfitta militare, lo avrebbe portato ugualmente alla sua fine – anche se ovviamente in un più lungo arco di tempo e per evoluzione-trasformazione e non per morte violenta – fu un’altra: fu l’impossibilità, per contraddizione “che nol consente”, di creare quella propria nuova classe dirigente che sola gli avrebbe permesso di perpetuarsi nelle nuove generazioni e proiettarsi quindi nel futuro. In questa prospettiva il fallimento della politica di Starace – cioè, al solito, di Mussolini – volta appunto a fare del PNF lo strumento per educare e formare i nuovi quadri fascisti è veramente esemplare.
P. 228
Citazione dai Colloqui di Ludwig di Mussolini:
“Noi tendiamo a questo, a fare dell’Italia non precisamente una imitazione dell’antica Prussia, bensì un popolo altrettanto fortemente disciplinato. Noi abbiamo un concetto non analitico ma sintetico della nazione. Chi marcia, non si diminuisce… ma si moltiplica attraverso tutti quelli che marciano con lui. Noi siamo, come in Russia, per il senso collettivo della vita, e questo noi vogliamo rinforzare, a costo della vita individuale. Con ciò noi non giungiamo al punto di trasformare gli uomini in cifre, ma li consideriamo soprattutto nella loro funzione nello Stato. Questo è un grande avvenimento nella psicologia dei popoli, poiché viene fatto da un popolo del Mediterraneo, che era tenuto come inadatto a ciò. Là, nella vita collettiva, sta il nuovo fascino. Era forse diversamente nell’antica Roma? Al tempo della repubblica il cittadino non aveva che la vita di Stato, e con gli imperatori, sotto i quali questo mutò, venne appunto la decadenza. Si, questo è quello che il fascismo vuole fare della massa: organizzare una vita collettiva, una vita in comune, lavorare e combattere in una gerarchia senza gregge. Noi vogliamo l’umanità e la bellezza della vita in comune… L’uomo già a sei anni viene tolto in certo senso alla famiglia, e viene restituito dallo Stato a sessant’anni. L’uomo non vi perde nulla, lo creda pure: viene moltiplicato”.
P. 245
Il sigillo, che doveva mostrare al mondo che la crisi era ormai sepolta e che un nuovo periodo di amicizia e di collaborazione si era aperto, fu in questo senso costituito dalla visita dell’11 febbraio 1932, nel terzo anniversario della Conciliazione, Mussolini fece a Pio 11. In Vaticano. Lungamente preparato – tra l’altro con il conferimento al dice dell’ordine dello Sparon d’oro – la visita fu voluta soprattutto dal pontefice. In realtà, dal profondo, non valse a fugare in nessuna delle due parti né le diffidenze né i rancori. Valse solo a convincerle entrambe della opportunità – stante una certa situazione italiana ed internazionale – di evitare altri contrasti e di collaborare il più possibile entro questi limiti, in realtà non molto vasti, nei quali era possibile farlo senza pregiudicare il compromesso raggiunto sul piano dei rispettivi principi e cercando, al contempo, di sfruttare questa collaborazione per erodere, ognuno secondo i propri interessi, qualche piccolo miglioramento dello status quo a proprio vantaggio. Insomma, valse solo a dare ai rapporti tra la Chiesa e il regime sempre più il carattere di un matrimonio di interesse, in cui ognuno dei partners con un occhio controllava la situazione patrimoniale e con l’altro scrutava il futuro per anticipare eventualmente l’altro sulla via del divorzio, se non avesse più avuto vantaggi a rimanere legato ad esso.
P. 273-74
Certo, sui tempi lunghi, il fatto che l’Azione cattolica e in particolare le sue associazioni giovanili riuscirono bene o male a superare la bufera del ’31 avrebbe dato i suoi frutti. Come vedremo nel prossimo volume, è però un fatto che su questi frutti si furono, e copiosi - basta pensare all’esplosione della Democrazia cristiana dopo la caduta del fascismo e all’origine dei suoi quadri meno anziani -, ciò fu dovuto soprattutto alla nuova situazione italiana e internazionale determinatasi verso la fine degli anni Trenta: senza questo mutamento della situazione è difficile dire se, dopo la sconfitta del ’31, la sola esistenza dell’Azione cattolica sarebbe stata sufficiente ad evitare un progressivo perdere di importanza, un progressivo sfaldamento, una progressiva perdita di identità dei cattolici in quanto tali nella vita italiana. Per il momento però Mussolini riuscì a bloccare e a far retrocedere la penetrazione cattolica tra i giovani e il pericolo di una sua concorrenza sul terreno della formazione della nuova classe dirigente. Un successo, questo, che a ben vedere, rende ancora più grave lo scacco della sua politica verso i giovani, poiché conferma che questa fallì essenzialmente per l’intima contraddizione che era alla sua base e non per le resistenze o le alternative che ad essa venivano opposte dall’esterno.
Con questo excursus sulla crisi del ’31 tra il fascismo e la Chiesa possiamo considerare essenzialmente delineato il quadro complessivo del regime negli anni’29-’34, sia per quanto concerne la sua realtà di fondo, i maggiori problemi che esso dovette affrontare, il suo sviluppo tendenziale e le principali contraddizioni insite in questo sviluppo, sia soprattutto per quanto concerne il ruolo che nel determinare questa realtà di fondo ebbe Mussolini. Il quadro così delineato si riferisce però essenzialmente a quello che potremmo definire l’aspetto esterno del regime, alla sua proiezione verso il paese visto nel suo complesso. Per completarlo è quindi necessario ora soffermarci sugli aspetti più propriamente interni, su quelli che cioè attengono soprattutto (ma, ovviamente, non in modo esclusivo, ché, anzi, spesso ebbero echi notevoli nel paese e contribuirono a determinarne l’atteggiamento verso il regime), da un lato, alla organizzazione del potere statale, da un altro lato, alle diverse componenti del regime viste nei loro rapporti con esso e nel loro peso sulle scelte politiche del duce e, da un altro lato ancora, alla fisionomia del gruppo di potere fascista attorno a Mussolini: tre aspetti della realtà del regime nel ’29-’34 per molti versi distinti ma che crediamo opportuno trattare in questa seconda parte del capitolo il più possibile unitariamente, dato che solo visti nel loro insieme ci pare acquistino quella connessione e quella reciproca reattività che, in definitiva, finirono per avere gli effetti della più generale vicenda del regime e, quindi, dell’azione politica di Mussolini.
P. 275-76
Nell’ottobre ’31, in sede di Gran Consiglio, Mussolini affermò però e fece mettere a verbale che in una successiva riunione il supremo organo del fascismo si sarebbe dovuto occupare del problema della riforma dello Statuto. Sulla base di questa decisione il segretario del PNF, Giuriati, ebbe l’incarico di studiare il problema. Ai primi di luglio del ’33 Giuriati inviò a Mussolini una prima serie di proposte, riguardanti l’assetto legislativo e secondo le quali le Camere dovevano essere ridotte ad una sola, per metà nominata per decreto reale su proposta del Gran consiglio e per metà eletta dalle corporazioni col sistema del doppio grado di elezione. Ricevuta questa prima proposta, Mussolini scrisse il 10 luglio a Giuriati:
“Ho letto non solo con attenzione, il tuo scritto circa la riforma del nostro apparato legislativo. La tua diagnosi è perfetta. Le conclusioni vanno meditate. Comunque ti ringrazio e ti saluto con la vecchia cordialità”
P. 278-79
Negli anni precedenti Mussolini si era limitato, sfruttando i contrasti tra Cavallero e Badoglio, a confinare il secondo (tutt’altro che popolare tra i fascisti e considerato da molti un elemento infido) nella sua funzione di un suo “consulente tecnico”.
…..
Fu in questo periodo che, circolando la voce di prossime dimissioni di Gazzera, in alcuni ambienti si prese a ventilare la nomina a ministro della guerra di Augusto turati: questa ipotesi suscitò però vivaci proteste tra gli ambienti militari (il maresciallo Caviglia scrisse ai suoi colleghi marescialli proponendo loro che in tale eventualità intraprendessero un comune passo di protesta, dichiarandosi per parte sua pronto ad arrivare sino alle dimissioni):
p. 282-83
A meno di non spostare l’accento dal piano tecnico a quello politico; a meno cioè di non pensare che Mussolini, prevedendo la riottosità del sovrano e di uomini come Badoglio ad imbarcarsi in un eventuale conflitto coloniale, non pensasse che non era il momento di suscitare ulteriori motivi di polemica con Vittorio Emanuele 3 e con i capi dell’esercito. Ma con ciò non si fa che ritornare alla nostra tesi di fondo e confermarla vieppiù: si torna a dire che Mussolini non voleva toccare le forze armate perché sapeva che ciò gli avrebbe creato gravi difficoltà con la monarchia.
P. 286
Citazione da A. Iraci:
“dopo la cacciata di Arpinati, tutto cambiò nel fascismo, specie nei suoi quadri più alti, che, del resto, ormai erano completamente rinnovati, e non certo con un’elevazione delle qualità morali degli investiti. Essi compresero che potevano agire impunemente. L’occhio vigile del “censore disarmato” – come poi si disse – non c’era più. Rimaneva il pericolo delle “informative” di Bocchini. Ma questi, che desiderava soprattutto rimanere al suo posto, e, del resto, in materia di moralità non aveva interessi, poteva essere facilmente addomesticato da chi era potente. E così fu. Nel secondo periodo del fascismo, e poi sempre di più verso la fine, l’abuso dell’autorità e del pubblico denaro da parte di chi aveva il potere divenne la regola; non vi fu più discrezione né controllo. E il fenomeno, del resto caratteristico di ogni epoca di decadenza, assunse aspetti e proporzioni, che spiegano quella fama di disonestà generale che, forse anche in misura superiore al giusto, è rimasta attributo del regime fascista…
…..
questo toscano [Buffarini-Guidi], grosso e rubicondo, scaltro e intelligente, privo di principi e di scrupoli, fu proprio il tipo adatto per completare Starace. Il Ministero dell’interno, appena vi entrò Buffarini, accompagnato da una folta schiera di clienti, mutò fisionomia… Come abbiamo avuto occasione di dire, il Ministero dell’interno era stato sempre, pur nel fascismo, il controllore piuttosto severo di tutto ciò che avveniva nel paese, e anche l’estrema garanzia del cittadino offeso nei suoi diritti. Da allora divenne il complice, il compartecipe, il garante di tutti gli abusi, le illegalità, le prepotenze, le immoralità, che con ritmo crescente si perpetrarono in nome del fascismo”.
P. 298-99
Questo si spiega con la particolare prospettiva con la quale osservatori e storici si sono posti ognuno di fronte alla stessa realtà e, al tempo stesso, con la difficoltà di individuare veramente simili spartiacque, che in quanto tali sono la somma di tutta una serie di fatti e di momenti particolari. Resta però il fatto che per tutto lo spartiacque si pone grosso modo fra il ’32 e il ’34; resta cioè il fatto che il regime al suo interno cominciò la parabola discendente nel momento in cui godeva nel paese del maggior consenso, prima delle grandi iniziative di politica estera, prima che per Mussolini iniziasse il declino fisico. Entrare nel merito di questi spartiacque non sarebbe dunque solo inutile, ma anche assurdo.
P. 300
Tra il ’32 e il ’34 il regime – lo abbiamo detto – cominciò la sua parabola discendente. Questa però è una constatazione che possiamo fare noi oggi, in sede storica, tenendo conto di tutta una serie di elementi e di sintomi. Allora nessuno non solo se ne rese conto, ma neppure fu sostanzialmente sfiorato da una simile idea e ciò sia in Italia sia all’estero, sia tra i fascisti sia tra gli antifascisti più seri (lasciamo ovviamente fuori dal nostro discorso, perché ai suoi effetti irrilevanti, coloro i quali da anni il fascismo era sempre nell’ultimo semestre del suo potere). Al contrario, tutti gli elementi esterni inducevano a ritenere che il regime non fosse mai stato tanto solido e non avesse mai goduto di un consenso così vasto, sia all’interno sia a livello internazionale.
P. 304
E’ alla luce di tutto questo complesso di avvenimenti, di prese di posizione, di affermazioni e della loro utilizzazione ai vari livelli della formazione della pubblica opinione che si devono anche vedere e valutare i risultati del “secondo plebiscito” del 1934. Solo se si hanno presenti tutte le tessere del mosaico, tutte le motivazioni dirette ed indirette cioè, è possibile comprendere e la cura messa dal regime nel prepararlo e il suo esito. Une sito – lo ripetiamo – per tanti versi scontato e che indubbiamente fu condizionato dalla particolare situazione di illibertà in cui si svolse e dalle precauzioni prese dal fascismo per garantirne la plebiscitarietà, ma che, altrettanto indubbiamente, corrispose nel suo complesso al reale consenso che in quel momento caratterizzava – sia pure con motivazioni e stati d’animo diversi e molteplici – l’atteggiamento verso il regime e soprattutto verso Mussolini della grande maggioranza degli italiani.
P. 311
Citazione da Lelio Basso:
“Le polemiche scandalistiche che sono condotte intorno a questo gesto – da ritenersi tanto più coraggioso quanto più impolitico – sono una prova di più della scarsa conoscenza della situazione italiana di certi fuoriusciti, a cui non intendo ora replicare, anche però li considero politicamente inconsistenti e superati. Si può dissentire da Caldara, ma non è lecito ignorare che il suo atteggiamento non è che un aspetto di una situazione politica, che non è quella del 1922 o del 1926.
Bisogna avere una volta per tutte il coraggio di riconoscere che le antitesi Fascismo-Antifascismo, Dittatura-Democrazia, non hanno più fortuna in Italia, che le formule vuote di giustizia o di libertà non arricchiscono più…
Non è qui una tendenza, una simpatia, un desiderio che si esprime, è l’obbiettiva constatazione di una realtà di fatto. Ora in Italia i 12 anni di fascismo che sono passati e gli altri che si preparano son venuti formando e finiranno col plasmare una generazione per le quali le espressioni “democrazia”, “liberalismo” saran vuote di senso, una generazione interamente avezza a considerare i problemi politici e sociali nei termini in cui glieli presenta la realtà di ogni giorno.
I giovani che oggi, a 30 anni, vengono a poco a poco assumendo i posti di responsabilità nella vita civile e politica, nella scuola, nel giornalismo, nelle aziende, nelle libere professioni, erano in liceo all’epoca della marcia su Roma, e non hanno della lotta politica di un tempo che un ricordo confuso e, in genere, non gradito. Un fenomeno analogo, se non in tutto identico, si può riscontrare anche nella massa operaia.
Non voglio dire con questo che tutti gli italiani siano fascisti: tutt’altro. Alle realizzazioni miracolose del regime non crede quasi più nessuno, come pressappoco nessun prete crede ormai ai dogmi cattolici, ma tanto meno si crede all’antifascismo. I pochi convinti sono forse soltanto certi piccoli gruppi di giovani mistici del sindacalismo fascista, che vanno parlando di socialità e di collettivismo e credono in buona fede di potervi arrivare attraverso l’esperienza del corporativismo fascista. Per il resto del popolo il fascismo è ormai un’abitudine una realtà magari anche importuna, della quale si può brontolare o ridere volta a volta, ma che nessuno penserebbe seriamente di mettere in discussione.
Parlare oggi agli italiani di “difesa delle libertà democratiche2 è parlare un linguaggio che non intendono più. Bisogna rinunciare a difendere e puntellare un edificio che crolla da ogni parte se si vuol veramente costruire l’edificio del socialismo. E costruire non è possibile senza una massa alla quale non si può parlare se non di cose che erra conosce, delle esperienze che vive, dei problemi che la angustiano ogni giorno, di tutto quanto insomma forma da anni e formerà per anni ancora la sostanza della sua attività.
Bisogna convincersi una volta per tutte che il fascismo è una realtà di fatto della quale si deve tener conto, e che non i problemi di venti anni fa ma quelli che il fascismo lascia oggi aperti possono essere la matrice da cui scaturiranno le soluzioni di domani. Diversamente si è dei sopravvissuti. Le sconfitte delle socialdemocrazie su quasi tutti i fronti di Europa, l’involuzione del comunismo, ci permettono finalmente di liberarci dai pesi mori, dalle formule, dai luoghi comuni per iniziare veramente un lavoro nuovo con animo realistico e spregiudicato, totalmente sgombro da nostalgie e da soluzioni già pronte. Ritrovare Marx sotto incrostazioni pseudomarxistiche dei lunghi decenni parlamentari e democratici.
Al di là del caso Caldara vi è questo ansioso desiderio dei socialisti, che credono ancora nell’avvenire, di riprendere contatto con le vaste masse della gioventù, ben più concretamente che non attraverso una sterile propaganda clandestina, di portarle, dai bisogni insoddisfatti di oggi alle sperate conquiste di domani. Perché il domani socialista non può essere frutto e conquista che di questa gioventù”.
P. 319-20
Citazione da Berto Ricci:
“E’ certo che una parte della borghesia – aveva scritto l’Universale – viene alle Corporazioni con una mentalità anti-rivoluzionaria. Bisogna tenere presente questo fatto per evitare che certi posti di grande importanza strategica siano affidati a uomini i quali possono costituire un ostacolo alla marcia rivoluzionaria. Non bisogna confondere la gradualità degli sviluppi corporativi con lo spirito riformista. Il gradualismo è questione di tattica; ma conosce le mete da raggiungere e ad esse tende inflessibilmente. Il riformismo invece vorrebbe fare delle Corporazioni un inutile ed ibrido pasticcio, tra il liberalismo e il socialismo di Stato, un posto di medicazione, insomma, dell’economia individualista…
E’ bene anche intenderci quando si parla di riformisti. Questi nemici della rivoluzione si trovano non solo tra gli elementi della borghesia industriale, agricola e commerciale che vorrebbero fare delle Corporazioni l’istituto di salvataggio del capitalismo, ma anche tra i neo-convertiti della borghesia intellettuale, provenienti dal riformismo puro sangue del socialismo. Insistiamo sul termine “borghesia intellettuale” e non lavoratori, perché il riformismo fu nel socialismo una clausola tipicamente borghese e intellettualistica. Alcuni di codesti signori, i quali avevano a lungo diffidato del fascismo, si sono accorti finalmente che esso non solo tiene fede ai suoi principi, affermati fin dal lontano 1919, ma va oltre questi stessi principi, o meglio dà ad essi gli sviluppi che le diverse situazioni richiedono. Ed ecco i signori del riformismo riconoscere finalmente che il fascismo non ha tradito le aspirazioni sociali del popolo italiano: fin qui tutto bene. Il difficile comincia quando essi vorrebbero dare il contributo del loro pensiero e della loro azione alla rivoluzione corporativa. Allora bisogna sorvergliarli: vedere cioè se vengono al fascismo per accettarne il contenuto rivoluzionario e imperiale; oppure se sperano di portare a noi di contrabbando la loro concezione della vita e della politica. Bisogna dir loro che se la politica fascista all’interno in questi anni puta soprattutto sui problemi sociali, il fascismo non si esaurisce in essi e non tende solo al benessere materiale del popolo, ma soprattutto alla sua grandezza morale. . La spiritualità del fascismo è la sua premessa della sua concezione imperiale: se i borghesi del riformismo volessero portare con l’adesione formale alle Corporazioni un’attenuazione dello spirito politico del fascismo a favore di un’interpretazione sociologica e antimperiale della vita, bisognerà contro di loro appellarci ancora allo spirito squadrista, che nel socialismo non combatte il nemico della borghesia, ma precisamente la concezione materialista do origine borghese che si opponeva alla missione imperiale del popolo italiano.
P. 320-21
Cap. 4. Alla ricerca di una politica estera fascista
La costituzione del governo Mussolini nel ’22 non era stata in genere accolta dagli ambasciatori accreditati a Roma e dai loro governi con eccessivo allarmismo. Per qualcuno qualsiasi cosa era in definitiva meglio che il succedersi dei deboli e vacillanti governi che aveva sino allora caratterizzato la vita politica italiana. Altri erano convinti che la difficile situazione interna italiana avrebbe per un pezzo assorbito tutte le energie del nuovo presidente del consiglio e si mostravano propensi a credere sia ai propositi “normalizzatori” del duce sia alle assicurazioni di Contarini e dello stesso Mussolini che una cosa erano le affermazioni sulla “nuova” politica estera fascista scritte nei giornali e gridate nelle piazze, un’altra l’effettiva politica che il fascismo, giunto al governo, avrebbe fatto. Anche coloro che guardavano al fascismo con qualche simpatia, convinti che esso avesse impedito all’Italia di cadere nelle mani del bolscevismo, si rendevano tutti più o meno conto della possibilità di un radicale mutamento della politica italiana in senso nazionalista.
P. 326
Citazione da W. Churchill:
“Nazioni diverse hanno modi diverse di fare la stessa cosa. Termini e parole spesso inducono in errore. I valori e i significati attribuiti alle parole differiscono molto da paese a paese. Nessuna questione politica può essere giudicata indipendentemente dalla propria atmosfera e dal proprio ambiente. Se fossi stato italiano sono sicuro che sarei stato interamente con voi dal principio alla fine della vostra lotta vittoriosa contro i bestiali appetiti e le passioni del leninismo. Ma in Inghilterra non abbiamo ancora avuto da affrontare questo pericolo sotto la stessa forma micidiale. Noi abbiamo il nostro particolare modo di fare le cose. Ma su una cosa non ho il minimo dubbio, e cioè che noi riusciremo, nella lotta al comunismo, a strozzarlo.
P. 330
Citazione da Mussolini:
“La vecchia generazione che si compiaceva nella politica del “piede di casa”, che quasi ci godeva ad esibire agli stranieri agli stranieri una Italiuzza discreta, modesta, senza pretese, che si contentava di far l’albergatrice; questa generazione che fu flagellata da Carducci è morta. Gli uomini della mia generazione, anche quando si professano universalisti, socialisti, internazionalisti, sono dei “nazionalisti” nel senso migliore della parola. Noi – parlo di quelli che stanno fra i venti e i trent’anni – siamo degli esasperati della italianità. Noi sentiamo nelle nostre vene, in ciò che in noi c’è di più intimo, il dinamismo dell’Italia. Lavoriamo per un’Italia più grande dentro e oltre i confini. E’ la guerra che ha rivelato noi a noi stessi. Non andremo troppo oltre, con questi stati d’animo, perché il senso innato dell’equilibrio e delle proporzioni ci vieta di scivolare o nelle imitazioni o nella caricatura. Ma questo è il “dato” dell’anima italiana…”
Se non si ha ben presente questa serie di stati d’animo, di motivi culturali e di convinzioni che Mussolini aveva maturati negli anni precedenti l’assunzione del potere si rischia di non riuscire più a comprendere la su aplitica estera, forse sino alla guerra civile spagnola, allorquando la politica degli “interessi nazionali” andò perdendo rapidamente terreno rispetto a quella degli “interessi ideologici, certo sino al 1929-1930, quando avvenne il primo vero mutamento della politica estera mussoliniana dall’ottobre ’22.
P. 335
Da qui la sua tendenza a proiettare tutti i suoi progetti più ambiziosi e grandiosi, quelli che avrebbero dovuto consacrare il fascismo nella storia, sui tempi medi e lunghi, persino al di là della sua personale esistenza fisica. In questa prospettiva è evidente che una guerra coloniale localizzata era per Mussolini concepibile anche a breve scadenza, non così un grande conflitto intereuropeo, per il quale egli era convinto occorresse non solo la necessaria preparazione tecnica, ma quella preparazione morale e quella “virtù” che determinano la vittoria o la sconfitta e fanno della guerra un 2esame comparativo in cui i popoli rivelano i loro difetti e le loro capacità. Il che ci pare contribuisce a spiegare appunto in chiave psicologica perché Mussolini poté errare nel ritenere che la guerra non sarebbe scoppiata in Europa prima di molti anni. A questa considerazione, per valutate appieno la concezione nella quale Mussolini (e con lui la maggioranza dei suoi più stretti collaboratori in questo campo) avrebbe calato negli anni trenta i tempi lunghi della sua politica estera (concezione che, per altro, andò prendendo corpo già nella seconda metà degli anni Venti; si ricordi il sintomatico giudizio di Guariglia precedentemente citato a proposito della politica revisionistica), ci sembra indispensabile farne seguire, per avere un quadro d’insieme il più completo possibile delle componenti di base della politica estera mussoliniana, un’altra relativa alle alleanze alle quali Mussolini pensava per la futura guerra intereuropea, dato che, ovviamente, un conflitto di tale importanza ed entità poteva essere affrontato dall’Italia solo nel quadro di uno schieramento di vaste dimensioni. Ebbene, per quanto la cosa possa, forse, destare meraviglia in chi è ancora legato ad una delle varie schematizzazioni sulla politica fascista, la nostra convinzione è che, non solo sino al patto d’acciaio ma sino alla primavera del ’40, sino alle grandi vittorie militari tedesche in occidente, Mussolini, nonostante tutto, non fece mai una scelta veramente pregiudiziale, ma lasciò impregiudicata la questione (o meglio, si illuse di lasciarla impregiudicata), pensando di poter scegliere in tal modo il campo per lui più vantaggioso e nel frattempo raccogliere i frutti che una tale disponibilità gli procurava. Una strategia politica, questa, sulla quale – ancora una volta – si può certo discutere molto, in relazione sia al suo presunto realismo sia alla sua aderenza alla tanto declamata “etica fascista”, ma che è difficile – pur con tutte le dovute distinzioni storiche – considerare del tutto fuori della tradizione politica dell’Italia prefascista e in particolare di quella che è stata definita la tradizionale vocazione italiana per l apolitica dei “giri di valzer”.
P. 339-40
Ai suoi esordi la politica estera di Mussolini si mosse in una prospettiva strategica facilmente individuabile e che si ricollegava alla linea Di San Giuliano-Contarini-nazionalisti moderati. In base ad essa gli obiettivi da conseguire erano due: assicurarsi la sicurezza della zona danubiano-balcanica e tendere all’espansione nel Mediterraneo e in Africa. La prima direttiva ebbe come manifestazioni più importanti, nel ’24, la politica di amicizia con la Cecoslovacchia e soprattutto gli accordi del gennaio con la Jugoslavia (entrambi questi atti tendevano anche a controbilanciare in qualche misura l’influenza francese sulla Piccola intesa) e sui tempi più lunghi la sistemazione dell’annosa questione albanese, sulla base di un rapporto del tipo di quello tra l’Inghilterra e il Portogallo, di alleanza e di protezione al tempo stesso. Poiché a questa sistemazione si giunse solo nel ’26-’27, quando i rapporti con la Jugoslavia si erano intanto deteriorati, con essa Mussolini raggiunse anche il risultato di stringere il vicino regno slavo in una specie di morsa. Parzialmente collegato a questa politica di sicurezza nella zona danubiano-balcanica si può considerare anche il riconoscimento nel ’24 dell’Unione Sovietica, nel senso che contribuiva a “rimettere in circolo” la Russia e quindi a controbilanciare in qualche misura la presenza francese in queste regioni; gli accordi con l’URSS risposero anche e forse più a ragioni politiche più generali (dimostrare che l’Italia fascista non si muoveva in base a considerazioni d’ordine ideologico e cercare di mettere in difficoltà le sinistre italiane) e d’indole economica. Più complesso è sintetizzare l’altra faccia di questa politica, quella tendenzialmente espansionistica.
In quel momento pensare ad una iniziativa italiana autonoma era un assurdo. Le uniche possibilità per una politica di espansione erano connesse ai rapporti con l’Inghilterra e con la Francia e a trattative con questi due paesi per ottenere da essi dei compensi coloniali in base agli accordi stipulati nel ’15 e alla risistemazione “mandataria” del dopoguerra.
Persino verso l’Etiopia la politica italiana – che negli anni Venti Mussolini concepì ed attuò come “una politica coloniale pacifica ed ordinata, basata sullo sviluppo dei rapporti di amicizia, commerciali ed economici” – non poteva prescindere da quella inglese e francese. Al trattato di amicizia italo-etiopico del 2 agosto ’28 si poté giungere infatti solo dopo una lunga preparazione diplomatica e, ciò che più conta, dopo una serie di trattative tutt’altro che facili con Parigi e soprattutto con Londra: dopo la riconferma nel ’25-’26 degli accordi del 1906 sui rispettivi interessi in Etiopia e dopo che nel marzo ’28 l’Italia, in cambio del consenso inglese a passare dai progetti di penetrazione economica al trattato politico, ebbe di fatto rinunziato a proseguire la propria penetrazione economica nello Yemen.
P. 347-48
Il governo inglese (conservatore o laburista che fosse) era interessato all’amicizia italiana per molti motivi. Perché l’Italia, non avendo rivendicazioni sul continente europeo, era in quel momento un elemento di stabilità e di conservazione e, al tempo stesso, di parziale contrappeso all’egemonia continentale francese. Perché il suo espansionismo coloniale non poteva avere in definitiva che un carattere subalterno rispetto alla politica imperiale di Londra e, data la non mai del tutto sopita rivalità anglo-francese nel Mediterraneo, rappresentava anche in questo settore un utile contrappeso a Parigi. Perché, infine, rendendosi conto gli inglesi e Chamberlain in particolare del potenziale pericolo o, almeno, elemento di disordine che l’Italia fascista avrebbe potuto rappresentare in futuro, essi preferivano sorvegliare dal presso Mussolini ad avere con lui buoni rapporti da poterlo influenzare nel modo più efficace, servirsene come una pedina per il loro gioco diplomatico (come fecero nel dicembre ’24, quando Mussolini in pratica silurò il protocollo” per il regolamento pacifico delle controversie internazionali” approvato dalla Società delle Nazioni che il governo inglese non voleva fosse ratificato) e deviare eventualmente il suo espansionismo laddove meno li danneggiava.
P. 348-349
Il trattato di amicizia italo-ungherese, sottoscritto nell’aprile ’27 tra Mussolini e il conte Bethlen, è in genere considerato un momento decisivo della politica estera fascista. Con esso si sarebbe completata la frattura tra la prima fase di questa politica, quella mussoliniana-contariniana, e quella più propriamente mussoliniana; avviata tra la fine del ’25 e i primi del ’26 col sabotaggio del sistema di Locarno (in particolare attraverso l’accentuazione delle punte anti francesi e il tentativo di tenerne fuori la Germania, in modo da poterne sfruttare contro di esso il potenziale sovversivo) e con l’abbandono dei propositi di accordo con la Jugoslavia – che furono la causa delle dimissioni nel marzo ’26 di Contarini – la svolta mussoliniana si sarebbe infatti definita in tutti i suoi elementi nel ’27 con la scelta revisionista operata attraverso l’accordo con l’Ungheria. In questa periodizzazione-valutazione vi è certo del vero; a nostro avviso, ai fini di una valutazione concretamente storica del trattato italo-ungherese del ’27 e, più in genere, del revisionismo mussoliniano è necessario inserire questo problema in un quadro più vasto, che ci riporta ai rapporti italo-francesi.
P. 357
In una situazione internazionale sostanzialmente statica come quella della seconda metà degli anni Venti, per il duce la prospettiva della politica estera italiana – realizzato l’ancoraggio alla politica inglese – era ancora quella del periodo immediatamente successivo alla sua andata al potere: nonostante l’intransigenza di Parigi, egli vedeva l’obiettivo da raggiungere nell’amicizia con la Francia. Solo essa infatti poteva, in teoria, soddisfare le sue aspirazioni di espansione coloniale sia le sue necessità di sicurezza rispetto alla Germania. Se si esaminano da vicino le relazioni diplomatiche italo-francesi in questo periodo e, al tempo stesso, non ci si lascia suggestionare dagli aspetti esterni delle altre iniziative politiche mussoliniane parallele ad esse, è facile rendersi conto che Parigi era sempre la stella polare del duce. Lo era quando polemizzava violentemente con gli austriaci e soprattutto con i tedeschi per l’Anschluss e per le condizioni della popolazione di lingua tedesca dell’Alto Adige.
P. 358
Nelle pagine precedenti abbiamo cercato di individuare i momenti principali della politica estera italiana nei primi sette anni dopo la “marcia su Roma” e, al tempo stesso, di coglierne le motivazioni di fondo. Da quanto abbiamo detto si ricavano, a nostro avviso, alcuni punti fermi, così riassumibili:
- in questi primi anni per motivi generali (staticità della situazione internazionale) e particolari (situazione interna italiana), la politica estera di Mussolini fu scarsamente dinamica, priva di effettiva autonomia e concepita sostanzialmente in funzione della politica interna, come uno degli elementi, cioè, volti a suscitare il consenso attorno al regime che si andava costituendo;
- in questo quadro generale, Mussolini e al “carriera” mirarono soprattutto a realizzare una politica di sicurezza in Europa e una politica di espansione nel Mediterraneo orientale e specialmente in Africa;
- entrambe queste politiche avevano come pre-condizione l’amicizia con l’Inghilterra e con la Francia, considerata necessaria sia per l’oggettiva realtà europea, sia perché l’espansione coloniale veniva ritenuta possibile solo attraverso una serie di accordi con queste due potenze volti ad attuare il “sospeso coloniale” del patto di Londra;
- sia pure con qualche frizione temporanea, questa politica di amicizia poté essere realizzata con l’Inghilterra, non così invece con la Francia;
- da qui una tensione, in certi momenti anche grave, con la Francia e l’affermarsi della tendenza a costringere Parigi ad un accordo, cercando di mettere in difficoltà il suo sistema di egemonia europea e di rendere l’Italia indispensabile alla sua sicurezza, favorendo prima il revisionismo ungherese, poi quello tedesco.
P. 365
Citazione dal Di Nolfo (Mussolini e la politica estera italiana):
“Fino a questo momento l’attività di Mussolini come ministro degli esteri aveva comportato una responsabilità e una visione limitate unicamente alla considerazione degli interessi italiani. Su nessuno dei grandi problemi internazionali prospettatisi nel periodo 1922-29 (eccezion fatta per il memorandum sulle riparazioni del 1923) il governo italiano aveva preso una posizione autonoma e originale, contentandosi sempre Mussolini di seguire l’iniziativa altrui, e di restare al margine delle questioni. A partire invece dal 1929, le nuove conferenze delle riparazioni prima e poi quelle per il disarmo, ponendo in primo piano quei grandi problemi che… esprimevano la svolta avvenuta nella situazione mondiale, esigevano prese di posizione nuove da parte dell’Italia, le quali non potevano non essere, sulla base delle premesse poste dal fascismo, originali ed autonome. Per la prima volta quindi Mussolini e il fascismo si trovavano di fronte a problemi che implicavano quella visione complessiva e organica della situazione internazionale che Mussolini non era riuscito a formulare negli anni in cui aveva tenuto il ministero degli esteri. Il loro carattere particolare era che essi non potevano più venir considerati da un punto di vista ristretto e unilaterale, ma richiedevano una prospettiva più ampia, la considerazione di un interesse generale.
P. 369-70
Alla luce di questa pessimistica ma realistica diagnosi della situazione internazionale, per Grandi il fascismo – anche se la sua tradizione e i suoi stati d’animo lo portavano a muoversi in un senso diverso e contrario – doveva attuare una politica estera di pace, di disarmo, di collaborazione attiva con la Società delle Nazioni, di conciliazione, al limite, con le potenze democratiche. Questa era la vera politica estera rivoluzionaria che l’Italia fascista avrebbe potuto fare. La politica e estera che corrispondeva agli interessi generali dell’Europa, che realisticamente l’Italia poteva in quel momento permettersi (“I grossi eserciti, le potenti flotte, le grandi aviazioni sono, nella moderna età delle macchine, un diretto prodotto della ricchezza. Può l’Italia ricca di uomini, ma povera di mezzi materiali, competere su questo terreno con le altre nazioni?”), che le avrebbe permesso di “mettersi in grado di porre davanti alle assise del mondo il problema fondamentale dell’espansione italiana, ossia il diritto alla vita della nostra nazione”, era questa. Su questa strada si potevano incontrare momenti difficili, momenti di isolamento; essi non dovevano però spaventare l’Italia. Solo percorrendo con tenacia e coerenza questa strada l’Italia poteva infatti acquistare, da un lato, un posto, un ruolo autonomo nella politica internazionale e, da un altro lato, un peso determinante nella realtà europea, che le avrebbe permesso di realizzare i suoi obiettivi storici, ovvero la creazione di un vero e proprio impero coloniale.
P. 373
Anche ammettendo che il patto consultivo non finisse per rilanciare – come in un primo tempo fu temuto – l’idea di una unione federale europea avanzata da Briand due anni prima (che inevitabilmente avrebbe vieppiù rafforzata l’egemonia francese) è fuori dubbio che la rinnovata collaborazione anglo-francese (realizzata bilateralmente e solo successivamente allargata, con la proposta del patto consultivo, all’Italia, alla Germania e al Belgio) introduceva una nuova procedura nel modo di affrontare i problemi europei, facendone, in pratica, dipendere la trattazione dal preliminare accordo fra Londra e Parigi. A parte la questione del prestigio, così importante per Mussolini, ciò voleva dire un indebolimento dell’amicizia italo-inglese e soprattutto una riduzione assai grave dei margini di manovra della politica estera italiana e ciò, per di più, in un contesto che sanciva un notevole rafforzamento della posizione delle Germania (alla quale oltre tutto la Francia, volente o nolente, cominciava a mostrare l’intenzione di non negare più a lungo l’eguaglianza dei diritti, che, infatti, la Germania ebbe teoricamente riconosciuta meno di cinque mesi dopo). In altri termini voleva dire il fallimento o, almeno, il rinvio chi sa per quanto tempo della possibilità di costringere Parigi ad accordarsi con Roma alle condizioni di quest’ultima.
Una serie di fatti nuovi così gravi non poteva non avere conseguenze altrettanto gravi. La prima fu costituita dall’annuncio, il 21 luglio, della riassunzione da parte di Mussolini della guida della politica estera italiana e, una settimana dopo, della nomina di Grandi ad ambasciatore a Londra.
P. 393
Un primo motivo – il più evidente – fu quello di fare di Grandi una sorta di capro espiatorio su cui dirottare il malcontento di larga pare del gruppo dirigente fascista e, soprattutto, di cui servirsi in negativo per giustificare la rettifica decisa da Mussolini della politica di “collaborazione” internazionale sino allora attuata.
Un secondo motivo – più sostanziale – fu quello determinato dalla convinzione alla quale Mussolini era ormai pervenuto della necessità di imprimere (almeno formalmente, ché il suo radicato tatticismo gli impedì sempre di ancorare veramente la sua politica e specialmente quella estera a rigide formulazioni ideologiche) alla politica estera italiana un carattere più marcatamente fascista, più corrispondente cioè non solo alle richieste che venivano dal vertice del PNF, alle esigenze, per lui sempre più prioritarie, della formazione di nuove generazioni e alle indicazioni di base del “fascismo universale” dei vari gruppi intellettuali e giovanili fascisti, ma anche e soprattutto alla sua personale concezione ideologica del fascismo, quale egli veniva delineando in quel periodo in connessione con tutta una serie di avvenimenti (in primo luogo il drammatico sviluppo assunto dalla “grande crisi”) e di opportunità politiche. Di questa concezione (di cui una delle manifestazioni più significative, la Dottrina del fascismo, fu pubblicata proprio nelle settimane a cavallo dell’allontanamento di Grandi) non è qui il caso di parlare, dato che lo abbiamo già fatto ampiamente nei precedenti capitoli. Qualche parola merita piuttosto – a proposito di quelle che abbiamo definito le opportunità politiche – l’incidenza che sul suo convincersi della necessità di dare alla politica estera un carattere più marcatamente fascista dovettero avere, da un lato, i grandi progressi compiuti dal ’30 in poi in Germania dal nazionalsocialismo e, da un altro lato, i fermenti e le iniziative politiche che in questo stesso periodo tendevano – sinceramente o strumentalmente poco importa ai fini del nostro discorso – a cercare il superamento della crisi europea in una soluzione di tipo federalista.
P. 407-08
Il motivo decisivo dell’allontanamento di Grandi fu però un altro, squisitamente politico e di cui il precedente non era, almeno in parte, che la conseguenza. Alla metà del ’32 Mussolini era ormai convinto che la situazione europea fosse sul punto di modificarsi sul punto di modificarsi radicalmente e di avviarsi quindi su dei binari assai diversi da quelli lungo i quali si era mossa sino allora. In tutti i principali paesi la lotta politica andava, sotto i colpi della crisi economica, radicalizzandosi e polarizzandosi a favore delle forze estreme, di destra e di sinistra. In Germania in particolare l’andata al potere del nazionalsocialismo era per Mussolini scontata ed egli era ormai convinto che nulla ormai l’avrebbe evitata.
P. 411-12
In questa prospettiva, per Mussolini, la politica estera dell’Italia fascista doveva essere concepita ed impostata in termini assai precisi. Sui tempi brevi – in attesa della completa definizione della situazione interna tedesca – essa doveva tendere: 1) a prendere le proprie distanze sia dalla Francia sia dalla Germania, assumendo un atteggiamento equidistante da entrambe, in maniera da mantenere intatte tutte le possibilità per una futura politica pendolare, dalla quale trarre, a seconda delle circostanze, ogni vantaggio possibile; 2) a mettere in difficoltà e possibilmente in crisi l’accordo anglo-francese di Losanna, in maniera da recuperare all’Italia l’appoggio inglese, sfruttando a questo fine l’assoluta ostilità dell’Inghilterra ad impegnarsi di più sul continente e la sua paura che l’intransigenza francese aggravasse la situazione europea (alla importanza annessa da Mussolini a questo aspetto della sua politica ci pare si debba attribuire essenzialmente la nomina di Grandi ad ambasciatore a Londra, dove nessun altro diplomatico italiano avrebbe avuto tante per una simile azione; 3)a sfruttare il problema dei debiti di guerra per creare difficoltà al governo francese sia sul piano interno sia su quello dei rapporti con gli Stati Uniti; 4) a rinsaldare al massimo gli accordi con Budapest e Vienna, sia per creare difficoltà alla Francia e alla Piccola intesa, sia soprattutto per precostituire una barriera alla spinta politico-economica della Germania in quella regione; spinta già chiaramente delineatasi da un anno e più, ma che si sarebbe certamente accentuata (specie sull’Austria) quando i nazionalsocialisti fossero arrivati al potere. Lo sbocco di questa politica doveva essere un accordo tra le 4 grandi potenze. Italia, Inghilterra, Francia e Germania dovevano costituire una sorta di direttorio europeo, che – riprendendo in un certo senso lo schema di Locarno ma adeguandolo alla nuova realtà europea e cioè dando ad esso un valore non statico ma dinamico, ovvero moderatamente revisionistico – assicurasse all’Europa almeno un decennio di sostanziale stabilità e pace.
P. 413
In conclusione, alo stato della documentazione (ma non crediamo che i nuovi elementi possano modificare sostanzialmente il quadro), ci pare si possa dire che, nonostante le ripetute dichiarazioni di Hitler in senso filo-italiano e filo-fascista sull’Alto Adige e nonostante le sue avances per un incontro con Mussolini, l’interesse per il nazionalsocialismo fu negli anni Venti assai scarso sia a palazzo Chigi sia al vertice del PNF (è sintomatico che se fu inviato negli ultimi anni qualche rappresentante del partito ai congressi di Norimberga si trattò sempre di figure senza importanza, oscure addirittura), sia da parte di Mussolini e che i rapporti intrattenuti con alcuni dei suoi leaders non andarono mai oltre il tipo e il livello di quelli con altri esponenti di partiti e movimenti di estrema destra e filo-fascisti europei (e spesso si mantennero al di sotto di essi) e risposero solo alla logica di “guardar dentro” alla vicende politiche tedesche, cercare di controbattere in qualche modo la propaganda antifascista dei partiti democratici e di sinistra e assicurarsi una certa influenza in ambienti che si considerava opportuno avere amici, sia per servirsene per creare difficoltà al governo tedesco (soprattutto l’odiato Stresemann) sia nella prospettiva di una partecipazione al potere delle destre. Un mutamento in questo atteggiamento si ebbe solo nel 1930:
P. 423
Un atteggiamento che si può – a grandi linee – così riassumere: a) il nazionalsocialismo era il prodotto dell’errata politica delle grandi potenze vincitrici e della Francia soprattutto verso la Germania; b) esso si poneva nel denso dei nuovi tempi e del fascismo, ma sera troppo particolaristicamente tedesco, troppo dogmatico e poco politico; gli mancava, insomma, la carica universale del vero fascismo, quello italiano, che a questo derivava dalla capacità di sintesi e di equilibrio, tipica di un popolo la cui antichissima civiltà si rifaceva alla romanità; c) più che una vittoria nazionalsocialista in prima persona, era dunque auspicabile in Germania una vittoria del fronte delle destre nel suo complesso: tedesco-nazionali e Stahlhelm avrebbero infatti moderato Hitler, lo avrebbero indotto ad un maggiore realismo e, con la loro presenza, avrebbero dato vita ad una grande forza nazionale capace di darsi una politica e delle istituzioni veramente fasciste.
P. 426-27
Stanti queste buone disposizioni e questa situazione, già nel luglio G. Renzetti aveva preveduto la prossima costituzione di un fronte nazionale formato da tedesco-nazionali, nazional-socialisti e Stahlhelm e aveva consigliato di favorirlo e di puntare su di esso. Se a questi precedenti si aggiunge a) che lo Stahlhelm dava l’impressione di avere una organizzazione assai solida e vasti consensi nel paese; b)che per esplicite ammissioni dello stesso Hitler, non solo la polizia ma anche la Reichswehr erano in quel momento contrari al nazionalsocialismo; c) che la NSDAP era perpetuamente travagliata da crisi interne e defezioni, anche di esponenti di primo piano, e ciò faceva dubitare della sua solidità come partito e sembrava talvolta brancolare nel buio; d) che soprattutto, a Roma, nel partito come nelle sfere governative e diplomatiche, il nazionalsocialismo era visto con sospetto e con timore, come qualche cosa che poteva essere indubbiamente molto utile ma anche pericoloso e controproducente; non può destare meraviglia che subito dopo il 14 settembre Mussolini si facesse suggestionare da coloro – primo fra tutti il Renzetti – che concepirono l’idea di puntare, discretamente ma essenzialmente, sulla carta dello Stahlhelm, per cercare di farne il perno di una grande combinazione i destra, in grado di costituire un sicuro punto di riferimento per tutte le forze nazionali e di allargare quindi vieppiù il consenso popolare attorno a esse; un gruppo insomma che potesse porsi come effettiva alternativa di potere, ma che servisse anche a stemperare alcuni degli aspetti più eversivi e intransigenti del nazionalsocialismo, a renderlo più malleabile e “politico”; il tutto senza però inimicarsi Hitler, ma anzi atteggiandosi a suoi amici e consiglieri, in modo da tenerlo come carta di riserva, essere sempre al corrente delle sue intenzioni e influenzarne il più possibile la politica, sia direttamente sia attraverso i tedesco-nazionali e soprattutto lo Stahlhelm.
P. 431-32
A parte considerazioni più propriamente politiche che, per altro, riguardavano solo settori abbastanza limitati, l’andata al potere di Hitler, di cui erano ben noti i propositi revanchisti, aveva infatti risvegliato in molti ex combattenti della guerra ’15-’18 ricordi, timori, stati d’animo che non potevano essere sottovalutati; così come, a un altro livello, non poteva neppure essere trascurato il peso che nel giudizio sul nazionalsocialismo non potevano non avere le condanne che di questo movimento aveva pronunciato negli anni precedenti l’episcopato tedesco e della quali la stampa, specie quella cattolica, non aveva mancato di dare a suo tempo notizia. Né, infine, in un paese sostanzialmente estraneo all’antisemitismo come l’Italia si poteva evitare di tener conto dell’impressione suscitata dal fatto che all’andata al potere di Hitler fossero subito seguite in Germania gravi manifestazioni di intolleranza antisemita; specie dato il clamore che esse avevano suscitato in molti paesi europei e americani. La spiegazione di fondo dell’atteggiamento assunto dalla stampa italiana va però ricercata soprattutto ne carattere che Mussolini aveva subito impresso ai rapporti italo-tedeschi dopo il 30 gennaio.
P. 440
Per comprendere a fondo questo atteggiamento di Mussolini bisogna avere ben presente a stretta collaborazione che in questi mesi intercorse tra i rapporti italo-tedeschi, la questione austriaca e le trattative per il Patto a quattro. E’ opinione comune che il primo accenno all’idea di quello che sarebbe dovuto essere il patto a Quattro Mussolini l’abbia fatto nel discorso di Torino del 23 ottobre ’32. Su questo punto non ci pare possano essere dubbi di sorta. Nel discorso di Torino, infatti, non solo si trova il primo accenno alla opportunità che la pace europea fosse assicurata da una collaborazione tra le quattro grandi potenze (Francia, Inghilterra, Germania e Italia), ma sono anche enunciati alcuni degli argomenti per i quali Mussolini riteneva necessario l’accordo tra di esse. In questa occasione il duce, infatti, dopo aver negato che l’Italia avesse avuto alla conferenza per il disarmo un atteggiamento machiavellico e aver affermato che essa “segue una politica di pace, di vera pace, che non può essere dissociata dalla giustizia, di quella pace che deve ridare l’equilibrio all’Europa, di quella pace che deve scendere nel cuore, come una speranza e una fede e che sarebbe rimasta nella Società delle Nazioni, perché “oggi che essa è straordinariamente malata, non bisogna abbandonarne il capezzale”, aveva detto:
“Vi sono stati dei tentativi per disincagliare l’Europa da questa costruzione troppo universalistica. Ma io penso che, se domani, sulla base della giustizia, sulla base del riconoscimento dei nostri sacrosanti diritti, consacrati dal sangue di tante giovani generazioni italiane, si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali, l’Europa sarebbe tranquilla dal punto di vista politico e forse la crisi economica, che ci attanaglia, andrebbe verso la fine.
Vi è un’altra questione, quella che concerne la domanda tedesca di parità. Anche qui il fascismo ha avuto delle idee e delle direttive recise. La domanda tedesca della parità giuridica è pienamente giustificata. Bisogna riconoscerlo, quanto più presto, tanto meglio! Nello stesso tempo, sinché dura la conferenza del disarmo, la Germania non può chiedere di riarmarsi in nessuna misura, ma quando la conferenza del disarmo sarà finita e se avrà dato un risultato negativo, allora la Germania non potrà rimanere nella Società delle Nazioni se questo divario che l’ha diminuita sin qui non viene annullato.
Non vogliamo egemonie in Europa. Noi saremo contro l’affermazione di qualsiasi egemonia, specialmente se essa vuole cristallizzare una posizione di patente ingiustizia”.
P. 443-44
Il 7 giugno pomeriggio, prima di recarsi alla cerimonia della sigla, Mussolini tenne al Senato un discorso che aveva annunciato il girono prima. E’ un discorso che va esaminato da vicino, dato che offre alcuni elementi per comprendere le ragioni per le quali il duce considerava il patto un suo successo. In esso si possono distinguere grosso modo tre parti. La prima concerneva la genesi e la collocazione storico-politica del patto. Il patto veniva ricollegato strettamente con quello di Locarno e con gli impegni di collaborazione effettiva che da esso discendevano per le quattro grandi potenze. Questo collegamento serviva a Mussolini per ribadire come, a suo giudizio, “molte delle opposizioni suscitate dal Patto sono l’effetto di reazioni sentimentali, più che di un meditato esame della realtà”: il patto non stabiliva infatti gerarchie definitive e immutabili, non era diretto contro nessuno, non voleva imporre a chicchessia nulla, non voleva gettare le basi di nessun potenziale fronte unico contro nessuno; esso si muoveva nello spirito e nella lettera del patto della Società delle Nazioni e mirava “a ristabilire l’equilibrio fra tutti gli articoli del Covenant, come è indispensabile che si voglia se si deve fare opera costruttiva e duratura”. Il patto tendeva solo ad assicurare la collaborazione tra le grandi potenze e, quindi, la pace. Solo in questo clima, Mussolini lasciava intendere, si sarebbe potuto procedere a quella revisione pacifica dei trattati che lo stesso patto ginevrino prevedeva.
P.460-61
Per valutare appieno il significato non solo tattico ma strategico che il patto a quattro aveva per Mussolini e come esso si inseriva nel contesto generale della sua politica non ci si può limitare all’esame delle vicende che portarono alla sua stipulazione, né alla valutazione che il duce ne diede al Senato. Al contrario, bisogna estendere l’esame anche alle vicende diplomatiche dei mesi successivi, a quelle direttamente connesse al patto e cioè verificatesi entro la metà del novembre ’33, ma anche a quelle successive, relative a tutto il ’34. Da questo complesso di vicende si può infatti ricavare una serie di elementi che permette di farsi un’idea precisa delle linee di fondo lungo le quali Mussolini si mosse nei due anni successivi all’andata al potere di Hitler e rendersi conto di come in questo periodo la sua politica continuò sostanzialmente ad essere quella del peso determinante, anche se, ovviamente, adattata alla nuova situazione. In particolare, si può dire:
a) dopo la conclusione del patto a quattro, anche se fece di tutto per non darlo a vedere, Mussolini continuò ad allontanarsi sempre di più dalla Germania, sicché in realtà l’asserita equidistanza di Roma da Parigi e da Berlino fu solo un’apparenza che a livello diplomatico non ingannava nessuno, ma che al duce serviva per motivi di ordine sia interno sia internazionale: per continuare a recitare il ruolo, che si era dato proponendo il patto a quattro, di mediatore, ovvero – come ebbe a dire, con una evidente punta di sarcasmo, un diplomatico belga – di “Principe della Pace”; per distinguere anche in politica estera il fascismo dalla democrazia e dal nazionalsocialismo; per non impegnarsi con la Francia prima di aver ottenuto reali contropartite (e nella speranza di lucrare, intanto, qualche cosa anche dalla Germania) che, tenendo le cose in sospeso, doveva pensare di rendere anche più consistenti; e, infine, come era nel suo carattere, per non compromettersi irrimediabilmente anzi tempo e, quindi, per un verso precludersi la possibilità di un ripensamento (al limite, in quel momento forse anche giustificabile stante la riottosità dell’Inghilterra ad impegnarsi oltre un certo punto sul continente) e, per un altro verso, rinunciare a prospettare una propria politica, autonoma da qualsiasi altra;
b) in conseguenza id ciò, pur allontanandosi sempre di più dalla Germania, Mussolini cercò, fino e che gli fu possibile (luglio ’34), di non contrastarla apertamente e in particolare di evitare una formale crisi dei suoi rapporti personali con Hitler e, soprattutto, di differenziare pubblicamente la politica italiana da quella della Francia e dell’Inghilterra, in maniera da farla apparire il più possibile autonoma e darle, a seconda delle circostanze e dei problemi, un carattere elastico, super partes, di mediazione, pendolare; tipico è in questo senso l’accenno finale nel già citato dispaccio a Grandi del 31 maggio ’33 al Reno e al Danubio, ovvero alla opportunità di una politica più vicina a Berlino per questioni come quella del disarmo e più vicina a Parigi per questioni quella austriaca;
c) il fulcro, il polo di riferimento di questa politica si confermò via via essere la questione austriaca, che in questo periodo costituì per Mussolini il problema del problemi, quello in funzione del quale dovevano essere visti tutti gli altri, dato che questi avrebbero assunto un valore e una prospettiva diversi conformemente a come quello fosse stato risolto; la questione austriaca – a seconda della sua evoluzione – avrebbe potuto persino consigliare un riequilibrio dell’equidistanza o addirittura una inversione di tendenza e, quindi, un avvicinamento a Berlino, ovvero al limite opposto – se sistemata secondo le intenzioni di Mussolini – avrebbe dimostrato che la posizione speciale dell’Italia non era – come sosteneva Vansittart, “un bene deperibile”, che col tempo avrebbe perso dunque valore - ma un elemento decisivo della nuova situazione europea con il quale tutti avrebbero dovuto fare i conti e che, quindi, avrebbe permesso all’Italia di sistemare i suoi problemi in sospeso con la Francia non solo alle migliori condizioni ma, in pratica, senza rinunciare completamente per questo alla sua autonomia e, quindi, alla possibilità di far valere ancora, in futuro, il suo peso determinante;
d) in questa prospettiva, per Mussolini le trasformazioni subite prima del suo progetto e le difficoltà incontrate poi dal patto a quattro, sino alla sua mancata entrata in vigore in seguito al ritiro, il 19 ottobre ’33, della Germania dalla Società delle nazioni (che lo rese inapplicabile, dati i collegamenti che in esso erano stabiliti con il Covenant ginevrino), è evidente avessero una importanza assai relativa; a parte gli aspetti più propriamente propagandistici e di prestigio, ciò che per lui contava era che il patto avesse impedito il costituirsi di due blocchi contrapposti e offerto all’Italia di poter assumere e veder praticamente riconosciuta la sua posizione speciale; né è da escludere che la sua mancata entrata in vigore fosse da lui vista con favore, dato che gli permetteva per il momento di rinviare la conclusione dell’accordo bilaterale con Parigi, lasciandogli al tempo stesso la possibilità – se lo avesse stimato utile – di rilanciare l’idea del patto, sia con gli stessi partner sia solo a tre sia a cinque o più partecipanti a seconda dello scopo a cui avrebbe dovuto servire.
P. 464-67
Questo atteggiamento della stampa e della propaganda italiana suscitò in Germania vivaci reazioni a livello governativo sia di opinione pubblica. Ai fini di una giusta comprensione del modus operandi di Mussolini si deve però notare che se, dopo il putsch di Vienna, i rapporti diplomatici italo-tedeschi andarono perdendo – per usare un’espressione tratta da un’ampia relazione dell’ambasciatore Cerruti del 26 settembre sulla Situazione politica in Germania e suoi rapporti con l’estero – “la loro intimità” e assunsero un tono di freddezza, essi furono però mantenuti da parte italiana ben lontani dall’asprezza che contemporaneamente caratterizzava l’atteggiamento della stampa italiana. A parte quella austriaca sulla quale era intransigente, sulle altre questioni (tipica quella della Saar) Palazzo Chigi o mutò atteggiamento o lo mutò assai poco e mai portò le cose in modo da rischiare pur lontanamente una vera rottura. Ciò sarebbe stato infatti non solo imprudente ed inutile in quel particolare momenti, ma – ciò che più conta – avrebbe fatto perdere all’Italia quella sua posizione speciale sulla quale si fondava tutta la strategia mussoliniana. In quel momento essa doveva essere realizzata sul tavolo delle trattative con la Francia; in prospettiva, sui tempi più lunghi cioè, se voleva – come voleva – continuare a realizzarla ancora, Mussolini avrebbe dovuto inevitabilmente tornare in qualche modo ad una posizione di equidistanza tra Parigi e Berlino; da qui la necessità di non rompere con la Germania e di circoscrivere, sia pure in un quadro di durezza, il contrasto con Hitler essenzialmente alla questione austriaca, in modo che un accordo su di essa potesse in futuro aprire la strada ad un nuovo movimento pendolare della politica italiana alla fine del quale, a seconda delle circostanze, il pendolo avrebbe trovato il suo nuovo punto di sosta…..
505-06
Cap. 5. Mussolini e l’Europa
Per dare una spiegazione non unilaterale del nuovo modo con cui in questo periodo fu visto il fascismo nel mondo occidentale bisogna tenere presente tutta una serie di elementi, particolari e al tempo stesso interagenti tra loro. Schematizzando (una trattazione articolata esula dai limiti di questo lavoro e comporterebbe centinaia di pagine), è evidente che, a livello di opinione pubblica media (meno politicizzata), fattori significativi di questo mutamento furono:
- il tempo: a dieci e più anni dalla sua andata al potere, il fascismo era diventato un elemento abituale del panorama internazionale; fatti come il delitto Matteotti e la crisi di Corfù, che tanto avevano scosso la opinione pubblica, erano stati se non dimenticati certo sempre più ridotti ad episodi sui quali il tempo esercitava la sua usura, favorito, per un verso, dal non ripetersi di fatti tanto brutali e clamorosi e, per un altro verso, dal moltiplicarsi nel mondo di atti di violenza, individuali e collettivi, che provocavano un appiattimento, un pareggiamento delle singole responsabilità, una sorta di assuefazione ad essi; contemporaneamente il consolidarsi del regime e il suo durare nel tempo, determinavano una sorta di processo di legittimazione del regime stesso, da un altro lato inducevano a cercare di penetrarne le ragioni (significativo è in questo senso il moltiplicarsi alla fine degli anni Venti dei servizi giornalistici e dei libri sull’Italia fascista) e ad individuarle sempre più spesso in due direzioni: quella della immaturità democratica degli italiani, che li portava ad accettare il fascismo e ad esaltarsi per Mussolini, e quella dei benefici materiali realizzati dal regime con la sua “organizzazione sociale del paese;
- l’atteggiamento della classe dirigente democratica e delle grandi fonti di informazione: all’origine dell’atteggiamento via via più possibilista di molti ambienti democratici europei e americani verso l’Italia vi erano indubbiamente motivazioni assai diverse: per alcuni si trattava di una necessità oggettiva dettata da opportunità di ordine politico ed economico, le stesse che li inducevano ad abbandonare la politica dura messa in atto negli anni precedenti verso l’URSS, ad intrattenere relazioni commerciali e ad accordarsi con essa a seconda delle esigenze politiche e delle necessità economiche appunto, senza che ciò volesse dire rinunciare alla proprie relazioni ideologiche; per altri si trattava di una mera accettazione di una realtà che, non riguardando il proprio paese e la propria condizione di vita, veniva ritenuta non contraria ai propri interessi e quindi oggettivamente accettabile, mentre erano imprevedibili le conseguenze di un suo eventuale sovvertimento; per altri ancora si trattava di una effettiva simpatia per la capacità dimostrata dal fascismo nel liberare l’Italia dal pericolo comunista: altrettanto indubbiamente tutte queste motivazioni (e altre secondarie sulle quali non ci soffermiamo) a livello di opinione pubblica media venivano però recepite, amalgamate tra loro e quindi assumevano culturalmente un valore che – con linguaggio politico di oggi – si può definire di distensione e di coesistenza pacifica; né, sempre in questo ambito di suggestioni culturali, possono essere sottovalutati due sub fattori particolari che contribuivano aa completare lo amalgama: a) l’influenza che nei paesi e nelle comunità cattolici aveva avuto la Conciliazione, anche se va detto che l’atteggiamento delle gerarchie ecclesiastiche e soprattutto del clero verso il fascismo era assai spesso diverso e più articolato in quelli che non in Italia; b) la convinzione, largamente diffusa e in buona parte legata all’idea che il fascismo fosse un fenomeno tipicamente italiano, connesso alla mentalità e all’arretratezza civile degli italiani, che in sostanza si poteva credere a Mussolini quando diceva che il fascismo non era una merce d’esportazione;
. l’influenza diretta e indiretta della propaganda fascista: anche se in questo periodo l’organizzazione della propaganda fascista all’estero non era ancora giunta al suo massimo, è fuori dubbio che anche questo fu un fattore importante, soprattutto in due direzioni, quella delle comunità italiane all’estero (alcune delle quali e specialmente quella statunitense avevano un peso non trascurabile sulla vita dei rispettivi paesi) e quella di alcuni giornali di opinione (soprattutto inglesi e statunitensi) sui quali, attraverso i loro corrispondenti in Italia e le rappresentanze diplomatiche all’estero, il regime riusciva ad esercitare una certa influenza, che, essendo in genere né troppo esplicita né continuativa, finiva per risultare la più produttiva; se nella prima metà degli anni Trenta il quadro dell’Italia che prese a circolare all’estero fu caratterizzato sempre più da una messa in valore degli aspetti positivi del regime e da un tono, in genere, discreto nel trattare quelli negativi (e, per di più, quasi sempre con una sorta di ricorso più o meno esplicito al leit motiv dell’immaturità civile degli italiani) ciò fu dovuto anche a questo ménagement diretto ed indiretto della stampa internazionale;
. l’affermazione del nazionalsocialismo in Germania: la vittoria di Hitler, dopo il primissimo momento di incertezza, giocò a tutto vantaggio del fascismo, sia perché nel confronto tra i due regimi quello mussoliniano apparve subito più umano, liberale, pacifista, conservatore dello statu quo europeo di quello hitleriano (alla fine del ’33 la stampa ebraica degli USA fece un sondaggio di opinione per stabilire chi avesse sostenuto più efficacemente i diritti civili e politici degli ebrei: Mussolini fu fra i dodici prescelti), sia perché l’atteggiamento antitedesco assunto da Mussolini e specialmente la sua reazione al putsch di Vienna fecero convergere sull’Italia non poche simpatie e speranze che, certo, erano frutto di paura ma, altrettanto certamente, fecero passare in second’ordine molte prevenzioni verso il fascismo e contribuirono non poco ad accreditare la convinzione che esso fosse un elemento di ordine e non di disordine internazionale.
P.518-20
Che Roosevelt fosse un sincero democratico è fuori dubbio. Per lui a quest’epoca Mussolini e Stalin erano “fratelli di sangue”. Ciò non gli impediva però di considerare il duce un vero galantuomo, di tenersi in contatto con lui e di dirsi “molto interessato e profondamente impressionato da ciò che egli ha realizzato e dal suo comprovato onesto sforzo di rinnovare l’Italia e di cercare di impedire seri sconvolgimenti in Europa”.
P. 342
Citazione da Landsbury (capo dell’opposizione laburista a Londra):
“Io non riesco a vedere che due metodi e questi sono già stati indicati da Mussolini: lavori pubblici o sussidi. A mio avviso vi è una enorme quantità di opere che possono essere compiute nel campo dell’agricoltura e della bonifica, nelle strade, nelle comunicazioni e nelle miniere…. Se io fossi dittatore, io farei come Mussolini: sceglierei cioè gli uomini che sappiano tracciare dei piani di opere pubbliche effettivamente utili al paese e continuerei risolutamente sulla mia strada fino a portare una completa riorganizzazione nella vita nazionale”.
P. 543
L’aspetto francese della “cultura della crisi” è stato ampiamente studiato sia nelle sue manifestazioni particolari più significative sia nel suo complesso. Fondamentale è a quest’ultimo proposito la ricerca di J. L. Loubet Del Bayle sui “non conformisti” della prima metà degli anni Trenta. Da questi studi risulta chiaramente come questa cultura, rimettendo tutto in discussione, dall’assetto capitalistico della società, al sistema politico, ai valori che sino allora erano stati bene o male alla base della società occidentale, alla stessa organizzazione internazionale e alla posizione della Francia in Europa, giungesse a parlare di una “crisi totale di civiltà” e, volendo combattere le cause del “disordine stabilito” della società contemporanea e cioè “l’egoismo ottuso del mondo borghese e liberale”, “il materialismo economico e spirituale” e “l’importanza di una politica senza spirito e senza anima”, finisse per sostenere la necessità di una “terza via” tra capitalismo e comunismo e, in alcuni casi, tra destra e sinistra e, quindi, per trovarsi o per dare l’impressione di essere su una linea non dissimile da quella del fascismo. Pochi esempi possono spiegare meglio questa posizione. In campo internazionale la “cultura della crisi” era critica verso il trattato di Versailles, la Società delle Nazioni, l’internazionalismo e il pacifismo. In campo politico la sua critica e la sua sfiducia si appuntavano contro i partiti, sia contro il parlamentarismo, sia contro la democrazia liberale, accusati tutti di essere corrotti e falsati dal gioco del capitalismo.
P. 546
Pur presentando caratteristiche e sfumature diverse da paese a paese, l’atteggiamento della stampa d’informazione occidentale in questo periodo può essere schematicamente riassunto attorno a due tendenze: quella a dare poco rilievo alla sostanza antidemocratica e repressiva del fascismo e a privilegiare, invece, alcuni aspetti operativi, tecnici, innovatori della politica del regime, considerati positivi per l’Italia e, non di rado, prospettati in un modo che lasciava trapelare non solo interesse e consenso, ma anche una sorta di invidia per le possibilità di governare effettivamente il paese e di determinarne l’impegno morale e materiale nel senso voluto dal governo che il fascismo aveva e che mancavano invece ai governi democratici; e quella di attribuire assai spesso tutto ciò alla personalità di Mussolini, alla sua capacità di realizzare la sua politica con il consenso e la partecipazione della gran maggioranza, del popolo italiano, al suo dinamismo, al suo realismo, alla sua spregiudicatezza nel mettere in discussione ciò che non era più adeguato ai tempi, senza per altro aver paura di andare contro corrente quando si trattava ei preservare e rivitalizzare valori e istituti che considerava utili alla realizzazione dei suoi fini. Sebbene spesso strettamente confuse fra loro, queste due tendenze, a ben vedere, di rado si fondevano veramente. Questa constatazione è, a nostro avviso, la chiave per comprendere e valutare giustamente il vero significato della “fortuna” di Mussolini, quale appare dalla stampa del tempo, e, insieme, l’influenza che essa ebbe sull’opinione pubblica e le ragioni del suo crollo nella seconda metà degli anni Trenta.
P. 369-70
A parte l’influenza di questi fatti, già di per sé significativi per capire quel tipo di visione, non bisogna sottovalutare infatti quella di tutta una serie di altri fatti: 1) dopo il delitto Matteotti non si erano più verificati casi di violenza estrema che avessero avuto all’estero una eco lontanamente simile a quella suscitata dalla uccisione del leader riformista: ciò aveva favorito il diffondersi della convinzione che il delitto Matteotti fosse stato solo un episodio e che in ogni modo il regime di fosse ormai liberalizzato ed umanizzato; 2) in confronto ad altri paesi occidentali, il regime fascista dava l’impressione di fronteggiare bene la “grande crisi”; 3) mentre gli antifascisti avevano per anni parlato di una imminente caduta del regime, questo non solo appariva ben solido, ma forte di un vasto consenso popolare; 4) il sistema corporativo era ancora nella fase della sua elaborazione culturale ed istituzional-organizzativa: in una fase, dunque, nella quale non emergevano ancora in che misura minima i suoi difetti e la sua inefficienza, mentre il fervore delle discussioni che attorno ad esso si sviluppavano, il battage propagandistico del regime e la suggestione di certi apparenti affinità con altri tentativi che si venivano facendo nel mondo per fronteggiare la crisi e correggere il capitalismo potevano indurre a credere in esso.
P. 571
In questo senso il caso più tipico e al tempo stesso il caso limite fu costituito dalla stampa statunitense. Come ha scritto il Diggins:
“consapevolmente o no, i giornalisti americani “fecero” Mussolini mediante il controllo di quello strumento di ipnosi che è la pubblicità, ed essi “fecero” lui semplicemente perché lui faceva notizia”:
Il fenomeno non fu però solo statunitense, in misura minore fu comune anche alla stampa di altri paesi. E, d’altra parte, dato il peso delle grandi agenzie americane, i collegamenti tra le varie catene giornalistiche, il prestigio di alcuni giornalisti e inviati speciali che più si dedicarono al genere (sovente traendo successivamente dai loro servizi e dalle loro interviste dei libri, che spesso avevano l’ambizione di comparare e mettere a confronto i vari dittatori del tempo e che ebbero tutti grande successo) e la suggestione imitativa che il giornalismo statunitense suscitava nella stampa mondiale, molto di ciò che si stampava oltre oceano rimbalzava direttamente ed indirettamente anche in Europa. Se non si capisce questo fenomeno non solo è impossibile avere una idea realistica del carattere particolarissimo che nella prima metà degli anni Trenta ebbe – a livello di opinione pubblica di massa – la “fortuna” di Mussolini, ma non ci si può nemmeno rendere conto del perché essa subì, come si è detto e ripetuto, un crollo così drastico ed improvviso. Questo infatti fu si conseguenza della reazione morale e politica suscitata all’estero dalla guerra d’Etiopia e dalla successiva politica mussoliniana e, in quanto tale, ebbe una motivazione immediatamente e squisitamente etico-politica; ma non si valuta giustamente la sua imponenza se non ci si rende contro che – a livello di opinione pubblica di massa - essa dipese anche e soprattutto dal carattere particolarissimo che sino allora aveva avuto la “fortuna” di Mussolini. Un carattere particolarissimo che spiega, appunto, perché – appena la grande stampa capovolse il proprio atteggiamento – la “fortuna” si trasformò in “sfortuna” per gran parte dei suoi lettori. Il che è stato riassunto per la stampa statunitense dal DIggins quando ha scritto:
“Che la stampa, dopo la guerra d’Etiopia, potesse fare a pezzi l’immagine di Mussolini, indica che il prestigio del dittatore era in grandissima parte un prodotto della stampa americana”.
P. 575-76
A parte i sospetti (non ingiustificati del resto) che dietro l’iniziativa del CAUR si nascondesse una manovra di tipo egemonico degli italiani, le riunioni interfasciste del ’34-’35 misero infatti in luce gli ostacoli e le divisioni che rendevano impossibile un effettivo accordo fra i vari partiti e movimenti fascisti. In primo luogo l’assurdità della pretesa italiana di escludere dal campo fascista i nazionalsocialisti (e cioè l’unico altro governo che si proclamasse apertamente fascista), dato che questa esclusione poteva essere giustificata solo in base ad argomenti di opportunità e di interesse politico nazionale, che potevano trovare sensibili solo alcuni fascismi, mentre era insostenibile sotto ogni altro profilo; in secondo luogo (ma in realtà più che di una questione a sé si trattava di un aspetto particolare della precedente) la impossibilità di trovare un effettivo punto d’accordo sulla “questione ebraica”. Per Mussolini, a quest’epoca, il problema ebraico e più in genere quello della razza erano problemi non solo non sentiti, ma che, politicamente, egli vedeva in maniera antitetica a come li vedeva Hitler; sia perché si rendeva conto della impopolarità e degli odi che essi suscitavano contro la Germania, sia perché le teorie razziali naziste tendevano più o meno esplicitamente a sottolineare la superiorità della razza germanica rispetto a tutte le altre razze, quella italiana compresa, con le conseguenze morali e politiche che ciò comportava. In vari movimenti fascisti (in genere dell’Europa orientale) la componente antisemita era però assai forte e, quindi, la suggestione della posizione nazionalsocialista assai viva, anche se molto spesso chi era d’accordo con i nazionalsocialisti in materia di antisemitismo era però in disaccordo con essi in materia razziale, si mostrava assai geloso della propria integrità ed indipendenza nazionale e partecipe di una comune civiltà occidentale che nulla aveva a che fare con la Weltanschauung nazionalsocialista del primato della razza ariana e aveva, invece, molti punti in comune con la concezione fascista italiana, che, per altro, aveva il difetto – almeno per i più coerenti – di dividere il fronte fascista, laddove essi lo volevano rafforzato al massimo perché si rendevano conto (e col ’35-’36 se ne sarebbero sempre più resi conto) che non era affatto detto che l’affermazione del fascismo si sarebbe realizzata attraverso una pacifica conquista delle nuove generazioni ai suoi ideali e non comportasse invece uno scontro frontale – interno ed internazionale – con l’altro aspirante alla successione alla società democratico-capitalistica: il comunismo. Da qui l’impossibilità non solo di dar vita ad una internazionale fascista, ma anche di fare del “fascismo universale” la piattaforma ideologico-politica attorno a cui far gravitare i vari fascismi; diventato “merce d’esportazione” il fascismo non poteva sottrarsi alle “leggi del mercato” e, tra gli elementi del mercato, quello italiano non era certo, almeno potenzialmente, il più forte. Sicché per Mussolini l’”esportazione” del fascismo, se indubbiamente costituiva un motivo di prestigio e gli dava alcune carte utili al suo immediato giuoco politico, lo poneva però anche e soprattutto di fronte ad una prospettiva drammatica per il futuro: o farsi fascista tra i fascisti, accettando la logica e i rischi di una identificazione con i nazionalsocialisti (soluzione per lui perniciosa sul piano internazionale) o rinunciare nella sostanza ad identificare il fascismo con una delle grandi alternative storiche della civiltà contemporanea (soluzione per lui altrettanto perniciosa sul piano interno). In altre parole, il fallimento del “fascismo universale” lasciava intravvedere quella che prima o poi sarebbe stata l’alternativa per Mussolini: una scelta di campo fra fascismo e interessi nazionali, tra fascismo e civiltà occidentale, una scelta dunque che in ogni caso avrebbe significato in pratica la negazione del fascismo storico italiano, dato che avrebbe portato al suo travaso nel ben più vasto fascismo europeo, inevitabilmente egemonizzato dal nazionalsocialismo, o alla sua riduzione da fatto rivoluzionario e rinnovatore della civiltà occidentale a fatto riformistico della società italiana.
P. 595-96
Cap. 6. La guerra d’Etiopia.
Se questo accordo e questo rispetto dovevano essere la chiave di volta di tutta l’operazione, la sua ragion d’essere “politica” doveva risiedere nell’amicizia e nell’alleanza di Roma con Parigi e Londra contro Berlino, mentre la sua premessa “di diritto” doveva risiedere nell’accordo tripartito del 1906, con il quale Inghilterra, Italia e Francia avevano indicato e si erano impegnate a rispettare le rispettive zone di interessi in Etiopia. L’accordo tripartito del 1906 era per Guariglia “la magna charta dei nostri diritti e delle nostre aspirazioni”. Per quel che riguardava l’Inghilterra, il suo significato era stato confermato e ribadito nel dicembre ’25 con lo scambio di note tra Graham e Mussolini: con tali note i due governi si erano infatti impegnati ad aiutarsi vicendevolmente per ottenere da quello di Addis-Abeba la concessione a costruire uno sbarramento idraulico nel lago Tana, una strada automobilistica dalla frontiera sudanese allo sbarramento (per l’Inghilterra) e una ferrovia congiungente l’Eritrea e la Somalia attraverso l’Ovest etiopico (per l’Italia) e l’Inghilterra si era impegnata, una volta ottenuto ciò che le stava a cuore, a riconoscere il diritto italiano ad ottenere “l’esclusività dell’influenza economica nell’Ovest dell’Abissinia ed in tutto il territorio attraversato dalla ferrovia”. Per quel che riguardava la Francia, poi, il significato dall’accordo tripartito era stato confermato e ribadito ben più esplicitamente dagli accordi Laval-Mussolini del gennaio ’35. In questa prospettiva, per Guariglia l’operazione Etiopia non doveva solo servire a dare all’Italia il modo di espandersi in Africa, ma era necessaria per realizzare altri due obiettivi, squisitamente politici e non meno importanti:
“1) creare una più forte ragione di solidarietà con l’Inghilterra e con la Francia nella condotta politica tendente ad evitare futuri conflitti europei, oppure, se questi si fossero dimostrati inevitabili, nella nostra partecipazione alle lotte destinate a risolverli conformemente agli interessi europei e in particolare ai nostri interessi;
2) rafforzare anziché indebolire l’efficienza militare dell’Italia in Africa, cioè nel teatro di guerra che in caso di conflagrazione fatalmente si sarebbe aperto a fianco del teatro europeo”.
P. 599-600
Apparentemente chiarissimo e, a suo modo, esauriente, questo documento, in realtà, serve solo a provare a) che, decisa l’azione, Mussolini era convinto della necessità di tradurla in pratica e di concluderla nel più breve tempo possibile ed era pronto a questo scopo ad impiegare tutti i mezzi, senza risparmio alcuno. E che era convinto: b) che – sia pure per motivi diversi – nessuna delle grandi potenze si sarebbe concretamente opposta alla sua iniziativa; c) che la Società delle Nazioni non si sarebbe mossa o non avrebbe potuto fare nulla di veramente efficace per impedirla. E ancora: d) che, apparentemente, egli sembrava anche convinto che l’Etiopia si andava rafforzando in misura tale da rendere col passare del tempo difficile e pericolosa un’azione che in quel momento, invece, non presentava grandi difficoltà; sicché era sua convinzione e) che per risolvere il problema dell’espansione in Etiopia non vi fosse altro mezzo che un’azione militare, in grande stile, e portata a fondo, sino alla completa occupazione dell’impero etiopico.
P. 609
Citazione da G. W. Baer (La guerra italo-etiopica):
Quasi certamente l’avventura etiopica fu, almeno in parte, escogitata coma un’alternativa alla riforma sociale: era un mezzo per glorificare il duce e distogliere di conseguenza l’attenzione del pubblico dai problemi interni. Nel 1934 Mussolini si trovò di fronte a un crescente malcontento popolare, il quale esigeva uno sfogo prima che potesse diventare una minaccia alla dittatura. L’Italia fu gravemente colpita dalla crisi economica mondiale degli inizi degli anni Trenta. Apparve manifesto che, benché il fascismo avesse recato benefici ai proprietari, lo Stato fascista non era garante, rispetto a operai e contadini, della loro protezione. Alla pressione dei lavoratori disoccupati delle fabbriche e dei campi s’aggiungeva ora la tensione che la disoccupazione portava in seno alla classe media urbana: piccoli commercianti erano soffocati dalla maggiore concentrazione di capitale, possessori di titoli di stato subivano una riduzione nel tasso di interesse e appartenenti alle professioni liberali e laureati non potevano trovare impiego. Anziché fruire di benefici sotto il fascismo, la piccola borghesia italiana, come gli operai e i contadini, stava vivendo in condizioni di insicurezza crescente. Ciò, naturalmente, era fonte d’un possibile pericolo per Mussolini, il quale aveva sfruttato, dopo la guerra, analoghe tensioni nella sua conquista del potere politico. Ed eccoci giunti alla grande svolta nella storia del fascismo italiano: Mussolini mancò in quella circostanza di attuare per l’Italia un programma globale di riforma sociale ed economica, e quindi non gli restò nessun’altra scelta tranne che ribadire gli sterili slogan del fascismo: l’attivismo, il militarismo, il nazionalismo combattivo. Per evitare le conseguenze del suo fallimento nel risolvere i problemi di politica interna, Mussolini cercò di coinvolgere la nazione nella conquista dell’Etiopia”.
P. 611-12
Citazione da F. Chabod (L’Italia contemporanea, 1918-1948):
Per spiegare la guerra, i giornali affermano che essa è una necessità votale per l’Italia, dato l’eccesso di popolazione. Il problema esiste. Tuttavia non fu questo il principale motivo che indusse Mussolini ad iniziare la campagna d’Etiopia; e neppure la necessità di trovare un diversivo alla grave situazione economica interna. E’ probabile che questa preoccupazione non fosse del tutto assente, ma solo in via subordinata. Essenziale è invece nel pensiero di Mussolini il motivo politico, cioè la potenza della nazione, dell’Italia. Ciò che lo occupa ora è il nazionalismo. Sempre più volge lo sguardo verso l’esterno, la mente rivolta alla potenza, al prestigio dell’Italia, il che fa tutt’uno con la sua potenza e col suo prestigio personale. E’ la legge fatale delle dittature: il successo all’esterno destinato a compensare la perdita delle libertà all’interno.
P. 612-13
La ragione prima della decisione presa da Mussolini con le direttive del 30 dicembre ’34 (nel momento stesso cioè in cui fu sicuro che l’accordo con la Francia sarebbe stato concluso formalmente tra qualche giorno) va individuata nella convinzione del duce: a) che con l’accordo franco-italiano si stava finalmente realizzando in Europa quel rapporto delle forze (reali ma soprattutto politiche, che indubbiamente la Francia era militarmente più forte della Germania, ma non poteva per tutta una serie di motivi soggettivi ed oggettivi far valere la sua forza), che avrebbe reso il ruolo dell’Italia determinante, specialmente in funzione della sicurezza della Francia; b) che in quel momento, data la sproporzione delle forze reali esistenti in Europa, l’Italia poteva limitarsi ad esercitare il suo peso determinante in termini politici, senza cioè doversi impegnare a fondo anche in termini di presenza militare sul vecchio continente; c) che tale duplice realtà favorevole era però destinata a mutare via via che il riarmo tedesco (già iniziato) fosse diventato una realtà; d) che se l’Italia voleva espandersi in Etiopia quello era l’unico momento possibile, dato che la Germania non era sufficientemente forte per approfittare dell’impegno militare italiano in Africa, neppure per minacciare le posizioni dell’Italia in Austria ed in Ungheria, e la Francia e l’Inghilterra non potevano impedirlo, perché – specie la prima – erano convinte di non poter fare a meno dell’amicizia e dell’alleanza italiane contro la Germania; e) che – nonostante questa convinzione – sia la Francia sia l’Inghilterra non avrebbero mai spontaneamente accondisceso ad un sostanziale rafforzamento dell’Italia, sia perché oggettivamente contrario ai loro interessi, sia perché ciò avrebbe creato ai loro governi difficoltà molteplici e di vario genere, interne, internazionali e di principio; f) che, stando così le cose, per l’Italia non vi era altra via che quella di forzare la mano a Parigi e Londra, costringendole a subire una iniziativa unilaterale italiana, senza per altro ledere i loro interessi diretti in Etiopia e, anzi, garantendoli esplicitamente, così da coinvolgere il più possibile in tutta l’operazione e dimostrare loro al tempo stesso la volontà di Roma di farne un banco di prova della comune amicizia e della comune solidarietà.
P. 614-15
Se non si penetra questa atmosfera e non se ne individuano e comprendono le varie componenti e il loro interagire si rischia di non rendersi conto del clima che attorno alla vicenda etiopica si venne creando nel ’35 e, ciò che più importa, il significato che questo clima ebbe non solo nel determinare le grandi adunate e manifestazioni popolari che accompagnarono l’avvicinarsi del conflitto, l’entrata in guerra, le sanzioni, le prime vittorie militari ovvero il successo di grandi iniziative essenzialmente politico-propagandistiche del regime come la “giornata della fede” (18 dicembre) e la raccolta dell’oro e del ferro “per la patria”, ma ci si impedisce anche di valutare giustamente come e in che misura questa atmosfera agì a sua volta sia a livello politico del vertice del regime, sia a livello internazionale, sia sullo stesso Mussolini.
P. 627
Citazione da un rapporto del Ministero dell’interno:
“Da persona che è esponente di primo piano della massoneria giustiniana apprendiamo che “verso il 20 agosto u. s. in Roma, e mentre S. E. il Capo del Governo era sul teatro delle grandi manovre dell’esercito, si sarebbero riuniti alcuni senatori, inseriti nel fascismo, ma tendenzialmente avversari della politica del duce, per esaminare la situazione del nostro paese nei rapporti con l’estero e per compiere un passo verso S. M. il Re d’Italia allo scopo di precisare le proprie responsabilità nel caso che il Capo del Governo persistesse, in odio ad ogni tentativo di conciliazione offerto all’Italia, ad affrontare l’alea della guerra in Abissinia.
Sempre secondo il nostro informatore confidenziale, alla riunione avrebbero partecipato, oltre all’on. Federzoni, il senatore Casati, Caviglia, Badoglio ed altri, notoriamente fedeli alla monarchia, di cui non ci si è voluto dire i nomi. Gli adunati, esaminata minutamente la situazione interna in rapporto alle nostre possibilità economiche e finanziarie nonché alla propaganda comunista e antifascista che si è fatta più sensibile nel paese; considerato che “la politica di intransigenza di Mussolini porterebbe al completo isolamento dell’Italia e alla conseguente organizzazione di un potente blocco di stati antifascisti che renderebbe più difficile e più dura la nostra guerra; avrebbero deliberato di compiere un passo collettivo verso il Re per suggerirgli, nell’interesse dell’avvenire della nazione, di consigliare al duce una linea di condotta meno aspra e meno provocatrice verso la Gran Bretagna e l’istituto ginevrino, accontentandoci per ora di avere quello che ci potrebbe venire per via diplomatica e rimandando a miglior tempo il compimento del nostro programma di espansione coloniale”. Nella stessa riunione qualcuno avrebbe avanzata la proposta di far sapere al re che sarebbe consigliabile, visto che molti stati, nel trattare con il nostro paese fanno una pregiudiziale antifascista e chiedono addirittura la sostituzione dell’attuale regime mussoliniano, di togliere al duce il timone dello Stato per passarlo ad un uomo che goda delle simpatie straniere: Mussolini, tanto per non distruggerne il mito, diventerebbe Presidente del Consiglio senza portafoglio e tutti i dicasteri che egli tiene oggi nelle sue mani passerebbero ad uomini capaci e preparati ad assumere le sue responsabilità nel momento difficile che il duce attraversa.
A S. M. il re la commissione senatoriale porrebbe o avrebbe già imposta questa condizione, avente valore di dilemma: “O si accettano le nostre proposte, o noi da questo momento decliniamo le responsabilità, tutte le responsabilità, su quello che nell’interno del paese potrebbe accadere durante o dopo la guerra che Mussolini sta per scatenare”.
P. 631
Alla luce di questi elementi non ci pare di escludere che la spiegazione del comportamento di Badoglio possa essere trovata anche nel diverso se queste fossero state concordi, i margini di manovra del capo di Stato maggiore generale ( e di coloro che nelle gerarchie militari ne condividevano le preoccupazioni) sarebbero stati probabilmente maggiori e Badoglio avrebbe, forse, potuto esercitare la sua influenza anche su Vittorio Emanuele 3; essendo invece su pozioni diverse, è evidente che per Badoglio pochissimo, anche volendo, vi era da fare specialmente data l’evoluzione che nel frattempo, come si è visto, aveva subito l’opinione pubblica e dato che ormai anche le perplessità e i timori tra le gerarchie fasciste mostravano la tendenza a placarsi o, almeno per il momento, a rientrare. Sicché appare a suo modo naturale che, da quel politico tempista che era, Badoglio non abbia voluto correre personalmente rischi e abbia preferito invece giuocare le sue carte per poter essere, nonostante tutto, l’uomo che avrebbe raccolto sul campo di battaglia gli allori etiopici.
P.641
Citazione da Mussolini:
“Non è la medesima strada che ho previsto ma è ancora il medesimo viandante. La via si è cambiata, perché così fa la storia: l’individuo rimane lo stesso. Il materiale dell’uomo politico, l’uomo, è appunto una materia viva. Tutto il materiale è talmente flessibile che le conseguenze di un’azione non possono affatto essere sempre tali quali si previdero”
In questa convinzione, oltre che nella giustezza della sua intuizione di fondo, che, per altro, da sola non sarebbe stata sufficiente, è a nostro avviso la chiave per comprendere – la di là della mera abilità tattica, importante ma non decisiva – le ragioni del successo della politica mussoliniana in Etiopia, ovvero, se si preferisce, la sua superiorità rispetto a quella inglese, troppo incapace di uscire da una serie di schemi troppo rigidi e tra di loro contraddittori e troppo legata ad alcune previsioni che, a torto o a ragione, non si volevano o non ci si sentiva moralmente e politicamente in grado di riconoscere superate dalla realtà degli avvenimenti.
P. 643
E ciò tanto più che alle parole del duce corrispondevano alcune iniziative politiche e di propaganda fasciste (e di penetrazione economica, però, in genere sul momento passarono inosservate) che avevano per oggetto l’oriente mediterraneo e che non potevano non mettere in sospetto e preoccupare gli inglesi, che in questa regione avevano già tante difficoltà con gli arabi e con gli ebrei per non considerare una intromissione italiana in essa come una vera iattura. In questa sede basterà solo ricordare sia le avances che in questi anni Mussolini fece con Weizmann e con altri esponenti sionisti, offrendo loro il suo aiuto per la creazione di uno Stato ebraico nella parte meridionale della Palestina, sia l’azione di avvicinamento e di sostegno (anche non dissimulato: per esempio attraverso le emissioni in arabo di Radio bari, che molto allarmarono gli inglesi) dei movimenti nazionali arabi messa ina atto a vari livelli dal regime con risultati nel complesso non irrilevanti. Due linee di azione che solo in apparenza possono sembrare contraddittorie: a parte le difficoltà che questa politica poteva procurare agli inglesi (e durante la guerra d’Etiopia esse furono per quel che riguarda gli arabi notevoli, anche se non vanno sopravvalutate, perché Londra in parte le drammatizzò ad arte e in parte se ne spaventò troppo e finì per dar corpo ad una strategia mediterranea di Mussolini che non esisteva o, al massimo, era proiettata in un futuro assai remoto), essa ha, a ben vedere, una sua chiara logica: giungere alla creazione di uno Stato ebraico abbastanza piccolo da essere accettato dagli arabi, eliminando così con il conflitto arabo-ebraico ogni giustificazione per la permanenza dell’Inghilterra in quella regione e, quindi, ottenere, il triplice risultato di cattivarsi sia le simpatie ebraiche sia quelle arabe, di scalzare il mandato britannico e di assicurarsi (facendo anche leva sulla questione dei luoghi santi) una posizione di privilegio nel Vicino Oriente.
P. 655-56
Citazione da J. Barros:
La frase conclusiva originariamente affermava che “le tre potenze, l’obiettivo della cui politica è il mantenimento collettivo della pace nel contesto della Società delle Nazioni, si trovano completamente d’accordo nell’opporsi, con tutti i mezzi possibili, a qualsiasi ripudio unilaterale dei trattati che possa mettere in pericolo la pace ed agiranno in stretta e cordiale collaborazione a questo scopo”. Quando questa venne letta, Mussolini propose che la dichiarazione fosse modificata così: “che possa mettere in pericolo la pace dell’Europa”. La proposta del duce era chiara per tutti. Vi fu silenzio. MacDonald guardò Simon e così fece sir Robert Vansittart, il sottosegretario permanente al Foreign Office. Nel settore francese del tavolo la richiesta di Mussolini “provocò un sorriso saputo sulle labbra del sig. Laval”. Il primo ministro francese, Pierre-Etienne Flandin, rimase silenzioso. Non fu sollevata nessuna obiezione e la proposta del duce fu accettata.
P. 660-61
La seconda parte del calcolo di base al quale dovette essere deciso l’invio della Home Fleet nel Mediterraneo non comporta, dopo quanto abbiamo detto sull’atteggiamento inglese successivo al fallimento delle conversazioni tripartite di Parigi di metà agosto, che ci si dilunghi ad illustrarla. La sua logica è infatti evidente. Qualche parola merita piuttosto quello che si può definire il risvolto più propriamente italiano di questa seconda parte del calcolo inglese, ché, infatti, la presenza nel Mediterraneo di buona parte della flotta britannica se serviva ad accreditare agli occhi del mondo una certa idea dell’impegno inglese a sostegno della Società delle Nazioni, voleva esercitare anche sull’Italia una seconda forma di pressione, meno evidente, forse, della prima, ma per Londra certo più importante. Se nonostante tutto Mussolini avesse “tirato dritto”, al presenza della Home Fleet doveva servire (oltre che come deterrente per i nazionalisti arabi nel caso che avessero pensato di poter approfittare della situazione per scuotere il dominio inglese) a ricordargli che il Mediterraneo era e restava la maggiore e più importante linea di comunicazione imperiale dell’Inghilterra e che, se questa, volente o nolente, poteva chiudere un occhio sulle sue ambizioni etiopiche, mai gli avrebbe permesso però di alterare lo statu quo mediterraneo.
P. 681
Oltre che gli inglesi, queste pubbliche prese di posizione avevano come destinatari anche gli italiani e servivano al regime per completare il quadro che della situazione internazionale e dei rapporti italo-inglesi esso voleva accreditare all’interno, onde far apparire l’Italia il più possibile vittima della egoistica prepotenza dei popoli ricchi. In questo senso esse non possono essere viste disgiunte dalla sempre più violenta campagna anti-inglese che l’apparato propagandistico del regime portò avanti in questo stesso periodo e alla quale contribuì personalmente anche il duce con alcuni articoli anonimi sul Popolo d’Italia, che in più di un caso le dettero anzi il la. Di questa campagna esse furono certamente parte integrante, in quanto ne costituivano l’aspetto italiano, positivo e responsabile, in contrapposizione a quello inglese, negativo e irresponsabile, che veniva prospettato essenzialmente in base ad alcuni argomenti che servivano a loro volta da avvio per tutte le altre variazioni sul tema: l’Inghilterra non voleva un’espansione coloniale italiana, aveva essa stessa mite sull’Etiopia ed era dietro all’atteggiamento aggressivo del negus; l’Inghilterra maneggiava a suo piacere la Società delle Nazioni e si serviva del suo paravento per coprire per coprire un apolitica mirante esclusivamente a difendere i suoi interessi imperiali; l’imperialismo inglese agiva in stretto collegamento con l’antifascismo massonico internazionale che voleva umiliare e battere il fascismo e si serviva a questo scopo di tutti gli alleati (compreso il bolscevismo) e di tutte le armi, anche di quelle, come le sanzioni, che non erano mai usate in altre circostanze, più gravi (aggressione giapponese alla Cina nel ’31), o che avevano visto di fronte due paesi di uguale grado di civiltà (guerra del Chaco nel ’32), ma che non avevano riguardato un paese fascista. Nonostante la loro funzionalità rispetto al tipo di mobilitazione psicologica del paese che il regime voleva realizzare, sarebbe però sbagliato ritenere che queste prese di posizione “distensive” e “rassicuranti” fossero solo strumentali e propagandistiche. In realtà esse non furono che alcune manifestazioni di quella che abbiamo definito la prima linea di azione verso l’Inghilterra messa in atto da Mussolini e dalla diplomazia italiana un po’ a tutti i livelli e che aveva effettivamente l’obiettivo di sdrammatizzare il contrasto con Londra e di permettere una ripresa delle trattative per giungere ad una composizione del conflitto ocn L’Etiopia appena ciò fosse stato possibile e cioè appena – come Mussolini sin dal 19 agosto lasciò capire all’incaricato d’affari statunitense Kirk – le truppe italiane avessero riportato un primo tangibile successo su quelle etiopiche.
P. 684-85
Cap. 7. Il fondatore dell’Impero.
Da qui, in giugno, l’appello alla “riconciliazione del popolo italiano” con cui i comunisti si rivolsero direttamente alle masse fasciste:
“Noi tendiamo la mano ai fascisti, nostri fratelli di lavoro e di sofferenze, perché vogliamo combattere assieme ad essi la buona e santa battaglia del pane, del lavoro e della pace. Tutto quanto noi vogliamo, fascisti e non fascisti, possiamo ottenerlo unendoci e levando la nostra voce, che è la voce del popolo. Fascisti, ex-combattenti dell’Africa, conquistate al popolo il diritto di parlare in tutte le organizzazioni. Fate che ogni organizzazione, ogni circolo, ogni sindacato diventi il cuore pulsante della nazione riconciliata, contro i suoi nemici che l’affamano e l’opprimono, contro il pugno di parassiti che domina il nostro paese.
Noi comunisti vogliamo fare l’Italia forte, libera e felice. La nostra aspirazione è pure la vostra, o fascisti, cattolici, uomini italiani d’ogni opinione politica, d’ogni fede religiosa.
Uniamoci. Uniamoci in un solo cuore ed in una sola volontà.
Uniamoci ovunque ed in ogni ora. Parliamo un linguaggio solo: quello degli interessi del popolo e del paese. Lottiamo uniti, per il nostro pane, per il nostro lavoro, per la nostra pace, perché l’Italia sia strappata ai suoi nemici e restituita agli italiani, perché l’Italia sia salvata dalla catastrofe”.
P. 774
Dire che questi ceti erano stati in gran parte coinvolti psicologicamente nella guerra della propaganda fascista e avevano in qualche misura condiviso sia le motivazioni che questa aveva dato della guerra sia le speranze, i miti di un futuro benessere che l’Italia tutta avrebbe tratto dall’impero, è limitarsi ad un solo aspetto del problema, anche se certo il più appariscente. Ad essa se ne affiancava però un altro, reale quanto il primo, anche se meno appariscente, specie per chi giudicava la realtà italiana ormai quasi solo dall’esterno ed in base ad un metro di giudizio in parte astrattamente ideologico e in parte ormai inadeguato a capire una realtà molto diversa da quella per il quale esso era stato elaborato e – per di più – la giudicava sotto l’impressione traumatica di aver dovuto constatare che quei ceti si erano comportati di fronte alla guerra in modo contrario a tutte le sue convinzioni e previsioni. Un aspetto che per altro non sfuggiva all’occhiuta vigilanza – tutto realismo e pragmatismo - della polizia fascista e dei suoi informatori e di quella parte del PNF che viveva la vita dei lavoratori in fabbrica, nei sindacati, nei dopolavoro, nella realtà quotidiana. Tanto è vero che è d queste fonti che esso emerge più chiaramente e con notevole anticipo rispetto ad altre. Riassumendo e generalizzando al tempo stesso, questo secondo aspetto è così individuabile. A livello di massa, il coinvolgimento psicologico dei ceti popolari e soprattutto di quelli operai nella guerra d’Etiopia non equivaleva ad un pieno consenso politico verso il regime fascista: le riserve (come gli apprezzamenti) rimanevano e con esse le preoccupazioni e le insoddisfazioni connesse alle condizioni di vita e di lavoro, i timori per i sacrifici e i rischi che la politica estera mussoliniana poteva ancora provocare e le aspirazioni ad un diverso assetto politico. Diverso assetto politico che – parlando sempre in generale e schematizzando - per gli anziani rimaneva pressoché sempre quello da essi vagheggiato in gioventù, talché avevano sostanzialmente ragione quegli informatori dell’OVRA che in piena guerra d’Africa mettevano in rilievo che la grande maggioranza degli operai dei grandi magazzini industriali “quantunque apparentemente facente parte delle organizzazioni sindacali fasciste, e benché iscritta al Partito, è rimasta quella che era, cioè socialista e comunista per convinzione. Mentre per i giovani questo diverso assetto politico poteva essere lo stesso che per i padri (specie se si trattava di famiglie con una certa tradizione di milizia politica “sovversiva” o di non recente inurbamento) ma, più spesso, era invece concepito nel quadro, nella prospettiva fascista e sovente più propriamente mussoliniana, in cui per altro ciò che la caratterizzava era il porre in primo piano tutta una serie di suggestioni e di istanze, sociali, progressiste, più o meno esplicitamente anticapitalistiche, e di aspirazioni all’autogestione e alla democratizzazione della vita interna dei sindacati.
Se lo si vede in questa prospettiva, il problema dell’atteggiamento della masse popolari verso il regime all’indomani della guerra d’Etiopia appare assai più articolato, complesso e “aperto” di quello che può sembrare a prima vista e di come, sul momento, apparve a parte dell’emigrazione antifascista. E se lo si vede in questa prospettiva, si capisce come nel giro di pochi mesi – di fronte, prima alla vittoria del fronte popolare nelle elezioni francesi (che, confermando quella di pochi mesi prima del fronte popolare spagnolo, le diede una sorte di valore di tendenza) e poi, soprattutto, della guerra civile spagnola – i suoi termini cominciarono a subire alcuni mutamenti, non certo sconvolgenti, ma altrettanto certamente significativi, se non altro proprio perché essi dimostrano come la guerra d’Etiopia avesse inciso meno di quanto si fosse creduto e si potrebbe credere. E, in particolare, si capisce che esisteva ancora, sia pure latente o, se si preferisce, dormiente una serie di potenzialità antifasciste che in definitiva non attendevano altro che di essere rimesse in moto, ridestate, se appena vi fossero stati gli stimoli adatti e, ancor più, delle concrete prospettive per un’azione antifascista.
P. 776-77
Citazione da una nota del Ministero dell’interno:
“Se l’impresa etiopica non ebbe alcun effetto in favore dei partiti politici antifascisti, ma anzi si rafforzò lo spirito patriottico del popolo italiano e portò perfino ad un riesame di coscienza non pochi antifascisti, le vittorie dei “fronti popolari” nelle elezioni politiche francesi e spagnole prima e la guerra civile spagnola dopo hanno avuto una innegabile ripercussione in quella parte del popolo italiano che non ha aderito con pieno animo al regime”.
P. 778
In un momento in cui molti giovani fascisti – convinti di essere dei precursori che, in un periodo di transizione, tendevano a creare un ordine nuovo nel mondo dello spirito e nella concreta realtà politica, economica e sociale – erano pronti alla lotta purché questa ne valesse veramente la pena, cioè potesse condurre ad un rinnovamento del fascismo e della società italiana, ed erano convinti di essere pienamente in grado di realizzare da “veri” fascisti la propria disciplina nella propria libertà, ma - al tempo stesso – si ribellavano nel proprio intimo (un po’ consapevolmente un po’ esteticamente) ai formalismi, alla grettezza del fascismo e all’imperiosità, alla sicumera della sua propaganda, in questo momento così delicato, la decisione di Mussolini di bloccare ogni discussione e di ridurre tutto al “credere, obbedire e combattere” provocò nella maggioranza di questi giovani una crisi gravissima. Molti infatti furono colti da un senso di insoddisfazione, di delusione, di frustrazione che si tradusse, a seconda dei casi, o in un disinteresse per la politica attiva e in un allontanamento da essa, o in un conformismo passivo ed opportunista, in un “menefreghismo passivo per mezzo del quale si attua quella forma di assenteismo che deriva dall’evitare le responsabilità, dallo scaricare il lavoro sugli altri, dal rimettersi ciecamente e perciò quasi sempre intelligentemente agli ordini e alle disposizioni”.
P. 780
In particolare la valorizzazione dell’impero doveva puntare a sei obiettivi: 1) creazione delle condizioni generali per la vita civile e lo sviluppo economico (in primo luogo attraverso la costruzione di una adeguata rete stradale e la creazione di alcuni centri urbani pilota); 2) produzione locale del fabbisogno per la popolazione, indigena e da far immigrare dall’Italia; 3) immigrazione permanente (di popolamento) e temporanea su vasta scala dalla madrepatria; 4) sviluppo per l’esportazione della produzione locale; 5) individuazione e messa in valore delle materie prime locali; 6) interscambio commerciale con la madrepatria e, in un secondo tempo, sviluppo del commercio estero con l’AOI.
P. 784
Sebbene non molto diversa, forse più attendibile psicologicamente ci pare la spiegazione che lo stesso Mussolini diede nell’estate del ’43 al vicebrigadiere dei carabinieri Giuseppe Accetta a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, ove era stato internato dal governo Badoglio. All’Accetta, con cui talvolta conversava per passare il tempo e che gli aveva detto – riecheggiando quello che, come si è visto, era allora un luogo comune per tanti italiani – che, se dopo la conquista dell’impero, si fosse ritirato dal governo o avesse evitato un’altra guerra, “sarebbe rimasto nella storia uno dei grandi benefattori del popolo italiano”, egli replicò che “è insito in qualsiasi uomo l’amore della grandezza e il senso del progresso. Come spiegazione l’una e l’altra sono attendibili. Psicologicamente, dicevamo, la seconda ci pare metta però meglio a fuoco l’elemento dell’amore della grandezza che, a nostro avviso, dovette essere quello prevalente, anche se – come vedremo – non l’unico.
P. 798
Tutto quello che abbiamo detto a proposito del suo crescente amore della grandezza non basta però da solo a spiegare perché Mussolini non accettò le esortazioni della moglie a ritirarsi dalla vita politica. E soprattutto, accontentarsi di questa spiegazione impedisce di comprendere e valutare pienamente un avvenimento estremamente importante nella storia del regime fascista che seguì immediatamente la conclusione della guerra d’Etiopia: la nomina di Galeazzo Ciano e ministro degli esteri.
P. 802
Il vero significato del rimpasto era però un altro e consisteva nella nomina di Galeazzo Ciano agli Esteri, di cui il resto del movimento non era che la mascheratura. Con questa nomina in pratica Mussolini aveva scelto il suo successore e cominciato ad aprirgli la strada. Non avendo veramente stima e fiducia di nessuno e non potendo fare una scelta politica tra uomini di primo piano del regime, aveva deciso di allevarsi il successore, scegliendo un giovane, figlio di una delle pochissime persone di cui aveva fiducia (e che quindi poteva avere una influenza su di lui) e soprattutto marito di sua figlia, intelligente, ma senza una propria personalità marcata (così da poterselo plasmare come voleva) sostanzialmente estraneo ai grandi giri del regime e che in Etiopia, come ufficiale d’aviazione, aveva dato buone prove di coraggio (che per la mentalità fascista non era cosa trascurabile9 e, per aprirgli la strada ed affermarlo sia all’interno sia all’estero, gli aveva affidato il ministero a suo avviso più prestigioso ed importante, del quale in sostanza egli si sarebbe ad ogni buon conto continuato ad occupare personalmente dietro le spalle del genero in maniera da guidarlo con la sua “mano sicura” e facendo così del nuovo ministro une secutore fedele della sua politica.
Mussolini – lo si è detto – era un cattivo conoscitore dell’uomo-individuo e in particolare di quelli non della sua stessa generazione e formazione. Come pedagogo poi non aveva né capacità né esperienza e inoltre era portato a considerare l’individuo un po’ come considerava le masse, come un oggetto inerte da plasmare con le sue mani da “artista”. Con queste premesse, la scelta di Ciano si rivelò assolutamente sbagliata.
P. 804-05
Un atteggiamento, un tipo di rapporto che spiegano perché quando, ad un certo momento, la sudditanza psicologica verso il duce sarebbe venuta meno, anche la possibilità di una vera intesa tra i due uomini sarebbe definitivamente sfumata e al suo posto si sarebbe venuto a creare un reciproco, amaro disagio psicologico, che in Ciano si sarebbe via via trasformato in una sorta di irritazione profonda e in un criticismo insoddisfatto e frustrante e in Mussolini in un nuovo motivo di umana solitudine, in sfiducia in tutti, in autoconvincimento della propria insostituibilità ed eccezionalità.
A metà del 1936 tutto ciò ara ancora però lontano e imprevedibile, e Mussolini, nonostante tutto, poteva credere di aver trovato per il suo impero se non un secondo duce – ché una tale eventualità, impensabile già nel ’32, era oggi per lui un assordo – almeno un delfino, scelto es espresso da lui. La parola d’ordine, l’obiettivo degli anni duri, durare, sembrava essere diventata una realtà.
P. 807-08
FINE