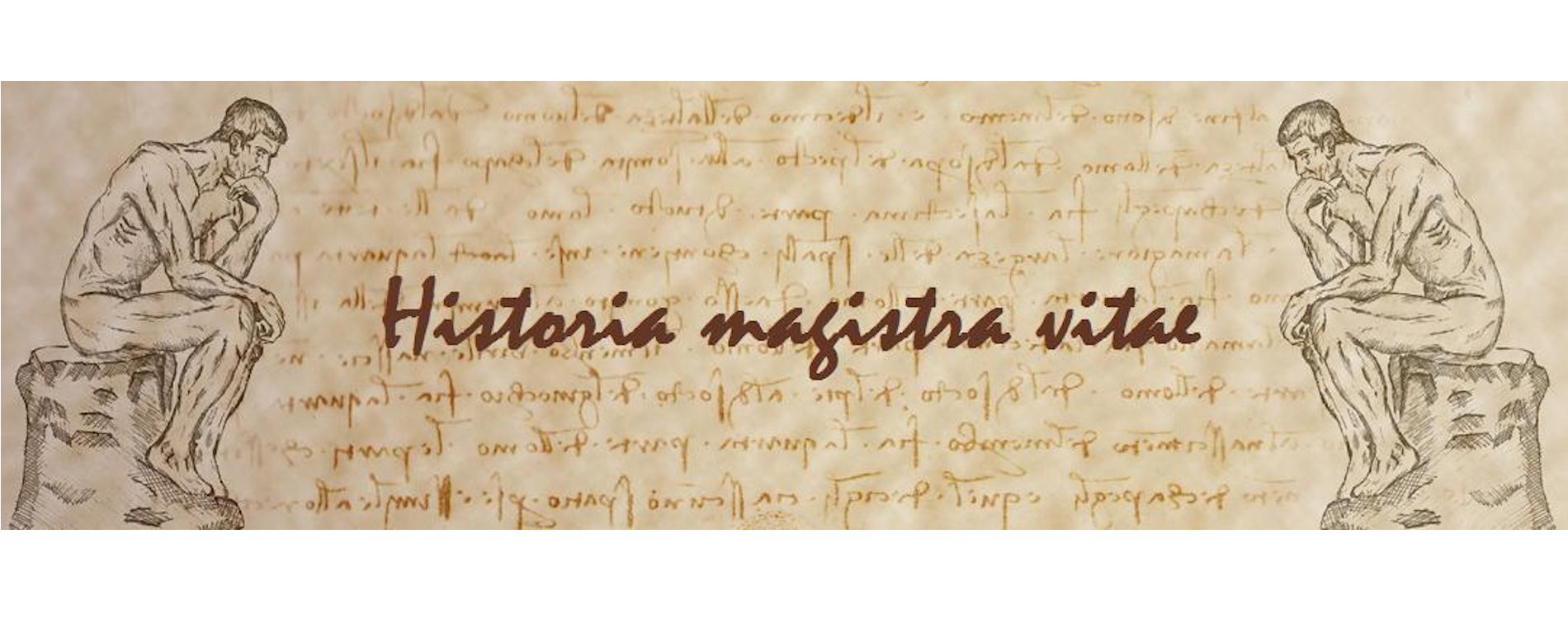Prefazione
Vorrei che questo libro risultasse accessibile e utile in particolare per coloro che, pur volendo imparare di più sui romani e il loro impero, possiedono delle conoscenze limitate sulla storia romana così come viene recepita oggi.
Avendo in mente questi lettori, ho fornito spiegazioni di termini tecnici e presentazioni di alcuni eprsonaggi storici più di quanto avvenga di norma in un testo dtrettamente accademico, e ho inoltre aggiunto una cronologia; allo stesso tempo, il libro contiene degli aspetti originali (descritti sommariamente nel cap. 1.) che potrebbero attirare l’attenzione di altri studiosi dell’Antichità.
“Così come viene recepita oggi”: con ciò intendo dire che ho tentato di tener conto delle ricerche più recenti e di quelle più datate, nella consapevolezza che, purtroppo, è impossibile per chiunque pretendere di aver letto e consultato tutto ciò che concerne un millennio di storia romana: nel volume vengono citati circa 130 autori dell’antichità (senza contare quelli dei materiali documentati) e ci sono fonti che non ho letto.
Inoltre, la moderna storiografia, nonché gli studi su letteratura e diritto dell’età romana e le indagini archeologiche sono uan vera e propria giungla: ho cercato di tenerne conto per quanto possibile.
Per amor di trasparenza ho inserito il più spesso possibile i riferimenti alle fonti primarie e ai numerosissimi e variegati materiali che uno studioso di storia romana ha a disposizione; nelle note ho fornito delle semplici indicazioni di base sui moderni studi sul potere romano, ponendo in rilievo il materiale più nuovo pur senza escludere opere meno recenti.
Ho deliberatamente evitato di stilare delle bibliografie complete su ciascuna controversia.
Inoltre, essendo stato pensato inizialmente per un pubblico anglofono, il volume privilegia – mio malgrado – le opere in inglese, pur sapendo che lo studioso dovrebbe consultare la produzione accademica in almeno cinque lingue moderne.
Il libro è breve se rapportato all’immensità della materia.
Ho però stabilito di escludere due aspetti, scelta per la quale il lettore ha quindi il diritto a delle spiegazioni: in primo luogo, non mi sono dilungato troppo su motivi, parzialità, interessi, metodi, presupposti o esperienza generale degli uomini (sono praticamente tutti uomini), i cui scritti rappresentano le nostre fonti testuali.
Una discussione completa avrebbe richiesto un volume separato di natura alquanto differenti, seppure i lettori noteranno senza dubbio un certo numero di valutazioni implicite.
Ho anche escluso quasi ogni trattazione dell’ambiente naturale in cui vivevano i romani e i popoli vicini, poiché questo tema costituisce infatti il mio prossimo progetto.
I lettori di questo volume noteranno qualche riferimento alle risorse minerarie e di legname, il cui accesso si rivelò in diverse occasioni fondamentale per il potere romano.
D’altro canto, il motivo per cui non si troveranno qui altre informazioni sull’ambiente è piuttosto semplice: tutt’oggi esistono ancora troppe incertezze sull’argomento.
Per fare due esempi: è già difficile determinare la deforestazione, per non parlare di quantificarla; di certo fu cospicua, ma è possibile che gli abitanti dell’impero abbiano gestito le proprie risorse boschive abbastanza abilmente da non provocare gravi danni ecologici e ambientali (ho discusso la questione in altra sede: Harris, 2011a).
E poi la questione – ad essa collegata – dei cambiamenti climatici: vi è un generale consenso sull’esistenza di un “periodo calmo romano”, ma quando avvenne esattamente e quale influenza poté avere sulle capacità di sopravvivenza dell’impero (per una panoramica, cfr. Hin, 2013; Manning, 2013)?
Per dirla breve, siamo ancora piuttosto lontani dal poter mettere in rapporto convincente la crescita, la sopravvivenza o il declino dell’Impero romano ai fattori ambientali.
E’ stato Walter Scheidel a convincermi in modo sistematico sul tema del potere invitandomi a scrivere un saggio per l’Oxford Handbook of Roman Studies e di ciò lo ringrazio.
Per scrivere questo libro sarebbe occorso ancora più tempo se non fosse stato per un generoso assegno di ricerca da parte della Andrew W. Mellon Foundation, di cui sono profondamente grato, in modo particolare alla funzionaria che si è spesa per questo, l’eminente sociologa Harriet Zuckerman.
Rivolgo la mia gratitudine anche a Emma Dench, Kyle Harper, Evan Jewell, Irene Sanpietro e Caroline Wazer per la loro lettura critica di vari capitoli; sono inoltre grandemente in debito con Emily Cook, una giovane ed emergente storica dell’arte che ha trascorso molte ore aiutandomi a comporre l’apparato bibliografico del volume.
Altri amici e conoscenti generosi hanno stimolato la riflessione e fornito informazioni pertinenti, in particolare Jairus Banaji, Mary Beard, Anne Hunnell Chen, Holger Klein, Myles Lavan, David Leith, Jonathan Prag, e lo stesso Walter Scheidel.
Ringrazio anche una delle mie ex studentesse più dotate, SARA Phang, per aver fornito la bozza della carta diventata la figura 25.
I commenti dei referees anonimi della Cambridge University Press si sono rivelati estremamente costruttivi, e ringrazio il colto ed energico Michael Sharp per averli coinvolti.
Pag. 11-13
Cronologia
393 a. C. ca. Roma conquista e distrugge l’etrusca Veio
390 ca. Roma occupata per qualche tempo dai galli senoni
390-380 Culmine della carriera politica di Marco Furio Camillo
367 Leggi licinie-sestie
356 Primo dittatore plebeo
351 Primo censore plebeo
340-338 Roma in guerra con i latini
338 Fondazione della prima colonia cittadina, ad Antium
334 Fondazione della prima colonia latina, a Cales
327 Inizio delle guerre di Roma fuori del Lazio
321 Battaglia delle Forche Caudine
313 Abolizione della schiavitù per debiti (nexum)
312 Tracciato della via Appia
311 Raddoppio del numero delle legioni
305 ca. Amicizia con Rodi
295 Battaglia del Sentino
287 ca. Secessione della plebe; Lex Hortensia
273 Fondazione delle colonie latine di Cosa e Paestum
272 Taranto soccombe a Roma
264-241 Prima guerra punica
241 Battaglia delle Egadi
218-202 Seconda guerra punica
218-206 Scipioni in Spagna
215 Battaglia di Canne
215-206 Prima guerra macedonica
202 Battaglia di Zama
200-197 Seconda guerra macedonica
190 Battaglie di Mionesso e Magnesia
188 Pace di Apamea con Antioco 3.
186 Soppressione del culto di Bacco
173 Primo anno in cui entrambi i consoli sono plebei
169 Lex Voconia
168 Battaglia di Pidna
167 Schiavitù di massa nell’Epiro
160-130 Polibio scrive la storia dell’espansione romana
146 Distruzione di Cartagine e Corinto
143-171 Epoca di grandi ribellioni schiavili in Italia e in Sicilia
139-130 Leggi elettorali
133 Tribunato di Tiberio Gracco
133-129 Roma governa direttamente
123-121 Tribunati di Gaio Gracco
107 Mario apre l’arruolamento nelle legioni a tutti i cittadini
91-89 Guerra sociale o marsica
90 La Lex Iulia concede la cittadinanza a molti abitanti della penisola
82-80 Dittatura di Silla
73-71 Rivolta di Spartaco
67-62 Guerre orientali di Pompeo
59-58 Culmine del potere popolare a Roma
58-5 Cesare conquista la Gallia
48 Battaglia di Farsalo
44 Cesare “dittatore perpetuo”; suo assassinio
42 Battaglia di Filippi
31 Battaglia di Azio
30 Roma occupa l’Egitto
27 Ottaviano diventa “Augusto”
20 Accordo con la Partia
19 Morte di Virgilio
12 a. C. Primi tentativi di Roma di conquistare territori a est del Reno
14-37 d. C. Regno di Tiberio
16 Tiberio ferma la guerra in Germania
27-37 Tiberio governa da Capri
41-54 Regno di Claudio
43 Invasione della Britannia
54-68 Regno di Nerone
67 Nerone ordina il suicidio del suo miglior generale, Domizio Corbulone
69 Anno dei quattro imperatori
69-79 Regno di Vespasiano
79 Il Vesuvio distrugge Pompei ed Ercolano
81-96 Regno di Domiziano
92 Primo console proveniente dal mondo greco
98-117 Regno di Traiano
101-2, 105-6 Conquista della Dacia
110 Tacito inizia a scrivere gli Annales
115-17 L’Impero romano raggiunge la sua massima estensione
117-38 Ragno di Adriano
131-5 Rivolta di Bar Kolcheba in Giudea
138-61 Regno di Antonino Pio
161-80 Regno di Marco Aurelio
166-75, 178-80 Guerre germani che di Marco Aurelio
167 Inizio della peste antonina
175 Rivolta di Avidio Cassio
180-92 Regno di Commodo
193-211 Regno di Settimio Severo
211-17 Regno di Caracalla
212 Caracalla estende la cittadinanza a quasi tutti gli abitanti liberi dell’Impero romano
217 Regno di Macrino
218-22 Regno di Eliogabalo
222-35 Regno di Alessandro Severo
226-42 Ardashir governa la Persia
244-49 Regno di Filippo l’Arabo
248 Mille anni dalla fondazione di Roma
249-51 Regno di Decio
251 I goti sconfiggono i romani ad Abrittus
253-68 Regno di Gallieno
260 La religione cristiana viene tollerata
270-5 Regno di Aureliano
293-305 Tetrarchia
301 Editto sui prezzi massimi di Diocleziano
312 Battaglia di Saxa Rubra, Costantino al potere a Roma
312-37 Regno di Costantino
324 Costantino riunisce l’Impero, fondazione di Costantinopoli
337-63 Regno della dinastia costantiniana
378 Battaglia di Adrianopoli
378-95 Regno di Teodosio 1.
385 Prime esecuzioni di “eretici”.
391 Chiusura dei templi, divieto di sacrifici animali
394 Battaglia di Frigido
395-408 Regno di Arcadio
395-423 Regno di Onorio
401 Alarico invade l’Italia
406 Radagaiso invade l’Italia
410 Alarico e i visigoti saccheggiano Roma
421-50 Galla Placidia “Augusta”
438 Codex Theodosianus
439 I vandali conquistano Cartagine
451 Concilio di Calcedonia
455 Genserico e i vandali saccheggiano Roma
474-91 Zenone imperatore d’Oriente
476 Romolo “Augustolo” viene deposto
527-65 Regno di Giustiniano
533, 542-49 Riconquista romana dell’Africa settentrionale
535-53 Riconquista romana dell’Italia
541 Inizio della peste di Giustiniano
559 Gli unni kutriguri raggiungono Costantinopoli
565-78 Regno di Giustino 2.
568 I longobardi invadono l’Italia
582-602 Regno di Maurizio
584 Gli avari alle porte di Costantinopoli
590-604 Papa Gregorio governa Roma
602-10 Regno di Foca
610-41 Regno di Eraclio
614 I persiani conquistano Gerusalemme
621 La maggior parte del Medio Oriente romano nelle mani dei persiani
627 Eraclio invade la Persia
632 Morte del profeta Maometto
636 Battaglia dello Yarmuk
638 Battaglia di Qadisiyya
639-41 I musulmani conquistano l’Egitto
641-68 Regno di Costante 2.
654 I musulmani attaccano Costantinopoli
656-61 Guerra civile fra i musulmani
698 I musulmani conquistano Cartagine
Cap. 1. L’evoluzione di lungo periodo del potere di Roma
Le domande alle quali questo libro cerca di dare uan risposta sono le seguenti: innanzitutto perché il potere di Roma si diffuse in modo così ampio, durando tanto a lungo?
Fattori esogeni come la relativa debolezza di molti popoli confinanti ebbero una grande rilevanza, ma nessuno può mettere in dubbio l’importanza fondamentale di quelli endogeni: alcuni di questi furono di natura geografica, demografica o economica, ma anche i rapporti di potere all’interno del mondo romano ebbero un grande impatto; dunque, in che modo è possibile caratterizzare tali rapporti?
Quanto potere – politico, legale, economico, psicologico o di altro genere – esercitavano alcuni individui del mondo romano sugli altri?
Inoltre, porrò la domanda implicita se sia effettivamente utile per gli storici farsi tentare dalla strada dell’analisi, distinguendo cioè il potere politico da quello giuridico, economico e così via, pur sapendo che nelle società premoderne la maggior parte del potere – di qualunque genere fosse – era concentrata nelle mani di un élite e dei suoi collaboratori.
Che cosa finì per andare storto (dal punto di vista dei romani, ovviamente)?
Ancora all’epoca delle riconquiste di Giustiniano (527-65) l’Impero romano si estendeva da un estremo all’altro del Mediterraneo e cessò di essere una potenza imperiale solo sotto Eraclio (610-41): per quale motivo non riuscì a mantenere la sua posizione, e quali furono le strutture interne di potere che ne accompagnarono il declino?
Qualunque analisi del poter nel mondo romano degna di questo nome, per quanto succinta, deve svilupparsi su tre dimensioni diverse.
Deve cogliere innanzitutto la dimensione nazionale del potere, il predominio del gruppo – in graduale espansione – di coloro che si definivano romani sul resto degli abitanti dell’Impero (nonché quale fosse questo potere ai confini nazionali e oltre).
Deve poi comprendere la dimensione della differenziazione sociale o delle classi sociali, senza sottovalutare l’importanza delle istituzioni e delle strutture politiche, o della schiavitù, o del potere di genere, o del potere all’interno della famiglia.
Infine, deve tenere pienamente conto del tempo, delle continuità che si incontrano nel corso del migliaio di anni della storia romana, diciamo da Camillo (il leggendario condottiero degli anni Novanta e Ottanta del quarto secolo a. C.) fino ad Eraclio.
Pag. 24-25
Ma effettivamente una fine vi fu: dopo la battaglia di Yarmuk (636), quando gli arabi musulmani sottrassero all’imperatore bizantino le vitali province siriache, inizia ad avere molto più senso considerare Bisanzio non come un impero nel senso proprio del termine, ma come uno dei tanti Stati dell’Eurasia occidentale e del Mediterraneo.
Antiochia cadde in mano musulmana nel 637 (lo stesso anno di Gerusalemme) e nel volgere del tempo il califfato omayyade divenne più grande di quanto non fosse mai stato l’Impero romano.
Che nel 636 pochi sudditi dell’impero parlassero ancora il latino è una questione di secondaria importanza: i bizantini dei secoli sesto e settimo ritenevano di essere romani e chiamavano il proprio territorio Romania (di qui che Giovanni Lido trovasse naturale iniziare con Romolo il proprio Sulle magistrature di Roma, repubblica di un popolo che riconosceva come proprio, malgrado fosse nato in Asia Minore), e la loro storia ininterrotta giustificava questa convinzione.
Dopo i disastrosi eventi del 636-42 tuttavia la questione è se Bisanzio fosse ancora sufficientemente potente da poter essere definita un impero; di fatto, non avrebbe rispettato di nuovo i criteri imperiali per altri trecento anni, non fino agli inizi dell’undicesimo secolo e agli ultimi anni di regno di Basilio 2.
Il periodo compreso fra il 636 e gli insuccessi di Costante 2. (641-68) deve dunque essere considerato come l’effettiva fine dell’Impero romano.
Pag. 25-27
Che cosa pensarono gli stessi romani, nelle varie fasi della loro storia, riguardo il funzionamento del potere?
Lo si vedrà nel seguito, ma è bene porre subito due questioni.
1. La riflessione romana sul potere fu di tipo straordinariamente legalistico?
La risposta naturale sembrerebbe affermativa: la repubblica espresse molti dei principali cambiamenti storici nel corso della propria evoluzione sotto forma di leggi, e nella sua vita pubblica esisteva una forte corrente di pedanteria giuridica; la presenza di giureconsulti tecnicamente abili e politicamente influenti fu una costante a partire dal primo secolo a. C.
Potrebbe darsi tuttavia che la grande attenzione data alla delimitazione della potestas (il potere stabilito legalmente e costituzionalmente) e dell’imperium (il diritto di alcuni alti funzionari a vedere eseguiti i propri ordini) non fosse semplicemente il risultato di uan speciale mentalità giuridica, ma della particolare natura dello stesso sistema sociopolitico romano.
Sotto la Repubblica tale sistema era ri tipo aristocratico – entrare a far parte dei circoli più ristretti del potere era in effetti assai difficile – e persino sotto il Principato era socialmente esclusivo; ma allo stesso tempo i normali cittadini possedevano dei diritti specifici, custoditi gelosamente per secoli.
Lo status legale era spesso questione della massima importanza, e ciò continuò a valere nel periodo tardoimperiale: delle definizioni precise erano dunque necessarie.
2. Una parte considerevole di ciò che i romani dissero e scrissero sul potere consistette nella costruzione dei miti, e dovremmo quindi identificare quali fossero quelli predominanti.
Il primo – quello di Roma come una democrazia di cittadini – è illustrato da un brano del De Legibus di Cicerone, in cui l’autore parlando del rapporto fra cittadini e magistrati scrive che “è necessario pertanto che chi obbedisce abbia la speranza di poter un giorno comandare (imperaturim)”, un’assoluta chimera per molti romani.
Due secoli più tardi, Elio Aristide (A Roma 90, cfr. anche 60) poteva solennemente – forse non senza un pizzico di privata ironia – spiegare ai romani che il loro sistema politico, sotto la guida di un singolo individuo, era “un’unica democrazia universale”; tracce di questo concetto si ritrovano anche in un periodo più tardo, come si vedrà in seguito (le idee moderne, per inciso, possono essere ugualmente paradossali: il governo di Traiano – assicura uno storico dei nostri giorni – “non era una monarchia”).
Un altro mito romano sosteneva che l’Urbe governava il mondo intero: questa idea venne inizialmente articolata dai romani nel secondo secolo a. C. ed entro gli anni Settanta del primo secolo a. C. era ormai pienamente accettata, come dimostrano ad esempio le monete rappresentanti il globo terrestre.
Il concetto compare di frequente in Cicerone e riecheggia ancora nel quinto secolo (Paolo Orosio, Historiarum adversus paganos, 6, 20, 2).
Per tutto questo tempo l’élite romana, per non parlare dell’esercito, era a un qualche livello perfettamente consapevole di non governare affatto sul mondo intero (anche se esistono prove di una tendenza a sottovalutare l’estensione dei territori che rimanevano al di fuori del dominio romano).
Presumibilmente questi miti – fantasie o illusioni, se si preferisce – avevano una natura funzionale, e possono anzi fornire indicazioni importanti: l’immaginaria democrazia di Roma rifletteva uan qualche duratura fede nei diritti dei cittadini; per quanto riguarda il concetto di potenza globale, occorrerà chiedersi in quale momento l’incrollabile fiducia in sé stessi si sia trasformata in arrogante autosuggestione.
Pag. 31-32
I lettori possono ben chiedersi quale teoria del potere – se una c’è – sia più consona al contenuto di questo libro.
Il mio approccio per quel che riguarda la teoria è selettivo e assai critico: il questo studio cerco semplicemente di scoprire fino a che punto il carattere dei sempre mutevoli rapporti esterni dello Stato romano fosse determinato da quello delle ugualmente cangianti strutture di potere interne, e viceversa.
Questa è la maniera in cui voglio affrontare le dinamiche del potere imperiale e della sua successiva fine, e costituisce il mio principale obiettivo.
Pag. 32-33
Questo per certi versi è vero, e anzi il secondo fattore è uno dei luoghi comuni della storiografia e ne riperlerà in seguito: la “coesione interna” di Roma è invece assai più problematica.
Gli Stati che vincono ripetutamente delle guerre tendono di fatto a dimostrare tale qualità, e viceversa è sertamente possibile affermare che il minor grado di coesione del tardo impero romano fu un fattore importante del suo declino, e che il compito principale dello storico che voglia studiare questo fenomeno è di analizzare per quali ragioni tale coesione si fosse indebolita.
Si tratta tuttavia solo di una condizione necessaria, mentre per la costruzione di un impero serve molto di più: in particolare, una volontà aggressiva di combattere una guerra, un élite politica in grado di pianificare le operazioni belliche e di mobilitare lo Stato a tal fine, nonché la capacità di approntare le tecniche di organizzazione necessarie per mantenere e sfruttare quanto conquistato.
Infine, popoli, collettività e Stati esercitano il potere, così come le astrazioni e i miti; altrettanto fanno le immagini, come va di moda sottolineare da una generazione a questa parte.
Questo tipo di indagine ha sollevato domande fondamentali sulla capacità di chi detiene il potere di controllare e influenzare popolazioni diverse tramite programmi di costruzione architettonica, statue e monumenti pubblici, tipologie di monete e – traccia più evanescente – spettacoli; fonti materiali di questo genere sono già state citate varie volte nel costo di questa breve introduzione.
Ma rimane ancora molto lavoro da fare sugli aspetti sociologici e psicologici – nonché prettamente archeologici – della questione: per dirla in breve, conosciamo la forma data al tempio di Iside o Osiride a Dendur nell’Alto Egitto dai collaboratori di Augusto, che fecero rappresentare il loro princeps come un faraone (e possiamo rinfrescarci la memoria visitando il Metropolitan Museum), ma in che modo gli abitanti della provincia reagirono a tale raffigurazione rimane quanto meno incerto.
Di recente, gli storici dell’arte hanno iniziato a prestare una maggiore attenzione a questo genere di tematiche, trascurando tuttavia un elemento chiave qual è il pubblico delle élite.
L’arco di Costantino, per fare un esempio, destò senza dubbio un generalizzato stupore in molti degli osservatori, ma pochi che ne compresero il programma iconografico erano spesso personaggi influenti.
Pag. 34-35
Cap. 2. Roma contro gli altri, 400 a. C.-16 d. C.
Possiamo iniziare con un periodo di oltre quattro secoli che si estende fino ai primi anni del regno di Tiberio, nello specifico al 16 d. C., giacché uno dei più straordinari aspetti dell’espansione romana in quanto processo più o meno continuo è la sua durata: dal tardo quarto secolo a. C. (che non ne segnò tuttavia l’inizio in assoluto) fino a quando il successore di Augusto non stabilì di interromperla; fu questa uan svolta importante, anche se finì col rappresentare un rallentamento e non certo la fine dell’espansione imperiale.
Verso il 400 a. C. i romani controllavano una parte del territorio circostante la città, ma né l’intero Lazio né la foce del Tevere; non possedevano una flotta, avevano pochi o punti contatti di tipo politico con popoli al di là dei loro vicini immediati ed erano alle prese con un conflitto (vinto poi nel 393 a. C.) con l’etrusca Veio (Veii), distante appena una ventina di chilometri.
Nei primi anni Ottanta del quarto secolo a. C. i galli senoni valicarono gli Appennini saccheggiando e occupando per breve tempo la stessa Roma; quattrocento anni dopo, risultato di un’espansione quasi ininterrotta, i romani controllavano – e tassavano – tutti i territori dal canale della Manica fino all’Eufrate e all’Egitto meridionale, ed erano impegnati nella conquista dei germani.
Come ebbe origine questa incredibile espansione?
Pag. 37
Si trattava già di un grado di espansione considerevole, ma ciò che seguì – due generazioni di guerre (dal 327 al 272 a. C.) che portarono al controllo dell’intera penisola fino alle sponde dell’Arno – fu ancora più notevole.
La prima guerra punica (264-241 a. C.) consegnò a Roma la Sicilia, la Sardegna e la Corsica; la Seconda (218-202 a. C.) la rese la potenza dominante del Mediterraneo occidentale; nel 190 a. C. la vittoria sui Seleucidi (che avevano il proprio centro in Siria) le fruttò il controllo navale sul resto del Mediterraneo e nel 168 a. C. la sconfitta del re macedone a Pidna (Pydna) instaurò stabilmente il dominio di Roma sull’intera regione.
A ragione si poteva affermare – come fece Polibio – che i romani governavano l’intero mondo mediterraneo; sebbene per quell’epoca avessero iniziato a occupare alcuni territori lontani dal litorale (nel Nord della penisola iberica, dal 179 a. C.), il loro era per la maggior parte un impero mediterraneo, consolidatosi progressivamente fino al 30 a. C.
Fu Giulio Cesare, negli anni Cinquanta del primo secolo a. C., a spingersi per primo, e con decisione, verso nord, guidando i romani fino alle rive del Reno; Augusto raggiunse poi quelle del Danubio.
Pag. 39
Il sistema alimentò anche l’opportunistica belligeranza del Senato romano (composto in pratica da coloro che avevano detenuto delle cariche pubbliche, da questore in su, e a nomina vitalizia); fatta eccezione per alcuen rarissime occasioni, per tutta l’età medio repubblicana Roma combatté uan guerra all’anno, il che la rese un caso estremo di entusiasmo guerresco.
Tra il 327 e il 241 a. C. vi furono al massimo quattro anni di pace, spesso conseguenza di un’aspra lotta intestina in corso dell’Urbe; di norma, ogni anno la classe dirigente, sicura di sé (su questo non c’è dubbio) e pressoché sprezzante del pericolo al livello personale, era in gradi di mobilitare un numero sufficiente di soldati (cittadini e alleati italici) nonché tutte le altre risorse necessarie per combattere i nemici del momento.
Ciò fu possibile grazie soprattutto a una peculiare reazione a catena che influiva sul numero dei combattenti: ogni successo bellico forniva infatti degli schiavi che potevano lavorare la terra, il che permetteva quindi ad altri contadini di andare in guerra.
E’ difficile stabilire con esattezza il momento in cui questo fenomeno – che senza dubbio di tanto in tanto contribuì all’espansione anche di altri Stati dell’Antichità, come ad esempio Cartagine – iniziò a incidere significativamente sulla politica romana: al più tardi nel 311 a. C., quando Roma raddoppiò il numero delle proprie legioni, ma forse almeno una generazione prima.
Pag. 43
La pratica di combattere una guerra quasi ogni anno e in territori sempre più lontani prima dall’Urbe, poi dal Lazio e infine dall’Italia non sarebbe potuta durare se non avesse goduto di un ampio sostegno da parte dei cittadini di Roma, degli stessi latini (di fatto, cittadini di seconda classe) e degli alleati italici (di fatto, soldati).
Le fonti di cui disponiamo mostrano che, a lungo, l’intera cittadinanza romana – per la maggior parte composta di contadini e artigiani – accettò volontariamente, anzi con entusiasmo, uan politica di costante belligeranza, ed è piuttosto facile capirne il motivo: è vero che c’era un certo grado di controllo sociale e che esistevano la coscrizione e una rigida disciplina all’interno dell’esercito; ma è altrettanto vero che i potenziali guadagni, di natura sia materiale sia psicologica, erano considerevoli e tutti ne erano consapevoli.
Servire nelle legioni costituiva di fatto una sorta di privilegio, da cui di norma i cittadini più poveri furono esclusi fino al periodo tardorepubblicano.
Naturalmente i romani subirono talvolta delle gravi sconfitte (ad es. nel 321 a. C. alle Forche Caudine, nel 249 a. C. in Sicilia, e nel 171 a. C. a Callinico, Callinicum, in Tessaglia) e quando Annibale invase l’Italia (218-202 a. C.) Roma attraversò uan crisi che mise a rischio la sua stessa libertà infliggendole gravissime perdite.
Tuttavia le milizie cittadine furono capaci di superare anche questa tempesta, non solo perché i loro membri ritenevano che il sistema funzionasse a loro beneficio, ma anche perché i romani riuscirono a mantenere in riga uan proporzione sufficiente dei propri alleati italici.
Nell’intera storia militare dell’età mediorepubblicana conosciamo un unico episodio, di secondaria importanza, in cui i soldati romani si ammutinarono di fronte a delle forze nemiche superiori (Polibio, 1, 21, 260 a. C.).
Alla metà del secondo secolo a. C. la questione si complicò: l’impero era ora in gradi di fornire ai suoi abitanti svariate opportunità economiche e a partire dallo stesso periodo (dal 351 a. C.) si cominciarono a intravedere i segni di una maggiore selettività da parte dei cittadini romani – del tutto o in parte su uan base economica – riguardo a quali guerre convenisse combattere.
Assai più tardi, alla fine della Repubblica e nel periodo augusteo, l’imperatore poteva vantarsi di aver ampliato “il territorio di tutte le province del popolo di Roma con le quali confinavano popolazioni riottose al nostro comando” (Res gestae 26): è dunque evidente che il popolo romano continuava a essere favorevole all’espansione che, a quel punto, non costituiva più un grande onere, dato il maggior numero di cittadini in grado di servire nelle legioni.
Pag. 44-45
Se i sanniti e gli etruschi avessero unito in tempo le proprie forze avrebbero probabilmente potuto bloccare l’avanzata di Roma, ma ciò non accadde fino alla campagna di Sentinum (presso l’attuale Sassoferrato) e la vittoria dei romani nell’omonima battaglia sembra essere stata decisiva: nel 290 a. C. avevano eliminato quasi ogni resistenza a sud dei fiumi Arno ed Esino.
Le guerre continuarono per tutti gli anni Ottanta: l’offensiva romana subì uan temporanea battuta di arresto quando nel 281 a. C. la fazione democratica di Taranto (Tarentum) chiese aiuto al re Pirro dell’Epiro; ma alla fine degli anni Settanta Taranto era rimasta l’unica città ancora libera e dovette infine soccombere nel 272 a. C.
Durante la generazione precedente, Roma aveva imposto la denominazione di “Italia – applicata in precedenza solo all’attuale Calabria – a tutta la penisola fino all’Arno, probabilmente nel tentativo di diluire le identità dei popoli conquistati: ironicamente, questa nuova identità mise radici e due secoli più tardi, nel 91-89 a. C., divenne la bandiera dell’ultima grande ribellione antiromana nella penisola, la guerra sociale, detta così perché combattuta contro i socii o alleati.
Pag. 48-49
Altre modalità organizzative furono forse più originali: il tipo di colonizzazione romana di questo periodo era al servizio della potenza strategica dello Stato e perciò Roma – al contrario delle madrepatrie greche e fenicie del passato – mantenne sulle proprie colonie un controllo piuttosto stretto.
La sistematica misurazione delle terre – la “centuriazione”, nella moderna terminologia – ebbe inizio verosimilmente al più tardi nel 273 a. C. (Paestum) e assicurò uan distribuzione precisa, anche se ovviamente non equa, a tutti i coloni; Filippo Coarelli ha di fatto sostenuto in modo convincente che la centuriazione era già in uso lungo il percorso della via Appia ancor prima che questa venisse tracciata, nel 312 a. C.
Soprattutto, le colonie erano assai numerose: fra il 338 e il 263 a. C., a un ritmo più o meno costante, vennero fondate in Italia 5 o 6 colonie cittadine e 19 “latine” (che permisero a Roma di soddisfare e collocare i propri cittadini di seconda classe), a cui prima della fine del secondo secolo a. C. si aggiunsero altre 25 circa di entrambi i tipi.
Le colonie avevano l’ulteriore e prevedibile vantaggio di incrementare la forza militare a disposizione dell’Urbe.
Un’altra tecnica probabilmente originale fu la costruzione di strade di lunga distanza, in questa fase ancora rudimentali ma che costituivano comunque un importante strumento di controllo oltre ad avere una forte valenza simbolica come rappresentazione della potenza romana; così nel 312 a. C. venne iniziata uan strada verso Capua (la via Appia) e nel 307 a. C. un’altra verso est, attraverso gli Appennini.
Pag. 52-53
Assai più tardi (nella guerra sociale del 91-89 a. C.) molti di loro si ribellarono e Roma reagì saggiamente, benché in modo tardivo, estendendo la cittadinanza a uan vasta popolazione: tutti gli italici a sud del Po.
Pag. 53
L’espansione romana fra il 241 e il 146 a. C. può essere suddivisa grosso modo in sei fasi, elencate di seguito:
1. Un periodo, fra il 238 e il 202 a. C., in cui ne vennero gettate le basi con una serie di conflitti nell’Italia settentrionale, nella penisola iberica, in Illiria e con la guerra contro la Macedonia (non combattuta sul territorio macedone).
Il processo venne interrotto dai lunghi anni dell’invasione di Annibale, che provocò perdite terribili (forse un quarto della popolazione adulta maschile di Roma perse la vita, compresi undici consoli o ex consoli) e terminò con la sconfitta di Cartagine sul proprio territorio (battaglia di Zama, nel 202 a. C.) e con l’effettiva impossibilità grazie al conseguente trattato di pace, di ogni futura possibile resistenza cartaginese.
2. Un nuovo periodo di rapida espansione (ancora in Iberia e Italia settentrionale, contro gli Stati greci e la Macedonia, e poi contro Antioco Terzo in Grecia e Asia Minore) fra il 201 e il 188 a. C., terminato con la dura pace di Apamea imposta al monarca seleucide.
3. Un periodo di costanti ma meno spettacolari successi militari (Iberia e Italia settentrionale, 186-172 a. C.); anche in Oriente non fu un periodo di inattività: sembra ad esempio che nel 179 a. C. Roma abbia instaurato un trattato di “amicizia” sia con Farnace re del Ponto sia con gli abitanti della Tauride.
4. Una successiva campagna che vide la deliberata distruzione del regno macedone (172-168 a. C.), uno dei tre principali Stati del Mediterraneo orientale.
5. Un altro periodo dedicato in gran parte alle guerre in Italia settentrionale, Iberia e Dalmazia (166-150 a. C.)
6. Infine, l’ultima guerra punica così come un decisivo regolamento dei conti in Macedonia e Grecia, che nel 146 a. C. portarono alla distruzione fisica di Cartagine e Corinto.
Polibio aveva ovviamente ragione ad affermare che la battaglia di Pidna – la decisiva vittoria su Perseo, ultimo re della Macedonia, combattuta sul suolo macedone nel 168 a. C. – diede ai romani il dominio dell’intero mondo (mediterraneo), nel senso che in seguito nessuno poté permettersi di disobbedire.
Un celebre episodio avvenuto più avanti nello stesso anno serve a illustrare la nuova realtà (Polibio, 29, 27): Antioco 4. di Siria, dopo aver invaso l’Egitto raggiungendo Pelusio, nella parte orientale del delta del Nilo (e senza dubbio complimentandosi con sé stesso per l’andamento della campagna), si vide venire incontro l’ex console Gaio Popilio Lenate, emissario praticamente disarmato del Senato, che gli consegnò un decreto senatorio in cui gli si ordinava di ritirarsi.
Alla richiesta di Antioco di consultare i propri consiglieri Popilio tracciò un cerchio nella polvere attorno al sovrano e gli impose seccamente di decidere prima di mettervi un piede fuori: Antioco dovette obbedire.
Come è stato spesso fatto osservare, il potere raggiunge tutto un altro livello quando non serve alcuna minaccia per vedere eseguiti i propri ordini e questo ne fu un esempio.
Pag. 56-57
A trarne benefici era ovviamente anche lo Stato: alla metà del secondo secolo a. C. si trattava ancora di uno Stato per molti versi rudimentale ma in cui esisteva da tempo una res publica, una sfera pubblica.
Certo è difficile sostenere che i senatori che decidevano le politiche belliche scegliessero la guerra sulla base del calcolo dei benefici finanziari che ne sarebbero derivati allo Stato: ma se consideriamo quali vantaggi avesse ai loro occhi l’afflusso di nuove entrate (e la loro probabile reazione di fronte alla prospettiva di tali vantaggi) è inevitabile che fossero condizionati a favorire una politica estera aggressiva.
Quello che vedevano era infatti una profusione di nuovi templi edificati dai generali vittoriosi; una mole sempre più ingente di opere pubbliche finanziate dallo Stato, specie dopo il 184 a. C.; le finanze pubbliche in costante crescita.
E poi, ancora, vedevano la prima adozione della moneta su vasta scala in Italia e, nel 167 a. C., l’abolizione della tassazione diretta per i cittadini romani.
Pag. 63
Non è difficile accorgersi che i cosiddetti “realisti” che si occupano di storia romana cercano di fatto di dare una giustificazione all’odierna politica estera degli Stati Uniti – una politica magari giustificabile, ma preferibilmente non facendo della pseudo storia.
Pag. 64
Ma ciò che più impressionò lo storico fu la combinazione di meticolosa organizzazione di disciplina draconiana; riteneva i metodi di reclutamento e la costruzione degli accampamenti i migliori esempi dell’organizzazione militare romana.
Pag. 65
Nel periodo dell’espansione in Italia, la decisione presa nel 326 a. C. di prolungare l’imperium del console oltre il mandato annuale risolse un notevole ostacolo costituzionale e politico, rendendo possibili campagne militari più ambiziose.
La principale innovazione dopo il 264 a. C. fu invece la creazione di province al di fuori della penisola e di ulteriori magistrature annuali di alto livello (le preture) che ne permisero una supervisione continua.
Il termine provincia denominava originariamente (e continuò a denominare) una sfera di responsabilità, ma acquisì un significato territoriale a partire dal 227 a. C., quando il numero di preture salì da due a quattro e quello delle questure da sei a otto: ai nuovi funzionari venen affidato il compito di governare la Sicilia e la Sardegna.
Nel 197 a. C. la creazione di due province nella penisola iberica portò all’aggiunta di altre due preture e forse di altrettante questure: tutti questi funzionari si avvalevano di un piccolo staff personale, eccetto ovviamente quando dovevano assumere il comando di ingenti forze militari.
Pag. 66
In breve, Roma fu in grado di ideare le tecniche di organizzazione necessarie per lo sviluppo e il mantenimento di quello che potremmo definire un impero “più che mediterraneo”: sarebbe difficile dire in quale altro modo avrebbe potuto raggiungere questo risultato in modo più efficace.
Pag. 70
Quali furono gli effetti del successo di questo imperialismo sugli stessi romani?
Si tratta di un’altra questione complessa, di cui si parlerà nel capitolo seguente.
Il potere fruttò ricchezza allo Stato, alle élite e ad alcuni cittadini comuni; portò anche, certamente entro la fine del secondo secolo a. C., un certo grado di corruzione.
Due altri effetti di grande importanza furono il cambiamento nella struttura della società romana provocato dall’affluenza di schiavi – tanto che Roma divenne più dipendente dalla manodopera schiavile di qualunque altro grande Stato precedente – e il collegamento tra il mondo economico romano e quello ellenistico, con la conseguenza che nel secondo secolo a. C. il commercio mediterraneo visse una fase di sviluppo senza precedenti (si potrebbe dire, semplificando, che i romani fornirono il capitale e i greci raffinate tecniche finanziarie).
La scala e la natura di questa economia schiavile verranno analizzate nel prossimo capitolo: qui basterà notare che l’imponente mobilitazione militare dei cittadini per tutto il terzo e il secondo secolo a. C. fu possibile grazie al fatto che una grandissima parte del lavoro, compreso quello agricolo, veniva svolto da schiavi.
Pag. 70-71
Con la vittoria di Ottaviano ad Azio (Atium), nel 31 a. C., la natura del processo decisionale politico di Roma cambiò per sempre; ma non fu solo uan “dipendenza del percorso” che spinse Augusto a impegnarsi in quasi quarant’anni di espansione militare: era ciò che ci si aspettava da lui e ne rafforzò l’autorità (cfr. Res gestae, 26-27 e 39) – ed è indubitabile l’intenzione di aumentare i profitti di Roma (cfr. Svetonio, Divus Augustus, 25-61; Strabone 4, 200-201).
E’ possibile seguire passo passo lo stretto legame fra le sue guerre all’estero e le sue necessità politiche all’interno dello Stato romano, ma ciò non significa che Augusto volesse infrangere la tradizione: l’unica vera novità stava nell’enorme menzogna – possibile solo sotto il potere di un solo individuo – riguardo a quella sottomissione dei parti (implicita nei Res gestae 29, 2, in alcune monete e sulla lorica del celebre Augusto di Prima Porta) che era stata nelle intenzioni di Cesare; in realtà i suoi rappresentanti avevano concluso un accordo nel 20 a. C. che permise ad Augusto di concentrare la maggior parte delle proprie forze in Europa.
Che in epoca augustea vi sia stata “un’interruzione delle guerre” è del tutto falso, e anzi i leali sudditi del princeps diedero briglia sciolta alla fantasia: Orazio, ad esempio, attendeva con ansia la conquista della Cina (Odi, 1., 12, 56).
Pag. 76
Le principali attività ufficiali dei governatori, a parte la manifesta repressione di ogni opposizione antiromana, consistevano nel giudicare le cause più importanti (i senatori romani ritenevano che il potere giudiziario fosse fondamentale) e nel garantire la riscossione delle tasse; la loro abilità stava nel bilanciare gli interessi contrastanti dello Stato romano e die locali (i quali potevano aspettarsi di soffrire, ma potevano anche chiedere l’intervento dei potenti patroni romani), riempiendosi nel mentre di tasche – ma non in modo troppo appariscente.
I testi classici sull’argomento sono le requisitorie di Cicerone contro Verre e Pisone, le sue difese di Fonteio e Flacco e le sue lettere dalla Cilicia – testi tutti da leggersi cum grano salis.
Di tanto in tanto si cercò di regolamentare ciò che i governatori potevano e non potevano fare (ad es. con al Lex Porcia, databile al 121 a. C. ca.), ma il controllo da parte dell’amministrazione centrale rimase un obiettivo sguggente, in parte per motivi pratici e in parte perché iL Senato si mostrava spesso indulgente nei confronti delle peraltro ben note colpe dei suoi membri, come Verre.
Pag. 80
E ciò nonostante il fatto che a partire degli anni trenta del secondo secolo a. C., e per oltre cento anni, Roma si trovò spesso in uno stato di profondo dissidio interno, a colte sfociato in vere e proprie guerre civili su larga scala.
E se riuscì a mantenere il controllo sulle province fu in parte grazie a metodi ormai tradizionali: la prontezza nell’uso della forza e l’alleanza con le élite locali.
Augusto poi aumentò senza dubbio l’efficienza del governo grazie alla nomina di procuratores, che agivano anche in quelle province che non amministrava direttamente: gestivano le sue enormi e crescenti proprietà, ma costituivano anche i suoi occhi e le sue orecchie.
Vi furono però due nuovi sviluppi di enorme importanza in questo periodo: il primo fu l’estensione della cittadinanza romana ai sudditi italici e la loro parziale integrazione nello Stato romano, cosa che aumentò progressivamente il coinvolgimento degli italici nell’amministrazione centrale, in un momento in cui le loro identità locali di etruschi o sanniti andavano indebolendosi: un piccolo gruppo di questi italici potrebbe persino aver raggiunto il rango senatorio.
Il secondo sviluppo fu una nuova ondata di colonizzazione, soprattutto in Italia sotto Silla ma estesa poi anche alle province da Cesare a Augusto.
Le colonie create da Silla in Campania – almeno otto – vi consolidarono il potere di Roma, mostrando nel contempo ai soldati quali vantaggi potessero trarre dall’appoggiare un usurpatore di successo.
Pag. 81
La classe politica romana si abituò via via a questo genere di integrazione, e nel periodo sotto esame si dimostrò verosimilmente poco incline a teorizzare sulla questione (giudizio che dipende in parte dalla datazione delle lettere dello Pseudo-Sallustio a Cesare); questa politica peraltro non mancò mai di solide basi pragmatiche e i greci, in particolare, avevano dei buoni contatti a Roma.
Nei territori non ellenici, di contro, i romani dimostrarono uno scarso interesse – almeno al livello di alto funzionariato – a trovare un’intesa con le culture locali.
Augusto diede prova di maggiore flessibilità, ma non troppa, permettendo agli egizi di rappresentarlo coem un faraone e autorizzando l’introduzione di alcuni elementi celtici nelle celebrazioni del culto di Roma e di Augusto nella capitale della Galizia, Ancyra (la moderna Ankara), ma le tradizioni greche e romane mantennero la propria preponderanza; questi sviluppi favorirono il suo dominio personale.
Pag. 82
Virgilio e gli altri grandi poeti dell’età augustea simboleggiano il trionfo culturale di Roma in Italia e nelle province occidentali, sia europee che africane.
All’epoca id Augusto tale trionfo apparteneva per lo più ancora al futuro, ma il potere imperiale romano si era già impegnato nel cooptare gli uomini di talento per gli incarichi locali, e persino nel facilitare la loro ascesa sociale; nel contempo coinvolse a tal punto scrittori come Virgilio, Orazio e Tito Livio – i cui avi dovettero possedere identità culturali piuttosto diverse tra loro – in un cambiamento così profondo da essere riconosciuti come i portavoce più rappresentativi della nazione romana.
Pag. 83-84
Ma la diffusione del potere di Roma portò anche all’ellenizzazione delle élite romane: se non si sa in che cosa consistesse nel secondo secolo a. C., quando era già in corso, per l’epoca di Silla, Pompeo e Cicerone era divenuta tutt’altro che superficiale; si vedrà nel capitolo seguente quali ne furono le conseguenze in termini di lotte per il potere all’interno dello Stato romano.
La maggior parte degli storici tuttavia respinge la teoria secondo cui le idee greche minarono seriamente il sistema repubblicano, pur ritenendo allo stesso tempo che l’esistenza di un impero abbia in qualche modo disfatto il sistema di governo di chi lo guidava.
La teoria consueta è che un impero di vaste dimensioni avesse id tanto in tanto necessità di mobilitare eserciti enormi, il che poneva armate forti e più o meno fedeli nelle mani di uomini come Silla e Cesare, incapaci di resistere alla tentazione di sfruttarle per dichiararsi dittatori.
L’instaurazione dell’impero indubbiamente ebbe due effetti di enorme significato politico: rese necessario il reclutamento di soldati impoveriti che avevano scarsi motivi per sostenere lo status quo politico e fece nascere una città-capitale immensa (per gli standard dell’Antichità), di ricchezza e lusso incomparabili e altrettanto ben dotata di quartieri poveri: capitale che per gli anni Settanta del primo secolo a. C. (e di fatto da almeno un paio di generazioni prima) non era più disposta a sottostare in silenzio al controllo degli aristocratici conservatori.
Il dominio di un singolo individuo ne fu la logica conseguenza.
Pag. 85
A spiccare chiaramente nel capitolo sono la profonda dedizione a una guerra spietata – una dedizione diffusa in tutta la società romana ma specialmente forte nell’élite (il pieno significato di questo aspetto diverrà chiaro nel cap. 3) -, insieme a una grande creatività nell’imporre un controllo permanente sulle terre e sui popoli sottomessi da Roma.
La combinazione di questi due fattori rese possibile un’incredibile espansione della potenza romana.
A partire dagli anni Settanta del primo secolo a. C., tuttavia, la dedizione bellica romana si evolse in una più normale accettazione imperiale della guerra come attività professionale, meno essenziale per l’identità dei senatori (anche se ancora di vitale importanza per i leader più importanti); fino a che punto questo cambiamento abbia causato la decelerazione dell’espansione imperiale avvenuta dopo il 16 a. C. è un’altra questione da rimandare al capitolo 4.
Esiste ovviamente in questo caso un certo numero di similitudini con quanto avvenuto nelle fasi di espansione degli imperi cinese e britannico, tra gli altri; una di queste è la propensione a creare delle zone di impero “informale”, così come dei territori di impero “formale” sotto controllo diretto.
Ci si potrebbe dunque chiedere se anche Roma – coem molti ritengono sia stato il caso della Gran Bretagna nel diciannovesimo secolo – abbia imposto un controllo informale ovunque fosse possibile e un’autorità formale solo quando necessario; ma le differenze nei due casi tra ciò che costituiva il “controllo” (sfruttamento economico? Limitazione del potere di Stati rivali?) e ciò che costituiva la “necessità” impedisce il paragone di gettare molta luce sulla storia.
Un’altra similitudine è che nel corso dei periodi fondamentali della sua espansione imperiale Roma, come la Gran Bretagna, fu governata da un’oligarchia più o meno aristocratica (dal 400 a. C. al 49 a. C. nel caso romano, dal 1688 al 1902 in quello britannico), ma tale espansione godeva di un ampio grado di sostegno popolare.
Le oligarchie in questione erano assai differenti come struttura, ma è possibile metterle a confronto con l’insuccesso dell’Atene democratica del quinto secolo a. C. di mantenere il proprio potere per un lungo arco di tempo; quella ateniese era una democrazia solo in senso limitato – e venne condotta al disastro dagli aristocratici – ma in ogni caso il paragone non è molto illuminante.
Una classe dirigente compatta, coem quella di Roma, è in grado di stabilire e mantenere il tipo di legami con le élite locali utili ai fini di successi imperiali, ma la maggior parte degli imperi sono stati costruiti da sovrani volitivi, da Dario e Alessandro agli imperatori del diciottesimo secolo.
Ciò che distingue maggiormente i romani di questo periodo è quello che Stanislav Andreski avrebbe chiamato il loro maggiore RPM (Rapporto di Partecipazione Militare), ovvero la proporzione dei cittadini che si trovavano regolarmente sotto le armi; questa era assai più alta sotto la Repubblica romana, fino all’integrazione dei socii del 90 a. C., di quanto non sia mai stato il caso della Gran Bretagna imperiale e della Cina dei Qing.
Gli imperatori Qing non sembrano aver mai mantenuto un esercito altrettanto ingente di quello di Augusto, anche se la popolazione sotto il loro dominio era fra le quattro e le dieci volte maggiore; livelli paragonabili sono probabilmente da ricercare in due popoli che molto più tardi ebbero un effetto letale sul tardo impero romano, i germani degli inizi del quinto e gli arabi del settimo secolo.
Questo elevato livello di partecipazione cittadina alle attività belliche era legato a un altro aspetto distintivo dell’espansione romana: il costante ricorso alla politica di riduzione in schiavitù di un gran numero di prigionieri di guerra, rimasta immutata negli oltre quattro secoli coperti da questo capitolo.
Mentre è possibile dibattere a lungo sui numeri, rimane però ovvio che Roma fu in grado di mobilitare così tanti dei sui cittadini e alleati perché rimpiazzò in gran parte la loro forza lavoro con la manodopera schiavile: questa non fu mai una politica praticata su grande scala in Cina, e se la schiavitù fu un elemento importante della crescita economica britannica del diciottesimo secolo, non fu essenziale ai bisogni dell’esercito di un impero in espansione.
Pag. 87-88
Cap. 3. Roma contro sé stessa: dalla Repubblica alla Monarchia
Durante l’età medio repubblicana il potere politico, militare, economico e religioso rimase in gran parte nelle mani dell’aristocrazia, anche se, come si vedrà, i cittadini non nobili più facoltosi avevano un peso politico non secondario, che sarà importante valutare.
Nell’ultimo ventennio del secolo scorso alcuni studiosi hanno cercato di dimostrare che Roma, dopo tutto, fu una democrazia.
La loro non era che una distorsione del fatto, ben noto agli storici ottocenteschi come Theodor Mommsen, che il regime romano era un’aristocrazia con alcuni elementi di potere dei cittadini, il che è piuttosto diverso (una prospettiva revisionista che di fatto Henrik Mouritsen ha seppellito).
In particolare, Fergus Millar ha enfatizzato il potere legislativo dei comizi tributi, le assemblee “per tribù”, tuttavia esso divenne uno strumento utilizzabile dai cittadini contro gli interessi dell’aristocrazia solo dopo l’approvazione delle leggi sul voto, nel 139 a. C.; Mouritsen, invece, ha dimostrato che in particolare durante l’età medio repubblicana la partecipazione politica formale dei più poveri tra i cittadini comuni non poteva che essere minima.
Considerando i limiti di tempo e spazio necessari, è infatti assai improbabile che più di 3000/4000 uomini al massimo abbiano potuto partecipare a una singola votazione in questi comizi.
Positivo è, invece, il contributo fornito dagli storici della “scuola della democrazia” nel far emergere l’elemento dei conflitti di classe nelle lotte politiche del periodo tardo repubblicano, quando le circostanze erano radicalmente mutate, evitando di cadere nella trappola di considerare la democrazia solo un modo di “gestire i rapporti di potere per minimizzare il dominio” – uan definizione debole (in tutti i sensi), pensata dal suo autore nella speranza di far rientrare gli Stati Uniti nella medesima categoria.
Pag. 95
Consoli, pretorie, edili e questori – le cariche esecutive dello Stato – rimanevano in carica solo per dodici mesi; a un certo punto, probabilmente fin dalla Lex Genucia del 342 a. C., entrarono in vigore delle norme che stabilivano di fatto l’impossibilità di riassumere il consolato prima di un intervallo di dieci anni.
I censori, normalmente degli ex consoli con importanti funzioni su cui torneremo in seguito, avevano un mandato di appena diciotto mesi.
Tutti questi magistrati poi venivano eletti da assemblee cittadine, sebbene in maniera decisamente non democratica (che verrà descritta a breve); il cosiddetto “dittatore”, un comandante supremo nominato in casi di emergenza dai consoli, rimaneva in carica non più di sei mesi.
Nel suo complesso, l’élite sembrerebbe essere stata concorde sul fatto che per quanto un individui potesse divenire preminente per qualche tempo, tale periodo doveva essere breve.
Pag. 96
Le assemblee incaricate del processo di elezione non erano certo democratiche per i parametri moderni: consoli, censori e pretori venivano eletti dai comizi centuriati, in cui i voti venivano contati non individualmente ma tramite unità elettorali denominate “centurie”, nelle quali le preferenze di pochi uomini facoltosi erano assai più importanti di quelle delle masse, che assai probabilmente non erano né in grado di assistere in grande numero, né abituate a ciò.
Un altro fattore restrittivo, o comunque conservatore, era che il magistrato che presiedeva i comizi, un console, aveva il diritto di decidere chi fosse un candidato appropriato; un altro ancora era che i voti degli anziani (ovvero di età superiore ai 46 anni: si ricordi che nell’Antichità l’aspettativa di vita era breve) avevano un peso maggiore di quelli dei giovani.
Pag. 98
Un altro potere riservato ai comizi centuriati viene talvolta addotto come prova decisiva a favore della democraticità della Roma medio repubblicana, ovvero la facoltà di decidere nelle questioni riguardanti la guerra, la pace e i trattati (cfr. Polibio, 6, 14, 10-11).
I comizi, tuttavia, di norma accoglievano le indicazioni in materia del Senato senza frapporre ostacoli e l’unica occasione in cui il loro intervento si rivelò decisivo – con i senatori divisi su come procedere – fu nel 264 a. C., a favore della guerra contro Cartagine (mentre quando nel 200 a. C. i comizi votarono nel modo “sbagliato”, preferendo la pace, il Senato li costrinse a rettificare: Tito Livio, 31, 6-8).
Dopo il 171 a. C. questo ruolo divenne ancora più marginale e l’unica occasione in cui è noto che i comizi abbiano respinto i termini di un trattato di pace precedentemente accettati da un magistrato fu nel 241 a. C., quando insistettero per imporre misure più severe nei confronti di Cartagine (Polibio, 1, 63).
Pag. 99
Prima di esaminare i rapporti sociali ed economici che facevano funzionare la macchina statale, vale la pena di spendere qualche parola in più riguardo al Senato.
Sembra che la nomina o la riconferma di ciascun membro spettasse ai consoli, e fu una misteriosa Lex Ovinia ad assegnare questa funzione ai censori (Festo 290 Lindsay), forse non molto prima della nomina a censore del non meno misterioso patrizio Appio Claudio Cieco, nel 312-311 a. C.
Questa riforma diede a ogni membro del Senato un mandato minimo di cinque anni e deve aver notevolmente aumentato il potere de facto di questo organismo.
Nell’età medio repubblicana il Senato controllava la politica la politica estera ed esercitava anche grande potere negli affari interni: gestiva le finanze dello Stato e spesso adottava importanti decisioni di carattere religioso.
La crescente complessità delle relazioni esterne di Roma chiaramente rafforzò la posizione senatoria a partire dal quarto secolo a. C., e ancora più quando l’Urbe iniziò a essere coinvolta nel complesso mondo greco e divenne quindi necessaria dell’esperienza in materia.
Durante questo periodo il Senato ebbe sempre l’accortezza di mantenere in gran parte riservate le proprie riunioni (sfortunatamente per noi); costituiva un’élite sociale e non solo politica, i cui membri indossavano toghe bordate di porpora e particolari calzature, i calcei, che li rendevano facilmente riconoscibili in una società (almeno nel caso maschile) in cui si prediligeva invece un abbigliamento austero.
Pag. 102
Nella Roma medio repubblicana il potere legislativo risiedeva nelle assemblee cittadine (sebbene per i moderni criteri la loro attività fosse scarsa, così come quella di amministrazione): i consoli – o, assai occasionalmente, i pretori – presentavano le loro proposte ai comizi centuriati, di carattere conservatore, oppure i tribuni – di norma in accordo con almeno una parte dell’élite senatoria – facevano altrettanto nelle assemblee della plebe; parrebbe dunque che non vi fosse molto spazio per misure di carattere radicale.
Che “a Roma non si ebbe mai la democrazia perché le assemblee popolari non poterono funzionare come istituzioni autonome” è vero fino a un certo punto, ma per la maggior parte del tempo tali assemblee non furono veramente “popolari” e, in ogni caso, una tale spiegazione pecca di eccessiva astrazione.
Pag. 103
Il potere dell’aristocrazia si basava sia sulla competizione sia sul consenso dei cittadini, ma anche con i latini e gli “alleati” italici.
Le rivalità per le cariche politiche – descritte al meglio, seppure in termini assai generici, da Sallustio (Cat. 7-12) -, non portarono mai (o quasi mai) a minare le fondamenta del sistema stesso, anche quando forme più o meno esplicite di corruzione divennero evidenti dopo la guerra contro Annibale.
Naturalmente, la compravendita dei voti tendeva ad apparire ripugnante agli occhi degli aristocratici.
Nello stesso tempo, era di fondamentale importanza creare spazio per i più capaci tra i nuovi venuti (spesso aiutati nella loro ascesa da patrizi influenti): la prima generazione di questi senatori di rado ottenne il consolato (Catone, nel 195 a. C., fu un’eccezione) ma per i loro figli fu meno difficile.
I membri delle gentes più note erano però avvantaggiati, e in occasione dei funerali pubblici queste famiglie non mancavano di esibire le cariche occupate facendo sfilare dei figuranti con indosso delle maschere di cera, accuratamente conservate, di coloro tra i propri defunti che in passato avevano detenuto delle cariche pubbliche: Polibio osserva come queste cerimonie incoraggiassero “i giovani a sopportare qualunque cosa per il bene dello Stato, per conseguire la gloria che accompagna gli uomini di valore” (6, 54, 3).
A partire dal 264 a. C. questi funerali costituirono anche l’occasione per le gentes aristocratiche di organizzare dei combattimenti pubblici fra coppie di gladiatori (un dettaglio che Polibio diplomaticamente tralascia): un secolo più tardi questo genere di spettacolo era ormai divenuto di grande popolarità e si svolgeva nel principale spazio cittadino, il foro (dove le principali famiglie iniziarono a collocare le statue a grandezza naturale dei loro membri più insigni, a quando sembra a partire dal 338 a. C.; Tito Livio 8, 13, 9).
Pag. 104
L’elemento in gran parte mancante nei classici studi sulle strutture del potere nella Roma medio repubblicana è proprio quello strutturale, nel senso che non si specifica in che modo il potere politico fin qui considerato si rapportasse con quello economico.
Il primo punto da sottolineare è che l’economia del periodo medio repubblicano, anche nella sua forma più sviluppata, era di tipo agricolo e militare: gli uomini di potere erano sia proprietari terrieri sia, di tanto in tanto, generali: in quest’ultima veste distribuivano il bottino ai loro soldati al termine delle campagne vittoriose, mentre nella prima condizionavano la vita economica dei contadini, in qualche modo già nel quarto secolo a. C.
Successivamente, con l’affluenza di schiavi avviata nell’ultimo decennio dello stesso quarto secolo e proseguita per i successivi trecento secoli e oltre, Roma si trasformò nel classico Stato schiavista mediterraneo dell’Antichità: anno dopo anno, con brevi pause, gli eserciti romani ridussero in schiavitù decine di migliaia di nemici sconfitti.
Quando, nel 167 a. C., Roma rese schiavi circa 150000 abitanti dell’Epiro, nel nord della Grecia, la sua popolazione ufficiale non superava i 313000 cittadini (maschi in età militare), ma il mercato degli schiavi assorbì i nuovi arrivi, vale a dire li utilizzò a fini produttivi, senza alcuna apparente difficoltà.
Questa nuova forza lavoro coltivava la guerra, soprattutto nelle proprietà dei grandi latifondisti appartenenti agli ordini senatorio ed equestre.
Pag. 107
Sull’onda dell’imperialismo del secondo secolo a. c. Roma e almeno alcune delle città italiane divennero sempre più prospere: affluivano le entrate, l’impero forniva molteplici opportunità di investimento e il costo del lavoro doveva essere basso; ma verso il 140 a. C. – e nonostante l’élite senatoria dovesse apparire allora più potente che mai – un vero e proprio terremoto era ormai sul punto di scatenarsi.
Pag. 108
La natura del terremoto che mise fine alla repubblica, lasciando di nuovo Roma nelle salde mani di un autocrate, è stata assai dibattuta e assai male interpretata.
E’ probabilmente sintomatico che un acuto commentatore come Michael Mann, pur avendo recepito la maggior parte della moderna storiografia, abbia fornito un’analisi in parte sbagliata, non riuscendo a spiegare per quale motivo Silla, Cesare e Ottaviano scelsero di agire in modo non conforme alla tradizione o perché “l’esercito non poté essere tenuto insieme dallo Stato”; in particolare, le opinioni su Cesare degli storici contemporanei sono molto spesso guidate, quando non determinate, dalle loro preferenze politiche, riconosciute o no.
Innanzitutto, va messo in chiaro che tra il 140 a. C. e il regno di Tiberio (14-37 d. C.) si verificarono in effetti dei cambiamenti di vasta portata.
Alla fine di questo periodo l’Impero romano era esteso come mai prima d’allora, e governato ancora in modo parzialmente immutato: la maggior parte delle vecchie istituzioni era sopravvissuta (la “dittatura”, tuttavia, era incompatibile con la nuova monarchia); dagli anni Ottanta del primo secolo a. C. l’esercito, divenuto gradualmente più professionalizzato, si era trasformato nell’arbitro del potere interno e mantenne questo ruolo anche sotto il Principato, nonostante il fatto che per diverse generazioni, come si vedrà, la successione imperiale avvenne spesso senza scontri armati.
Ciò detto, il nuovo sistema:
1. Costruì una monarchia quasi assoluta;
2. Eliminò il potere politico di cui godevano i cittadini comuni, con l’importante eccezione del potere locale
3. Sostituì alla vecchia aristocrazia senatoria un nuovo ordine senatorio più plutocratico e politicamente meno influente
4. Integrò gli abitanti delle province non in casi sporadici, bensì su scala tanto vasta quanto ambiziosa.
Pag. 108-9
Ma a dare fuoco alle polveri a Roma furono i bisogni dei cittadini più poveri, i quali avevano finalmente trovato in alcuni membri dell’ordine senatorio di mentalità riformista i difensori dei loro diritti: quando Tiberio Gracco (figlio e nipote di consoli) usò la prerogativa dei tribuni per proporre una legge al fine di recuperare l’ager publicus, cioè quei terreni di proprietà dello Stato allocati ai ricchi, per ridistribuirli fr ai cittadini (133 a. C.), la maggioranza conservatrice dei senatori, guidata dall’ex console Publio Cornelio Scipione Nasica, non esitò a fare ricorso all’omicidio.
Identica sorte toccò dodici anni dopo al più giovane dei Gracchi e ai suoi sostenitori; questa volta il Senato stabilì che l’uccisione dei riformisti doveva ritenersi legittima, in base a un suo decreto secondo cui “i consoli devono vigilare affinché lo Stato non abbia a soffrire alcun male”, il cosiddetto senatus consultum ultimum (“ultima decisione del Senato”).
Pag. 111
Tuttavia, a cambiare erano le basi stesse della politica: il nuovo esercito creato da Mario, formato da uomini che non possedevano terre o ne avevano in quantità minima, inizialmente non fece nulla per sovvertire l’ordine costituito; ma quando, nell’88 a. C., scoppiò lo scontro politico fra lo stesso Mario e il console Lucio Cornelio Silla (causato dalla disputa su chi dovesse avere il privilegio di condurre la guerra contro il formidabile Mitridate), ciascuno dei due contendenti schierò le proprie legioni contro altri romani, e per la prima volta si formarono attorno a due leader dei nutriti e duraturi gruppi di sostenitori, “mariani” e “sillani”.
Quando Silla riuscì a rovesciare con la forza il governo legittimo (83-82 a. C.), divenendo dittatore di nome e di fatto, ricompensò le proprie truppe con delle terre non conquistate oltremare, ma sottratte in Italia a persone che erano ormai (cavilli legali a parte) cittadini romani.
Pag. 112-13
Dopo aver conquistato il potere, Sila inflisse all’élite romana un numero di morti violente senza precedenti in un periodo di tempo così breve: oltre a coloro che perirono durante la guerra vera e propria, più di quaranta senatori e 1600 cavalieri rimasero vittime delle proscrizioni, che oltre alle esecuzioni capitali comprendevano anche confische di proprietà (Appiano, Guerre civili 1., 95, 442-444); forse un terzo dei membri del Senato perse la vita.
Silla varò anche il cambio di regime più radicalmente reazionario che la repubblica romana avesse mai conosciuto, neutralizzando di fatto il tribunato (i tribuni persero il diritto di proporre delle leggi e fu loro vietato di candidarsi ad altre cariche) e affidando l’amministrazione di gran parte della giustizia penale a sei nuovi “tribunali perpetui”, uno per ogni genere di reato (ne esisteva già uno per l’”estorsione”, in cui le giurie erano formate esclusivamente dai membri dell’élite).
Quest’ultima riforma ebbe effetti maggiori nel lungo periodo, ma sfortunatamente non esistono studi soddisfacenti sull’origine di questi tribunali o sul loro effetto sulla distribuzione del potere, giacché gli storici del diritto si interessano di rado al ceto dei giurati.
Pag. 113
Il nuovo esercito rappresentò il fattore più importante nella fine della repubblica. Syme scrisse che i soldato “andavano perdendo il senso di devozione allo Stato”, ma una formulazione più precisa sarebbe che lo strato sociale chiamato a servire sotto le armi dal 107 a. C. in poi non aveva di fatto mai avuto delle forti ragioni per dimostrare fedeltà alla tradizionale organizzazione dello Stato.
Cesare, generale vittorioso e (grazie ai suoi successi militari) enormemente ricco, poté in ogni caso contare su soldati e ufficiali che avevano combattuto con lui in Gallia anche quando, durante la guerra civile, ebbe problemi di liquidità, in parte perché non poteva ovviamente permettere alle sue truppe di saccheggiare le proprietà degli abitanti delle province.
Pag. 115
Molte delle principali personalità del tempo sostennero Cesare quando, imitando Silla, invase la penisola nel 49 a. C. proclamandosi “dittatore”, o si unirono rapidamente ai suoi ranghi (almeno la metà dei senatori di cui conosciamo lo schieramento nel corso della guerra civile): rapporti personali, opportunismo e un più o meno manifesto desiderio di una leadership forte ebbero tutti una certa importanza.
Cesare combinò uan politica di riconciliazione (clementia) con l’efficienza militare: le forze della repubblica si ritirarono attraverso l’Adriatico in Tessaglia e furono sconfitte nella battaglia di Farsalo (48 a. C.), che segnò la fine di un sistema politico.
Ma, dopo aver trionfato in una lunga e aspra guerra civile (dopo Farsalo i combattimenti durarono ancora per parecchio tempo), Cesare si schierò per lo più dalla parte dei diritti dei proprietari (la cancellazione di un anno di canoni d’affitto fu probabilmente il suo provvedimento più estremo): coloro che premevano per delle misure veramente radicali, come il pretore Marco Celio Rufo nel 48 a. C. e il tribuno Publio Cornelio Dolabella nel 47 a. C., vennero richiamati all’ordine con fermezza e le restrizioni poste suo collegia (Svetonio, Divus Iulius, 42) dovettero rappresentare una delusione per la massa dei suoi sostenitori.
Nell’aprile 46 a. C. Cesare fu proclamato dittatore per un periodo di dieci anni, fatto mai avvenuto, e agli inizi del 44 a. C. divenne “dittatore perpetuo”.
Al diavolo le tradizioni repubblicane!
Pag. 117
Quattro anni dopo la battaglia di Farsalo, nelle idi (ovvero il 15) di marzo del 44 a. C., un gruppo di senatori di inclinazioni repubblicane – molti dei quali avevano beneficiato della clementia di Cesare – assassinarono colui che era ormai un “dittatore perpetuo”; ma probabilmente non è necessario ricorrere al senno di poi per immaginare che la loro fosse una causa senza speranza: pur riuscendo a reclutare delle forze formidabili da opporre ai successori di Cesare, Marco Antonio e Ottaviano, vennero sconfitti in maniera decisiva nella battaglia di Filippi (42 a. C.).
Di recente, uno studioso ha dimostrato coem Sesto Pompeo, il figlio più giovane di Pompeo, avesse continuato a rappresentare una seria minaccia per Ottaviano fino alla sua disfatta nella battaglia di Nauloco (Naulochus), al largo delle coste settentrionali della Sicilia (36 a. C.); ma se anche Sesto, dopo Filippi, avesse creduto nella possibilità di una restaurazione dell’ordine repubblicano – e non esiste alcun indizio in tal senso – non avrebbe fatto altro che inseguire un sogno.
Il potere politico era passato definitivamente nelle mani di coloro che potevano contare sull’incrollabile fedeltà delle legioni.
Pag. 119
La battaglia di Azio (31 a. C.), combattuta tra le forze di Ottaviano e quelle di Antonio, fa apparire inevitabile il governo dell’Impero romano da parte di un singolo uomo (avrebbe forse potuto essere diviso).
Ciascuno dei due contendenti, nei tredici anni precedenti, aveva praticato l’arte di accumulare il potere sia nei modi tradizionali (patrocinio, elargizioni, propaganda delle vittorie sui nemici all’estero) sia in altri meno ortodossi: come già visto, utilizzarono degli opuscoli per influenzare i soldati dell’avversario e nel 32 a. C. Ottaviano si fece giurare fedeltà dall’Italia e dalle province occidentali (Res gestae 25, 2).
Un’altra innovazione fu la “potestà tribunizia” che lo stesso Ottaviano si arrogò probabilmente in due fasi (nel 36 e nel 30 a. C.), un’implicita – e fraudolenta – pretesa di stare dalla parte della plebs.
Pag. 120
Il princeps (“primo cittadino”), come si definiva (Res gestae 13 ss.), permise infatti alle istituzioni politiche della Repubblica di continuare a funzionare, ma solo laddove queste erano compatibili con il governo monocratico: le assemblee eleggevano i magistrati come prima e Augusto distribuì persino delle tangenti perché le elezioni sembrassero autentiche (Svetonio, Divus Augustus, 40); di fatto per le cariche minori, fino alla pretura, esisteva uan qualche reale concorrenza, anche se successivamente Tiberio semplificò le procedure trasferendo al Senato le nomine di consoli e pretori.
I senatori erano ovviamente da sempre grandi proprietari, ma Augusto introdusse dei requisiti finanziari formali (1 o 1,2 milioni di sesterzi, le fonti sono contraddittorie) come forma di garanzia politica.
Per quanto riguarda i governi provinciali, gli ex magistrati continuarono a svolgere il proprio ruolo ma coloro che detenevano il comando delle milizie dovevano rispondere direttamente al princeps: quest’ultimo nominò dei “legati” per governare le province e le legioni sotto il suo diretto controllo, mentre i “proconsoli” incaricati delle province populi Romani venivano estratti a sorte fra gli ex alti magistrati disponibili.
Pag. 122
Che il potere supremo avrebbe assunto una forma dinastica divenne gradatamente sempre più palese, ma sulla questione regnava un certo imbarazzo: la tradizione repubblicana non forniva certo alcuna base per obiettare al fatto che Augusto ricorresse ai suoi familiari per formare delle alleanze politiche, ma la palese designazione di un erede era tutt’altra questione.
L’imperatore ebbe uan sola figlia legittima, Giulia, e a quanto sembra nessun desiderio di proseguire su quella strada: il suo primo potenziale successore, il nipote e genero Marcello, morì nel 23 a. C. prima di compiere 20 anni: il ruolo di genero passò quindi ad Agrippa, il vero vincitore delle battaglie di Nauloco e Azio, ma questi aveva all’incirca la stessa età di Augusto e morì nel 12 a. C.
Fu dunque ai due figli di Agrippa e Giulia, Gaio e Lucio Cesare, che il princeps rivolse la propria attenzione, adottandoli già nel 17 a. C. e riempiendoli di onori; sembra che i loro nomi apparissero nei giuramenti di fedeltà imposti da Augusto a una serie di città delle province fra il 5 e il 2 a. C.
Ma anche questi due eredi morirono in giovane età (nel 4 e nel 2 d. C., rispettivamente), il che lasciò ad Augusto come unico parente stretto e competente il figliastro Tiberio: dal 6 a. C. al 2 d. C. questi rimase in un esilio semivolontario a Rodi, ma dovette essere richiamato per essere designato come futuro princeps, e nel 13 d. C. i suoi poteri nominali equivalevano ormai a quelli di Augusto.
Pag. 124
Infine, come riassumere nel caso romano i reciproci effetti delle relazioni di potere interne ed esterne?
Iniziamo con l’effetto delle relazioni di potere interne sui rapporti esterni dello Stato.
La posizione dell’aristocrazia romana nel quarto o terzo secolo a. C. non era affatto precaria, ma veniva fino a un certo punto messa in discussione: i suoi leader si contendevano il prestigio militare, ma cercavano anche di soddisfare sia le proprie ambizioni sia i bisogni della massa della popolazione, combattendo costantemente contro i popoli confinanti; la schiavitù – agricola e artigianale – rese possibile soddisfare le crescenti necessità di personale militare.
Quando la politica interna di Roma si fece più decisamente competitiva, con un crescendo negli anni tra il 63 e il 31 a. C., ciò ebbe in un certo senso un effetto sorprendentemente limitato sulla capacità dello Stato di mantenere e anzi aumentare notevolmente il proprio potere esterno: in parte perché i nemici temibili erano ormai pochi e lontani, in parte perché le politiche imperiali, espansionistiche e di sfruttamento, servivano gli interessi di tutti coloro che a Roma contavano.
L’atteggiamento nei confronti della guerra – guerra tr ai cittadini, oltre che conflitti all’estero – stava cambiando, ma per lungo tempo ciò ebbe solo scarse conseguenze sui rapporti esterni: le entrate finanziarie dell’impero, nel periodo tardo repubblicano ma anche sotto Augusto, erano sufficienti a mantenere le forze militari necessarie per i bisogni immediati.
La nuova dittatura ebbe invece effetti complessi sui rapporti esterni di Roma: il regime si impegnò infatti in una serie continua di guerre all’estero, con una pausa significativa negli ultimi anni di Augusto; ma che una politica di aggressione fosse nell’interesse del princeps divenne sempre meno ovvio e anche se molti membri dell’ordine senatorio prestarono il proprio servizio militare, traendone dei benefici, i possibili guadagni derivanti da queste attività si assottigliavano sempre più.
Per i senatori, e di fatto per la maggior parte della popolazione, aveva più senso approfittare delle opportunità fornite dall’impero già esistente, mentre gli abitanti delle province, un po’ meno sfruttati di un tempo, poterono acquisire una maggiore influenza.
Per quel che riguarda gli effetti dei rapporti esterni sulle strutture di potere interne, questo capitolo e il precedente hanno già fornito una parte della risposta: semplificando, ma non eccessivamente, si potrebbe dire che per molto tempo le conquiste e il successo imperiali favorirono la stabilità sociale e politica, ma finirono poi col minarne le fondamenta.
La notevole stabilità politica dello Stato romano, durata dagli anni Sessanta del quarto secolo fino agli anni Ottanta del primo secolo c. C., fu dovuta in parte al fatto che i romani di ogni classe sociale potevano sperare di vedere soddisfatte le proprie ambizioni – nonché la propria inclinazione alla violenza – nel mondo esterno.
La teoria romana sul perché ebbe fine questo soddisfacente stato di cose afferma che ciò che aveva tenuto in riga i romani era il loro timore di Cartagine, timore che dev’essere andato scemando dopo la sconfitta di Annibale nel 202 a. C. e infine svanito dopo il 146 a. C.; l’ovvia ipotesi soggiacente era che finché dovevano fare i conti con dei temibili nemici all’estero, non avrebbero rischiato di fare a pezzi il loro stesso Stato.
I conservatori dell’epoca tardo repubblicana inoltre tendevano a dare la colpa all’ambizione dei tribuni populares, mentre altri facevano ricadere la responsabilità sui “signori della guerra” aristocratici e in particolare su Silla.
L’idea che la mancanza di nemici terribili abbia portato a un conflitto incontrollato fra gli stessi romani ha perfettamente senso, ma dev’essere completata facendo riferimento ad altri effetti di un imperialismo di successo, in particolare quelli economici e culturali già notati in precedenza.
Inoltre, come è stato spesso sottolineato, le continue guerre all’estero dell’età tardo repubblicana resero necessaria la creazione sia di ingentissime forze armate al comando di generali come Pompeo e Cesare, sia di un esercito parzialmente rinnovato e disposto, a determinate condizioni, a combattere contro altri romani.
Gli eventi esterni contribuirono alla stabilità politica che sembrò ritornare all’indomani della vittoria di Ottaviano, nel 31 a. C.?
Il nuovo governante cercò di sfruttare al massimo la sua presunta vittoria contro un pericoloso nemico esterno, Cleopatra (Cassio Dione 51, 19, ecc.).
Gli storici moderni tendono a credere che i contemporanei non si siano lasciati affatto ingannare da questa propaganda, ma i sostenitori di Augusto arrivarono quasi a monopolizzare i mezzi di comunicazione, e una parte del consenso che il princeps riuscì a costruire dipese verosimilmente dal suo essere percepito come colui che aveva restaurato l’integrità della fondamentale parte orientale dell’Impero romano.
Pag. 130-32
Cap. 4. Roma contro gli altri, dal 16 al 337.
Ma chi era dentro, e chi fuori dei confini dell’Impero?
I romani ci paiono un po’ confusi quando affermano che il mondo era sotto il loro controllo, nonostante la classe dirigente sapesse bene che non era vero; anzi, non mancava di sottolineare – almeno fino ad una certa data – come esistessero ancora molti popoli stranieri da conquistare.
Tacito, che scrive negli anni Dieci del secondo secolo, critica Tiberio per “non essere [stato] interessato a espandere l’impero” (Ann. 4, 32), un’allusione piuttosto trasparente alla propria epoca.
Inoltre, a lungo gli autori romani furono soliti riferirsi agli abitanti delle province con il nome di externae gentes; La confusione era probabilmente aggravata dal fatto che, come già in precedenza, Roma considerava i “re clienti” parte dell’Impero, nonostante fossero una regolare presenza alla periferia.
Infine, a quest’epoca era abbastanza comune che truppe romane fossero dislocate oltre i confini delle province, coem sarebbe accaduto ancora lungo la frontiera settentrionale sotto i tetrarchi (Diocleziano e i suoi tre colleghi) e poi Costantino.
Pag. 133
Le mie domande iniziali, in ogni caso, riguarderanno l’ideologia della conquista e che cosa ne sia stato, nonché i vincoli finanziari legati all’espansione; passeremo poi a valutare gli interessi dell’imperatore, dell’élite e dell’esercito, nonché dei loro nemici effettivi e potenziali: tutti aspetti che cambiarono nel corso delle generazioni.
Prenderemo poi in considerazione le conoscenze dei romani, il ricorso alla violenza e alla diplomazia con i popoli stranieri, e alcuni dei loro caratteristici modelli di comportamento; e infine, in che modo questa serie di relazioni con il mondo esterno abbia influenzato i rapporti di potere interni dell’Impero.
Pag. 134
A mo’ di introduzione, presento qui un sommario riassunto cronologico dei più importanti eventi militari e politici: i momenti di svolta, per quanto possano essere isolati dal contesto, avvennero sotto Adriano (117-38), alla morte di Filippo l’Arabo (244-49) e, in maniera più controversa, sotto Aureliano (270-75).
Pag. 134-35
L’oro della Dacia risolse i problemi finanziari di Traiano, ma l’imperatore non si riteneva per niente soddisfatto: aspirava alla più grande espansione a Oriente dai tempi di Pompeo, e la morte del sovrano nabateo Rabel 2. portò nel 106 all’annessione del suo regno, incorporato come provincia romana dell’Arabia; già nel 111 i romani erano impegnati nella costruzione di una strada che collegava Bostra, la capitale di Rabel, al Mar Rosso, strada il cui significato strategico non è chiaro, ma che rese assai più facile spostare truppe e rifornimenti dall’Egitto alla frontiera siriaca.
Nel 114 Traiano avviò un’offensiva contro i parti, che inizialmente si rivelò un successo: nella prima campagna depose il monarca dell’Armenia trasformandone il regno in una provincia, e nelle due successive avanzò lungo l’Eufrate fino al Golfo Persico, creando due nuove province, “Mesopotamia” e “Assiria” (a quanto sembra la Mesopotamia meridionale); sul trono partico venne posto un re cliente.
Ma il controllo romano era fragile, e la salute dell’imperatore altrettanto: dopo la morte di Traiano, nel 117, Adriano ritirò le forze romane da tutti i territori oltre l’Eufrate, compresa l’Armenia, e negli ottant’anni successivi nessun imperatore combatté una guerra di uan qualche importanza all’estero.
Pag. 138
La dinastia dei Severi, avendo senza dubbio compreso l’inutilità di una Marcomannia o di una Sarmazia, tornò a concentrare le proprie iniziative militari sulle frontiere orientali: Settimio invase la Mesopotamia nel 195 creandovi la nuova piccola provincia di Osroene, e nel 197 attaccò la Partia riconquistando Ctesifonte.
Anche Settimio, come Traiano, creò una provincia della Mesopotamia, che corrispondeva solo a una minima parte dell’omonimo territorio; ma l’imperatore, la cui città natale era la libica Leptis Magna, decise nel 197-202 di estendere il controllo romano a sud del Sahara, dalla Tripolitania alla Mauretania; il governatore della Numidia posto al comando delle operazioni, Anicio Fausto, viene quasi ignorato dalle fonti letterarie ma le iscrizioni e i resti archeologici rivelano l’esistenza di una nuova e più meridionale linea di fortificazioni.
Pag. 141
Nel 248-9 il suo generale Decio ebbe identico successo, a quanto sembra, nel ricacciare Quadi, Goti e altre popolazioni dalla province del medio e basso corso del Danubio: ma a questo punto a rappresentare la minaccia principale non erano tanto i barbari, quando lo stesso Decio che, proclamato imperatore delle sue truppe – il primo dei tanti imperatori illirici – marciò su Roma sconfiggendo le forze di Filippo nei pressi di Verona.
Filippo divenne così il primo imperatore a morire in battaglia (con al possibile eccezione di Gordiano 3.), e ciò accadde contro un esercito romano.
Pag. 143
Entro l’estate del 285, Diocleziano aveva stabilito la propria autorità su tutte le province dell’Impero, cooptando poco dopo un altro ufficiale dell’esercito, Massimiano, poiché ne condividesse il potere; le frontiere richiedevano un’attività e una vigilanza costante ma i tetrarchi riuscirono a proteggerle in modo efficace.
Il loro successo più notevole fu contro i persiani: la guerra condotta da Diocleziano e dal suo vice Galerio nel 196-8 portò ancora una volta all’occupazione di Ctesifonte ma soprattutto a un trattato con il re Narses (299) che a quanto sembra stabilì il fiume Tigri come frontiera tra i due imperi (Pietro Patrizio fr. 14, am si tratta di un racconto frammentario), almeno nell’immediatezza; seguirono poi delle guerre civili (308-13, 316, 323-4) ma i tetrarchi e Costantino riuscirono a mantenere i confini esistenti.
Costantino riorganizzò l’esercito dislocando un minor numero di truppe lungo le frontiere; lo storico Zosimo, che gli era ostile, afferma nella sua Storia nuova (2, 34) che in tal modo “permise ai barbari un accesso incontrastato nei territori romani”, ma per quanto la lamentela possa essere giustificata, apparentemente l’iniziativa non ebbe alcun effetto negativo durante il suo regno; anzi, le campagne danubiane del 322, 332 e 334 videro soprattutto dei combattimenti oltre i confini e non esiste alcun indizio del fatto che i Sarmati o i Goti pensassero di aver ottenuto, appunto, un “accesso incontrastato”.
Pag. 145
Fino a che punto il rallentamento e la fine delle guerre di conquista romane furono causati da considerazioni di natura amministrativa, finanziaria o economica?
E’ importante qui non equiparare la razionalità degli imperatori o dei loro consiglieri a quella attribuita a volte ai moderni statisti, sebbene le guerre degli ultimi cento anni mostrino ben poco di razionale nelle motivazioni finanziarie o economiche che le hanno mosse.
Entro l’epoca di Tiberio, a ogni modo, chiunque contasse credeva probabilmente che Roma governasse già le zone migliori del mondo abitato, come afferma Strabone (17, 819) descrivendo in modo dettagliato tre continenti.
Tale opinione era diventata un luogo comune, ma un luogo comune abbastanza significativo.
Pag. 150
Diocleziano e Costantino rafforzarono molto la capacità di Roma di riscuotere i tributi, ma secondo alcuni storici aumentarono altrettanto notevolmente le dimensioni dell’esercito: e questo è uno dei maggiori problemi effettivi della storia romana, dal momento che condusse alla catastrofe militare avvenuta due o tre generazioni dopo la morte di Costantino.
Le scarse fonti di cui disponiamo sono in disaccordo e mentre conosciamo più o meno il numero delle legioni sotto il comando dei tetrarchi (almeno 67), non sappiamo quante di esse potessero contare sul tradizionale numero di effettivi (5280 in teoria) e quante disponessero di appena un migliaio di uomini, come è senza dubbio il caso di diverse legioni di Costantino.
Alcune erano gravemente sotto organico già ai tempi di Diocleziano (ad es., 116 effettivi in un’unità che in altri tempi ne avrebbe dovuti avere 500).
E’ comunque assai improbabile, soprattutto per motivi finanziari, che l’organico dell’epoca possa aver superato i 450-475000 effettivi agli ordini di Settimio.
Giovanni Lido, che di solito non è particolarmente affidabile per quel che riguarda le cifre, non dovrebbe però essere lontano dal vero quando afferma che sotto Diocleziano vi erano 389704 soldati (sebbene l’apparente precisione del numero non rappresenti alcuna garanzia di accuratezza).
Pag. 153
Molto dipendeva dunque dal temperamento del singolo imperatore: a Traiano e a Settimio Severo il comando militare sul campo evidentemente piaceva, ad altri meno.
Al momento del suo insediamento, la presa di Adriano sul potere era oggettivamente e soggettivamente tutt’altro che salda: in breve tempo sancì (o secondo alcuni, permise) la condanna a morte di quattro ex consoli con dei solidi precedenti militari.
E’ anche possibile che la pace si confacesse all’indole edonista dell’imperatore, il quale peraltro durante la seconda guerra in Dacia di Traiano era stato al comando di una legione, e non era certo un pacifista.
Le avventure all’estero erano di fatto inutili – i parti sapevano bene quanto Roma potesse essere pericolosa – e mettevano a rischio la posizione stessa dell’imperatore.
E poi, ancora, colui che si ribellò a Marco Aurelio, Avidio Cassio, era un generale di successo; si noti che gli usurpatori cercavano di rovesciare anche imperatori all’apparenza ben saldi sul trono come Antonino Pio (un certo Cornelio Prisciano tentò una rivolta in Spagna nel 145) e appunto Marco Aurelio.
Dal 172 al 175 quest’ultimo combatté ogni anno oltre il Danubio, ma mentre si trovava lì scrisse in greco – presumibilmente a suo uso personale – dei commenti sprezzanti sui successi militari, in cui emerge l’implicito ma chiaro giudizio che la guerra contro i sarmati fosse un atto di semplice banditismo.
Pag. 155-56
I graduali cambiamenti nella natura dell’esercito tra l’epoca di Tiberio e il 235 certamente influenzarono sia la società romana sia le lotte di potere interne.
Si può dire che ebbero altrettanta influenza sulla forza di Roma alla periferia dell’Impero?
I mutamenti veramente importanti furono tre, tutti peraltro avviati prima dell’ascesa al potere di Tiberio: il primo consistente nell’organizzazione regolare delle truppe “ausiliarie” in unità semipermanenti, i cui effettivi servivano normalmente per 25 anni prima di ricevere la cittadinanza romana all’atto di congedo – un sistema creato da Augusto e perfezionato dai suoi successori; come già nei secoli passati, gli ausiliari erano spesso più numerosi dei legionari e la loro efficacia militare era di grande importanza.
Il che porta al secondo aspetto, quello del reclutamento: all’epoca delle guerre civili (dal 49 al 31 a. C.) e sotto Augusto i provinciali avevano avuto accesso in gran numero ai ranghi delle legioni; i coscritti provenivano dalle comunità coloniali o comunque romanizzate, ma non solo: un’iscrizione risalente ai primi anni del Principato (ILS, 2483) mostra come quasi tutti gli effettivi delle die legioni stanziate in Egitto fossero stati reclutati fra le comunità di non cittadini delle province orientali (la cui lingua franca era il greco).
In tutto l’Impero le province maggiormente romanizzate fornirono un numero sempre più alto di legionari, mentre gli italici – che formavano il grosso della meglio retribuita guardia pretoriana – contribuirono sempre meno; in pratica, le autorità erano ora disposte a reclutare dei non cittadini, concedendo loro la cittadinanza all’atto del giuramento.
Questa “provincializzazione” probabilmente rifletteva uan qualche riluttanza romana e italica a prestare servizio (l’Italia era troppo prospera), ma anche una certa intenzione da parte degli imperatori di coinvolgere a pieno titolo gli abitanti delle province.
A partire dal regno di Adriano la prassi normale (a eccezione delle Britannia) fu quella di reclutare i legionari nelle province in cui erano necessari, ma partendo da elementi realmente romanizzati o ellenizzati (e i legionari erano più frequentemente alfabetizzati rispetto agli ausiliari).
Si trattava di una forza nel complesso ben organizzata e disciplinata e che probabilmente non mancava di spirito combattivo, almeno fino all’epoca di Traiano: la scelta dei comandanti sul campo di far sostenere l’urto iniziale del combattimento alle unità ausiliarie mantenendo i legionari in riserva – una prassi attestata per la prima volta in un’importante battaglia a Idistaviso, in Germania, nel 16 (Tacito, Ann. 2, 16, 3) – poteva essere dettata da varie ragioni di indole tattica.
Pag. 157-58
Il terzo cambiamento militare potenzialmente di grande importanza nel periodo precedente al 235 consistette non tanto nel fatto che con il passare delle generazioni molte unità dell’esercito romano divennero stanziali, venendo coinvolte in compiti essenzialmente amministrativi, quanto nel fatto che molti soldati romani non videro mai il campo di battaglia.
Questo esercito non era mai stato imbattibile, ma il suo disastroso fallimento nel proteggere la frontiera danubiana nel 170-71 sembra indicare un significativo peggioramento.
Forze nemiche raggiunsero l’Italia settentrionale per la prima volta in circa 270 anni mentre altre, come già menzionato in precedenza, saccheggiarono il territorio spingendosi a sud fino all’Attica: le fonti in nostro possesso al riguardo sono scarse, ma si può ipotizzare che una carenza di ufficiali e soldati con esperienza di combattimento abbia influito non poco sull’insuccesso romano, e che ciò fosse a sua volta l’effetto di una politica consapevole.
Sotto altri aspetti, i romani erano normalmente avvantaggiati: per tutto il periodo in questione rimasero superiori ai loro avversari in settori importanti quali l’artiglieria e il genio (“I romani costruiscono ponti sui fiumi senz’alcuna difficoltà, dato che sono abituati a svolgere quest’attività militare”: Cassio Dione 71, 3).
Pag. 159
Già Tiberio sapeva che valeva la pena mantenere due legioni in Dalmazia, in parte a sostegno delle altre schierate sul Danubio (Tacito, Ann. 4, 5); gli imperatori successivi finirono col concludere che l’ormai tradizionale schieramento delle forze romane, con la maggior parte dei soldati dislocata lungo i confini o nelle zone adiacenti, non era adatto a resistere a delle grandi invasioni che potevano provenire da altre direzioni.
Era sempre stato necessario bilanciare le necessità della frontiera danubiana con quelle dell’Eufrate, ma entrambi i confini divennero più pericolosi alla fine dell’epoca dei Severi; una volta poi che Roma ebbe rinunciato all’iniziativa militare le distanze divennero un problema quasi insormontabile: occorrevano più di due mesi, ad esempio, per trasferire delle truppe da Roma a Colonia.
Il meglio che si potesse fare era costituire un esercito di riserva che potesse essere inviato dovunque fosse necessario senza dover indebolire altre guarnigioni di importanza fondamentale: sembra che a creare una forza centrale di cavalleria sia stato Gallieno (cfr. Zosimo, 1, 40; Cedreno, vol. 1, p. 454, Bekker).
E’ impossibile da seguire in dettaglio lo sviluppo di questi distaccamenti, denominati comitatenses, ma a quanto pare Costantino ne ampliò il ruolo (Zosimo, 2,21, 1 potrebbe riferirsi a loro), centralizzando anche la struttura di comando dell’esercito attraverso un comandante generale della fanteria (il magister peditum).
Tuttavia, rimase difficile contrastare un’invasione su vasta scala uan volta che questa avesse superato i confini settentrionali od orientali: un governatore volenteroso avrebbe potuto reclutare una milizia locale (populares: AE, 1993, n. 231b, ci mostra un governatore della Rezia fare proprio questo nel 260), ma si sarebbe trattato di truppe in gran parte non addestrate e prive di qualunque esperienza.
Pag. 163
Nel 232-33, l’epoca in cui il raggruppamento di germani noto sotto la denominazione di alamanni (“tutti uomini”, attestata per la prima volta dalle fonti romane nel 213) inflisse all’impero dei danni piuttosto gravi, avevano ormai avuto luogo dei cambiamenti fondamentali: siamo forse dinnanzi a niente di meno che alla nascita di una nazione.
A fare la differenza in questo caso fu probabilmente un fatto piuttosto semplice: questi nuovi gruppi, come i franchi a partire dal 260 potevano schierare sul campo forze maggiori di qualunque singolo popolo germanico; ma i tetrarchi e Costantino, a quanto sembra, furono sempre in gradi di sconfiggere i popoli del nord in battaglia.
Pag. 164-65
Per certi versi l’Impero romano era piuttosto mal equipaggiato per affrontare i nemici esterni: un numero considerevole di imperatori del periodo precedente alla crisi non aveva quell’esperienza militare che li avrebbe aiutati a valutare le condizioni e le capacità delle proprie forze militari, per non parlare di quelle nemiche.
Ciò vale in particolare per Claudio, Nerone, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo (che aveva accompagnato il padre durante una campagna ma che al momento dell’ascesa al trono era appena diciottenne), Alessandro Severo e Gordiano 3. (i cui regni coprirono esattamente un arco di cento anni su un periodo di 230); ovviamente alcuni di loro, specialmente Marco Aurelio, dovettero imparare sul campo.
Pag. 165
Le fonti invece forniscono scarse informazioni su quanto bene i romani conoscessero i propri principali nemici: è evidente tuttavia che persino alcuni degli imperatori meno competenti si interessarono al funzionamento dello Stato dei parti e più tardi dei sasanidi (cfr., ad es., Erodiano 6, 7, 1 su Alessandro Severo); dal regno di Claudio fino a quello di Adriano vi sono prove di un serio interesse da parte delle autorità per regioni quali il Sudan, il Sahara e il Mar Nero orientale.
Le fonti di Cassio Dione conoscevano il nome di un certo numero di sovrani transdanubiani sotto Marco Aurelio, e anche qualche dettaglio delle loro politiche interne; non esiste invece alcuna prova che confermi l’affermazione secondo cui Commodo e i suoi consiglieri sottovalutarono “enormemente” la distanza fra il Danubio e il Baltico.
Per quanto riguarda la tattica militare, l’esercito romano durante il Principato sembra in generale essersi mantenuto ben informato (la sconfitta di Varo fu assai atipica), ma potrebbe esservi stato un qualche deterioramento già prima della grande crisi: quando Ardashir sconfisse l’esercito invasore di Alessandro Severo ciò avvenne, a quanto sembra, perché le forze persiane colsero i romani di sorpresa (Erodiano 6, 5, 9); successivamente, al rovina di Decio fu forse causata da una ricognizione inadeguata (Zosimo 1, 23, 3).
Pag. 166
Occorre aggiungere qualcosa di più sulla frontiera imperiale; questa esisteva effettivamente, anche se come già spiegato nella maggior parte dei casi il potere di Roma si estendeva anche oltre.
I confini delimitati dal Reno e dal Danubio erano chiari, e da Domiziano in poi sembrano essere esistite anche delle frontiere terrestri relativamente fisse, almeno in alcune regioni.
Niente di tutto questo implicava l’esistenza di una linea di confine immutabile o di un atteggiamento soprattutto difensivo nei confronti del mondo esterno; il problema storico non dovrebbe quindi essere posto nei termini della semplice dicotomia “o Roma voleva una frontiera difensiva fissa, oppure era ancora una potenza espansionistica”: nessuna di queste due opinioni può essere sostenuta a priori.
Il Reno, il Danubio e l’Eufrate costituirono alcuni dei confini di Roma per un periodo molto lungo, ma non impedirono – né, a quanto pare, scoraggiarono – un’ulteriore espansione; all’inizio del quarto secolo tuttavia quasi nessun romano pensava ancora a un’espansione territoriale e i tetrarchi costruirono un numero sempre maggiore di fortificazioni di frontiera, specie a quanto pare in Oriente.
Pag. 168
Conclusioni
Ci eravamo prefissi di dare una spiegazione alla crescita e alla stabilità dell’Impero.
All’epoca in cui il governo di Tiberio affermò mendacemente di aver conquistato la Germania, i tradizionali incentivi di cui godevano coloro che decidevano la politica dello Stato romano – avevano ormai perso molta della loro forza.
Le classi superiori, almeno fino al tempo di Traiano, conservarono tuttavia parte dell’antico impeto e anche successivamente la grande maggioranza degli imperatori continuò ad attribuirsi con soddisfazione il merito di aver ampliato le frontiere (così Settimio sul suo arco) e di aver sconfitto i nemici stranieri.
Ma sostenere che le grandi guerre all’estero avessero senso dal punto di vista finanziario divenne sempre più difficile, e questo modo di pensare, sebbene non inedito, sembra aver avuto maggior peso che non all’epoca di Augusto.
Gli interessi personali degli imperatori e, talvolta, la loro mancanza di esperienza militare furono poi fattori fondamentali nel limitare le guerre di conquista in tutto il periodo compreso fra il regno di Tiberio e quello di Filippo l’Arabo; e anche dopo il ritorno di una certa stabilità, negli anni Ottanta del terzo secolo, la politica interna ostacolò grandemente ogni tentativo di espansione su grande scala.
L’incredibile stabilità dell’Impero romano in quanto struttura imperiale durante questo periodo era saldamente basata sulla potenza militare e sull’utilizzo intelligente della stessa; ma questi tre secoli e oltre di confini per la maggior parte stabili necessitano di un’ulteriore spiegazione, soprattutto alla luce dei gravi disordini interni del 66-69, 193-96, 235-84 e 305-24.
Le frontiere erano sempre vulnerabili, specialmente quando il potere imperiale, per qualsiasi motivo, cessava di essere intimidatorio; ma l’Impero in sé stesso non era vulnerabile – o almeno non ancora.
Le sue risorse umane e finanziarie erano ancora sufficienti per mantenere il proprio potere sul grosso se non sulla totalità del proprio territorio; l’esercito romano a volte svolgeva i propri compiti di difesa dei confini in modo insoddisfacente persino nel secondo secolo – e come abbiamo visto andava evolvendosi in direzioni diverse -, ma sotto Diocleziano era ancora numerosi, piuttosto ben equipaggiato e diretto e adeguatamente addestrato (se fossero già presenti i semi della futura debolezza – oltre alle difficoltà di reclutamento – verrà analizzato nei capp. 5 e 6).
Ma esisteva un’altra componente della durata dell’Impero, un fattore interno difficile da descrivere con accuratezza ma ciò nonostante di comma importanza: una gran parte della popolazione credeva non solo nei destini, ma anche nell’unità imperiale.
Alla morte di Alessandro Magno i suoi estesi domini si divisero in quattro grandi regioni; anche l’Impero romano era soggetto a tendenze centrifughe e nel terzo secolo nacquero degli effimeri “Stati nello Stato”, uno in Gallia (258-74) e un altro con centro a Palmyra (261-72 ca.).
Un imperatore che si sentisse sufficientemente forte da riprendere il possesso di questi territori non avrebbe ovviamente mancato di farlo: nei fatti se ne incaricò Aureliano, ma ciò che faceva apparire il suo intervento come naturale non era tanto l’ambizione personale, quanto la diffusa identità romana di coloro che per molte generazioni erano stati integrati nei ceti proprietari romani.
Di qui che fosse importante, addirittura un vero e proprio vantaggio, il fatto che tra il regno di Settimio severo e quello di Decio gli ufficiali appartenenti all’ordine equestre avessero rimpiazzato quelli di ordine senatorio, visto che si trattava di un gruppo più numeroso formato da uomini di norma abbienti, che si consideravano romani ed erano leali allo Stato romano.
Questa immensa struttura poteva ovviamente difendersi solo finché era in grado di ottenere entrate sufficienti dai suoi cittadini e dai suoi nemici, ma aveva anche bisogno – e nel 337 possedeva ancora – di un personale amministrativo e militare sufficientemente competente e fedele dislocato più o meno nei posti giusti: costoro dovevano essere devoti, almeno fino a un grado ragionevole, all’idea di Roma.
Quanto profonda fosse questa devozione è un problema su cui torneremo nel prossimo capitolo, ma possiamo anticipare che lo fu abbastanza da mettere l’Impero di Costantino relativamente al sicuro dalle minacce imminenti di tutti i suoi nemici.
Pag. 169-71
Cap. 5. Roma contro sé stessa: da impero a nazione?
L’obiettivo principale di questo capitolo infatti è quello di spiegare in che modo un sistema caratterizzato da un potere implacabile e basato sullo sfruttamento – oltretutto in una situazione di rapida evoluzione fra la metà del terzo e il secondo decennio del quarto secolo – potesse risultare così stabile.
Ma a richiedere uan spiegazione è di fatto un doppio mistero: la durata dell’Impero romano e l’elevato grado di obbedienza che vi vigeva; caratteristiche ancor più sconcertanti se si considera che per gli standard di altre monarchie sia gli imperatori sia le dinastie romane tendevano ad avere vita breve, ed erano quindi intrinsecamente instabili.
Queste domande faranno da cornice a quanto segue, portando in primo luogo a una discussione sul potere politico in tutte le sue principali manifestazioni, poi sul potere sociale ed economico e sugli effetti, in molti aspetti della vita, dell’appartenenza a un ceto e a un genere, e infine sul potere delle convinzioni e delle idee.
Non dobbiamo considerare come scontata la durata dell’Impero romano fino all’epoca della sua prima grande frammentazione, il primo decennio del quinto secolo.
E’ vero che l’Impero riuscì sempre conservare la propria unità, pur attraversando grandi crisi interne, come avvenne durante il secondo triumvirato e di nuovo nel 69, 193-96 e periodicamente fra il 255 e il 284: i nuovi governanti e i loro eserciti, permeati da un profondo senso della maestosità dell’Impero romano nonché dei propri interessi, di solito ritennero naturale che dovesse esistere un singolo organo centrale che governasse in nome di Roma, organo cui civili e militari avrebbero nel complesso obbedito.
Come già visto, le forze armate romane si dimostrarono quasi sempre assai efficaci nel controllare le province più inquiete e nel sorvegliare i confini.
Ma l’aspetto più straordinario dei fallimenti militari del terzo secolo è che i romani riuscirono a recuperare quasi completamente le loro capacità operative.
Pag. 174
In generale, il governo imperiale manifestò la tendenza, sul lungo periodo, a passare gradualmente dai metodi alquanto confusi dell’epoca repubblicana a una serie di procedure di natura più sistematica e regolarizzata; come si vedrà più avanti, queste procedure divennero sempre più competenza di funzionari esperti, almeno fino alle crisi militari del terzo secolo.
Pag. 175
Nel frattempo, le forze armate svolgevano uan tripla funzione: affrontavano le minacce esterne; collaboravano, come vedremo, all’amministrazione delle province meno mature (mature dal punto di vista romano, ovviamente); e grazie al reclutamento su larghissima scala dei non cittadini, trasformati così in soldati di Roma, promuovevano l’identità romana.
Questa tesi è nel complesso convincente, ma occorre corredarla di un’ulteriore dimensione sia storica sia (ed è un aspetto fondamentale) sociologica.
Nel seguito del capitolo fornirò il contesto sociologico: qui accennerò ad alcuni cambiamenti di tipo storico.
Pag. 176-77
Chi erano dunque le persone da integrare e di cui conquistare il sostegno (il che costituisce invece la dimensione sociologica del problema), due processi fino a un certo punto indipendenti?
Flavio Giuseppe ancora una volta mette in luce una verità fondamentale osservando (Guerra giudaica 2, 338) che nella Giudea del 66 le persone agiate desideravano la pace, il che è ovvio: per costoro l’Impero era una garanzia di tranquillità e di rispetto dei diritti di proprietà.
Fin dai tempi della conquista romana dell’Italia, secoli prima, Roma si era sempre mostrata incline a favorire gli abbienti – normalmente proprietari terrieri – in qualsiasi comunità straniera, ricompensandoli con privilegi politici e attirandoli nell’orbita romana: “Non c’è bisogno di guarnigioni che tengano sotto controllo le acropoli, ma ovunque i cittadini più importanti e potenti custodiscono le loro patrie per voi”, scrive Elio Aristide (A Roma 64), e per una volta aveva perfettamente ragione.
Pag. 180
Tornando alla questione dell’integrazione culturale, la plurisecolare diffusione dell’identità romana fece un’immensa differenza nello stabilire chi esercitasse l’autorità nel mondo romano e chi ne fosse suddito; la “provincializzazione” della classe dirigente e dell’esercito condusse al potere persone diverse, ma anche il concetto stesso di “romanità” era andato man mano evolvendosi.
La natura sbilanciata delle fonti in nostro possesso rende piuttosto ipotetica la ricostruzione di una storia culturale complessiva dell’Impero: alcune regioni sono poco conosciute e – dato ancora più importante – il numero delle testimonianze relative alla massa della popolazione, fatta eccezione per l’Egitto, è assai limitato, nonostante la grande quantità di reperti archeologici.
Uno studio sul potere nell’Impero deve infatti poter giudicare quanto i suoi abitanti si sentissero romani, con l’ulteriore complicazione dovuta al fatto che la cultura dominante era anche greca, oltre che romana.
Così, mentre noi possiamo considerare alcuni cambiamenti culturali come segni di romanizzazione (un termine indispensabile, a patto che non venga inteso come un riferimento a una qualche politica complessiva), questi potrebbero non essere stati percepiti all’epoca come specificamente romani.
Ciò può valere, ad esempio, per tutta una serie di fenomeni che vanno dalle forme romane di urbanesimo alla diffusione dei combattimenti fra gladiatori in tutto l’Impero occidentale e in parte di quello orientale; può anche valere per la massiccia diffusione in tutto l’Occidente di manufatti di stile romano – molti dei quali in realtà di origine ellenistica – quali le lampade di terracotta, il vasellame noto come terra sigillata, o il vetro.
Pag. 181
Molte pratiche di governo, fra cui l’abitudine di reclutare un gran numero di soldati in province relativamente poco romanizzate o ellenizzate come la Germania Inferiore, la Tracia o la Cappadocia, contribuirono in parte ai mutamenti linguistici e in generale a una più ampia diffusione della cultura.
Pag. 182-83
La conoscenza di testi romani canonici come l’Eneide si diffuse in tutta l’élite della metà latina dell’Impero; i culti religiosi erano talvolta stati duramente perseguitati nel corso della conquista romana e nella fase immediatamente successiva (Britannia, Giudea), ma di solito le divinità locali sopravvissero, anche se grazie al sincretismo con quelle greco-romane.
Quanto la lingua latina abbia finito per diffondersi possiamo constatarlo, grosso modo, dal fatto che portoghese, spagnolo, francese e romeno devono infinitamente di più al latino che non a qualsiasi altro substrato linguistico.
Con l’allargamento della cittadinanza, prima e ancor di più dopo l’editto di Caracalla (212), si diffuse anche il diritto romano; tuttavia, per la maggior parte dei provinciali le leggi locali rimasero le più importanti, sia nel periodo precedente all’editto sia persino in quello successivo, in cui sembra chiaro (ma la questione è controversa) che in molti territori tali leggi continuassero ancora a far parte del sistema giuridico.
Pag. 183
Coloro che odiavano Roma e lo esprimevano attivamente, come ad esempio l’autore dell’Apocalisse o quelli degli Oracoli sibillini del secondo e terzo secolo (cfr. ad es. Oraculi sibillini 8, 31-42, 91-5, 121-9) costituivano forse non più di una minoranza, e di fatto gli stessi cristiani rimasero una minoranza, e di fatto gli stessi cristiani rimasero una minoranza assai contenuta fino al tardo terzo secolo.
Gli ebrei della giudea si dimostrarono estremamente recalcitranti alla dominazione romana e di conseguenza nella rivolta di Bar Kokheba subirono una rappresaglia prossima al genocidio: a opera dei romani “furono rase al suolo cinquanta delle loro principali fortezze e novecentottantacinque dei loro più rinomati villaggi, mentre vennero uccisi, nelle scorrerie e nei combattimenti, cinquecentottantamila uomini […] cosicché quasi tutta la Giudea rimase spopolata” (Cassio Dione 69, 14; le cifre sono problematiche, ma il massacro fu senza dubbio di proporzioni spaventose).
Colpisce che persino un greco filoromano come Plutarco possa riferirsi all’Impero come a un sistema schiavista, mentre anche Elio Aristide, il quale godeva di una posizione privilegiata e divenne famoso per il panegirico di Roma pronunciato in Senato probabilmente nel 143, risulta a un’attenta analisi aver nutrito un profondo risentimento nei confronti del dominio romano.
Pag. 184
Non possediamo alcuna statistica aggiornata, ma stando alle cifre più recenti quasi la metà dei senatori di cui si conoscono le origini ai tempi di Adriano veniva dalle province, mentre poco dopo quelli provenienti dal mondo greco risultano formare circa il 50% di questo contingente; l’ordine equestre attraversò un’evoluzione simile.
Ma va notato che questi nuovi arrivati erano di cultura latina e greca, e che nel complesso appartenevano alla stessa classe sociale dei loro predecessori: vivevano quasi tutti di rendita.
Fino a che punto gli abitanti liberi dell’Impero costantiniano del quarto secolo si identificassero con Roma è uan questione delicata, sulla quale ritorneremo di nuovo alla fine del capitolo.
Ognuno di loro sapeva di essere cittadino romano, e anche coloro che si areno “alienati” come Tertulliano (apologeta cristiano dell’Africa proconsolare) davano per scontato che tutti (eccetto ovviamente i cristiani) appartenessero allo stesso Stato o comunità (civitas, Apologeticum 1,7), quella romana.
A dire il vero, non esisteva molto spazio per gli “alienati” se non ai margini dell’Impero, e la loro situazione iniziò ad assumere importanza solo quando Decio cercò di eliminare il cristianesimo e, più tardi, quando il numero dei fedeli iniziò a crescere a dismisura.
Per quando riguarda i soldati, la grande maggioranza degli uomini che combatté nelle milizie di Roma nel secondo e terzo secolo era composta di provinciali, e non vi è alcun motivo di dubitare della loro identità romana, né peraltro alcuna prova che tale identità fosse incondizionata; sembrano aver appoggiato assai raramente uan qualche causa antiromana, e quando si ribellavano o disertavano era per motivi assolutamente banali, come il mancato pagamento dei salari.
Pag. 188
Come tutti gli uomini di potere, anche l’imperatore prestava ascolto alle sue conoscenze più fidate, ai suoi “amici”, che in età altoimperiale erano quasi tutti senatori o cavalieri; consultava inoltre coloro che considerava le personalità “principali” di entrambi gli ordini.
Qualsiasi ipotesi di un formale consiglio di collaboratori (consilium) venne archiviata da Tiberio, ma gli sviluppi successivi sono controversi: tutto dipendeva, a quel che sembra, dal tipo di decisioni da adottare.
Se si trattava di una questione giuridica, come accadeva di frequente, veniva esaminata da un apposito consilium, almeno ai tempi di Adriano che vi incluse degli esperti di diritto (Historia Augusta, Adrianus 18).
Quando l’imperatore si occupava di altri problemi, ad esempio fiscali o militari, non vi sono indicazioni in merito alla consultazione di un organo istituzionale (la migliore prova in contrario, Erodiano 7, 13, riguarda l’anomalo regno di Alessandro Severo), ma richiedere il consiglio degli amici poteva comunque essere questione di una certa formalità (altrimenti non avrebbe senso la satira di Giovenale 4, 72-154).
Pag. 190
Con il tramonto del potere del Senato divenne concepibile che un potente generale di ordine equestre giungesse alla porpora imperiale.
Il primo – e dalla vita breve – fu Macrino (217), un ex comandante della guardia pretoriana; da Massimino il Trace (235-38) in poi gli imperatori con alle spalle una lunga esperienza militare divennero sempre più una necessità, e la loro origine non senatoria la norma.
Ma l’eliminazione dell’antica aristocrazia non mise al sicuro la persona dell’imperatore; Walter Scheidel ha dimostrato come i regni degli imperatori romani siano stati più corti fra tutte le trentuno varie monarchie da lui prese in considerazione (anche gli imperatori bizantini ebbero la vita relativamente breve).
Le dinastie romane durarono a lungo: dei settantadue uomini che tra il 16 e il 337 possono ragionevolmente essere classificati come Augusti e non semplicemente come degli usurpatori di secondaria importanza, cinquanta morirono a causa di una qualche azione militare romana;la loro aspettativa di vita fu specialmente limitata fra il 211 e il 284.
Non sorprende certo che le radici militari del sistema monarchico si trasformassero in una minaccia, a meno che un princeps non fosse astuto, vigile e fortunato: tuttavia, l’alto tasso di “fine prematura” (Scheidel) fra gli imperatori romani necessita di qualche spiegazione che vada al di là delle responsabilità dell’esercito o dell’inclinazione dei romani allo spargimento di sangue, per quanto importanti fossero questi fattori.
Le milizie infatti non vennero mai addomesticate; Settimio Severo, sul letto di morte, consigliò come è noto a Caracalla e a suo fratello: “Andate d’accordo tra di voi, arricchite i soldati, non datevi pena di tutti gli altri” (Cassio Dione 76, 15, 2).
E per quanto riguarda l’inclinazione alla violenza, in quale altro paese Caracalla sarebbe stato ampiamente ritenuto colpevole di aver architettato la morte del padre Settimio, che lo aveva nominato coimperatore.
Pag. 192-93
Domande imperiali
- La lealtà delle milizie
- L’ideologia
- L’obbedienza della popolazione civile
Risulta dunque chiaro che se da un lato gli imperatori si sforzavano di guadagnarsi e di conservare il sostegno delle élite provinciali, dall’altro non vi è motivo di pensare che siano anche riusciti a raggiungere un obiettivo così ambizioso come la creazione di un “consenso” di massa della popolazione, in Oriente o in Occidente.
E’ di fatto probabile che vi fosse una grande variabilità non solo fra le province “interne” e quelle “esterne”, ma anche fra città e campagne; proprio alle città spettava sempre più il compito di trasmettere il messaggio imperiale: pare che fin dagli inizi la corte distribuisse dei ritratti dell’imperatore alle principali località.
Tuttavia, la maggior parte della popolazione era ovunque formata da contadini e braccianti, gente che probabilmente non fu molto influenzata dai messaggi che arrivavano dal centro: il massimo che gli imperatori possono aver ottenuto dalla massa dei provinciali era l’acquiescenza e, in una certa misura, un cambiamento di identità.
Per molto tempo fu forse tutto ciò di cui ebbero bisogno: ma in seguito, come ha acutamente osservato Keith Hopkins, il fatto che “l’Impero nel suo complesso non possedesse dei rituali efficaci che conferissero a tutti i suoi abitanti […] una singola identità collettiva” – in netto contrasto con il coeso corpo cittadino di epoca medio repubblicana – contribuì a renderlo vulnerabile ai cristiani prima e ai germani poi.
4. La successione
Per quale motivo gli imperatori non riuscirono mai a istituire un sistema stabile di successione?
SI potrebbe sostenere che ciò non fosse particolarmente insolito, almeno fino a quando il fenomeno non si intensificò a partire dal 235, dato che molte altre monarchie premoderne ebbero gravi problemi a questo riguardo.
Prima del 211 la maggior parte degli imperatori cercò di designare in vita il prossimo princeps e coloro che avevano dei figli naturali, persino dei figli palesemente inadeguati come Commodo, li volevano come successori.
Ma cosa accadeva quando un imperatore rimaneva vittima di morte violenta?
La prima volta in cui la successione apparve poco chiara, dopo l’omicidio di Caligola nel 41, fu la guardia pretoriana a decidere chi dovesse governare, mettendo così fine alle ubbie senatorie di restaurazione della repubblica.
Da allora in mancanza di un successore prestabilito la decisione venne, quasi sempre, demandata alla forza delle armi.
Ma a parte il fatto che fino al terzo secolo nessuno poteva diventare imperatore se fra le altre cose non era un senatore eminente, esistevano delle convenzioni da rispettare che non dovrebbero essere liquidate come una pura e semplice formalità.
In altre parole, l’Impero romano reclutava adesso i suoi dirigenti in un bacino di talenti assai più vasto.
Le difficoltà incontrate dagli imperatori nel sopravvivere e nel trasmettere la propria autorità ai loro eredi personali riflette i limiti del loro potere, questione su cui torneremo.
5. Le donne imperiali
6. I limiti del potere imperiale
I veri limiti del potere imperiale erano di ordine pratico e riguardavano principalmente il denaro, le informazioni e il tempo.
La ricchezza dell’imperatore era in linea di principio immensa, ma altrettanto lo erano le spese: le stravaganze o una guerra inaspettata potevano portare a una drastica mancanza di liquidità (come dovettero scoprire loro malgrado Nerone, Marco Aurelio e Pertinace, fra gli altri).
Ma la maggiore difficoltà riguardava il sapere che cosa stesse succedendo lungo i confini e oltre, fra i pubblicani, nelle milizie e persino nella stessa corte; i procuratori imperiali e i governatori delle province imperiali inviavano lettere in cui la qualità delle informazioni era spesso buona e abbastanza aggiornata, ma senza dubbio per lo più di carattere apologetico.
La corrispondenza fra Plinio e Traiano (Ep. 10) non deve essere considerata tipica: Plinio era stato inviato in Bitinia in seguito a una crisi scoppiata nella provincia.
Ma è anche vero , come già constatato, che gli imperatori mostravano interesse per i dettagli locali.
Sol un uomo dal talento straordinario avrebbe potuto governare l’Impero romano di questo periodo, diventato ormai troppo vasto per essere gestito come nell’Antichità.
In un serto senso i romani avevano vinto troppe guerre, o piuttosto avevano bisogno di un sistema di decentramento più efficace, a cui provvide Diocleziano.
Si potrebbe affermare che un buon terzo degli imperatori da Tiberio ad Alessandro Severo dimostrò di essere abile e capace nel governo; ma va anche detto che per tutto il periodo dei regni brevi e generalmente precari iniziato nel 211, o almeno dopo il 235, il potere imperiali si era notevolmente indebolito.
Le conseguenze più importanti furono probabilmente di natura fiscale, il che ci porta alla questione fondamentale delle finanze.
7. L’imperatore e il denaro
Tale interesse era necessario, perché dal princeps ci si aspettava che fosse munifico: si è già visto come ciò valesse per l’esercito e la plebs urbana, ma la liberalitas era una qualità di importanza assai più generale e dai tempi di Adriano e fino al terzo secolo inoltrato fu la più celebrata sulle monete.
Nella pratica la munificenza iniziò tuttavia ad avere delle conseguenze discutibili: le città che erano riuscite a ottenere un’esenzione fiscale erano poche all’inizio, ma entro l’epoca dei Severi queste concessioni comportavano uan diseguale distribuzione del carico fiscale.
Nell’elencare le città di alcune province cui gli imperatori avevano concesso l’esenzione dalle tasse di proprietà, Ulpiano (D. 50, 15) dà l’impressione che questo privilegio fosse ormai ampiamente diffuso, cosa che è confermata anche da altre fonti e che nel 250 provocò forse una reazione contraria.
A doversi mostrare generosi erano soprattutti gli usurpatori: da questo deriva la reputazione di spendaccione di Costantino (la cui rivendicazione al trono era peraltro legittima quanto quella di tanti altri), il quale se lo poté permettere grazie al fatto che Diocleziano e gli altri tetrarchi avevano reso più efficace il sistema di tassazione.
Pag. 194-208
Diocleziano e Costantino
Diocleziano, Massimiano e Costantino vissero più a lungo della maggior parte dei loro colleghi, in parte grazie al rinnovamento della rete di spionaggio interno: come già accennato, gli imperatori erano soliti impiegare i frumentarii come agenti per la raccolta di informazioni, ma in questo periodo, a quanto sembra, li sostituirono in tale funzione da agents in rebus o agentes rerum (Aurelio Vittore, Epitome 29, 44-5), benché si possa solo ipotizzare quale differenza comportò tale scelta.
Anche le guardie del corpo imperiali erano numerose, ma i metodi con cui Diocleziano riuscì a potenziare il controllo imperiale andavano ben al di là della (peraltro non banale) salvaguardia da possibili assassinii.
Sia lui sia Costantino compresero pienamente come mantenere il sostegno dei soldati.
Diocleziano ripristinò con successo i censimenti nelle province, essenziali per un’efficace riscossione dei tributi; lo stesso sistema di tassazione delle persone fisiche e delle proprietà venne radicalmente riorganizzato e in tutto l’Impero le comunità che avevano goduto di privilegi sembrano aver perduto al propria immunità.
Diocleziano impose anche una riorganizzazione su vasta scala delle province, frazionando le circa cinquanta esistenti in un centinaio (in un caso estremo l’Asia, pur di dimensioni modeste, fu divisa in sette regioni).
L’Impero venne suddiviso poi in “diocesi”, ciascuna composta di otto o nove province (queste diocesi non sono attestate fino al 314, data nella quale tuttavia non costituivano certo una novità); anche in questo caso l’obiettivo era chiaramente quello di facilitare la riscossione delle tasse.
Pag. 210
Qui inizia a porsi il problema della burocrazia, che ricorrerà in tutta la trattazione del potere dello Stato nel tardoantico.
Nel 288 ci imbattiamo infatti per la prima volta in un fenomeno ricorrente nel quarto secolo: un alto magistrato in Egitto che per ragioni finanziarie cerca di mantenere limitato il numero dei propri subordinati (P.Oxy. 1, 58); il controllo centrale, che era stato debole, con l’ascesa di Diocleziano potrebbe essersi nuovamente rafforzato.
Tuttavia è anche probabile che si moltiplicasse il numero dei funzionari, almeno in parte per motivi legittimi: vi sono infatti prove sufficienti per dimostrare come in alcune zone, in cui la tenuta dei registri godeva di grande tradizione, la produzione di documenti fiorì sotto Diocleziano come mai in precedenza.
Pag. 211
Costantino diede due straordinarie dimostrazioni di potere: fondò uan capitale alternativa circa 1400 chilometri più a est, e introdusse niente di meno che una nuova religione di Stato al posto di quella esistente.
La fondazione di una nuova capitale era in parte il riconoscimento di un dato di fatto – ovvero che nel periodo recente gli imperatori raramente avevano avuto bisogno di recarsi a Roma – e inferse il colpo di grazia al potere del Senato; ma soprattutto, diede all’Impero una capitale più vicina ad alcune delle zone più vulnerabili, il basso Danubio e la Mesopotamia, il che costituiva un netto vantaggio (e nel lungo periodo la sua posizione si rivelò meglio difendibile).
L’innalzamento del cristianesimo a uan posizione di privilegio naturalmente ebbe col tempo un enorme effetto sulle strutture di potere interne dell’Impero e anche nel breve periodo diede agli ecclesiastici visibilità e accesso alla munificenza imperiale.
Sarà importante poter valutare quale fosse il potere secolare dei vescovi: nel 318 detenevano già la giurisdizione sulle cause fra i cristiani – un’importantissima deroga dei poteri dello Stato -, e anche se pochi fra di loro erano esperti di diritto; tuttavia, Costantino sembra aver promosso sia cristiani sia appartenenti alla religione tradizionale senza alcun pregiudizio apparente.
Pag. 211-12
Se un cittadino romano ben raccomandato coem Plutarco poteva provare un simile nervosismo, figuriamoci un magistrato locale meno protetto: non meraviglia che verso il 100, in Italia e altrove, alcune città iniziassero a incontrare delle difficoltà a trovare persone disponibili ad assumere un incarico pubblico; in seguito questo divenne un problema diffuso, al quale l’imperatore doveva a volte porre rimedio inviando dei commissari (curatores).
Tuttavia, il potere di queste élite municipali fu per molto tempo una delle due colonne portanti (l’altra era l’esercito) dell’intera struttura imperiale: ad amministrare la giustizia erano i magistrati romani, ma questi tendevano sempre a limitare il loro intervento alle questioni più importanti, riguardo sicurezza e finanza (e protezione dei cittadini romani), lasciando quindi la maggior parte della giurisdizione nelle mani della magistratura locale.
L’utilità delle funzioni delle élite locali andava però ben oltre le questioni strettamente politiche e giuridiche: a loro spettava organizzare i giochi dei gladiatori e se necessario gli approvvigionamenti, e spesso si occupavano della costruzione degli edifici pubblici assumendosene il merito; e pur escludendo i liberti dalle cariche pubbliche, convivevano con i più prosperi fra questi – e accettavano il principio della mobilità sociale concedendo i titoli onorifici locali anche ai figli dei liberti.
In precedenza, abbiamo accennato alla distinzione fra province “interne” e quelle “esterne”: in almeno alcuni territori di queste ultime élite autoctone erano ritenute a quando sembra incapaci di provvedere al governo locale; in questi casi toccava all’esercito colmare il vuoto, normalmente nella persona dei centurioni che in Egitto (esclusa Alessandria) agivano da giudici de facto, coadiuvati, dove necessario, da piccoli distaccamenti di soldati.
In Britannia esistevano dei centurioni regionali, dotati probabilmente di ampi poteri, e quando nel terzo secolo il procuratore imperiale dovette comporre un conflitto fra due piccole comunità della Frigi la persona incaricata di far applicare la sua decisione fu un optio, uan specie di vicecenturione.
Pag. 216-17
Fino a che punto contava il merito nelle carriere funzionariali di alto livello?
Nella sottoclasse sociale veniva dato per scontato un certo grado di competenza: sembra che i suoi membri pensassero che un’adeguata educazione bastasse a garantirla (cfr. Cassio Dione, specialm. 52, 26) e gli imperatori raramente o mai davano la preferenza a un possibile candidato sulla base delle sue conoscenze specifiche; il merito maggiore consisteva nella “buona reputazione”, un’espressione di comodo per definire uan combinazione di lealtà, buone maniere e opinioni convenzionali.
Per tornare al tema della burocrazia, lo Stato romano dovette creare delle strutture pubbliche per venire incontro alle proprie necessità fiscali e militari: doveva gestire un esercito in armi di circa 350000 uomini, e per riscuotere le tasse aveva dovuto ideare dei censimenti provinciali.
Tali questioni amministrative di routine non hanno lasciato molte tracce nelle fonti letterarie, e sappiamo che non erano ovunque le stesse.
E’ probabile che il sistema sia diventato sempre più complesso sotto la dinastia dei Severe.
Pag. 220
I funzionari di cui abbiamo parlato condividevano molti valori e convinzioni: a essere forse più rilevante in questo contesto è la loro palese fiducia nella permanenza e nell’inevitabilità della potenza romana (e non solo del potere).
Non dovremmo considerarli tolleranti, virtù che necessita di un qualche retroterra intellettuale, ma ben disposti ad accettare la diversità nelle questioni non essenziali, mentre nelle altre imponevano un sistema di governo che serviva gli interessi delle classi più elevate della società, offrendo nel contempo ampie opportunità per quelle che potremmo chiamare “classi medie”.
Successivamente tornerò sugli aspetti psicologici e filosofici della loro fiducia in questo sistema di potere, e su cosa accadde quando Costantino rovesciò l’elemento religioso della vecchia ideologia.
Pag. 221
Questi proprietari terrieri del quarto secolo ci portano a un’ulteriore considerazione sul potere sociale, con il quale intendo il potere esercitato da coloro che godevano di una relativa ricchezza e posizione sociale (compreso il vantaggio di essere maschi).
Ovviamente la distinzione fra potere dello Stato e potere sociale è alquanto artificiosa: la maggior parte delle volte erano le stesse persone ad esercitare entrambi.
A fare la differenza era il fatto che mentre il potere statale riguardava tutti ma i suoi effetti sul singolo individuo potevano essere limitati o saltuari (a seconda della cittadinanza, era invece sempre universalmente presente.
Ma in che modo è possibile descrivere strutturalmente questa società?
Il problema essenziale è capire se ci si debba concentrare sulle distinzioni di status utilizzate dagli abitanti dell’Impero romano o parlare invece in termini di classi sociali.
Innanzitutto, va notato che alcune categorie sociali come “senatore” o “cavaliere” riguardavano una percentuale infima della popolazione, e una descrizione dettagliata dovrebbe tener conto non solo di questa distinzione ma anche di un’ampia gamma di status provinciali più o meno conosciuti, come il ceto “ginnasiale” nell’Egitto romano.
In secondo luogo, i greci e i romani – e probabilmente ogni altra popolazione romana – mettevano spesso a confronto ricchi e poveri, senza definire ciò che intendevano più di quanto normalmente non facciamo noi; i termini per “povero”, in particolare, potevano riferirsi ai lavoratori meno abbienti o ai gravemente indigenti.
Ora, lo status influenzava ovviamente i rapporti di potere: soprattutto, molto dipendeva dall’essere di un libero, uno schiavo o una via di mezzo fra i due (il che poteva coler dire un liberto – fino al terzo secolo ve ne furono sempre molti – o un dipendente di altro genere).
Sono stati scritti libri su libri per illustrare come si traducessero queste condizioni di vita, di cui esamineremo gli aspetti più importanti.
Tuttavia, va considerato anche l’aspetto della classe sociale: non occorre fare di questa espressione un feticcio ideologico (potremmo anche parlare, in modo meno agevole, di tre generi di esistenza umana), ma di fatto essa possiede un grande potere esplicativo.
Non è questa la sede per una discussione teorica dettagliata, ma è comunque del tutto privo di logica affermare che la classe sociale non era importante data l’esistenza dei legami verticali del patronato personale, che caratterizzavano praticamente ogni società premoderna di cui si conservi documentazione storica.
Pag. 223-24
La vita degli schiavi era di norma dura e mostrava tutta la spietatezza del potere interno, il corrispettivo della brutalità dei romani nei confronti dei nemici esterni dello Stato: in questo periodo, la legge e le consuetudini romane permettevano ai proprietari di schiavi di metterli a morte a proprio piacimento; dove prevalevano leggi e usi provinciali non era sempre così, ma successivamente come è ovvio il diritto romano finì per esser applicato dappertutto.
Le terribili punizioni corporali erano consuete e là dove la schiavitù era una presenza cospicua nell’economia agricola si usavano le squadre di lavoro forzato.
E’ probabile che fossero pochi gli schiavi ad aver goduto di una vita familiare stabile, mentre lo sfruttamento sessuale era estremamente diffuso.
Pag. 226
A livello individuale, gli schiavi spesso reagivano, ma a parte l’omicidio, le loro armi principali erano l’inadeguato svolgimento del lavoro, la finta malattia e il furto: tutti e tre i metodi erano endemici, ed evidentemente anche il ricorso alla fuga era piuttosto comune.
Pag. 227
Nell’Impero romano le donne erano ovviamente escluse quasi ovunque dal potere politico formale, ma per quanto riguarda il potere sociale e quello economico la questione era piuttosto diversa: a ogni livello sociale le donne erano meno influenti degli uomini, ma a contare di più era precisamente il livello sociale della persona.
Il periodo in esame iniziò e finì con due influenti Augustae, Livia e Elena (di fatto assai meno potente); talvolta l’influenza politica esercitata da alcune donne appartenenti alle classi sociali superiori era tale da indurre un imperatore tirannico a esiliarle (Plinio, E. 3, 2, 3).
Pag. 227-28
Gli svantaggi peraltro iniziavano già alla nascita: alcune popolazioni abbandonavano più di frequente le neonate che non i neonati; poche bambine poi venivano mandate a scuola e il paradosso per cui alcune donne possedevano un’istruzione elevata si doveva soprattutto allo studio privato.
In ogni caso il matrimonio veniva imposto in giovane età: molte si sposavano a 12 anni, la maggioranza probabilmente si era già maritata a 15 o 16 e quasi tutte prima dei 20; le nubili, per quanto ne sappiamo, erano di norma costrette a sposare un uomo scelto dalla propria famiglia.
Pag. 228
Chiunque aspirasse a un autonomo esercizio del potere aveva bisogno di saper leggere e scrivere correntemente: l’amministrazione dello Stato, delle milizie, delle province e delle loro comunità costituenti dipendeva dalla parola scritta.
Le istruzioni (e le relative risposte) potevano essere emanate oralmente, ed esistevano diversi intermediari come i familiari acculturati, i banditori pubblici e gli scribi a pagamento, ma i semialfabeti e gli analfabeti totali si trovavano senza dubbio in una posizione alquanto vulnerabile: in qualunque transazione complessa erano costretti ad affidarsi alla propria memoria e all’onestà degli interlocutori.
La diffusione dell’alfabetismo doveva variare a seconda dell’ambiente sociale, ma nel complesso era elevata per gli standard dell’antico Vicino Oriente, bassa per quelli dell’Europa occidentale ottocentesca: forse un 10% della popolazione adulta, compresi donne e contadini, era in grado di leggere e scrivere almeno a un livello modesto.
La vulnerabilità di un simile sistema educativo non sta tanto nel suo possibile discredito, quanto nel fatto che possa diventare irrilevante: Macrino, Massimiano e i successivi imperatori-soldato del terzo secolo non avevano bisogno di alcuna reputazione di uomini colti.
Nel frattempo, avendo fallito nel tentativo di coinvolgere le masse nell’alta cultura e nei suoi ideali, l’élite rimase scioccata nello scoprire, forse non molto tempo prima delle persecuzioni di Decio, che una religione fanatica che rinnegava quegli ideali stava conquistando un gran numero di fedeli.
Pag. 230
A un primo sguardo si potrebbe dire che la tendenza generale dei governi tetrarchico e costantiniano fu di rendere l’Impero ancor più opprimente; nel contempo, tuttavia, Costantino cercò almeno di sfruttare il suo potere per alleviare la povertà, dichiarando persino – senza dubbio con scarsi effetti – che “le orecchie del giudice presteranno ascolto ai più poveri così come ai ricchi”.
Pag. 231
Quest’ultima osservazione ci porta naturalmente alla questione del potere delle idee, ma gli storici non concordano su alcun modello quantitativo, cosicché si corre il serio pericolo di rimanere sul vago, trappola nella quale sono talvolta caduti quegli studiosi che hanno scritto sul “potere delle immagini” e sul “potere della religione”.
Ciò di cui intendo occuparmi in questa sede, a ogni modo, non è del potere che alcune idee – come quelle degli stoici o di altri filosofi, oppure dei cristiani – possono aver tutto nel cambiare la vita delle persone, per quanto sia certamente uan legittima materia di indagine, bensì del potere delle idee di rafforzare, modificare o sovvertire i rapporti di potere sociali e politici.
Mi concentrerò quindi su quelle idee che possono essere associate a delle effettive pratiche sociali o politiche: ciò significa ad esempio che l’ideale della paideia (cultura), che nel bene e nel male forgiava il modo in cui le famiglie abbienti educavano i propri figli e occasionalmente le proprie figlie, aveva un’importanza notevole, come già visto.
Di contro, è difficile identificare quali siano stati gli effetti della missione civilizzatrice dell’humanitas, che ebbe una qualche diffusione nella seconda metà del primo secolo (Plinio, Nat. Hist. 3, 39): certo fu di conforto alle classi superiori istruite, ma ebbe qualche altro effetto sociale o politico?
Pag. 231
Pochi storici si sono chiesti quale concetto di Roma e dell’Impero avessero in questo periodo gli stessi romani: esisteva un’idea in cui credevano quegli ufficiali dell’esercito che si trascinavano nel fango della Britannia e della Dacia?
Si, con ogni probabilità.
Un impero perfettamente organizzato non era solo un alato ideale retorico di Elio Aristide: tutti i romani che riflettevano sulla questione ritenevano che Roma fosse la grande potenza mondiale, erede di una tradizione gloriosa e destinata a durare per sempre (su quest’ultimo punto cfr. Elio Aristide, A Roma 108, nonché e le monete di Adriano e dei suoi successori con la legenda ROMA AETERNA).
Qualunque viaggiatore rimaneva impressionato dalla città e dalle strade dell’Impero, dalla sua grandezza e dalla sua maestosità.
Nel 248 Roma celebrò il suo presunto millesimo compleanno e senza dubbio il fatto che l’imperatore in carica fosse un siriaco (Filippo) costituisce un segnale di forza; allo stesso modo, il fatto che Costantino sia stato in grado di fondare uan nuova capitale senza alcuna perdita significativa di credito politico dovrebbe essere considerato un segno di coesione nazionale.
A mancare in larga misura nel periodo tetrarchico-costantiniano è però uan qualche nuova espressione del mito nazionale – mito che il cristianesimo era impegnato a minare alle fondamenta.
Pag. 232
Il sistema di idee di carattere più marcatamente filosofico che si ritiene abbia sostenuto l’alto impero è quello di un tardo (e annacquato) stoicismo, ma gli effetti delle idee specificamente stoiche sui rapporti di potere furono probabilmente scarsi.
Il principale risultato ottenuto dall’”opposizione filosofica” di età neroniana e flavia, a parte la sua stessa distruzione, fu il rendere la vita difficile a dei veri filosofi come Epitteto.
Vi sono pochi motivi di pensare che quando i romani al potere trattavano i propri sudditi o i propri schiavi in maniera appena decente lo facessero per ragioni teoriche, piuttosto che per semplice prudenza.
E’ stato sostenuto che gli stoici cercarono di indurre i padroni del mondo a trattare i loro sudditi con un certo grado di umanità; è vero che lo stoicismo era moralistico, ma tendeva anche al fatalismo e poco o niente nel comportamento pubblico, né in quello privato, di Seneca e Marco Aurelio – su cui siamo ben informati per i parametri della storia antica – riflette uno stoicismo distinto dalle norme convenzionali delle classi superiori romane.
E’ vero che Arriano, al quale dobbiamo la nostra dettagliata conoscenza dello stoicismo di Epitteto, era egli stesso un funzionario romano, ma le sue convinzioni ne influenzarono il comportamento?
Peter Brunt ha sostenuto che il cosiddetto cosmopolitismo degli stoici romani non ebbe “conseguenze pratiche”; d’altro canto sembra probabile che il concetto, oramai diffuso nel periodo in esame, che i governanti dovessero controllare la propria ira abbia avuto un qualche effetto: dopo tutto, aveva delle basi prudenziali e non solo teoriche.
Pag. 233-34
Ma in che senso dunque il cristianesimo si dimostrò effettivamente sovversivo?
Come la magia, o un certo numero di altri culti, offriva l’accesso a un universo alternativo in cui l’imperatore e i suoi odiosi agenti venivano sostituiti da ben altre potenze.
Dopo il 312 la nuova religione acquisì importanza principalmente in due modi: portò uan nuova gerarchia, quella ecclesiastica – e in generale indifferente agli interessi dello Stato – a esercitare il potere secolare e creò le condizioni per un’imminente polarizzazione della lealtà religiosa nell’unico gruppo dove la fiducia nel divino aveva un’importanza pratica, l’esercito.
Entrambi questi sviluppi sono già visibilmente in atto, ad esempio, quando nel 335 i cristiani di Alessandria impiegarono i soldati per perseguitare coloro con le cui opinioni teologiche erano in disaccordo (P. Lond. 6, 1914); avremo modo di ritornare sull’ossessione cristiana per l’eresia, e le sue conseguenze, nei capitoli successivi.
Pag. 234-35
Possiamo terminare questo capitolo con alcune osservazioni su coloro che di tanto in tanto esercitarono un potere carismatico nel senso già menzionato in precedenza, ovvero senza un corrispondente potere istituzionale.
Non ho qui in mente Augusto, Traiano o Costantino, ma Gesù di Nazareth, Apollonio di Tiana, Tessalo di Tralle e il greco paflagone del secondo secolo, Alessandro di Abonutico – e pochi altri.
Si tratta innanzitutto di una questione relativa all’acquisizione della fama nel mondo antico, e particolarmente difficile perché nei primi due dei casi in esame mancano le fonti contemporanee; sappiamo a malapena che genere di seguaci ebbe Apollonio, dal momento che la biografia di Filostrato è posteriore di un secolo e infarcita di palesi invenzioni.
Ma il punto centrale è chiaro e ovvio: si trattava di uomini capaci di colpire le sensibilità legate alla religione o alla medicina, o preferibilmente entrambe, e che durante la loro vita si circondarono di un nutrito seguito – Gesù e Apollonio forse soprattutto come artefici di miracoli, Tessalo come guaritore e Alessandro come profeta.
Fu quest’ultimo a guadagnare ascendente su alcuni uomini di potere, tra cui alcuni funzionari dell’ordine senatorio (uan volta convinse Marco Aurelio a far gettare nel Danubio due leoni come gesto augurale per l’imminente campagna militare dell’imperatore: le due belve nuotarono fino all’altra riva dove vennero bastonate a morte dai nemici – Luciano, Alessandro, o il falso profeta 48) e secondo Luciano esercitava uan qualche influenza in tutto l’impero.
Ci si potrebbe chiedere se sia solo un caso legato alle fonti che i capi di gruppi ribelli quali i Boukoloi e i Bagaudi non emergano come figure distinte.
Pag. 236
Potere interno, potere esterno
- L’insicurezza degli imperatori da Caracalla a Carino
- Il potere delle legioni
- Integrazione
- La morte lenta dei diritti e della libertà dei cittadini
In che modo questa distribuzione interna del potere influenzò a sua volta il potere di Roma lungo e oltre le proprie frontiere?
La rinnovata capacità romana di reclutare dei soldati affidabili costituì chiaramente un elemento di grande forza ai confini fino all’età dei Severi, ma di fatto per tutto il periodo in esame.
Da questo punto di vista invece il sistema monarchico, nella forma assunta in pratica, si rivelò alla fine alquanto debilitante, ma è degno di nota che i suoi svantaggi abbiano avuto effetti relativamente trascurabili fino alla morte di Costantino.
Era lecito attendersi che i problemi legati alla successione e ‘assoluta necessità per gli imperatori di evitare di favorire la carriera di generali capaci, che avrebbero provocato danni maggiori di quanto effettivamente accadde: di fatto, impedirono ogni ulteriore espansione dopo le fallite campagne di Traiano in Mesopotamia, ma consentirono agli imperatori di difendere tutte le frontiere a eccezione della Dacia e del limes della Germania sudorientale.
Ovviamente, Roma fu anche fortunata nell’avere in tutto questo periodo un solo formidabile nemico esterno.
L’Impero di Costantino sembrava abbastanza saldo da poter resistere a qualsiasi minaccia esterna: fino a che punto soffrì di debolezze o tensioni interne che più tardi causarono dei problemi è oggetto di interminabile dibattito, ma quattro diversi sviluppi si dimostrarono potenzialmente letali.
In primo luogo, l’infinita serie di putsch militari dal 235 in avanti rese la monarchia fortemente instabile (e né i tetrarchi né Costantino modificarono questa situazione); in secondo luogo, l’estromissione della fascia superiore dell’élite dalle responsabilità militari fece sì che non potesse esservi alcuna leadership quasi-nazionale in caso di minacce esterne (in una società tradizionale la professionalità non è sufficiente).
Terzo, il processo di formazione di una coscienza nazionale sembra esservi interrotto nella generazione successiva all’editto di Caracalla, forse ostacolato ulteriormente dal fatto che l’Impero romano non era più in grado di offrire quella varietà di opportunità economiche caratteristiche dell’età preseveriana; infine, incombeva l’ombra degli aspri conflitti, ormai prossimi.
Pag. 238
Cap. 6. Roma contro gli altri, dal 337 al 641
L’Impero romano non finì nel giro di una notte: il suo declino, come la sua ascesa, fu anzi un processo assai prolungato.
La decisione di Gibbon di continuarne la storia fino alla conquista turca di Costantinopoli, nel 1453, è comprensibile, ma allo stesso tempo è un grave errore: lo Stato romano-bizantino, fra il tardo settimo e gli inizi dell’undicesimo secolo, non si può certo definire un impero.
Tuttavia, a non essere razionale è la scelta di fissare la fine dell’Impero già al sesto o addirittura al quarto secolo.
Vi sono poi coloro che rifiutano il termine “declino” in questo contesto, eppure nessun serio studioso di storia del potere politico potrebbe dubitare del fatto che il potere dello Stato romano si ridimensionò grandemente e sebbene sia un luogo comune dire che tutti gli imperi hanno una fine, questa particolare diminutio merita una spiegazione – o piuttosto, come si vedrà, uan serie di spiegazioni.
Il fenomeno che prenderemo qui in considerazione attraversò due fasi principali, la prima fra gli anni Settanta del quarto e i Trenta del quinto secolo – con un limite estremo rappresentato dal 455 – e la seconda fra gli anni Sessanta del sesto e il 636-41; in entrambi i casi è possibile, nonché necessario, esaminare le cause antecedenti, ma in ogni caso questi furono i decenni decisivi.
Le domande che dobbiamo porci quindi sono le seguenti: in primo luogo, perché lo Stato romano venne indebolito così tanto dalla invasioni germaniche nelle due generazioni fra gli anni Settanta del quarto e gli anni Trenta del quinto secolo, tanto che la sua metà occidentale divenne una sorta di impero fantasma con un potere assai scarso entro i propri precedenti territori?
Questo dibattito iniziò subito dopo le invasioni, anzi ancor prima che finissero, per poi riesplodere di nuovo durante l’Illuminismo.
In secondo luogo: perché il redivivo impero di Giustiniano, che al suo apice comprendeva l’Italia, quasi tutta l’Africa settentrionale e persino una parte della penisola iberica – oltre alla quasi totalità del vecchio impero d’Oriente – iniziò a vacillare dopo la sua morte per poi collassare, in quanto impero, nel secolo successivo?
Un primo problema fondamentale è dunque quello della sconfitta e del ripiegamento militare; un secondo, la natura dei rapporti di potere entro i superstiti domini di Roma.
Che genere di legame esisteva fra questi due problemi?
La mutata natura del potere nel mondo romano ebbe degli importanti effetti sugli insuccessi bellici di Roma nei due periodi summenzionati?
E viceversa, in che modo queste due epoche di sconfitte militari alterarono i rapporti di potere fra i romani?
Pag. 239-40
Iniziamo dunque dal periodo compreso fra gli anni Settanta del quarto e gli anni Trenta del quinto secolo.
Poche questioni della storia tardoantica presentano maggior difficoltà del capire perché, nella metà occidentale dell’Impero, le forze armate e il governo romani fallirono: le fonti documentarie e l’archeologia non ci dicono mai abbastanza, inducendo alcuni storici moderni a inventare racconti improbabili sull’entità dell’esercito romano, ad esempio, e sulla presunta assenza di un conflitto.
Sugli invasori germanici possiamo aggiungere assai poco di utile: sapevano ovviamente combattere in modo molto efficace e possiamo immaginare che avessero imparato alcune lezioni pratiche dai romani – ma quanto di tutto ciò costituisse uno sviluppo recente o decisivo è impossibile da stabilire.
Ovviamente occorre anche capire in che modo gli imperatori d’Oriente, i loro ministri e i loro eserciti riuscirono invece a superare la crisi: furono delle vulnerabilità interne di un qualche tipo a fare la differenza oppure le forze esterne in Occidente erano semplicemente superiori rispetto ai nemici orientali di Roma?
Pag. 240
In che modo valutare le capacità militari romane in questi sessant’anni?
Da qualche decennio alcuni storici contemporanei hanno incredibilmente iniziato a negare che qualcosa di molto grave sia successo, il che sembra una curiosa e distorta eco dell’esplosione di interesse per il tardoantico avvenuta nel mondo accademico dell’ultimo mezzo secolo.
Uno di questi studiosi, ad esempio, scrive che “l’operato dell’esercito nei decenni successivi al 378 non fu affatto un completo disastro”, cosa che suscita tre risposte immediate.
In primo luogo, non si deve scrivere di storia facendo della retorica: se l’esercito romano in questo periodo non fu “un completo disastro”, si ammetta quanto meno l’ovvio fatto che sempre di disastro si tratta; secondo, l’”operato dell’esercito” è un concetto troppo limitato per poter valutare le capacità militari romane: occorre aggiungervi, fra gli altri fattori, la leadership politica e coloro che non combatterono, ma che avrebbero dovuto farlo; e infine, nessuno dubita del fatto che tra i romani vi fossero degli ottimi soldati – ma non abbastanza e troppo spesso impegnati a battersi contro la loro stessa parte.
Questo punto di vista inguaribilmente ottimista è quindi indifendibile, e anzi assurdo: Vegezio, che scrisse probabilmente sotto Teodosio (379-95), sapeva bene come stessero le cose (Epitoma rei militaris 1, 7: così tante sconfitte).
Pag. 241
Dopo il 406 nessuna delle province occidentali dell’Europa poté considerarsi al sicuro: tra il 407 e il 408 vandali, alani e svevi assunsero di fatto il controllo di ampie aree della Germania e della Gallia prima di spostarsi in Spagna; Alarico, coem è noto, conquistò Roma il 24 agosto 410 per poi dirigersi a sud verso la Calabria.
Dopo la sua morte, avvenuta nello stesso anno, il suo successore Ataulfo nel 412 guidò i goti in Gallia, dove nel frattempo i Bagaudi erano di nuovo tornati a causare disordini nelle regioni nord-occidentali.
Per l’Impero d’Occidente le conseguenze di una simile perdita di potere furono gravi, e a minimizzarne la portata possono essere solo storici incapaci di visualizzare gli effetti di queste invasioni.
Con la perdita di territori importanti sotto il profilo fiscale come la Pannonia il governo romano poté permettersi un minor numero di soldati ben equipaggiati, diminuendo quindi la capacità di difendere le vecchie frontiere, il che a sua volta portò a ulteriori perdite territoriali.
In poche parole, un circolo vizioso.
Pag. 243-44
L’Italia, insieme alla Sicilia e alla Sardegna, cadde gradualmente nelle mani dei germani alla metà del secolo: gli imperatori d’Occidente che regnarono nominalmente dal 455 al 476 – Petronio Massimo, Avito, Maggioriano, Libio Severo, Antemio, Olibrio, Glicerio e Romolo “Augustolo” – lo fecero al massimo su alcune parti dell’Italia e della Gallia, con scarse truppe sotto il proprio comando e nessuna prospettiva di vedere rafforzata la propria posizione; quando fu deposto, Romolo non venne considerato nemmeno degno di essere assassinato.
Gli uomini di potere di parte romana, Ezio (435-54) e Ricimero (457-72) – quest’ultimo mezzo Svevo e mezzo Goto – non cercarono di farsi proclamare imperatori né, malgrado le loro evidenti capacità, riuscirono ad arrestare il declino militare di Roma.
Pag. 245
Quali furono dunque le cause di questo fallimento romano?
Innanzitutto, la situazione non era più quella in cui si era trovata Roma alla metà del secondo secolo a. C., e cioè davanti agli sforzi più o meno coordinati di una grande potenza come Cartagine.
D’altro canto, le capacità militari degli invasori erano spesso formidabili, e il loro numero lo era a volte altrettanto se paragonato all’entità delle forze che dovevano opporvisi: sembra che talvolta gli eserciti goti e vandali potessero contare su 25000 o 30000 uomini; nel 408 l’esercito di Alarico potrebbe averne avuti 40000 e un contemporaneo afferma che Radagaiso aveva con sé oltre 200000 effettivi (Orosio, Hist. 7, 37, 4), anche se questa è senza dubbio un’esagerazione.
Le debolezze interne avevano imposto una strategia difensiva ancor prima che le frontiere dell’Italia e del Reno venissero travolte, rispettivamente dopo il 401 e il 406.
Uno Stato imperiale resiliente deve affrontare i propri nemici principali, come fecero Roma nel secondo e terzo secolo a. C. e i musulmani nel settimo secolo d. C.: Giuliano (imperatore unico dal 362 al 3639 indubbiamente se ne rese conto e, se avesse avuto il dono sovrumano della precognizione, avrebbe attaccato i germani invece dei persiani.
Nel tardo quarto secolo, la miglior maniera di adulare la saggezza militare di un imperatore era sostenendo che egli avesse eretto un lungo “muro adamantino” di bastioni difensivi sulle frontiere, un evidente segnale che fu profuso grande sforzo per edificare tali fortificazioni (Temistio, Orazione 10, 36-138; per il suo atteggiamento difensivo, cfr. ivi 16, 208C e 211A).
Pag. 246
Un altro fattore “strategico” che può aver inciso fu la divisione definitiva dell’Impero nelle sue parti occidentale e orientale, avvenuta nel 395 quando a Teodosio successero Onorio e l’altro figlio Arcadio, entrambi ancora bambini.
Questa partizione ebbe anche un aspetto positivo, nel senso che limitò la dimensione dei problemi che un singolo imperatore e i suoi generali dovevano affrontare, tuttavia l’imperatore d’Occidente Onorio, insieme a Stilicone, sprecarono tempo e risorse nel tentativo di subordinare l’Oriente o quanto meno di assumere il controllo della diocesi dell’Illirico.
Pag. 246-47
Imperatori e grandi dignitari si trovavano normalmente di fronte a un ventaglio di scelte assai limitato e a problemi che si erano andati accumulando gradualmente.
Un tempo, ad esempio, l’aver permesso alle popolazioni “barbare” di stanziarsi nelle province romane era stata una politica piuttosto affidabile, i cui precedenti risalivano fino al primo secolo; quando, a partire dalla metà del quarto secolo, i franchi si stabilirono nella Gallia settentrionale, tale circostanza potrebbe aver rappresentato un vantaggio per l’imperatore.
Quando poi, nel 382, Teodosio concluse con i goti un trattato che li autorizzava a vivere in autonomia da Roma all’interno di alcune province romane fra cui la Mesia, la Dacia e la Macedonia, sarebbe difficile obiettare che avrebbe dovuto fare altrimenti: non aveva alternativa (e i goti erano in grado di fornirgli uan milizia); tuttavia la pace del 382 sancì un importantissimo cambiamento nella politica imperiale, giacché i goti mantennero la propria identità di gruppo tribale almeno semi-indipendente.
Temistio (che scriveva non molto lontano, a Costantinopoli) auspicava che i goti si romanizzassero come già avevano gli ex barbari galati (Orazione 16, 211CD), ma tale ottimismo non aveva molte ragioni d’essere: quando, negli anni Novanta del quarto e nel primo decennio del quinto secolo, questi “alleati” germani diedero ripetute prove di non essere né docili né inclini al compromesso era oramai troppo tardi per poterli espellere.
Pag. 247-48
Probabilmente una delle cause principali della debolezza militare era che il bacino fiscale si era ridotto: non veniva più effettuato alcun regolare censimento e id conseguenza i potentiores, anche sotto un imperatore relativamente forte come Costantino, trasferirono uan buona parte del fardello tributario sulla spalle dei ceti inferiori (su questo punto, cfr. CTh 13, 10, 1, relativo all’anno 313), i quali naturalmente non sempre erano in grado di pagare.
Le informazioni di cui disponiamo in merito alla capacità del governo di riscuotere le tasse fra gli anni Settanta del quarto e la crisi degli anni Dieci del quinto secolo sono necessariamente frammentarie, ma registrano segnali assai negativi anche per alcune zone che non avevano ancora subito un’invasione: in una famosa lettera, Ambrogio di Milano descrive lo stato di decadenza di città e campagne fra Bologna e Piacenza (Ep. 39, 3) e gli antecedenti letterari di questo documento non ne inficiano seriamente il valore probante.
Già nel 393 gli imperatori ammettevano che alcune province potevano contribuire assai poco (CTh 7, 4, 19); due anni dopo dovettero essere condonati gli arretrati fiscali di circa il 40% delle terre della Campania, un tempo ricca.
Il declino delle città romane in Occidente, anche se non uniforme, è ben accertato e altamente indicativo; è gravemente fuorviante affermare che le “risorse dell’Impero [non erano] diminuite”.
Pag. 250-51
E’ ragionevole dunque supporre che i soldati romani di questo periodo – quando erano romani – fossero pagati saltuariamente, poco addestrati, insubordinati, inclini alla diserzione e spesso impegnati in attività non militari: ma come si era arrivati a questo punto?
La risposta di MacMullen è “corruzione”, ma una corruzione diffusa dovrebbe essere considerata un sintomo che a sua volta necessita di una spiegazione; un gettito fiscale insufficiente costituisce solo un aspetto della questione e deve talvolta aver messo in situazioni difficili dei comandanti come Romano.
Pag. 254
Dopo il 400 l’equilibrio del potere in seno all’esercito si spostò in modo decisivo in favore dei cristiani e de anche i rituali pagani sopravvissero nei siti militari, hanno lasciato poche tracce; continuarono tuttavia a esservi soldati pagani o eretici e quando il giovane e pio Onorio decretò che “i nemici della fede cattolica” non potevano servire come guardie di palazzo (CTh 16, 5, 42) fu a quanto sembra costretto a revocare il provvedimento (Zosimo 5, 46, 4).
Nei decenni successivi il governo impiegò questi uomini come soldati pur negando loro i diritti religiosi e infine civili (cfr. CTh 16, 5, 65, relativo all’anno 435): a meno di non supporre che questi militari fossero per lo più non religiosi – il che è improbabile -, il loro morale deve averne sofferto e senza dubbio alcuni dei loro commilitoni cattolici avrebbero preferito non dover servire accanto a persone che ritenevano profondamente in errore quanto a fede religiosa.
Pag. 526
Furono le invasioni germaniche a mettere fine all’Impero d’Occidente, ma questo era stato indebolito da cause interne: entro il 410 i segnali di questa debolezza erano vari ma ovvi, e nessuno storico li potrebbe attribuire a un’unica causa.
Possiamo dire che Roma non aveva fatto progressi sufficienti nella trasformazione da impero a nazione, e che era eccessivamente divisa dai conflitti, religiosi e di classe [???], per poter sopravvivere.
Benché esistessero rituali e miti condivisi, non avevano mai funzionato nei confronti della massa della popolazione e il cristianesimo li aveva ulteriormente indeboliti; inoltre, a incidere fu anche il declino fiscale ed economico, associato alle debolezze della struttura politica.
Tutti questi fattori erano già presenti alla metà del quarto secolo, ma si intensificarono a partire dagli anni Settanta: a rendere diverso l’Occidente dall’Oriente durante il periodo in esame non fu quindi un qualche aspetto interno all’Impero, almeno non inizialmente, giacché come abbiamo visto i punti di forza e debolezza delle due parti sembrano essere stati gli stessi (sebbene sarebbe difficile trovare un vescovo orientale altrettanto sovversivo di Paolino di Nola).
Fu piuttosto l’intensità della pressione esterna, esacerbata dai danni economici provocati dalle invasioni, a fare la differenza: la fortuna degli imperatori d’Oriente, invece, fu di dover fronteggiare delle invasioni complessivamente meno gravi (anche se comunque pericolose).
Questa differenza divenne palese nel biennio 421-22: la nuova Roma d’Oriente attaccò la Persia di Bahram 5., non senza provocazione, e ne uscì essenzialmente alla pari (Socrate Scolastico, Storia ecclesiastica 7, 20 ecc.).
Poi, nel 450, in un modo o nell’altro, il re degli unni Attila venne convinto a lasciare in pace la regione del basso Danubo (Prisco di Panion, fr. 15, 4-5, in Blockley, 1981) e dopo la sua morte, tre anni dopo, il suo regno si disintegrò; la frontiera persiana, infine, rimase per lo più in pace dal 422 fino al regno di Giustino 1. (518-27).
Pag. 257-58
La caduta dell’Impero romano d’Oriente costituisce invece una storia alquanto diversa: negli studi recenti sul periodo tardoantico non vi è nulla di più deplorevole della diffusa tendenza a cumulare indiscriminatamente le diverse condizioni prevalenti dal quarto al settimo secolo (la grande sintesi di A. H. M. Jones ne è in parte responsabile).
Nel 600 l’Impero romano era ancora un impero, sebbene fragile: governava l’antico Vicino Oriente romano, la maggior parte del litorale nordafricano, alcuen parti dell’Italia, persino qualche territorio nella penisola iberica e tutte le grandi isole mediterranee; nei Balcani la sua presenza era debole, e controllava solo le zone attorno a Costantinopoli e all’Egeo.
Così come alcuni storici novecenteschi di varie scuole riducono a un non evento la caduta dell’Impero d’Occidente, alcuni altri ritengono di scarso rilievo quella dell’Impero romano d’Oriente nel settimo secolo.
Questa tesi tuttavia si basa su una pretesa di continuità culturale in gran parte superficiale e che riguarda solo secondariamente la questione del potere (fatto strano, coloro che la difendono, prestano scarsa attenzione all’esistenza materiale dei contadini, che in effetti potrebbe non essere cambiata molto nelle parti di Siria, Egitto e Africa settentrionale non devastate dagli eserciti tra il 600 e il 700).
E’ davvero necessario giustificare l’affermazione secondo cui “la prima ondata di conquiste arabe segnò un importante spartiacque” nella storia del Mediterraneo?
Gli storici dell’Islam sono chiari su questo punto: a dominare ora erano uan nuova lingua (nota a pochissimi studiosi cristiani della tarda antichità) e una nuova religione; le tasse finivano in Arabia e in altri centri musulmani e non a Costantinopoli; un muro culturale divideva il Sud- Est dal Nord-Ovest.
Il mondo veniva riorientato: nel 644 per la prima volta uan flotta trasportò l’eccedenza di grano egiziano non a Bisanzio, ma nell’Hijaz.
In tutto il periodo compreso tra le vittorie romane del secondo secolo a. C. e il collasso dell’Impero ottomano il mondo mediterraneo non venne segnato da nessuno spartiacque più importante di questo, e se tutti e tre questi eventi (o meglio, serie di eventi) rappresentarono politicamente degli tsunami, in termini culturali le conquiste musulmane furono le più significative.
Pag. 259-60
Nella generazione compresa fra le morti di Giustiniano e Maurizio (sul trono dal 582 al 602) l’Impero romano d’Oriente perse la maggior parte dei propri territori in Italia, mentre la sua autorità sui Balcani rimase fragile.
I longobardi invasero l’Italia nel 569, conseguirono una rapida vittoria nel Nord e circa un decennio dopo avevano ormai raggiunto il golfo di Napoli e instaurato un ducato a Benevento.
Per qualche tempo gli imperatori riuscirono a manovrarli contro gli altri invasori, i franchi, ma negli anni Novanta del sesto secolo il potere longobardo si estese ulteriormente nell’Italia centrale e meridionale e nel 602 le poche zone ancora controllate dall’Impero si trovavano sotto pressione quasi dappertutto; Smaragdo, l’esarca bizantino di Ravenna durante gran parte del regno di Foca, dovette cedere ulteriori territori.
Conosciamo molti dettagli politici del periodo coincidente con il papato di Gregorio Magno (590-604), pontefice che si alleò con tutte e tre le parti in conflitto a seconda di quali fossero i propri interessi del momento.
Pag. 261-62
Un nuovo e persino più pericoloso attacco non tardò ad arrivare: il primo scontro fra i bizantini e i seguaci di Maometto ebbe luogo a Mut’a, a sud-est del Mar Morto, nel 619.
Ma una volta che il successore del profeta, Abu Bakr, ebbe consolidato il suo controllo sull’Arabia (Maometto era morto nel 632) iniziarono incursioni molto più serie e la prima grave perdita di territorio non si fece attendere: nel 634-35 i musulmani cacciarono le forze bizantine dalla Palestina.
Le fonti e gli studiosi sono in disaccordo sull’importanza relativa e la topografia delle successive battaglie in Siria, ma lo scontro sul fiume Yarmuk (a sud-est del lago di Tiberiade, e che segna l’odierno confine fra Siria e Giordania), in cui i musulmani misero in rotta l’esercito più numeroso che i bizantini fossero ormai in grado di mettere insieme, viene considerato decisivo (agosto 636).
Un’altra battaglia più a nord, tra Damasco ed Emesa (l’odierna Homs), finì anch’essa con un disastro romano (uno dei principali storici di questo periodo ha di recente contestato il modello della “conquista violenta” di questa fase dell’espansione musulmana, ma sembra essere riuscito solo a stabilire che gli avversari esagerarono talvolta l’entità delle relative distruzioni).
Pag. 265
Queste perdite ridussero a tal punto lo Stato romano d’Oriente da non poterlo più considerare un impero panmediterraneo come quello che i romani avevano tenuto insieme per oltre ottocento anni.
Con la perdita della Siria e dell’Egitto svanirono infatti anche i tre quarti delle entrate statali balcaniche e orientali; le eccedenze di grano egiziano ora venivano spedite in Arabia, coem già detto; le vittorie musulmane poi continuarono, portando nel 652 alla distruzione finale dell’Impero sasanide e nel 654 a un attacco contro la stessa Costantinopoli.
Il governo di Costante 2. (641-48: aveva solo 10 anni al momento della sua ascesa al trono) cercò invano di contrastare il potere longobardo in Italia: alla metà del secolo Bisanzio controllava più o meno una gran parte dell’Asia Minore, la periferia europea della capitale, alcuen zone della Grecia continentale (ma nel Peloponneso vi erano già stanziati gruppi di slavi) e la maggior parte delle principali isole del Mediterraneo e dell’Egeo, oltre a un’area corrispondente grosso modo alle moderne Tunisia e Algeria orientale (ma in costante ridimensionamento), alcune zone di territorio italiano e assai poco altro.
Come ottocento anni prima, molto dipendeva dalla potenza navale; nel 649 e 650 i musulmani invasero Cipro e l’Impero bizantino non trovò né i fondi né forse l’esperienza necessaria per una reazione adeguata: lo stesso Costante andò incontro pochi anni dopo a una fine ignominiosa, assassinato in un bagno pubblico si Siracusa.
Dal 643 in poi i musulmani avanzarono inesorabilmente lungo il litorale africano, raggiungendo l’attuale Tunisia nel 647-48 e imponendovi delle tasse, per arrivare infine in Marocco negli anni Ottanta del Settimo Secolo.
Dopo la battaglia di Yarmuk, in poche parole, il potere di Roma venne enormemente ridimensionato per poi vivere di un ulteriore e costante declino nell’arco delle due generazioni successive.
Pag. 266
Data l’importanza generalmente attribuita alla caduta dell’Impero romano, è sorprendente quanti pochi sforzi siano stati fatti per spiegare gli insuccessi romani nella prima metà del Settimo Secolo: sembra sintomatico che gli ultimi capitoli della grande storia del tardo impero di Jones non abbiano praticamente nulla da dire sull’argomento, concentrandosi sulla precedente caduta dell’Impero d’Occidente, quando la gran parte dell’opera si occupa invece dell’Oriente.
Persino una serie di studi dettagliati sulla guerra in età tardoantica per lo più elude la questione.
Di fatto, gli storici della tarda antichità sembrano in gran parte voler negare l’accaduto: “Nel corso di tutto questo periodo [284-641]”, scrive uno di loro, “le vittorie dell’esercito romano furono ben più numerose delle sconfitte, e le perdite più gravi si possono per lo più misurare in termini di truppe addestrate e di prestigio, , piuttosto che di territori e di città” – con buona pace della caduta dell’Impero d’Occidente, dell’incapacità del governo romano d’Oriente di difendere i Balcani e successivamente l’Anatolia, e dei disastri sotto Maurizio ed Eraclio.
Ancora una volta, siamo davanti a un gioco di prestigio: questi autori hanno evidentemente paura di sussurrare la parola “declino”, non rendendosi conto che in tal modo la storia bellica viene ridotta a una serie di eventi accidentali, una posizione assurda e antistorica (anche se nessuno vuole negare che la guerra ingenera sempre eventi accidentali, grandi e piccoli).
Esiste una riluttanza quasi patologica ad affrontare i decenni cruciali e in particolare le sconfitte romane: in un recente e poderoso volume dedicato all’esercito romano tardoantico in Oriente fino alla conquista araba solo tre dei trentatré saggi – incredibilmente – trattano quanto accaduto alle milizie romane nel regno di Giustiniano o nel periodo successivo.
Un altro libro ancora più recente, War and Warfare in Late Antiquity: Current Perspectives, evita qualsiasi discussione sul mancato successo nel resistere adeguatamente alle offensive musulmane.
Pag. 267
Nei conflitti appena accennati dovremmo in teoria considerare entrambe le parti: è necessario comprendere i principali nemici di Roma della fine del Sesto e del Settimo Secolo – i longobardi, gli avari, i persiani e altri, ma soprattutto gli arabi musulmani – se si vuole stabilirne la pericolosità in quanto nemici; ma le fonti, persino nel caso dei longobardi, sono troppo scarse per poter fornire più di una impressione generale.
Gli invasori erano troppo numerosi?
Erano guidati da motivazioni più forti di quelle dei difensori?
La società in cui vivevano fornivano un base, economica o psicologica, più salda rispetto a quella romana?
Si tratta chiaramente di interrogativi fondamentali.
Pag. 268
Infine, vale la pena di notare che anche se di recente sono stati condotti studi interessanti sui cambiamenti climatici nel tardoantico, non esiste alcun motivo per ritenere che l’Impero romano abbia conosciuto un peggioramento (o un miglioramento) delle proprie condizioni economiche dovuto al clima che non fosse comune anche ai suoi vicini.
Le indicazioni più probanti andrebbero ricercate nella penisola arabica: se si potesse dimostrare che il clima del Settimo Secolo vi fu relativamente benigno, al punto da permettere una significativa crescita demografica, avremmo allora un’informazione storica di valore.
Pag. 271
Va ammesso però che ciò non rappresentava nulla di nuovo: negli anni Trenta del Sesto Secolo l’esercito di Belisario in Italia era poliglotta, come di norma lo erano le armate di Giustiniano e il senso di identità romana dei suoi uomini sarà stato probabilmente limitato o, nel caso degli unni e degli sclaveni (slavi), nullo.
Pag. 274
Conclusioni
Anticipando il prossimo capitolo, possiamo chiederci in che modo le strutture di potere interne all’Impero romano ostacolarono la sua capacità di resistere alle minacce esterne.
Prima del 602 l’Impero d’Oriente era stato per lungo tempo risparmiato da sollevazioni militari vittoriose, e anche di disordini causati dai rovesciamenti di Maurizio e di Foca, dalla cospirazione contro Eraclio del 637 (che indusse l’imperatore a ordinare la mutilazione di alcuni membri della sua stessa famiglia) e dalla lotta di potere seguita alla sua morte nel 641, non avrebbero dovuto avere molta importanza in un impero dai confini sufficientemente sicuri.
In maniera analoga, la capacità del clero e dei monasteri di acquisire risorse per poi impiegarle per cause per lo più irrilevanti, se non dannose, per gli interessi dello Stato è un aspetto che l’Impero di Giustiniano poteva forse permettersi di tollerare, ma non certo gli imperatori del Settimo Secolo (e sotto la voce “risorse” dovremmo includere il coinvolgimento a livello psicologico).
Di solito si ritiene che gli imperatori di questo periodo godessero di un potere eccezionale all’interno delle proprie frontiere, tuttavia le difficoltà finanziarie che si trovarono a dover affrontare suscitano qualche dubbio sulla veridicità di questa tesi.
Nell’ultima fase del suo regno Eraclio perse gradualmente la propria autorità persino nei confronti dei suoi alti dignitari: nel 633 il suo generale in Numidia, Pietro, si rifiutò di inviare rinforzi in Egitto; nel 640 il patriarca di Alessandria e governatore de facto dell’Egitto, Ciro, negoziò un accordo di pace con gli arabi inaccettabile per l’imperatore, e quando venne convocato a Costantinopoli protestò pubblicamente con Eraclio (il che portò alle sue dimissioni e all’esilio; Niceforo, Breve storia, 28-30).
Per riassumere: a impedire all’Impero romano di resistere con successo alle invasioni arabe furono vari fattori, ed è difficile classificarli in ordine gerarchico.
In qualche misura anche in questo caso si verificò un circolo vizioso: le invasioni resero più difficile riscuotere tasse sufficienti, il che provocò un indebolimento dell’esercito, e così via; quello di Giustiniano fu un enorme azzardo che finì molto male.
Atri fattori che non avrebbero forse danneggiato un impero più robusto, in particolare i problemi causati dal cristianesimo dilagante, diedero poi il loro contributo.
Altre domande rimangono inevitabilmente senza risposta: forse le cose sarebbero andate diversamente se la popolazione dello Stato, nel periodo compreso diciamo da Maurizio a Costante 2., fosse stata più sinceramente devota all’Impero romano o ai suoi imperatori?
Pag. 280
Cap. 7. Roma contro sé stessa in due lunghe crisi
Costantino, monarca incontestato, morì nella primavera del 337, il 22 maggio: prima ancora che l’estate finisse non meno di nove dei suoi familiari erano già stati uccisi, per lo più su istigazione del diciannovenne Costanzo, il secondo dei tre figli che gli erano sopravvissuti.
Gli sfortunati parenti furono anche le uniche vittime, giacché l’impero non poteva essere governato da un eterogeneo comitato familiare: aveva bisogno di un’amministrazione centrale forte ed efficace gli spargimenti di sangue intra dinastici non figurano comunque tra le cause principali del declino della potenza di Roma nel tardoantico.
…….
L’Impero romano d’Occidente cadde per mano degli invasori germanici: avrebbe potuto resistere se avesse avuto un governo centrale ragionevolmente stabile e deciso; un’élite dotata del senso di responsabilità riguardo la capacità dello Stato di difendersi dai nemici esterni; un efficiente sistema fiscale in grado di riscuotere tasse sufficienti a mantenere delle forze armate ingenti e ben addestrate; e infine, un esercito dalla lealtà incontestabile e dal morale alto.
In questi decenni decisivi tutte queste risorse vennero a mancare.
Pag. 281
Anche per quel che riguarda l’identità nazionale e l’uso della lingua è possibile percepire alcuni cambiamenti nel corso del Quarto Secolo, ma nessun mutamento radicale, con l’importante eccezione rappresentata dal fatto che la quantità di persone che continuò a identificare i propri interessi con quelli dello Stato romano era diminuita; almeno, questa è la mia tesi.
Di fatto, lo Stato si indebolì notevolmente nel secolo successivo alla morte di Costantino: alcuni storici, in parte abbagliati dall’elaborato cerimoniale di corte, hanno talvolta affermato il contrario, ma tale opinione diventa inaccettabile se consideriamo il grado di potere ceduto dagli imperatori agli ecclesiastici, e in particolare ai vescovi, il venir meno in molte zone della pace sociale e la declinante efficienza del sistema fiscale, per non parlare delle manchevolezze militari analizzate nel capitolo precedente.
Pag. 282
Odoacre depose l’ultimo imperatore d’Occidente, Romolo “Augustolo”, nel 476.
L’unica autorità in grado di sostituire un imperatore con un altro rimase quella delle forze armate: come nelle epoche precedenti, le preferenze dei soldati dipendevano da una combinazione di denaro, lealtà dinastica e prestigio personale.
Pag. 283
Di solito, nella storiografia tradizionale che tratta del potere imperiale in questi anni a dominare sono tre temi: il rafforzamento della centralizzazione, l’ulteriore crescita di quella che è stata definita “una burocrazia sofisticata e ben organizzata” e la corruzione dei funzionari; tutti aspetti che necessitano di essere contestualizzati e definiti.
Pag. 286
Gli imperatori romani continuarono ad essere dei monarchi assoluti, ma il loro desiderio di controllare quanto avveniva nell’esercito e nelle province era per forza di cose limitato da vincoli pratici e di altro genere; fin dai tempi di Tiberio avevano aspirato al controllo totale, e almeno fin da quelli di Traiano erano intervenuti su questioni anche minime relative all’amministrazione provinciale.
Sotto la tetrarchia il moltiplicarsi dei funzionari civili aveva naturalmente creato dei problemi di ordine gerarchico che gli imperatori cercarono talvolta di risolvere (ad es. in CTh 6, 30, 8, relativo all’anno 384), segno che gli uomini al vertice avrebbero preferito avere a che fare con delle catene di comando ben definite.
Pag. 288
Un aspetto interessante di questi funzionari è che a partire probabilmente dai primi anni del regno di Costantino si presentavano in veste quasi militare, con diritto a delle “razioni” e indossando un’uniforme; il loro corpo e i loro incarichi erano definiti come militia.
E’ stato suggerito che ciò avvenisse perché a livello informale si riconosceva ormai il fatto che molti incarichi di natura essenzialmente civile venivano affidati a dei militari, ma una spiegazione più plausibile è che l’imperatore e gli alti funzionari volevano che i loro subordinati fossero (idealmente) altrettanto disciplinati dei soldati.
Un altro frequente oggetto di dibattito storico è la corruzione, in parte perché è arduo definire che cosa fosse considerato eccessivo all’epoca per quel che riguarda il dare e il ricevere dei doni, in parte perché è difficile valutare quanto fossero diffuse determinate pratiche in un’era in cui alcuni erano inevitabilmente più disonesti degli altri.
Eppure, tangenti e corruzione esistono in ogni epoca, il che porta alla problematica domanda su se e quanto dannosa fosse per lo Stato la compravendita delle cariche e dei servizi pubblici nell’Impero d’Occidente di questo periodo.
Gli economisti non sembrano granché interessati alla corruzione, che considerano semplicemente un modo come un altro di fare la coda: la Gran Bretagna acquisì una gran parte del suo impero in un’epoca in cui i seggi parlamentari e i gradi di ufficiale (nonché le successive promozioni) nell’esercito venivano comunemente comprati, di solito da persone più o meno competenti; un paragone con i moderni paesi mediterranei sarebbe superfluo.
Quello che è degno di nota, piuttosto, è rilevare come alla metà del Secondo Secolo a. C. i senatori romani fossero talvolta disposti a svendere gli interessi dello Stato (Diodoro Siculo 31, 27°, ecc.) senza che ciò avesse effetti catastrofici.
Ad ogni modo, molto si è discusso sulla pregnanza della venalità in questo periodo: a mio parere sia i “massimizzatori” (coloro che la considerano un enorme, persino fatale, difetto del sistema di governo) sia i “minimizzatori” sono in errore.
Entrambe le fazioni, infatti, sono solite confondere questioni fra loro diverse: se le promozioni avvenissero per altri motivi rispetto al merito in senso moderno (accadeva assai di frequente, come era sempre stato); se gli incarichi importanti venissero sempre comprati, e se è così, chi fosse esattamente a metterli in vendita; se e quanto questo genere di commercio causasse un pregiudizio effettivo; se la corruzione ostacolasse la messa in pratica di politiche imperiali importanti; e infine se queste difficoltà, se mai esistessero, siano aumentate in modo considerevole neo decenni della crisi.
Pag. 290
Quando però nel 388 Teodosio volle punire un vescovo che a capo di un gruppo di cristiani aveva distrutto la sinagoga di Callinicum (attuale Raqqa) sull’Eufrate, Ambrogio affermò che gli ebrei costituivano un bersaglio legittimo e riuscì a salvare il suo collega; la resa dell’imperatore rappresentò un significativo svilimento del sempre più limitato monopolio della forza dello Stato romano. [alla faccia di Hitler]
Pag. 294
Il mito dell’invincibilità di Roma venne sostituito in modo massiccio – sebbene gradualmente e mai del tutto – da quello dell’importanza fondamentale della fede cristiana, e anzi di una fede caratterizzata da ortodossia e conformismo.
Pag. 295
In quegli anni, l’identità religiosa e le sue implicazioni erano parte di una questione complessa, in cui l’opportunismo, l’adattamento e le lealtà divise erano altrettanto diffusi del fanatismo, ma a ogni modo non è mio compito analizzare in questa sede le origini dell’intolleranza cristiana.
Alan Cameron ha collocato la popolazione romana di quest’epoca in cinque categorie religiose: ai due estremi vi sono cristiani e i tradizionalisti (ovvero i “pagani”) “impegnati” – entrambi, sostiene, “una percentuale relativamente piccola della popolazione”; poi i cristiani e i pagani “moderati”; e infine coloro che sono difficili da classificare nelle altre categorie.
Molto dipende qui da che cosa si intenda con le definizioni di cristiano “impegnato” o “moderato”: ciò che importa in termini pratici non è ad esempio la preparazione teologica, bensì uan solida autoidentificazione, divenuta sempre più forte sotto Teodosio (cfr. la succitata legge del 380), Onorio e Arcadio.
Pag. 296
Queste prove della soppressione violenta di alcune pratiche religiose, e per estensione di alcune fedi, puntano in una direzione chiara: ai lettori cristiani non piacerà, e la storiografia moderna, predominantemente cristiana, ha spesso cercato di adombrarlo, ma il fatto è che tra il Quarto e il Quinto Secolo l’Impero romano visse una fase di grave disintegrazione sociale, di cui daremo ulteriori dimostrazioni più avanti.
Ciò non equivale a dire che il cristianesimo fu la sola causa di questo fenomeno o che non ebbe anche degli effetti sociali positivi, ma lo spezzarsi dei legami sociali nella popolazione e la diffusione dell’odio al suo interno sono fatti storicamente provati.
Pag. 297
Per quanto riguarda gli effetti delle idee cristiane – e delle leggi che cercarono di imporre l’ortodossia cristiana – sui rapporti di potere sociali, vi sono opinioni diverse.
Peter Brown ha descritto questo periodo come di transizione fra una “società aperta” e una chiusa, un giudizio che chiaramente contiene una gran parte di verità; la nuova ideologia dominante era per molti versi profondamente repressiva dal punto di vita intellettuale, sessuale e religioso.
Gli strumenti di questo cambiamento erano delle nuove figure autoritarie: gli artefici di miracoli e gli asceti (categorie che vantavano entrambe dei predecessori di epoca classica, ai quali tuttavia era stato accordato un rispetto assai minore), così come i vescovi e altri membri del clero.
Gli insuccessi militari di Roma durante questi decenni disintegrarono il potere romano in Occidente, sebbene le sue forme esteriori continuassero a persistere; i cambiamenti in seno alle strutture di potere fin qui citate avevano per lo più delle cause interne, ma in che modo influirono sulle capacità militari di Roma?
Alcuni storici ritengono che a fare la differenza fu l’impossibilità per l’imperatore di controllare la corruzione dei funzionari; io invece sostengo che il dissenso religioso – fra gli stessi cristiani, non solo fra i cristiani e i “pagani” – costituì un fattore più importante e l’unica soluzione a questo problema proposta dagli imperatori di questo periodo – ovvero la conformità dell’intera popolazione alla fede cattolica – fu quanto meno poco realistica.
Altri fattori politici, ed economici e psicologici resero di certo più difficili i successi militari: fra quelli menzionati all’inizio di questo capitolo, il più importante – a parte il morale delle forze armate – fu semplicemente l’impossibilità dello Stato di riscuotere tasse sufficienti a finanziare un esercito numeroso ed efficiente.
Pag. 307
Non esistono studi economici che tentino di paragonare l’era di Augusto e Traiano con quella di Eraclio e Costante 2.: questa è probabilmente una delle ragioni per le quali la storiografia esagera il potere dei successori di Giustiniano.
Un’opinione diffusa afferma che “l’imperatore romano di epoca tardoimperiale dominava la propria società come pochi altri monarchi, prima e dopo di allora”: per quanto riguarda il periodo compreso fra il 565 e il 636 ciò equivale a scambiare la pompa e la cerimonia con il potere effettivo, errore peraltro comune fra gli studiosi contemporanei, e a ignorare le fonti.
Tanto per cominciare, gli imperatori in questione non erano personalmente più al sicuro dei loro predecessori: Maurizio Foca e probabilmente Tiberio 2. (574-82) vennero assassinati, malgrado avessero a disposizione un gran numero di spie e informatori, come si evince da Procopio (Storia segreta 1, 2).
Pag. 308
Il potere ecclesiastico solleva interrogativi ancor più complessi (e qui dovremo necessariamente anticipare la questione del potere delle idee religiose).
Gli alti ecclesiastici potevano a volte essere incaricati di missioni politiche o diplomatiche: Gregorio, patriarca di Antiochia fra il 570 e il 593, aiutò a reprimere uan grave ribellione alla frontiera persiana nel 589, rendendo ulteriori servigi politici all’imperatore Maurizio.
Papa Gregorio Magno esercitò un grande potere politico nell’Italia bizantina, mentre a Costantinopoli il patriarca Sergio (610-38) sembra aver avuto una certa influenza politica su Eraclio.
Quest’ultimo arrivò persino ad affidare l’Egitto a un uomo di Chiesa: quel Ciro che successivamente consegnò la provincia ai musulmani dal 631 al 650 fu sia patriarca di Alessandria sia governatore.
In tutto l’impero, fin dal regno di Anastasio (491-518), i vescovi locali – nominati a vita dalla popolazione – avevano progressivamente assunto maggiori poteri nella gestione degli affari civili e quotidiani delle loro comunità, sebbene si trattasse di uno sviluppo ben poco sistematico; Giustino 2., come già visto, concesse ai vescovi la prerogativa – condivisa con alcuni laici influenti – di nominare i governatori provinciali.
Sul piano religioso si pongono dunque due questioni distinte, ma legate tra loro: ovvero, se i conflitti fr ai gruppi di fede all’interno dell’Impero abbiano costituito uan grave fonte di debolezza; e se considerazioni di ordine religioso abbiano ostacolato in qualche modo une ffettivo esercizio del potere da parte degli imperatori o dei loro altri funzionari.
Pag. 311
Potremmo paragonare la posizione di Eraclio negli anni Trenta del Settimo Secolo con quella di Elisabetta Prima di fronte agli attacchi dei cattolici: se gli inglesi fedeli alla Chiesa di Roma fossero stati più numerosi e fosse esistita una frontiera terrestre con una potenza cattolica, il risultato sarebbe forse stato diverso; ma oltre a ciò, il paragone fa emergere anche altri aspetti dell’impero di Eraclio, in particolare la carenza di comandanti militari affidabili.
Pag. 312
Se esiste un consenso su quale sia stato un fattore di debolezza – oltre a quelli esterni e quelli di natura fiscale – per gli imperatori di questo periodo, riguarda i notabili locali, in gran parte proprietari terrieri: ma quanto costituissero effettivamente uan causa dei problemi più gravi dell’Impero e non semplicemente un loro sintomo è ancora oggetto di discussione.
Il caso sempre citato è quello dei ricchissimi (e assai ben introdotti presso le autorità) Apioni, nell’Egitto del Sesto Secolo: sembra ad esempio che i membri di questa famiglia di grandi possidenti fondiari abbiano fatto uso di truppe imperiali per i loro scopi (il che era illegale) e che avessero costruito una prigione privata nelle loro proprietà.
A quanto se ne sa, erano fedeli all’imperatore (spariscono dalla documentazione nel periodo dell’occupazione persiana dell’Egitto, nel 617-29).
Forse ancor più tipica era la famiglia di un certo Abaskiron (il nome ci è giunto per tramite dell’etiopico, e la forma non è accurata), le cui attività illegali nel delta del Nilo e in altre zone durante il regno di Maurizio ci sono note dalla Cronaca di Giovanni di Nikiu (97): il capofamiglia era un uomo ricco, che tuttavia istigò gravi disordini.
Violenze di questo genere potrebbero essere soprattutto indice della carenza di personale militare.
Pag. 314
Le specifiche debolezze interne dell’Impero romano del Settimo Secolo in quanto nazione vanno ricercate altrove: quelle istituzioni che un tempo avevano tenuto insieme l’Impero, in particolare il culto imperiale e le forze armate, si erano completamente trasformate e i dissidi religiosi continuavano a minare l’unità interna, forse ancor più pesantemente di quanto non accadesse ai tempi del primo periodo.
Secondo un autorevole storico marxista fu “la combinazione di un potere economico e di un potere politico illimitato nelle mani delle classi proprietarie, del loro imperatore e della sua amministrazione a portare in ultima analisi alla disintegrazione dell’Impero romano” (si riferiva a entrambi i periodi di crisi discussi in questo capitolo).
Un elemento di questa analisi però non torna, giacché il potere imperiale durante la crisi del Settimo Secolo era tutt’altro che illimitato; ma i ceti proprietari, in base a questa tesi, scaricarono costantemente il peso principale della tassazione sulle spalle dei meno abbienti e una teoria di questo genere può ben sostenere che costoro fossero troppo poveri per fornire un gettito sufficiente e troppo alienati dall’oppressione per avere a cuore la sorte dell’Impero.
L’oppressione die contribuenti poveri non era peraltro un fatto nuovo nel tardoantico, e per poter comprenderne le conseguenze negative dovremmo collegarla al declino complessivo, spasmodico e diseguale dell’economia romana, un fenomeno che una parte della storiografia recente ha fatto del suo meglio per offuscare.
La vera difficoltà per lo storico sta nel fatto che, diciamo nel mezzo secolo precedente alla battaglia dello Yarmuk, siamo lontani come non mai dal poter analizzare la condizione dell’economia o i problemi fiscali dello Stato romano: ciò rende a sua volta più complicato valutare l’importanza relativa dei dissidi e delle preoccupazioni religiose che indebolirono l’unità e la coesione della popolazione dell’Impero, alienandola da un passato pieno di fiducia e generando odi e paure intense.
Il fallimento dell’Impero romano del Settimo Secolo, come quello dell’Impero d’Occidente di due secoli prima, ha fin troppe spiegazioni.
Le eccessive ambizioni militari di Giustiniano (con le relative conseguenze fiscali), i conflitti religiosi interni, la forza e la subitaneità delle offensive islamiche, la debole coscienza nazionale delle élite provinciali furono tutti fattori importanti; contrariamente all’opinione comune, anche la posizione dell’imperatore era piuttosto debole, specie forse sotto Maurizio e Foca.
Quanto pesasse la debolezza economica e demografica è difficile da stabilire, ma la numismatica conferma ciò che appare comunque ovvio: per varie ragioni – in particolare per le guerre rovinose in quelle che avrebbero dovuto essere delle province prospere e fiscalmente importanti -, l’economia non era più in grado di mantenere un esercito di entità e qualità pari a quello che Roma aveva messo in campo per settecento anni, dal Terzo Secolo a. C. al Quarto Secolo d. C.
Se poi di fatto valesse la pena salvare l’Impero di Eraclio è una domanda interessante, ma non di natura storica.
Abbiamo visto diffusamente nella seconda metà di questo capitolo come le ormai fragili strutture di potere interne del sopravvissuto Impero romano resero assai difficile, se non impossibile, una difesa efficace; ma in che modo, per porre la domanda un’ultima volta, il ridimensionamento del potere esterno di Roma fra il 582 e gli anni Quaranta del Settimo Secolo influenzò le strutture di potere in seno all’Impero?
In generale, indebolì l’imperatore regnante; nei periodi di incursioni straniere i governi romani e i loro rappresentanti erano assai meno in grado di mantenere l’ordine interno; la disciplina militare era scarsa, anche se forse migliore sotto Eraclio che non sotto Maurizio.
Proprio nel momento in cui l’imperatore aveva bisogno di maggiori entrate fiscali, tendeva probabilmente a ricavare un minor gettito, specie dopo l’occupazione persiana di molte province romane all’epoca di Eraclio; e proprio nel momento in cui avrebbe avuto bisogno di un più ampio sostegno da tutte le classi sociali, potrebbe averne ricevuto di meno.
Ancora una volta, l’irresponsabilità dell’élite e l’estraniamento dei poveri appaiono entrambi evidenti.
Può esserci stato anche qualche legame tra il declino del mito di Roma e dell’invincibilità dell’imperatore, da una parte, e la crescita del prestigio e del potere degli ecclesiastici, dall’altra; ma tale questione necessita di un’attenta analisi giacché gli imperatori continuarono fino alla fine ad arrogarsi la gloria militare.
Giorgio Piside, contemporaneo di Eraclio, lo paragonò favorevolmente ad Alessandro Magno.
Ad ogni modo, gli attacchi dei popoli stranieri incoraggiarono probabilmente sia i tentativi di imporre l’ortodossia religiosa (allo scopo di soddisfare la divinità) sia una tendenza a cercare di condurre un’esistenza al di fuori del mondo politico-militare (specialmente tramite il monachesimo, in costante proliferazione).
Alla fine del capitolo precedente ho elencato i principali fattori interni che sembrano aver impedito a Roma di difendersi con successo dall’offensiva musulmana, sottolineando il circolo vizioso delle invasioni e delle conseguenti difficoltà fiscali; in questo capitolo, ho cercato di completare il quadro esaminando le manchevolezze delle élite romane e le fratture create da un fervente cristianesimo.
Ad ogni modo, negli anni Trenta o Quaranta del Settimo Secolo sarebbe risultato comunque difficile per l’Impero romano sconfiggere in maniera decisiva gli arabi, dopo l’estenuante e distruttiva, pur se finalmente vittoriosa, guerra contro i persiani durata a tutti gli effetti dal 602 al 628.
Pag. 315-17
Cap. 8. Retrospettiva e alcune riflessioni
Dal momento che questo libro è già di per sé in buona misura una sintesi, non può essere riassunto senza che vadano perse alcune sfumature e precisazioni essenziali: ma i libri di storia hanno il dovere di stilare le loro conclusioni e dunque questo capitolo intende mettere in luce e sviluppare ulteriormente i temi principali dei sette capitoli precedenti.
Dovrebbe risultare chiaro, innanzitutto, quanto sia utile il confronto fra i romani delle diverse epoche: ma strano a dirsi, quei romani che costruirono un impero e quelli che lo persero si sono incontrati solo di rado nelle pagine di un libro di storia di produzione accademica.
Il contrasto fra queste due popolazioni è estremamente illuminante: anche se appare abbastanza ovvio che i romani del Terzo e Secondo Secolo a. C. fossero bellicisti e molto spesso aggressivi, nessuno che paragoni il loro comportamento con quello, così diverso, dei romani della tarda antichità potrebbe mai dubitarne.
Di contro, nessuno studioso di storia romana mediorepubblicana potrebbe mai esprimere un’opinione favorevole sulle capacità militari dello Stato romano nei due periodo del tardoantico descritti nei capitoli 6 e 7.
Se poi guardiamo allo Stato coeso e disciplinato della media repubblica, il mondo frammentato e intimorito dell’epoca di Teodosio Primo e dei suoi figli appare ancora più palesemente disfunzionale, e ciò vale a maggior ragione per l’Impero di Foca e di Eraclio, e per quelle sue parti che questi riuscirono a trasmettere ai loro successori.
In tutto il libro ho cercato di correlare i meccanismi del potere esterno e di quello interno: ci siamo quindi occupati allo stesso tempo di potere politico, militare, sociale ed economico, ma anche di potere di genere e di quello delle idee, nonché di tutti i canali, specie quelli ideologici, attraverso i quali il potere veniva esercitato; è stato costantemente necessario chiedersi quanto questi processi storici mettano in luce il predominio di una singola classe sociale.
Fin dall’inizio ho posto la domanda sul perché il potere di Roma si sia diffuso così estesamente e sia durato così a lungo.
Nell’età mediorepubblicana a contribuire a produrre una straordinaria ma non ininterrotta sequenza di vittorie militari furono molti fattori, fra cui il contesto geografico e il successo demografico, oltre alla schiavitù dei nemici sconfitti e all’integrazione degli schiavi affrancati.
Quanto all’eccezionale devozione romana per la guerra, appare ben visibile fin dagli albori della loro storia documentata.
Entro l’ultimo decennio del Quarto Secolo a. C., se non prima, le risorse di Roma erano molto superiori a quelle della maggior parte dei suoi nemici prescelti e riuscì a sfruttare con eccezionale abilità anche quelle di altre comunità, dapprima i latini e poi, al più tardi per gli anni Settanta del Terzo Secolo a. C., gli altri popoli italici.
Un’altra caratteristica che emerge con chiarezza già all’epoca della prima guerra punica è la capacità dei romani di impadronirsi della tecnologia bellica di altre nazioni.
La disciplina sociale, tuttavia, era fondamentale, compresa quella che sottendeva la competizione esistente in seno all’aristocrazia assicurando che non finisse fuori controllo.
In tutto questo periodo non esiste alcun indizio di una riluttanza da parte dei cittadini romani a servire sotto le armi; ma a guidare la politica estera dello Stato, e in modo coerente, era un’aristocrazia dotata di grande influenza, seppure non onnipotente.
Molto di quanto sopra rimane ovviamente avvolto nell’incertezza: mancano quasi del tutto dei testi coevi, , né sappiamo se quella violenza patologica e intimidatoria che Polibio e le sue fonti riscontravano nei soldati romani li differenziasse dalle altre popolazioni italiche già, poniamo, nel 300 a. C.
Siamo meglio informati sulle “tecniche di organizzazione” (per ripetere l’espressione di Michael Mann) che permisero a Roma di mantenere il controllo di quanto conquistato nella penisola, e che sono state studiate in modo approfondito: la colonizzazione, la confisca delle terre, la costruzione di strade, la diffusione della cittadinanza romana e dell’identità italiana, insieme a una limitata interferenza culturale e religiosa; Roma tendeva poi a favorire sempre le élite locali se queste erano disposte a cooperare, come di fatto accadeva assai spesso.
Queste tecniche funzionarono, seppure a malapena: Annibale fu sul punto di infrangere il predominio romano nella penisole, e la rabbia degli stessi italici sfociò nella grande rivolta del 91-90 a. C.; in entrambi i casi, tuttavia, un numero sufficiente di “alleati” italici decise invece di sostenere Roma ( quanto meno si dimostrò poco incline a prendere le armi per ribellarsi), permettendole così di avere la meglio.
Spiegare i successi militari romani nei conflitti con le altre grandi potenze mediterranee, fino alla distruzione di Cartagine nel 146 a. C., è un altro compito difficile.
Cartagine e la Macedonia cessarono di esistere come Stati indipendenti, e dopo la battaglia di Pidna, nel 168 a. C., un Impero seleucide assai indebolito dovette riconoscere il proprio ruolo subordinato.
La potenza navale ebbe un ruolo fondamentale: tra il 160 a. C. (con la battaglia di Milazzo) e il 190 a. C. (battaglia di Mionesso) Roma si appropriò del Mediterraneo, riuscendo ancora una volta a sfruttare alcuni vantaggi – in particolare, le risorse economiche necessarie per la costruzione e il rinnovamento di grandi flotte, e la più o meno volontaria cooperazione delle città greche dotate di esperienza navale.
Ma nel corso di questi 120 anni i romani condussero per lo più delle campagne terrestri, contro molti e diversi nemici: si trattò spesso di lotte impari ma, almeno inizialmente, non nel caso delle grandi potenze mediterranee; e anzi, non era per nulla scontato che Roma riuscisse a conquistare una gran parte della penisola iberica.
Gli eserciti romani riuscirono sempre a prevalere per motivi che risultano in buona parte insondabili: la disciplina, sia sociale che militare, si confermò ancora una volta un fattore molto importante; di fatto, costituì l’elemento centrale dell’analisi di Polibio – il quale scrisse anche di come la ferocia dei soldati romani avesse indebolito i loro avversari macedoni, che all’epoca erano probabilmente altrettanto risoluti di qualsiasi altra forza combattente del mondo mediterraneo.
Come già in Italia, negli altri territori che Roma arrivò a controllare fino al 146 a. C. i vincitori idearono diverse tecniche di organizzazione del tutti sufficienti a garantire un dominio di lungo periodo: da una parte, la creazione di province e di nuove magistrature, uan diplomazia molto più ambiziosa accompagnata da slogan appropriati, e ancora una volta il sostegno ai proprietari locali disponibili a cooperare; dall’altra, un brutale ricorso alla deportazione quando era considerata necessaria, culminato nella distruzione di Cartagine e Corinto e nella distribuzione delle rispettive terre ai colon romani e italici.
Nei successivi 130 anni di inarrestabile espansione, Roma dovette subire anche delle spettacolari sconfitte militari, in particolare ad Arausio (105 a. C.), Carre (53 a. C.) e nella foresta di Teutoburgo (9 d. C.) – conseguenze inevitabili, potremmo dire, di un atteggiamento nei confronti del mondo esterno altamente aggressivo e talvolta troppo sicuro di sé.
Ma il bilancio complessivo fu di nuovo trionfale, giacché le risorse e la dedizione di Roma erano tali da poter affrontare con successo qualsiasi avversario nell’area mediterranea o in Europa settentrionale – con una singola eccezione, l’Impero dei parti.
Nel Nord tuttavia la determinazione di Roma venne meno in un momento cruciale (dal 9 d. C. in avanti), per motivi peraltro del tutto validi e razionali, e le regioni a est del Reno e a nord del Danubio non furono quindi conquistate.
Durante tutto il periodo di espansione repubblicana e augustea è possibile stabilire un legame fra i rapporti di potere esterni e interni di Roma, i cui contorni sono chiari: la competizione fra aristocratici in una società guerriera – in cui oltretutto il potere dei cittadini non produsse alcuna seria aspirazione democratica fino all’epoca dei Gracchi – richiedeva un costante impegno bellico.
Il prestigio militare rimase indispensabile per chiunque pretendesse di governare, almeno fino all’epoca di Tiberio: alla fine l’espansione divenne meno attraente in gran parte perché al monarca non conveniva affidare il comando di grandi unità militari a dei potenziali rivali, né cercare di ottenere il necessario gettito fiscale.
La crescita del potere esterno, nel frattempo, aveva rivoluzionato la società romana, inondandola di schiavi e aumentando sempre di più il divario fra i ricchi e la gente comune: mai una democrazia, la Roma di età mediorepubblicana delegava alcune importanti prerogative ai cittadini ma a dominare era l’aristocrazia – assistita da diverse pratiche sociali e religiose che trascendevano i confini di classe, ma pur sempre un’aristocrazia.
La famiglia romana diede il proprio contributo a un’eccezionale disciplina civica, disciplina che valori dominanti come la fides e la virtus tendevano a rafforzare; l’ideale della libertas, d’altra parte, aveva effetti più complessi.
Ad ogni modo il Senato, piuttosto ampio rispetto all’entità della popolazione, dominava la politica e – malgrado alcuni segnali di allarme nel Secondo Secolo a. C. – fino al 140 a. C. circa l’ordine senatorio e i suoi alleati sembrarono tenere saldamente in mano le redini del potere: si erano arricchiti e avevano saggiamente condiviso i frutti di un imperialismo vittorioso.
Tuttavia, avevano anche lasciato che molti bisogni e aspirazioni dei romani comuni rimanessero insoddisfatti; nel contempo, la loro cultura stava cambiando, allontanandosi dal militarismo – sebbene questa tendenza non vada esagerata – e orientandosi verso la competizione e il piacere in altri aspetti della vita (qui si faceva sentire l’influenza greca).
I motivi di malcontento nella tarda repubblica erano di almeno quattro diversi tipi: il più semplice da soddisfare era legato alle aspirazioni dei ceti emergenti di cittadini moderatamente abbienti, alla base delle leggi elettorali degli anni Trenta del Secondo Secolo A. C.; assai più problematica – e mai risolta – era la tendenza alla ribellione degli schiavi, al suo culmine fra il 140 e il 71 a. C.
I non cittadini italici furono all’origine di gravissime difficoltà, cui venne infine data soluzione grazie alla più radicale inversione politica dell’intera storia di Roma, per lo più delineata in quella Lex Iulia che nel 90 a. C. concesse alla maggior parte di loro la cittadinanza romana.
Il quarto genere di conflitto, forse non più grave della ribellione degli schiavi o del malcontento degli italici, ma non suscettibile di soluzione senza una guerra civile, riguardava i bisogni della parte più povera della popolazione di tutta la penisola italiana.
Tali bisogni poterono venire soddisfatti, ma solo canalizzandoli nei ranghi di eserciti semi rivoluzionari al servizio delle ambizioni di quegli aristocratici che nell’arco di due generazioni, da Silla a Ottaviano, lottarono per il dominio personale: il risultato fu un mezzo secolo di disordini e insicurezza.
Non è certo sorprendente che l’ordine senatorio non fosse in grado di controllare l’ascesa di potenti dinasti in seno ai propri ranghi: assunse infatti molte iniziative discutibili perdendo infine la propria supremazia politica, sebbene non in modo decisivo fino all’epoca di Tiberio; e anche allora la classe sociale dei grandi proprietari fondiari, sopravvissuta alle proscrizioni e agli altri pericoli della tarda repubblica e dei periodi di triumvirato – quando molte famiglie aristocratiche sparirono o si avviarono al declino – continuò la propria esistenza, sostanzialmente impermeabile al malcontento popolare.
Augusto, dopo aver versato uan grande quantità di sangue, romano e altrui, ed essersi insediato come unico governante, riportò un livello di stabilità sconosciuto almeno dall’inizio della guerra sociale, sessant’anni prima della battaglia di Azio; con astuzia straordinaria e con un vasto arsenale di armi istituzionali e ideologiche si rese invulnerabile, trasmettendo infine il potere al suo successore prescelto.
Questi, Tiberio, operò un cambiamento nei rapporti di Roma con il mondo esterno che si rivelò di lunga durata: mentre Augusto aveva sfidato i popoli germanici ma non i parti, il suo successore lasciò entrambi per lo più indisturbati.
Nel corso dei due secoli successivi l’espansione romana rallentò bruscamente, per diverse ragioni: il fattore più significativo fu probabilmente la necessità dell’imperatore di proteggersi dagli usurpatori, giacché era ovvio che un generale eccezionalmente vittorioso costituiva una minaccia per l’uomo al vertice, mentre pochi imperatori desideravano, come Traiano, assumersi il compito di condurre di persona delle ardue campagne di conquista.
Un impero con una frontiera estesa e molti sudditi irrequieti si trovò poi inevitabilmente e assai spesso alle prese con dei conflitti secondari.
Un limite importante era rappresentato dall’onere finanziario che il mantenimento delle forze armate di Roma comportava, specie dopo la grande epidemia comparsa al tempo di Marco Aurelio (la peste antonina, che causò una contrazione del bacino fiscale) e dopo la decisione di Settimio Severo di aumentare il numero delle legioni.
Né va tralasciato il fatto che molti romani fossero convinti che al di fuori dell’Impero non esistesse nulla di cui valesse la pena impadronirsi, o che in una monarchia assoluta l’imperatore potesse proclamarsi un conquistatore senza avere di fatto mai conquistato alcunché; è inoltre evidente che praticamente l’intera classe dirigente aveva ormai perduto la passione repubblicana per la gloria militare.
Roma si assestò dunque dietro a frontiere che rimasero in gran parte immutate, e difese anche terrorizzando periodicamente i popoli vicini.
L’Impero di Costantino era più grande di quello di Tiberio e i suoi confini sembravano ragionevolmente sicuri: ma doveva fare i conti con delle manchevolezze militari e con dei problemi interni potenzialmente seri.
Che avesse speso troppo, in termini umani e finanziari, nelle guerre civili seguite alla crisi della tetrarchia potrebbe non aver avuto importanza, se non fosse stato per la certezza che la guerra civile sarebbe presto scoppiata di nuovo non appena Costantino fosse uscito di scena.
E’ facile lasciarsi andare alla tentazione di vedere negli eserciti tetrarchici e costantiniani i semi dei problemi futuri: spese enormi e un’imperfetta identificazione delle truppe “barbare” con Roma.
Nell’età mediorepubblicana un’alta percentuale dei cittadini maschi abili prestò un qualche tipo di servizio militare: Possiamo stimare che alla metà del Secondo Secolo a. C. almeno la metà di loro si fosse ritrovata sotto le armi in un periodo o nell’altro.
Dopo la scomparsa dei veterani delle campagne di Azio, sotto Tiberio, la quota di popolazione maschile ad aver svolto direttamente il servizio militare andò declinando e per la metà del Secondo Secolo a. C. possiamo stimare che appena il 4% dei cittadini maschi allora in vita si trovavano o erano stati sotto le rami, una percentuale ancora minore se si considera l’intera popolazione maschile.
Di coloro che indossavano l’uniforme in quel periodo, poi, pochi vissero vere esperienze in battaglia contro dei nemici temibili: dunque vi furono assai meno veterani con vecchie ferite di guerra, assai meno giovani vedove – e assai meno cittadini temprati dal combattimento.
Lo Stato romano era divenuto meno belligerante, e meno preparato ad affrontare un grande conflitto.
La durata dell’Impero romano dipese ovviamente in gran parte dalle sue strutture di potere interne, e grazie a un’abbondante documentazione e a numerose fonti letterarie tali strutture sono meglio conosciute fra il Primo e il Quarto Secolo che non negli altri periodi, precedenti o successivi: sulla corte imperiale rimane sempre un velo di segretezza, ma i sistemi principali sono ben discernibili.
Gli imperatori romani, da Tiberio in poi, erano monarchi assoluti e fino a un certo punto sacralizzati, che operavano all’interno di una corte e nel quadro di rapporti spesso non facili sia con l’ordine senatorio che con le forze armate (e men che meno un’invulnerabilità) né a ideare un sistema di successione efficace, ma la struttura politica centrale sopravvisse comunque.
Uno dei motivi fu che gli imperatori riuscirono invece a integrare uan notevole proporzione delle élite delle province, nonché un numero sufficiente di provinciali più modesti disposti a servire nell’esercito: un successo non sorprendente, dal momento che l’Impero romano rappresentava gli interessi economici di molti dei suoi abitanti, almeno finché riusciva a mantenere l’ordine.
Tuttavia, vi era anche qualcosa di più: una diffusa lealtà nei confronti dell’idea di Roma, lealtà che andava da poco più della semplice accettazione della potenza romana a una più articolata fede che dev’essere stata più forte fra coloro – una minoranza della popolazione, ma una minoranza numerosa e in costante crescita – cui era stato concesso l’onore della cittadinanza.
Questi fattori traghettarono l’Impero attraverso la crisi del Terzo Secolo, anche se non senza gravi difficoltà; il che non significa negare che molti altri sudditi romani si sentissero estranei e inclini invece alla ribellione.
Com’era distribuito il potere all’interno del mondo imperiale romano?
Fino al regno di Marco Aurelio, o forse persino alla dinastia dei Severi, la tendenza di lungo corso fu probabilmente quella di un ruolo più attivo del governo centrale, ma il potere era inevitabilmente diffuso fra le forze armate, i proprietari terrieri e i funzionari di ogni livello.
Non esisteva alcuna burocrazia in senso moderno, ma una rete assai ampia di persone preparate per gestire le procedure amministrative regolarizzate; quanto all’efficienza (un criterio in gran parte di epoca moderna), i risultati erano contrastanti, migliori in alcune province rispetto ad altre; l’ordine pubblico era lasciato in gran parte all’autogestione e i processi penali dipendevano in primo luogo dal ceto di appartenenza.
Ricostruire i vari generi di potere sociale è possibile solo in modo parziale, cosicché appare indispensabile un modello sufficientemente chiaro della struttura sociale dell’Impero.
Il predominio della classe dei proprietari terrieri risulta a ogni modo evidente: ma mentre le principali vittime del potere sociale erano, com’è ovvio, gli schiavi (è quasi superfluo dover precisare che la schiavitù definiva una condizione giuridica, non economica), a subire una maggior oppressione erano per lo più i semplici indigenti.
Il potere o la subordinazione di una donna, se si escludono fattori di natura personale, corrispondevano alla sua classe sociale, con l’ulteriore e principale complicazione della grande influenza delle consuetudini locali (sembrerebbe facile supporre che, a parità di altre condizioni, per una donna fosse meglio trovarsi il più lontano possibile dalle zone di influenza greca: ma la semigreca Alessandria era assai diversa dalla semigreca Tarso).
Gli schemi educativi altoimperiali, che servivano principalmente per fornire delle abilità linguistiche di vario tipo, crearono un mondo raffinato ed esclusivo riservato alle élite e in cui le allusioni ai classici della letteratura erano essenziali, mentre la grande massa della popolazione rimaneva al di fuori di qualsiasi tipo di apparato scolastico.
Questo sistema però funzionava solo perché esistevano delle condizioni intermedie, e perché era possibile acquisire un’alfabetizzazione (e, a un altro livello, un’istruzione ricercata) se si possedevano denaro a volontà sufficienti.
Ancora una volta molto dipendeva dal contesto geografico: sotto questo aspetto le città offrivano condizioni ben più favorevoli delle campagne, così come in generale le zone maggiormente ellenizzate e romanizzate (e fra auqete ultime quelle di cultura greca continuarono a favorire di più l’istruzione rispetto a quelle latine).
Il problema forse più difficile è quello di una valutazione del potere sociale e politico delle idee.
La mia descrizione tende a minimizzare gli effetti di alcune idee romane predominanti, mentre è senza dubbio vero che le dottrine che trattano dell’etica e dell’organizzazione della società tendono a perdere la loro purezza nella vita reale.
Ma credo che l’idea di Roma non possa essere paragonata a un moderno ideale nazionale: esercitava una forte attrattiva su persone di origini eterogenee, senza troppe pretese di essere democratica; l’integrazione costituì certamente un fenomeno limitato, ma almeno dall’epoca dei Flavi in poi un gran numero di persone – non solo le élite dell’Urbe ma anche quelle locali, così come la maggior parte dei militari – diede per scontato che Roma fosse degna della loro devozione.
Le idee sovversive sono più facili da isolare e valutare, grazie soprattutto al trionfo del cristianesimo: il rifiuto dello Stato romano da parte di molti cristiani e fedeli di altri culti costituì probabilmente un fenomeno di importanza trascurabile dal punto di vista del potere, ma tutto iniziò a cambiare quando Costantino concesse ai cristiani i primi privilegi; gli effetti più importanti degli ideali del cristianesimo si fecero sentire più tardi.
Il ridimensionamento tardoantico dell’Impero romano avvenne in due fasi completamente distinte: in Occidente nei decenni a cavallo del 410, in Oriente nella prima metà del Settimo Secolo; va ribadito che si trattò di due catene di eventi diverse, con delle similitudini ma che non saranno mai correttamente comprese se non analizzandole singolarmente.
La natura del cambiamento avvenuto durante la prima di queste due fasi è stata assai dibattuta: è chiaro però che l’area su cui lo Stato romano esercitava il proprio potere si vide bruscamente ridimensionata, ed entro il 476 l’Impero d’Occidente aveva cessato di esistere.
L’interrogativo che qui occorre porsi è se le vittorie degli invasori e i fallimenti politici e militari di Roma fossero dovuti ad alcuni fattori recenti o relativamente tali, da una parte o dall’altra (o da entrambe).
Forse perché avevano identificato delle debolezze nel sistema difensivo imperiale, gli invasori furono abbastanza numerosi; le milizie a disposizione di Roma non erano sufficienti né dal punto di vista quantitativo – nonostante alcune affermazioni in senso contrario – né qualitativo: rispetto all’epoca altoimperiale erano armate e addestrate in modo peggiore (la testimonianza di Vegezio si rivela in questo senso illuminante).
In termini materiali, l’Impero romano era ancora abbastanza ricco da attirare dei saccheggiatori ma a quanto sembra non era in grado di permettersi una difesa adeguata, e a ogni nuova offensiva lo diventò sempre meno; per quel che riguarda il morale, le forze armate romane erano eccessivamente in conflitto fra di loro dal punti di vista etnico e religioso, e quest’ultimo aspetto ebbe la sua importanza.
La diffusione del cristianesimo avrebbe potuto rappresentare una differenza marginale pe r le capacità difensive dell’Impero, se non avesse portato con sé l’intolleranza dei cristiani, intolleranza che spesso assunse la forma della ripugnanza e del disprezzo nei confronti degli ebrei, dei “pagani” e di quei cristiani che avevano opinioni differenti sul soprannaturale.
Per quel che riguarda la popolazione civile, non fu all’altezza della crisi: anche se l’élite sociale superiore di epoca repubblicana e altoimperiale era guidata da ambizioni e interessi personali, come la maggior parte degli esseri umani, dimostrò tuttavia un patriottico senso di responsabilità che ora era diventato merce rara.
La massa della popolazione non era per lo più interessata a difendere lo status quo, quando non se ne sentiva estranea; le nostre fonti fanno solo vaghi riferimenti ai motivi di questa situazione, che possono verosimilmente essere riassunti con il termine di “oppressione sociale”.
Fino all’alba del Quinto Secolo l’Impero d’Oriente fu probabilmente altrettanto a rischio di invasioni di quello d’Occidente, ma fu la scala di queste invasioni a far collassare il governo occidentale.
Entrambe le parti erano già state indebolite dall’interno (possiamo soprassedere all’ordine dell’esposizione seguito nei capitoli 6 e 7 per riprendere qui l’argomento), ma toccò all’Occidente essere messo alla prova.
A quest’epoca il governo centrale era in grado di offrire assai poco ai suoi sudditi, anche per gli standard dell’Antichità; il suo potere effettivo è stato spesso mal compreso, in parte perché in alcuni settori ben delimitati rimaneva ancora saldo (nessun imperatore venne assassinato fra il 383 ei l 455, il che era abbastanza insolito per Roma), ma per il resto era debole; non era in grado di mantenere neanche il modesto livello di ordine pubblico dei secoli precedenti più di quanto non riuscisse a tenere fuori i barbari.
Gli imperatori cercarono di imporre la propria autorità, ma fino a che punto vi siano riusciti è fonte di dibattito interminabile: in teoria le strutture formali del funzionariato fornivano loro la possibilità di esercitare un controllo minuzioso, ma a frapporsi erano due ostacoli (oltre alla sempre più frequente perdita del controllo militare a livello locale e le alterazioni dell’ordine pubblico): i vescovi e la corruzione.
Entro gli anni Settanta del Quarto Secolo i vescovi e le altre autorità cristiane si erano già ritagliati un ambito di potere semi-indipendente all’interno della comunità romana, ma anche se tale ambito comprendeva un crescente numero di persone e ricchezze sempre maggiori, i suoi effetti sullo Stato rimanevano ancora per lo più indiretti.
Anche la corruzione – sebbene non costituisse il problema fondamentale del governo romano, come è stato talvolta affermato – era diventata d’intralcio; di fatto, l’assai rapido ricambio nelle cariche al vertice può essersi rivelato un ostacolo altrettanto grave all’efficienza dell’amministrazione: in queste circostanze né il gettito fiscale né il reclutamento dell’esercito riuscirono a tenere il passo delle necessità dell’Impero.
Nulla poi potrebbe essere meno sorprendente, in questi decenni decisivi, della mancanza di entusiasmo della massa della popolazione per lo Stato romano: la delegittimazione delle antiche pratiche e credenze religiose e l’oppressione di cui erano vittime i coloni e altre categorie sociali facevano sì che fossero in molti ad avere motivi per sentirsi degli estranei.
L’intera popolazione visse un certo grado di disintegrazione sociale: le Chiese cristiane offrivano solidarietà ai propri membri, ma erano impegnate nel contempo in aspri e spesso violenti conflitti con i propri rivali.
Lungi dall’essere un forte Stato centralizzato, in questi anni l’Impero romano – seppure ancora un’immensa struttura che poteva ben paragonarsi al suo principale avversario in Oriente, la Persia sasanide – divenne incapace di mobilitare risorse sufficienti per resistere alle invasioni germaniche.
Esistono dei parallelismi fra la crisi militare in Occidente e quella successiva in Oriente: anche in questo caso è infatti possibile affermare che all’inizio del Settimo Secolo l’Impero romano d’Oriente era ancora abbastanza ricco da attirare dei saccheggiatori, ma non più in grado di difendere le sue eccessive pretese territoriali (la “follia di Giustiniano”); come già in Italia nel 410, non poteva neppure garantire l’inviolabilità del proprio nucleo geografico, per non parlare dei propri cespiti fiscali e men che meno della propria periferia più esterna.
Ma è ancor più difficile stabilire quali altri fattori si siano rivelati più importanti, data la scarsità di documenti a nostra disposizione – anche se l’incapacità dei generali e la mancanza di disciplina delle truppe senza dubbio diedero il loro contributo.
Ma fra le due crisi esistono anche delle profonde differenze: l’Impero di Giustiniano era insostenibile a lungo termine, mentre quello di Costantino probabilmente no (non fosse che qualsiasi impero diventa insostenibile nel lunghissimo periodo).
Altri fattori che possono aver contribuito all’impatto fatale degli arabi sull’Impero di Eraclio e dei suoi successori sono ancora più difficili da definire, ma includono un grado di militarizzazione da parte islamica che ricorda la società romana dell’età mediorepubblicana; anche la profonda divisione in seno all’Impero romano fra cristiani calcedoniani e monofisiti si rivelò assai pregiudiziale.
La devozione peraltro può essere stata altrettanto profonda fra i musulmani che fra i cristiani, e dunque se lo Stato romani di questi anni abbia sofferto delle conseguenze negative dal dedicare una così larga parte delle proprie risorse umane ed economiche alla religione deve rimanere una domanda senza risposta.
I successori di Giustiniano furono monarchi assoluti, ma il loro potere interno era nella pratica limitato o quanto meno fragile: la delega del potere di nomina dei governatori provinciali da parte di Giustino Secondo ne è un sintomo eclatante, così come lo è il potere indipendente delle fazioni del Circo; ma ve ne sono anche altri, in particolare il potere degli ecclesiastici e quello dei grandi proprietari terrieri.
Eraclio non riuscì a trovare entro i confini del suo regno dei comandanti militari capaci e fidati in grado di guidare il suo esercito, né riuscì a sfruttare a sufficienza l’energia dei propri sudditi se non per conservare solo uan piccola parte di quello che per secoli era stato un impero vasto e temuto.
La tensione tra i fattori materiali e psicologici è uno dei motivi conduttori di questo studio.
Da una parte ho insistito sull’importanza per il potere esterno di Roma delle sue risorse umane e finanziarie, che resero possibile la costruzione di u impero durevole; ho parimenti insistito sulla dannosa carenza di tali risorse in alcuni periodi decisivi della tarda antichità – uan carenza che, va detto, è spesso più presunta che provata.
Nel mezzo vi sono lunghi secoli in cui le occasionali disavventure imperiali sui campi di battaglia – se anche possono aver aiutato a definire i limiti dell’espansione romana – non rappresentarono un rischio significativo per la stabilità dello Stato.
Se si dovessero avanzare delle ipotesi – come uno storico dovrebbe fare di tanto in tanto – su altri fattori materiali importanti, ve ne sono alcuni che possono essere ritenuti alquanto plausibili: l’instaurazione del dominio navale nel Mediterraneo, ad esempio, può essere stata resa possibile da un più facile accesso al legname da costruzione rispetto ai regni ellenistici (e a Cartagine)?
Possiamo anche chiederci se alla fine del Quarto Secolo i vicini germanici di Roma non avessero acquisito armi migliori o non avessero imparato dei nuovi metodi di organizzazione delle loro forze combattenti rispetto ai periodi precedenti.
I fattori materiali erano ovviamente di importanza fondamentale nello strutturare il potere interno: sarebbe possibile scrivere una storia del Mediterraneo nell’Antichità a partire dall’ambiente fisico e dall’istituzione della schiavitù, che presumibilmente precorse di alcuni millenni qualsiasi tentativo di codificarla giuridicamente; si aggiungano i diritti di proprietà, e la scena è pronta per la comparsa della competizione per la terra e per ogni altra risorsa economica.
Un altro motivo ricorrente in queste pagine è stata la continua vittoria dei grandi proprietari terrieri, un dominio che raggiunse il suo culmine nell’età mediorepubblicana per vedersi poi minacciato – ma solo in modo marginale – all’epoca delle leggi agrarie (dal 133 al 69 a. C.); in epoca altoimperiale i princeps protessero i diritti di proprietà, anche se come abbiamo visto in precedenza il prezzo da pagare poteva essere elevato, mentre nel tardoantico i grandi proprietari rimasero per lo più incontrastati.
Anche i fattori psicologici sono comparsi spesso e in maniera importante nelle pagine di questo libro: le peculiarità psicologiche dei soldati romani – un’obbedienza disciplinata, una profonda tendenza a una violenza sanguinosa e presumibilmente un forte senso dell’onore – furono parte delle fondamenta principali dell’Impero di età mediorepubblicana; emersero con chiarezza anche la mancanza di scrupoli, l’ambizione e il coraggio di molti membri del ceto senatorio.
La professionalità die soldati di epoca altoimperiale, legionari o ausiliari che fossero, costituiva anch’essa un aspetto psicologico oltre che una tradizione instillata in loro da generazioni di ufficiali.
In questo stesso periodo, diciamo da Tiberio e Godiano Terzo (14-244), le caratteristiche psicologiche dei principali dirigenti dello Stato – gli imperatori e i funzionari più importanti, sia civili che militari – mostrarono uan maggiore varietà, ma possiamo osservare che una buona parte di costoro esibì un marcato, seppur comprensibile, autocompiacimento nei confronti del mondo esterno.
Che l’intolleranza religiosa fosse uan caratteristica di entrambi i periodi di crisi tardoantica che abbiamo esaminato non necessita di ulteriori discussioni: ho suggerito anche che tali periodi fossero caratterizzati da una coscienza nazionale relativamente debole fra la popolazione in generale, e anche questa è una caratteristica psicologica; sembra inoltre probabile, ad esempio, che l’aumentata ferocia delle punizioni tardoantiche abbia una base sociopsicologica.
Tutto ciò è parte essenziale di una storia del potere.
Questo non è un libro sul potere americano, ma nessuno storico che risieda da lungo tempo negli Stati Uniti può scrivere del potere di Roma senza riflettere sul modo in cui – fin dall’inizio della Guerra Fredda – gli scrittori e i registi occidentali, soprattutto ma non solo americani, hanno fatto uso della storia romana per giustificare questa o quella linea o iniziativa politica.
Negli ultimi anni un’enorme mole di letteratura più o meno popolare si è sviluppata attorno alla domanda se gli Stati Uniti siano in qualche senso Roma, la cui risposta è ovviamente “no” – a meno che non si voglia trattare quello romano come l’impero archetipico (senza dimenticare l’interessante parallelo che ciò che passa per impero americano, come quello romano, nacque in un periodo di governo ostensibilmente e parzialmente democratico, al contrario della maggior parte degli imperi).
Questo genere di letteratura tende a suscitare il disprezzo degli storici universitari, il che non sorprende, eppure può contribuire molto alla comprensione della storia degli imperi: quando ad esempio uno studioso – prostituendo la verità storica – afferma che i romani furono degli imperialisti riluttanti, proprio come noi, possiamo vedere all’opera la propaganda.
Lo studio degli imperi moderni è anzi indispensabile per uno storico del potere.
Sono stato accusato una volta da un critico di destra di soffrire della “sindrome del Vietnam dell’intellettuale americano”; a parte il fatto che non sono americano, ritengo che l’aver vissuto nel periodo della guerra in Vietnam come individuo politicamente impegnato mi sia stato assai di aiuto come storico: mi ha insegnato soprattutto quanto poco le parole di un governo imperialista possano corrispondere alle sue azioni, e quanto ampio sia il ventaglio di percezioni, moventi e atteggiamenti che, almeno a volte, è possibile trovare in una nazione imperiale; mi ha insegnato anche come gli abitanti dei paesi in guerra si disumanizzino reciprocamente.
Un apprendimento peraltro continuato a lungo: ancora nel 2001 un ufficiale gravemente coinvolto in un crimine di guerra in Vietnam e successivamente eletto al Senato degli Stati Uniti mi disse, dopo aver saputo che avevo partecipato ad alcune manifestazioni per la pace durante il conflitto, che non aveva importanza poiché eravamo “entrambi giovani e sciocchi”.
Il motivo evidente per cui di questi tempi esiste una così estesa pubblicistica americana sugli imperi ha poco a che fare con l’indagine storica; deriva in parte dall’ansiosa domanda, a cui non è possibile dare uan risposta, su quanto durerà il predominio militare degli Stati Uniti.
Aspetto più interessante, deriva anche dalle questioni morali e politiche che si trovano ad affrontare i cittadini riflessivi di una repubblica imperiale: con quale diritto, con quali giustificazioni possono gli Stati Uniti o chi per loro uccidere afghani, iracheni, somali, siriani o chiunque altro?
Ma non è più sicuro, non è meglio in un qualche senso del termine, vivere in un mondo in cui il potere imperiale e i suoi alleati garantiscono che le guerre saranno sempre periferiche?
A meno che, ovviamente, non capiti di vivere nella “periferia”.
Uno storico può avere molto da dire su tali questioni (compresa l’osservazione che le condizioni attuali sono radicalmente senza precedenti), questioni che però non sono di natura storica, quanto di carattere pratico e morale.