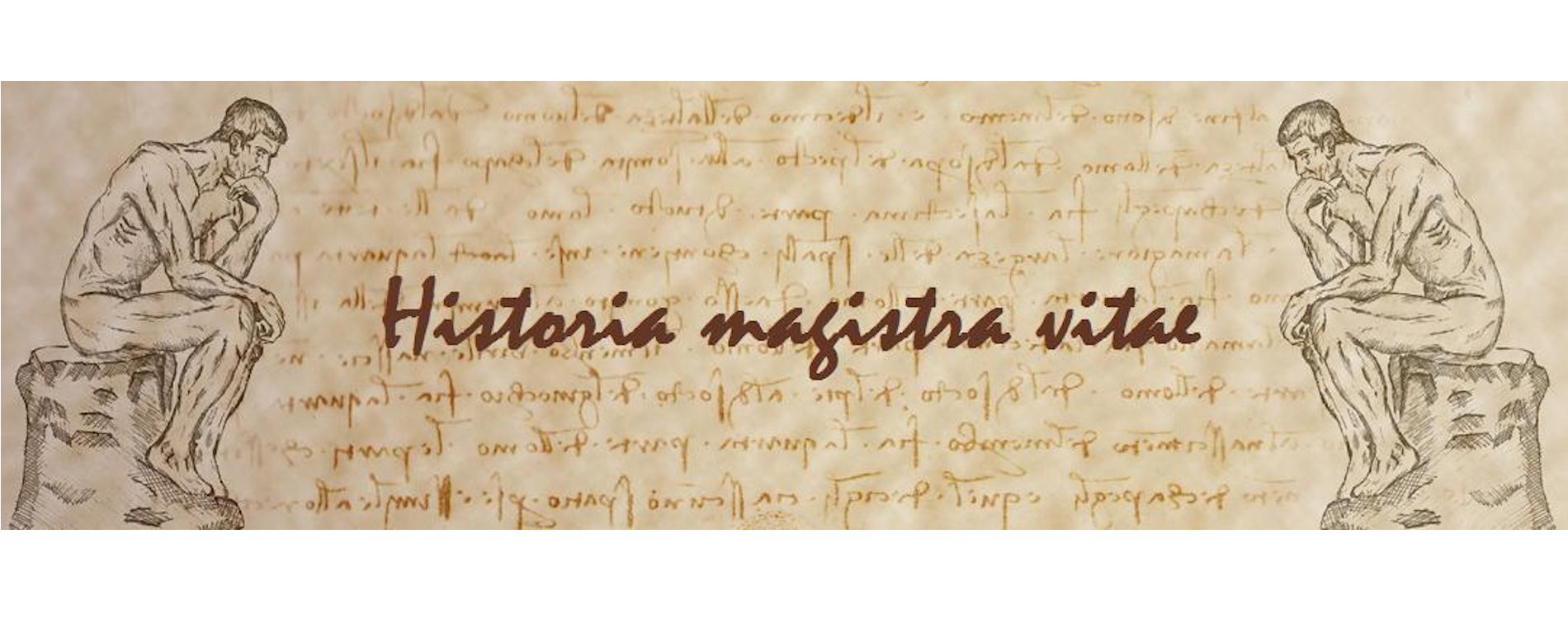Introduzione
La storia greca come storia universale
“La battaglia di Maratona, anche come evento della storia inglese, è più importante della battaglia di Hastings. Se in quel remoto giorno il risultato dello scontro fosse stato diverso (se i greci non avessero vinto), britanni e sassoni forse vagherebbero ancora per le selve”.
Così John Stuart Mill nel 1859; e sarebbe fin troppo facile moltiplicare citazioni come queste.
Esse non solo implicano che le radici comuni della civiltà occidentale risiedono nella grecità, ma anche danno per dimostrato il suo valore preternazionale e fondativo, che scavalchi a suo tempo, con bella spavalderia, i confini dei popoli e le barriere dei tempi: insomma, la storia greca come storia universale, o meglio come un suo snodo essenziale, necessario a intendere il mondo moderno, a partire dalle sue conseguenze per noi (o da quelle che decidiamo di prendere per tali).
Come un monumento provato dagli anni, una tale immagine, per attraente che possa essere, è però attraversata da crepe numerose e profonde.
Guardiamone una.
Nella citazione che abbiamo scelto, il carattere fondante della civiltà greca è simboleggiato dalla giornata di Maratona, e dunque identificato con una vittoria dei greci (leggi: degli europei) sui persiani, che stanno qui per un Oriente indeterminato e statico, l’’altro’ – perché perennemente uguale a se stesso – rispetto a un’Europa caratterizzata, a partire dalla grecità, da un accentuato dinamismo e da un continuo progresso; e per questo radice e madre della modernità.
Pochi sottoscriverebbero oggi un’idea come questa; eppure sarebbe facile rintracciarne più o meno sotterranee sopravvivenze.
La stessa, e più celebre, sentenza hegeliana secondo cui “Al nome Grecia, l’uomo colto europeo subito si sente in patria” non riflette forse, in ultimo, un’identica visione?
Queste formulazioni ci appaiono, oggi non solo strettamente eurocentriche, ma anche limitative e ‘datate’; ‘datate’, intendo, in quanto coestensive a una concezione della civiltà europea come culminazione d’ogni altra, e pertanto legittimata al colonialismo, all’annessione, alla ‘missione civilizzatrice’.
L’opposizione greci/barbari, tradotta con franco arbitrio in quella Europa/’altri’, veniva così continuamenti riattualizzata e proiettata ora verso le Americhe, ora in Asia o in Africa; i sistemi educativi, che includevano in posizione d’onore lo studio del greco per le élites designate a governare, e i musei che si fregiavano di marmi tolti ad Atene o a Pergamo, moltiplicandoli in calchi offerti a modello degli artisti, ribadivano incessantemente (forse proprio perché così improbabile) l’identità fra un ‘noi’ orgogliosamente europeo e i greci, padri e maestri di una stessa civiltà.
Questa identificazione, che sembrò assicurare alla cultura greca un posto perpetuo e garantirne la continua vitalità nel mondo moderno – quasi dovesse diffondervisi con le armi, le merci e le tecniche dell’Occidente – suona oggi al contrario come un canto funebre.
Quale può essere il posto dei greci in un mondo caratterizzato sempre di più dalla mescolanza dei popoli e delle culture, dalla condanna dell’imperialismo e dalla fine delle ideologie, dalla fiera rivendicazione delle identità etniche e nazionali e delle tradizioni locali contro ogni tentazione ‘annessionistica’?
Che senso ha cercare radici ‘comuni’, quando tutti sembrano piuttosto impegnati a distinguere le proprie da quelle del vicino?
Come possiamo vantarci di aver vinto sugli ‘altri’ a Maratona senza pensare all’Algeria o al Vietnam?
Con quale ostinata presunzione potremmo mai chiedere ai cinesi o agli indiani di riconoscersi nei greci, implicandone l’identità con un ‘noi’ tutto europeo, senza offrire in cambio il desiderio di indentificarci, noi, nella loro antichità?
Se quella è la nostra immagine dei greci, se quello è il loro ruolo nella ‘storia universale’ che vogliamo costruire, riducendo la storia universale a storia dell’Europa e dell’espansione europea, allora davvero i greci sono (o rischiano di diventare) il primo bersaglio di una cultura destinata a soccombere.
Non è questo che abbiamo inteso fare con questa nuova opera sulla storia, la cultura e l’arte greca.
Essa non intende né essere un ennesimo omaggio trionfalistico, al ‘miracolo greco’ che celebri in loro ‘noi’ stessi (quel ‘noi’); né però un bilancio consuntivo (più o meno triste, più o meno nostalgico), in chiusura di conti, sulla soglia di un momento fatale in cui ai greci nessuno guarderà più.
Di quell’uso che si è fatto della grecità, ‘noi’, e non i greci, siamo responsabili.
Esso comporta la nostra pretesa identità coi greci, e in nessun modo la loro identità con noi.
Tornare ai greci con un nuovo sguardo, costruire un nuovo ‘noi’ per guardare ai greci, è il compito a cui ci siamo ripromessi di dare una prima risposta, un contributo di pensiero e uno stimolo.
Non pretendiamo naturalmente di sapere (dimenticando il corso degli studi, e più ancora della storia) inaugurare in queste pagine un nuovissimo, candido sguardo sui greci, per nulla determinato da quello costruito dalle generazioni che ci hanno preceduto, ma s^ di provare a guardarne i testi e i resti con occhio più fresco e più attento alla diversità: più mirato all’oggi o al domani.
LA domanda è dunque: se i greci, che a quegli usi che non più accettiamo sembrarono piegarsi, abbiano ancora qualcosa da offrire a ‘noi’.
O meglio: quali ‘greci’ per quali ‘noi’.
Pag. XXVII-XXVIII
Cap. 1. Il confronto con gli antichi / François Hartog
Il problema, molto semplicemente, è quello della storia dell’Occidente e della sua cultura: dagli antichi sino a noi.
Quello anche del suo rapporto col tempo.
Possiamo quindi, tutt’al più, rilevare qualche pista, segnalare luoghi di passaggio, circoscrivere qualche momento di questa lunga storia dai registri molteplici, sfasati, connessi gli uni agli altri come in un gioco di incastri.
Ma se, abbandonando per un istante la prospettiva storiografica, ci si interroga direttamente sugli antichi e noi oggi, la e ha ancora un senso?
Perché ci sia confronto, ci vuole rapporto, compresenza, per non dire faccia a faccia.
Ora la distanza, fatta di rispetto, d’indifferenza, di oblio, o dei tre messi insieme, non si è forse irrimediabilmente imposta, al punto da rendere illusorio ogni rapporto effettivo, vivente, attivo?
Molière non metteva già forse sulla bocca di uno dei suoi personaggi questa chiara sentenza: “Gli antichi, signore, sono gli antichi, e noi siamo la gente di adesso”?
Nei primi anni del 18. secolo Jacob Perizonius, grande erudito dell’Università di Leida, celebrata poco meno di un secolo prima col nome di “Atene Batava” (da Johannes Meursius), dipinge un triste quadro della decadenza degli studi classici in Europa.
Da tempo, ormai, il verso un giorno famoso, “Chi ci libererà dei greci e dai romani?”
Un rapporto diretto con loro è ancora possibile?
Le loro domande sono ancora le nostre?
Possiamo ancora, o di nuovo, far nostre alcune loro domande?
La politica greca, la democrazia hanno ancora qualcosa da dirci, o piuttosto, siamo in grado di porre loro delle domande pertinenti sul nostro presente?
Le rovine antiche, è vero, sono attraenti: ondate di turisti si accalcano nei siti celebri, nel nome del viaggio culturale e sotto gli auspici dell’onnipresente e triste industria turistica.
Come tutti sappiamo, le conseguenze di questo tipo di confronto non sono sempre felici.
Lo sfruttamento moderno di questo “patrimonio” (dell’umanità) fa sì che queste rovine, oggi più protette che mai, siano anche più che mai minacciate.
Le rovine minacciano rovina: vittime del loro successo e di questo nuovo fattore chiamato “inquinamento”.
Dopo il sisma del 1980, Pompei è ridiventata uan città sinistrata, battuta milioni di volte dalle scarpe di milioni di turisti e invasa dalla vegetazione.
l’Acropoli è da tre anni irta di impalcature e i visitatori non hanno più accesso ai monumenti.
Di fronte a questa situazione, che fare?
Ritroviamo allora il dibattito, aperto almeno sin dal Quattrocento e ripreso senza sosta, sulla conservazione e sul restauro dei monumenti.
Con un testo pioneristico, pubblicato nel 1993, Der moderne Denkmalkultus, Alois Riegl scruta il concetto stesso del monumento storico, punto di incontro conflittuale re ciò che chiama il valore di antichità, il valore storico e il valore commemorativo.
Quale monumento mostrare?
Cioè, quale antichità si vuole visitare?
Come la si va a vedere?
Quale “rapporto” si vuole intrattenere con essa?
Cosa significa restaurare “nel contesto”: si tratta dell’ultimo contesto antico, del primissimo o dello stato in cui si trovava il monumento nel momento in cui gli archeologi lo hanno scoperto o ricoperto?
Oppure occorre restaurare sino a ricostruire, per rendere il monumento “accessibile” al più grande pubblico e, al limite, farlo sparire in quanto rovina?
Le discussioni sollevate dal restauro dell’Eretteo (terminato nel 1987) ne forniscono un buon esempio.
Oppure bisognerebbe non ricostruire, ma costruire accanto, per riprodurre, produrre una copia, la più perfetta possibile, di quell’originale ormai “vietato al pubblico”.
Così si è proceduto, a causa d’imperative ragioni di conservazione, per le grotte preistoriche di Lascaux.
E tale modo di procedere ha una sua logica, ma, dal punto di vista del rapporto con l’antichità, la produzione di questi simulacri che stanno in luogo del monumento reale e che occupano il suo stesso luogo ha comunque qualcosa di strano.
Quale rapporto con la temporalità si proietta su questo nuovo tipo di artefatti che sono come sottratti al tempo?
Giacché nulla impedisce di cambiarli non appena mostrino segni di usura.
Un’altra modalità contemporanea di confronto sarebbe piuttosto dell’ordine della citazione, per non dire del semplice ammiccamento.
E’ di quest’ordine il ricorso a nomi tratti dall’antichità per battezzare oggetti che sono gli emblemi stessi della scienza e della tecnica moderne.
Il missile europeo Ariane (ma perché proprio Ariane? Gli americani, da parte loro, si sono attribuiti Titano), il progetto di navetta spaziale Hermes, o la sonda Ulisse.
Come se, attraverso la riattivazione di questi vecchi nomi, che oggi non sono proprietà verbale di nessuno, si volesse suscitare, senza crederci troppo, qualche moderna mitologia.
Come se il più antico, l’arcaico, e il più moderno, il futuro, arrivassero quasi a toccarsi.
Come se l’età adulta vedesse realizzati i suoi sogni d’infanzia.
Come se l’antico mithos trovasse il suo compimento, se non la sua verità, in questa manifestazione del logos, nel suo massimo rigore.
Perché il costruttore automobilistico Renault ha giudicato commercialmente sensato di chiamare Clio uno dei suoi nuovi modelli (è vero che un altro si chiama Twingo)?
Entriamo qui nel vasto mondo della comunicazione, con le sue procedure di definizione di un “concetto”, nel senso che i pubblicitari attribuiscono a questa parola.
Non vi si incontra forse, in particolare, un uso puramente strumentale dell’antichità mirato a “civilizzare” delle sigle “barbare”?
Questo bricolage non ha altro scopo che renderle identificabili e memorizzabili, indipendentemente dal significato esatto, astruso o semplicemente piatto del loro contenuto.
L’ammiccamento per l’ammiccamento.
Altrimenti, come interpretare il fatto che la SNCF abbia battezzato il suo nuovo sistema di prenotazioni, messo in servizio con gran scalpore, Socrate?
Cosa è venuto a fare Socrate in questo inferno o meglio in questo programma informatico?
Questi pochi esempi non esauriscono il problema degli antichi e noi oggi, ma indicano, quanto meno, una tendenza.
Pag. 4-5
Cap. 2. La politica / Paul Cartledge
Data questa polarizzazione di opinioni, oltre a un’illimitata gamma di posizioni intermedie, non c’è indagine in grado di offrire risposte definitive o quanto meno affidabili a interrogativi tipo quelli sollevati sopra.
C’è però almeno una cosa che, con le sue ricerche di politica comparata, lo storico può fare: compilare e analizzare un “inventario delle differenze”, che forse può esserci d’aiuto in un’investigazione più approfondita sia della politica della Grecia antica, sia delle nostre (occidentali moderne) istituzioni politiche, delle nostre costituzioni e della nostra cultura; e può essere un utile incentivo a impegnarci con intelligenza nel tentativo di istituire tra queste realtà lontane nel tempo un rapporto proficuamente significativo.
Pag. 40
Mentre Machiavelli e Hobbes furono teorici dello Stato, la polis può essere tranquillamente definita una comunità politica senza Stato, anche se ciò naturalmente non significa equipararla sotto ogni aspetto a quei “sistemi politici africani” studiati dagli antropologi nell’omonima raccolta curata da Fortes ed Evans-Pritchard.
Pag. 45-46
Concludiamo, così come abbiamo cominciato, con un contrasto: nella realtà politica di scala limitata e a dominio maschile dell’antica Grecia, Simonide poteva tranquillamente e con grande precisione osservare che “la polis forma l’uomo”, vale a dire gli insegna ad essere cittadino.
Nel quadro della visione politica più ampia che abbiamo tratteggiato fin qui, al cittadino del futuro, donna al pari dell’uomo, occorrerà insegnare a diventare uan specie diversa di animale politico, ecologicamente adattato al nuovo ambiente della politica democratica.
Pag. 72
Cap. 3. Colonizzazione e decolonizzazione / David Asheri
Concepita in questi termini, la colonizzazione greca non si presenta certo come un’avventura gloriosa di espansione e di irradiazione culturale in senso unico: si presenta piuttosto come un dramma umano millenario di genti costrette e emigrare, spesso sradicate brutalmente dalla loro patria da forze maggiori – la siccità, la fame, le epidemie, le lotte di fazione, l’ordine di un tiranno, le guerre, le invasioni nemiche.
Dramma esistenziale di emigranti falliti che vengono ricacciati in mare dai loro concittadini rimasti in patria; di genti divelte dalle loro terre in cerca di nuove radici e di una nuova identità, di esuli politici in attesa di rimpatrio, di popolazioni indigene massacrate, estirpate e soggiogate, di donne vedove o orfane costrette a coabitare con conquistatori stranieri, di famiglie e di società miste di lingua, di mentalità, di cultura.
Come tutte le storie coloniali, anche quella greca è prevalentemente una storia di sopraffazioni, di violenze, di assimilazione e di resistenza.
Non è lecito, neanche con le migliori intenzioni, raddolcire questa vicenda per trasformarla in una storia idilliaca di convivenza volontaria e civile fra le genti.
Pag. 74
Pluralità delle cause: la scelta tradizionale fra sovrappopolazione e commercio è troppo riduttiva.
Il fenomeno della emigrazione in massa in età arcaica è un prodotto di quella crisi economico-sociale nella Grecia dell’ottavo e del settimo secolo a. C., che sta anche all’origine di altri fenomeni contemporanei di massima importanza nella storia greca, quali la formazione della polis, la legiferazione scritta, le riforme sociali, giuridiche e militari, le tirannidi.
Ma anche a parte questa elementare generalità, ben poco di sicuro può dirsi sul retroscena concreto dei singoli movimenti migratori, ciascuno dei quali dovette pure avere una sua propria “causa” o pretesto a livello locale e talvolta anche a livello individuale.
Pag. 78
Non pare che le tradizioni metropolitane predisponessero i coloni a programmi precisi: il caso della marinara Taranto colonia della agraria Sparta è emblematico.
La sovrappopolazione come causa di emigrazione e il traffico con gli indigeni come prospettiva in terra coloniale non stanno comunque in contraddizione, ma piuttosto esemplificano nel mondo arcaico il duplice aspetto causale di ogni movimento migratorio umano: la spinta e l’attrazione.
Pag. 79
In tal modo si inaugurava la politica siracusana di “decalciclizzazione” – un esempio antico tra molti di “ripulitura etnica” – ripresa alla fine del quinto secolo da Dionisio il Grande, il quale rieliminò Nasso e Leontini, restaurate dai calcidesi dopo la caduta della tirannide dinomenide, annettendone il territorio a Siracusa, e insediò a Catana e poi ad Aetna-Inessa, un contingente di mercenari campani.
Pag. 94
L’ellenizzazione dei barbari e l’imbarbarimento dei coloni greci non sono altro che le due facce di un unico processo di trasformazione etnico-culturale.
Pag. 99
Se il tema dell’assimilazione e resistenza degli indigeni all’ellenizzazione fa parte della tipica storiografia moderna, il tema dell’assimilazione e resistenza delle colonie greche alla barbarizzazione appartiene alla topica retorica e storiografica antica.
Pag. 100
Nelle aree colonizzate più densamente, l’imbarbarimento della lingua e dei costumi era efficacemente controbilanciato dall’ellenizzazione generale dell’intera zona, e il risultato in queste aree fu lo sviluppo di una koinè culturale livellatrice e integratrice di tutti gli elementi etnici della zona.
L’impatto culturale indigeno è ampiamente documentato nelle aree periferiche, nella lingua, nei costumi, e specialmente nei culti delle colonie: non va trascurato, ma neanche sopravvalutato sproporzionalmente, come facevano talvolta gli antichi per i loro motivi retorici suddetti.
Pag. 101
I greci dell’Ucraina e della Crimea non sono i discendenti degli antichi coloni, e l’origine delle isole linguistiche nelle Puglie e in Calabria è tuttora alquanto discussa.
………………..
Nessuno nega alla colonizzazione greca un posto d’onore nella storia del mondo antico.
Ma furono l’apertura degli orizzonti geografici e gli incontri con alterità culturale a generale nelle aree periferiche situazioni di fermento intellettuale inimmaginabili, in età arcaica, nei cantoni allora chiusi e provinciali dell’Ellade metropolitana.
Si sa che le colonie furono all’avanguardia delle legiferazioni scritte e delle riforme politiche, dell’arte urbanistica, delle scienze e della filosofia, della poesia epica e lirica, della medicina e della retorica.
Il contributo dell’esperienza coloniale greca alla nozione di civiltà, al pensiero utopico, alle riflessioni metastoriche sull’esilio e sull’idea di patria e al pensiero cosmopolitico, è innegabile; ed è pacifico che attraverso l’ellenizzazione di Roma, alla quale parteciparono attivamente le colonie greche d’Occidente nelle sue fasi iniziali, la civiltà coloniale greca giocò un ruolo anche nel lungo processo di trasmissione della cultura ellenica all’Europa medievale e moderna.
Ma tutto ciò non deve obliterare il fatto elementare che, come un organismo sociale, le colonie greche vissero – talvolta secoli, talvolta appena pochi anni – fiorirono, decaddero e sparirono.
Pag. 105
Se l’attuale rinascita in alcuni paesi europei di moti autonomistici regionali possa in futuro produrre un qualche impatto anche sullo spirito degli studi sui rapporti fra indigeni e immigranti nelle aree geografiche del passato storico, è un problema rispetto al quale ci sembra ancora prematuro prendere posizione.
Ma è senz’altro lecito pronosticare, più generalmente, che il modello della colonizzazione greca non cesserà anche in futuro di rinnovarsi continuamente, alla luce di nuove esperienze di contatti umani e di trasformazioni di società e cultura.
Pag. 115
Cap. 4. Città e campagna: l’immagine della “polis” da Omero all’età classica / Alain Schnapp
In Occidente, il rapporto di complementarietà tra spazi urbani e rurali fa parte delle nostre esperienze quotidiane.
Tale rapporto, saldamente radicato nella nostra civiltà dall’alto Medioevo in poi, ha invariabilmente determinato lo sconcerto dei viaggiatori occidentali di fronte alle città arabe o cinesi: esso scoprivano allora che lo spazio urbano poteva essere regolato da altri principi e che il passaggio poteva essere organizzato secondo altri criteri, diversi da quelli che erano loro familiari.
Le città moderne ci hanno fatto smarrire questo senso di contiguità e di complementarietà ancora così vivo negli uomini dei secoli 17. e 18.
Nel 1540, come ricorda Fernand Braudel, un’incursione di corsari algerini poteva cogliere di sorpresa una città che la vendemmia aveva letteralmente svuotato: la stessa tattica venne impiegata da Epaminonda quando ordinò ai suoi cavalieri di sorprendere Mantinea deserta per i lavori di mietitura.
Nei tempi moderni, l’instabilità dei piccoli centri in cui si intrecciano attività rurali e urbane rappresenta un problema amministrativo di particolare rilievo per politici e burocrati.
Esiste, tuttavia, tra le piccole concentrazioni urbane e le metropoli un filo continuo, una relazione stabile che fa sì che una città non sia un villaggio: “di là dai diversi caratteri originali, [le città] parlano tutte un medesimo linguaggio fondamentale: il dialogo ininterrotto con le campagne, prima necessità della vita quotidiana; il rifornimento in uomini, non meno indispensabile dell’acqua alla ruota del mulino; il contegno, la volontà delle città di distinguersi dalle altre; la loro situazione obbligata al centro di reti di collegamenti più o meno lontani…”.
La polis greca è spesso apparsa come l’esempio iniziale di quel modello di sviluppo urbano in cui si confondono città e campagna: Atene, con la sua popolazione rurale che si riversa sul mercato e sull’agorà, ne è l’archetipo.
Essa, infatti, offre allo storico (soprattutto dopo la riforma di Clistene) un quado di integrazione socio-politica tra città e territorio circostante particolarmente complesso per la raffinatezza dei suoi monumenti, dei suoi templi, delle sue piazze, del suo porto.
Basta però volgere lo sguardo verso Sparta – tale paradosso è peraltro tipico della storia greca! – per ritrovare un contraltare modello ateniese: distinzione politica netta tra città e campagna, assenza quasi totale di monumenti, rifiuto di qualsiasi pratica economica.
La città greca, così come è stata pensata e concepita dall’antichità ai giorni nostri, è stata soggetta alle vicissitudini della storia.
Polibio e gli storici romani ne hanno trasmesso un’immagine più simile a quella di una città romana: gremita di cittadini, abbellita dei più diversi monumenti pubblici, fortificata per mezzo di grandi mura e separata dalla campagna.
Così, la città greca ha finito per incarnare un modello architettonico, uan città-simbolo contrapposta alla barbarie dei tempi primitivi.
Quando Sigmund Meisterlin, uno dei primi umanisti tedeschi, colle far rappresentare la nascita della città di Augsburg (Augusta), le diede le sembianze di una città medievale, una via di mezzo tra il fortino del basso impero e i campi trincerati dei signori dell’anno mille: uno spazio edificato, racchiuso da una stecconata in legno che si contrappone alle caverne e alle capanne dei germani primitivi.
Maarten van Heemskerk, invece, proprio in quegli stessi anni (metà del sedicesimo secolo) raffigura una città greca piena di reminiscenze dell’antichità classica: il porto di Rodi è un paesaggio fittizio in cui si alternano edifici vagamente romani, facciate di monumenti a forma d’anfiteatro e torri medievali.
Per avere un’immagine “realista” di Atene con tutte le specificità topografiche del suo paesaggio, bisogna attendere la cosiddetta “pianta dei cappuccini” del diciassettesimo secolo.
E’ solo a partire da questa data che, con il procedere delle esplorazioni in Grecia, si formerà un’immagine di Atene in cui poco alla volta si distinguerà l’architettura romana da quella greca.
A tale riguardo, sono degni di nota i considerevoli sforzi di un viaggiatore del diciassettesimo secolo come Spon, di un antiquario del calibro di Fourmont e le fatiche di Stuart e Revett che culmineranno nelle Antichità di Atene.
Dal Rinascimento in poi, gli antiquari si sono caparbiamente sforzati di liberare la città antica dal suo involucro medievale, per poter infine distinguere la città greca da quella romana, fino a ricostruire, grazie agli studi dei filologi e archeologi tedeschi della metà del diciannovesimo secolo, l’immagine di una città regolare, secondo il modello d’Ippodamo, articolata a scacchiera, e prototipo di una nuova idea di pianificazione urbanistica.
Così, il Leitmotiv della città antica accompagna ininterrottamente i nostri legami con la civiltà greca.
D’altronde, lo si potrebbe seguire, questo “motivo di fondo”, sia sul piano architettonico – come si è appena fatto – che su quello storico.
Gli uomini del Rinascimento, per esempio, hanno concepito una città antica molto più simile a Roma che ad Atene o Sparta, e la città illuministica resta più una città romana che greca.
Ma la riscoperta progressiva della Grecia rappresenta anche l’occasione di un confronto storiografico, vivace già nel diciottesimo secolo per opera di Montesquieu, Rousseau e Helvétius, tra modello spartano e modello ateniese.
Ed è proprio Sparta ad essere preferita dagli illuministi in quanto immagine di una società integrata, di un sistema educativo collettivo, di una costituzione mista, nel contempo monarchica, aristocratica e democratica, là dove Atene sembra più che altro una città in crisi, facile preda di demagoghi e di fazioni.
Il modello spartano, però, non è esente da difetti.
L’ostacolo principale non consisteva tanto nel fatto che Sparta, dal punto di vista architettonico, non presentasse nessuna “visibilità” o identificabilità, quanto nell’essenza, al suo interno, di quei cittadini che gli uomini dei Lumi consideravano alla stregua di colleghi: i filosofi e gli artisti.
Il diciannovesimo secolo, invece, coem ha giustamente dimostrato Pierre VIdal-Naquet, si mostrerà più “ateniese” che “spartano”, e la repubblica dei professori, sempre più numerosi, troverà uan fonte d’ispirazione più stimolante nella storia di Atene che in quella di Sparta: “il ruolo centrale della democrazia ateniese nella storia greca è l’opera del liberalismo borghese della prima metà del diciannovesimo secolo e, nella fattispecie, del radicalismo inglese”.
Con la rivoluzione dell’Altertumswissenschaft [scienza dell’antichità] nel diciannovesimo secolo si è forgiata quell’immagine della città greca da cui siamo ancora fortemente influenzati.
Resta però il fatto che la polis è un’istituzione molto diversa dalla città moderna e che, al pari di quest’ultima, si presta molto male a fornire una tipologia coerente.
Se, insieme agli archeologi e agli urbanisti, si riduce la città all’insieme delle sue funzioni politiche, dei suoi spazi pubblici, delle sue delimitazioni architettoniche come piazze o mura, allora non vi è alcun dubbio (malgrado l’esempio contrario di Sparta) che quello che noi definiamo città affonda in parte le sue radici nella città greca.
Ma le differenze potrebbero superare le affinità.
Mentre, infatti, gli archeologi considerano la città come un modello immodificabile, gli storici (benché divisi in primitivisti e modernisti) si impegnano a mettere in evidenza la specificità della città antica rispetto a quelle medievali e moderne.
Nella città antica, per esempio, il contadino risiedeva nello spazio urbano: proprio il contrario di quel che capita nel Medioevo.
L’industrializzazione, infine, ha eretto tra la città medievale e il mondo moderno una barriera insormontabile.
Anche se la città degli archeologi sembra a volte molto distante da quella degli storici, non bisogna cedere all’illusione della continuità.
I greci si servivano della distinzione città/campagna al nostro stesso modo? O, per l’ennesima volta, quella Grecia antica che ci sembrava così vicina, non è forse molto lontana dalla Grecia che poeti, antiquari e urbanisti hanno spesso proposto alla nostra immaginazione?
Pag. 117-120
E’ improbabile che una cultura, in cui le immagini assolvano una funzione di rilievo sia sui monumenti pubblici che privati e assumano un ruolo centrale nell’elaborazione delle metafore poetiche e filosofiche, possa produrre un sistema iconografico non “orientato”, innocente.
Purtroppo, la pittura greca non ci è pervenuta.
Per ricostruire l’universo iconico della città, è necessario ricorrere alle raffigurazioni vascolari.
Non ci sarà mai possibile stabilire quale posto occupassero concretamente, nella gerarchia delle arti figurative, i creatori di immagini e i vasai dell’antica Grecia.
Ma, per quanto esile sia stata la loro influenza sulla grande arte, per quanto povero sia stato il loro contributo inventivo, essi partecipano dello stesso gusto estetico, dello stesso patrimonio figurativo comune a pittori e scultori.
I motivi iconografici dei vasi non sono dunque un riflesso inconsapevole della città, la conseguenza meccanica di un bisogno di immagini diffuso in vasti domini della vita pubblica e privata.
In uno dei pochi studi dedicati all’interpretazione generale delle figure vascolari, J. Thimme ne fa la seguente descrizione: “le immagini dei vasi greci, nella fattispecie quelle attiche, sono concentrate e condensate. Esse sono ricavate da temi che, a un primo sguardo, riescono di difficile interpretazione e, in generale, il loro contenuto figurativo, intendo dire il loro soggetto iconologico, si esprime in maniera abbreviata”.
Pag. 129
Cap. 5. La costruzione dell’”altro” / Wilfried Nippel
Nei gruppi etnici, la percezione della propria identità si accompagna per lo più alla delimitazione rispetto a un mondo esterno sentito come totalmente diverso da sé.
Come notava già Platone, l’idea che questo mondo esterno sia unitario deriva semplicemente dal fatto che esso differisce, in misura di volta in volta diversa, dagli standard abituali; a ciò, proprio nei grandi regni con solide strutture statali, è collegata la tendenza a ritenere il proprio ordinamento l’unico adeguato: basti citare la visione cinese degli stranieri o il modo in cui gli egizi comprendevano se stessi, riconoscendo il loro come regno dell’ordine nella contrapposizione a un mondo circostante estraneo e caratterizzato dal caos.
Gruppi etnici meno potenti possono a loro volta sviluppare un sentimento di affinità sotto la spinta di una minaccia esterna.
Né l’una né l’altra possibilità di contatti tanto con società altamente evolute quanto con società “primitive” di vario genere, essi erano predisposti a percepire in maniera differenziata il mondo esterno circostante.
Fu solo in seguito a sviluppi politici contingenti che anche presso di loro si svilupparono delle prospettive etnocentriche e degli stereotipi di percezione dell’estraneità; i greci elaborarono, ad uso dell’intera storia europea successiva, sia i modelli di un’analisi delle culture straniere che tendesse all’oggettività, sia i topoi per caratterizzare tali culture (impiegabili a piacimento per numerosissimi tipi di società).
Pag. 165
Il criterio di distinzione migliore rimaneva la lingua: in origine il concetto di barbaro si riferiva a coloro che non parlavano greco, senza che ciò fosse necessariamente connesso a un senso di superiorità
Pag. 168
Cap. 6. Mito / Carlo Ginzburg
Continuità di parole non significa necessariamente continuità di significati.
Ciò che chiamiamo “filosofia” è ancora, nonostante tutto, la “filosofia” dei greci; la nostra “economia” – sia la disciplina sia il suo oggetto – e l’”economia” dei greci hanno invece poco o niente in comune.
Di “mito” parliamo spesso, sia in senso generico sia in senso specifico: “i miti delle nuove generazioni”, “i miti della popolazioni dell’Amazzonia”.
Senza esitare applichiamo il termine “mito” a fenomeni lontanissimi nel tempo e nello spazio.
Si tratta di una manifestazione di superbia etnocentrica?
Questa domanda è stata formulata in maniera ora più ora meno implicita nell’ambito di un’intensa discussione sui miti greci e sulla nozione greca di mito (due temi connessi ma non identici) cominciata all’inizio del decennio scorso.
La possibilità d’identificare una classe specifica di racconti denominati “miti” è stata messa in dubbio.
I miti, si è sostenuto, non esistevano: è esistita la mitologia, un discorso aggressivo condotto in nome della ragione contro un indeterminato sapere tradizionale.
Questa conclusione, in sé più che discutibile, ha però un merito: quello di riportare l’attenzione sulla condanna del mito formulata da Platone.
Vale la pena di riesaminarla ancora una volta.
Pag. 197
L’anno prima un grande industriale scozzese J. A. Richmond, aveva osservato in una relazione alla Glasgow University Engineering Society, di cui era presidente, che “l’incursione nei poteri gestionali nelle fabbriche era diventata tale che, se non ci fosse stata la guerra, l’autunno 1914 avrebbe visto un disordine industriale di prima grandezza.
La guerra segnò una svolta irreversibile nell’organizzazione della società, su tutti i piani – compreso quello dell’organizzazione del consenso.
Le tecniche di propaganda adottate nei confronti del fronte interno e delle truppe, dei nemici e degli alleati, non smobilitarono in tempo di pace.
Il sangue si aggiunse al suolo, le invocazioni alla mitica comunità originaria assunsero toni razzisti.
“Intravedo la possibilità di neutralizzare la stampa per mezzo della stampa stessa. Poiché il giornalismo è una forza così potente, il mio governo diventerebbe giornalista. Sarebbe il giornalismo incarnato…”, aveva detto il machiavelli di Joly, rivolgendosi a Montesquieu.
Il ventesimo secolo doveva realizzare questa profezia.
Tra i materiali del grandioso progetto di Walter Benjamin su Parigi, destinato a rimanere incompiuto, troviamo questo passo:
“Un giorno un osservatore perspicace ha detto che l’Italia fascista era diretta come un grande giornale, nonché da un grande giornalista: un’idea al giorno, dei concorsi, delle sensazioni, un abile e insistente orientamento del lettore verso alcuni aspetti della vita sociale smisuratamente ingranditi, uan deformazione sistematica della comprensione del lettore per determinati scopi pratici.
Insomma, i regimi fascisti sono regimi pubblicitari”.
Cap. 7. Modi di comunicazione con il divino: la preghiera, la divinazione e il sacrificio nella civiltà greca
Se nel campo filosofico e politico la civiltà della Grecia antica continua a esercitare una forte influenza sulla nostra, diverso è il caso della religione.
Che si sia credenti o meno, la civiltà occidentale è improntata al cristianesimo, religione che si sviluppò a partire dal giudaismo.
E sebbene il cristianesimo si sia presto adattato al mondo greco-romano, l’attrazione di “quella gloria che fu la Grecia” non esercitò una grande influenza.
La verità di questa considerazione diventa ancor più evidente se si osservano da vicino i principali modi di comunicazione con il divino impiegati dai greci: mi riferisco alla preghiera, alla divinazione e al sacrificio.
Per quanto riguarda la preghiera, che, per comune ammissione, è una parte integrante del cristianesimo, essa affonda le sue radici nelle pratiche ebraiche, e non al di fuori dell’ambito strettamente religioso; e il sacrificio non ha mai fatto parte delle norme rituali cristiane: in Europa sopravvisse solo nelle aree periferiche, come nel Galles, nel territorio dei Careli ai confini tra la Finlandia e la Russia e nella Tracia greca.
Per quanto riguarda il modo in cui i greci pregavano la divinazione, l’argomento non è mai riuscito ad interessare l’uomo contemporaneo, a parte, forse, i turisti di Delfi.
Il sacrificio greco antico, invece, ha attratto un numero sempre crescente di studiosi.
Non è dunque un caso che le pubblicazioni più importanti in questo campo abbiano cominciato ad apparire agli inizi degli anni ’70, dopo la guerra del Vietnam: la violenza del presente incitava a occuparsi della violenza del passato.
Per questa ragione, ho deciso di concentrare la mia attenzione sul tema del sacrificio, anche se esso ci dice molte più cose sui greci che su di noi.
Un’analisi delle pratiche e delle ideologie del sacrificio contribuirà a offrirci un’immagine della civiltà greca che differisce notevolmente dall’oleogramma idealizzato che gli storici dell’Ottocento e degli inizi del nostro secolo ci hanno tramandato.
Così, nel dominio della religione, le differenze tra “loro” e “noi” sono più significative di quanto non si pensi.
Inizieremo, però, con qualche considerazione sulla preghiera e sulla divinazione.
Pag. 239-40
Se, per i greci, lo scopo principale dei sacrifici era comunicare con le divinità, il carattere “primitivo” di tale comunicazione è ancora difficile da accettare per gli interpreti moderni.
Per Meuli il sacrificio altro non era che un’uccisione rituale; per Burkert la partecipazione comune all’uccisione rituale aveva portato alla nascita della comunità; per Vernant, invece, il sacrificio era fondamentalmente concepito in funzione del nutrimento.
Quel che colpisce in queste esegesi moderne è l’approccio prevalentemente “secolare”, riduzionistico, che non tiene praticamente conto dei fini esplicitamente dichiarati dai greci stessi e cerca id ridurre il sacrificio a una formula univoca e chiara.
Certo, il sacrificio era un’uccisione rituale, rinforzava il senso di comunità e si effettuava per mangiare.
Ma, ed è questo l’oggetto della nostra dimostrazione, è anche vero che il sacrificio è molto più di questo.
E’ anche, per esempio, un’occasione per ostentare la propria forza fisica, i propri privilegi sociali, per partecipare a un pasto festivo, per mostrare i confini del gruppo e, innanzitutto, per mettersi in contatto con gli dèi.
Un atto rituale che occupi un ruolo centrale nella comunità non può non avere significati economici, politici, sociali, culturali, oltre quelli prettamente religiosi.
Una delle principali sfide per chi cerchi in futuro di esaminare da vicino il rito sacrificale nella Grecia antica sarà quella di dimostrare la ricchezza e la complessità di tutti questi significati, senza cadere nella tentazione di ridurre il fenomeno a una formula semplice, per quanto seducente possa essere.
Pag. 281
Nella concezione greca, la comunicazione con il divino non obbediva agli stessi nostri principi.
Per quanto riguarda la preghiera, la divinazione e il sacrificio, tale differenza dipende da diverse circostanze.
Innanzitutto, il cristianesimo aveva spinto la distinzione tra Dio e i credenti al punto che questi ultimi erano addirittura chiamati “schiavi di Dio”, sia nel Nuovo Testamento che nella prima letteratura cristiana.
Questa posizione di assoggettamento era in contrasto con l’attitudine greca, affabile ma cosciente di sé, nei confronti degli dèi.
Inoltre, anche se molti abitanti del Vecchio e del Nuovo Mondo consultano veggenti e leggono gli oroscopi, la divinazione non occupa più il posto ufficiale nella vita pubblica e non viene ritenuta affidabile dagli individui per così dire più illuminati.
La società moderna è infatti riuscita a eliminare molte delle incertezza del mondo antico.
D’altronde, gli stati moderni non hanno bisogno degli dèi nei casi di disaccordi troppo aspri e hanno trovato altri modi di risolvere le tensioni, per esempio attraverso l’istituzione di comitati o il ricorso ad arbitrati.
Infine, sebbene l’agricoltura fosse già praticata da millenni nell’area del Mediterraneo, l’eredità della cultura dei cacciatori era ancora abbastanza forte da influenzare le pratiche sacrificali greche che, a loro volta, erano state la conseguenza di un processo di domesticazione degli animali pienamente riuscito.
E’ impossibile in un solo saggio scandagliare in profondità i modi in cui i greci comunicavano con le divinità.
Ci siamo concentrati sul sacrificio in quanto aspetto estraneo alla religione moderna.
Ci siamo concentrati sul sacrificio in quanto aspetto estraneo alla religione moderna.
Ma anche la preghiera e la divinazione sembra fossero impiegate diversamente da noi: la religione greca, infatti, differiva dalla nostra molto più di quanto noi, moderni miratori dell’antichità, forse crediamo.
Pag. 282-83
Cap. 8. La dimostrazione / Luis Vega Renòn
Cap. 9. L’invenzione della natura / Patrice Loraux
Cap. 10. Il bello e il naturale: un racconto letale / Martin Warnke
Cap. 11. Eros / Froma I. Zeitlin
Il mito narrato da Socrate contribuisce a rendere ancora più ambigua la sessualità nell’immaginario greco, che, come abbiamo potuto constatare, esita costantemente, ancorché in forme diverse, tra potere e limitazione, aspirazione e ripiegamento, pienezza e perdita, realtà e mito; in definitiva, tra mortalità e immortalità.
Poiché Eros è sostanzialmente un attributo specifico del nostro essere creature, la nostra sottomissione ai bisogni fisici umani e agli impulsi che ci rendono simili agli animali, può venir utilizzato, come per esempio nel Simposio platonico, come strumento per superare questo stato di bisogno, attingere le vette del bene e negare il nostro stato di mortalità, che in definitiva è ciò che maggiormente temiamo.
Con l’eccezione degli studiosi delle pratiche sociali dei greci e dei teorici del desiderio omoerotico, c’è oggi la tendenza a estrapolare il messaggio idealizzante di Platone ignorando le implicazioni del quadro pederastico in cui si inserisce e la sua univoca concentrazione sulla soggettività maschile, sia in ambito erotico sia filosofico.
Come ho già accennato, il Simposio si è recentemente rivelato di una certa utilità per chi, facendo leva sul prestigio di tale modello, se n’è servito a giustificazione e fondamento di un’ideologia romantica, , di un ideale androgino, o di una ben definita identità sessuale.
Ogni epoca è condizionata da prospettive che finiscono per determinarne le strategie interpretative orientandole a fini autogiustificativi.
I misteri dell’infatuazione sessuale continuano a sfuggire al rigore dell’indagine scientifica.
Con tutte le nostre tecniche sofisticate in campo psicologico e biologico non abbiamo fatto molti progressi verso la comprensione del perché gli esseri umani s’innamorano, né di ciò che li spinge a perseguire l’oggetto del desiderio con tanta ostinazione e insistenza.
Al pari ei greci (o forse proprio a causa dei greci), non sappiamo immaginare una forza superiore a quella della passione amorosa.
Pur essendo un po’ più consapevoli della complessità delle nostre motivazioni, continuiamo a sperimentare l’eros come mescolanza di piacere, timore e stupore.
Sebbene si conferisca maggiore importanza alla soddisfazione erotica quale elemento essenziale della realizzazione personale, continuiamo a percepire il primo impatto dell’eros come qualcosa che sfugge al nostro controllo.
Le divinità pagane sono tramontate; ma nel nostro mondo attuale, desacralizzato e privatizzato, Eros, in quando forza del desiderio imperitura e irresistibile, continua ad essere più o meno lo stesso dio di sempre.
Pag. 429-30
Cap. 12. L’io, l’anima, il soggetto / Mario Vegetti
Cap. 13. La tragedia e il tragico / Diego Lanza
Aristotele offre una definizione della tragedia e un modello della migliore tragedia.
I due livelli sono stati spesso confusi nella tradizione che ha volta a volta interpretato come prescrittivo tutto ciò che è detto nella Poetica o, al contrario, ha scambiato i segmenti precettistici per una descrizione fenomenologica della tragedia del quinto secolo.
Tragedia è, com’è noto, per Aristotele, l’imitazione di un’azione seria che, operando attraverso pietà e paura, perviene a un effetto di purificazione.
Questa la definizione.
Ma come dev’essere questa azione per sortire al meglio tale effetto?
E’ a questa domanda che tenta di rispondere uan parte consistente della Poetica: la miglior tragedia è senza dubbio quella che realizza con maggiore efficacia il piacere proprio del genere, che è appunto l’effetto di cui si è appena detto.
Pag. 494-95
Cap. 14. L’agonismo sportivo / Henri Willy Pleket
Quale significato possono assumere per noi la pratica e la mentalità agonistica greca?
La domanda rientra naturalmente in una problematica assai più ampia, ossi a quella attinente la rilevanza del passato preindustriale, nel suo complesso rispetto al mondo contemporaneo, tardocapitalistico, che si avvia, se già non si trova, a vivere la seconda rivoluzione industriale, o elettronica.
In linea generale ritengo che questa rilevanza sia piuttosto scarsa, tuttavia credo che il passato preindustriale possa avere un certo interesse per l’uomo contemporaneo.
Le strutture sociali ed economiche di tale passato, ivi compresa la sua variante greco-romano, differiscono radicalmente da quelle del mondo contemporaneo.
Per quanto riguarda in particolare il mondo antico, ciò appare ancor più vero in quanto la storiografia contemporanea segue in gran parte la via aperta da M. I. Finley e dalla sua “scuola primitivistica”, che ribadisce in primo luogo la totale alterità della società antica rispetto alla società medievale e di ancien regime, per non parlare del mondo attuale.
Ne deriva che l’antichità greca non rientra nel dibattito relativo all’origine della società capitalistica moderna.
Il dato basilare del punti di vista dei “primitivisti” è che (tardo) Medioevo e ancien regime differiscono profondamente dall’antichità; inoltre, sulla scia di Max Weber, essi fanno un passo ulteriore e affermano che nascita e sviluppo della società capitalistica occidentale vanno collocate in questi due periodi.
Molti storici del Medioevo e degli inizi dell’età moderna sono sostanzialmente d’accordo con questa concezione weberiana, sebbene permanga un ampio dibattito in merito all’individuazione del motore che di fatto spinse l’Europa sui binari dell’era industriale.
Pag. 533
Cap. 15. Schiavitù e lavoro / Ellen Meiksins Wood
I greci non inventarono la schiavitù; furono invece, in un certo senso, gli inventori del lavoro libero.
Sebbene la schiavitù-merce si sia sviluppata nella Grecia classica, e in particolare ad Atene, fino ad assumere proporzioni prive di precedenti, il principio del lavoro dipendente ovvero la relazione padrone/schiavo non rappresentavano in alcun modo una novità nel mondo antico.
Quel che per contro rappresentava senza dubbio una formazione particolare e segnalava uan relazione priva di paralleli tra classi produttrici e classi “appropriatrici” era il lavoratore libero provvisto dello statuto che la cittadinanza gli conferiva e, specificamente, il “cittadino-agricoltore”, insieme con la libertà giuridico-politica implicita in questa condizione e la liberazione delle varie forme di sfruttamento esercitato tramite uan coercizione diretta dai proprietari terrieri o dagli Stati.
Questa formazione peculiare occupa un posto centrale nel quadro di molti altri aspetti della specificità della polis greca e in modo particolare della democrazia ateniese.
Si stenterebbe a individuare uno sviluppo politico o culturale ateniese che non ne sia in un modo o nell’altro influenzato, dai conflitti tra democratici e oligarchici nel quadro dello svolgimento della vita politica democratica fino ai classici della filosofia greca.
La tradizioni politiche e culturali dell’antichità classica pervenute sino a noi, pertanto, sono permeate dell’atteggiamento mentale del cittadino lavoratore e insieme dell’animosità antidemocratica che questi ispirava e che informava gli scritti dei grandi filosofi.
Lo statuto del lavoro nel mondo occidentale moderno, tanto nella teoria quanto nella pratica, non può essere interpretato in modo esauriente senza farne risalire la storia all’antichità greco-romana e alla peculiare struttura dei rapporti tra classi produttrici e classi appropriatrici nella città-stato greco-romana.
Al tempo stesso, se lo statuto sociale e culturale del lavoro nell’Occidente moderno può discendere dall’antichità classica, noi dobbiamo altrettanto da apprendere dalla radicale cesura che sotto questo profilo separa il capitalismo moderno dalla democrazia ateniese.
Questo è vero non solo nel senso ovvio che la schiavitù-merce, dopo che assunse nuovamente un ruolo preminente nella nascita del capitalismo moderno, è stata soppiantata, ma anche nel senso che il lavoro libero, nel momento in cui è divenuto al forma dominante, ha anche perduto gran parte dello statuto politico e culturale di cui godeva nella democrazia greca.
Questa tesi non contraddice solo le opinioni correnti, ma anche i convincimenti degli studiosi.
Il punto essenziale non sta tanto nel fatto che qualcosa di profondamente contrario a quanto comunemente si sarebbe portati a credere è insito nell’asserire che l’evoluzione dalle antiche società schiavistiche al moderno capitalismo liberale è stata contraddistinta anche da un declino dello statuto del lavoro.
Vi è anche la circostanza che al lavoro libero non si è mai iscritta l’importanza storica che si è caratteristicamente attribuita alla schiavitù nel mondo antico.
Se mai gli storici dell’antichità classica si rivolgono al problema del lavoro e dei suoi effetti culturali, essi in genere privilegiano la schiavitù.
La schiavitù, si sostiene spesso, fu responsabile dalla stagnazione tecnologica nella Grecia antica e a Roma.
L’associazione del lavoro alla schiavitù, così si argomenta, provocò un generalizzato disprezzo per il lavoro nella cultura della Grecia antica.
La schiavitù nel breve periodo rafforzò la stabilità della polis democratica, favorendo l’unione dei cittadini poveri e dei ricchi, mentre nel lungo periodo provocò il declino dell’Impero romano – vuoi con la sua presenza (nel senso che fu di ostacolo allo sviluppo delle forze produttrici), vuoi per la sua assenza (in quanto un declino della disponibilità degli schiavi impose sforzi intollerabili allo stato imperiale romano).
E così via.
Nessun effetto determinante di questo genere è invece comunemente ascritto al lavoro libero.
Nelle pagine che seguono si tenterà di ristabilire in qualche modo l’equilibrio e di prendere in considerazione le indicazioni che una differente percezione del lavoro nell’antichità può fornirci a proposito del corrispettivo moderno del medesimo.
Pag. 611-12
La liberazione dei contadini dell’Attica dalle forme tradizionali di dipendenza incoraggiò lo sviluppo della schiavitù, in quanto precluse altre forme di lavoro non libero.
In questo senso, democrazia e schiavitù ad Atene erano inestricabilmente connesse.
Ma questa dialettica di libertà e schiavitù, la quale conferisce al lavoro libero una posizione centrale nell’ambito della produzione materiale, suggerisce qualcosa di diverso dalla semplice affermazione che la democrazia ateniese era fondata sulla base materiale rappresentata dalla schiavitù.
E se riconosciamo che la libertà del lavoro libero rappresentava, in misura non minore dell’asservimento degli schiavi, una caratteristica essenziale, e forse la più distintiva, della società ateniese, allora dobbiamo necessariamente prendere in considerazione il modo in cui tale caratteristica aiuta a rendere conto di molte altre peculiarità della vita economico-sociale, politica e culturale della democrazia.
Pag. 616
Molti secoli dopo, quando la schiavitù-merce assunse un ruolo di spicco nelle economie occidentali, essa si trovò inserita in un contesto molto diverso.
La schiavitù delle piantagioni nel Sud americano, ad esempio, non faceva parte di un’economia agraria dominata da contadini produttori, bensì apparteneva a un’agricoltura commerciale su vasta scala inserita in un sistema di scambio che andava assumendo dimensioni sempre più internazionali.
La principale forza propulsiva al centro dell’economia capitalistica mondiale non era il nesso padrone/schiavo, né quello proprietario terriero / schiavo, bensì il nesso capitale/lavoro.
Il lavoro salariato libero stava diventando la forma dominante in un sistema di relazioni proprietarie.
Pag. 617
Gli storici sono in genere d’accordo sul fatto che la maggior parte dei cittadini ateniesi lavorava per vivere.
Certo, dopo aver posto il cittadino lavoratore fianco a fianco dello schiavo nell’ambito della vita produttiva della democrazia, non hanno compiuto molti sforzi per esplorare le implicazioni di questa formazione sociale unica, di questo lavoratore che era libero in singolare misura e del suo statuto politico privo di precedenti.
Nei casi in cui viene compiuto almeno qualche tentativo allo scopo di porre in relazione le basi materiali della società ateniese, con la sua politica e la sua cultura (e la tendenza dominante è ancora quella di separare la storia politica e intellettuale da qualsivoglia radice sociale), è la schiavitù che occupa la scena centrale come singolo fattore assolutamente determinante.
Pag. 619
Non è solo la filosofia politica occidentale che deve le sue origini a questo conflitto circa il ruolo politico di calzolai e fabbri.
Per Platone la separazione tra detentori del potere e lavoratori, tra quanti lavorano con la mente e quanti usano il proprio corpo, tra coloro che sono al potere e vengono mantenuti e coloro che producono il cibo e sono governati non è semplicemente il principio basilare della democrazia.
La divisione del lavoro tra detentori del potere e produttori, che è l’essenza della giustizia nella Repubblica, è anche l’essenza della teoria platonica della conoscenza.
La radicale opposizione gerarchica tra mondo sensibile e mondo intellegibile e tra le corrispondenti forme di conoscenza – un’opposizione nella quale si è riconosciuto il tratto più caratteristico del pensiero greco e che da allora ha fissato l’ordine del giorno della riflessione filosofica occidentale – è radicata da Platone in una analogia con la divisione sociale del lavoro che esclude i produttori dalla politica.
L’eclissi del lavoro libero.
Lo squilibrio tra l’importanza storica del lavoro libero nell’antica Grecia e la scarsa considerazione di cui ha goduto nella storiografia moderna è così grande che è indispensabile dire qualcosa circa il modo in cui tale squilibrio si è ingenerato e il cittadino lavoratore, nonostante tutta la sua peculiarità storica, è per così dire svanito nell’ombra proiettata dalla schiavitù.
Non che, ancora una volta, gli storici abbiano mancato di riconoscere che il corpo civico nell’Atene democratica era composto in larga parte di persone che lavoravano per vivere.
Piuttosto, si tratta del fatto che a questa consapevolezza non si è unito uno sforzo proporzionale colto a esplorare il significato storico di questa circostanza degna di nota.
Il lavoro libero è stato pressoché oscurato dalla schiavitù quale fattore determinante dello sviluppo storico, e non solo per l’ammirevole ragione che gli orrori di quella perversa istituzione hanno destato preoccupazione nei nostri istinti migliori.
Pag. 626
I rapporti sociali di proprietà che mettono in opera questo meccanismo propulsore hanno collocato il lavoro in una posizione unica dal punto di vista storico.
Nel capitalismo il lavoratore salariato nullatenente, che soggiace a imperativi economici non direttamente dipendenti da una condizione di subordinazione giuridica o politica, può godere di libertà giuridica e di uguaglianza e addirittura di pieni diritti politici in un sistema a suffragio universale, senza privare con ciò il capitale del suo potere di appropriazione.
E’ in questo che possiamo ravvisare la più grande differenza tra lo statuto del lavoro nell’antica democrazia ateniese e nel moderno capitalismo.
Il lavoro, la democrazia antica, la democrazia moderna
Nella democrazia capitalistica moderna disuguaglianza socio-economica e sfruttamento coesistono con la libertà civica e l’uguaglianza.
I produttori primari non sono dipendenti sul piano giuridico, né privi dei diritti politici.
Anche nella democrazia antica l’identità civica era distinta dallo status socio-economico, e anche in questo caso l’uguaglianza politica coesisteva con la disuguaglianza di classe.
Una differenza fondamentale però rimane.
Nella società capitalistica i produttori primari sono assoggettati a forme di costrizione di natura economica che non dipendono dal loro status politico.
Il potere del capitalista di appropriarsi del surplus di lavoro dei salariati non dipende da uno status sociale o giuridico privilegiato, bensì dal fatto che il lavoratori sono nullatenenti, il che li costringe a cedere la propria forza-lavoro in cambio di un salario, al fine di accedere ai mezzi di lavoro e di sussistenza.
I lavoratori sono assoggettati tanto al potere del capitale quanto agli imperativi della competizione e della massimizzazione del profitto.
Così, la separazione di status civile e collocazione di classe nelle società capitalistiche ha due facce: da un lato, il diritto di cittadinanza non è determinato dalla posizione socio-economica – e in questo senso il capitalismo può convivere con la democrazia formale; dall’altro l’uguaglianza civile non ha un’influenza diretta sulla disuguaglianza di classe e la democrazia formale lascia fondamentalmente intanto lo sfruttamento di classe.
Viceversa, nella democrazia antica esisteva una classe di produttori primari che erano liberi sul piano giuridico e politicamente privilegiati, nonché in ampia misura esenti, al tempo stesso, dalla necessità di mettersi sul mercato per assicurarsi l’accesso alle condizioni di lavoro e di sussistenza.
La loro libertà civile, a differenza di quella del moderno lavoratore salariato, non era controbilanciata dalle costrizioni economiche del capitalismo.
Come nel capitalismo, il diritto di cittadinanza non era determinato dallo status socio-economico, ma, a differenza che nel capitalismo, i rapporti tra le classi erano influenzati direttamente e profondamente dallo statuto civico.
L’esempio più ovvio è la divisione in schiavi e cittadini.
Ma la cittadinanza determinava direttamente le relazioni economiche anche in altre maniere.
Pag. 633-34
Il raggiungimento della democrazia formale e del suffragio universale senza dubbio significò un processo storico enorme, ma accadde che il capitalismo offrì una nuova soluzione al vecchio problema dei detentori del potere e dei produttori.
Ora che la democrazia poteva essere riservata a una sfera politica formalmente separata, laddove l’economia seguiva regole proprie, non era più necessario concretizzare la divisione di privilegio e lavoro in una separazione politica tra detentori del potere protagonisti dell’appropriazione economica e subordinati costretti a lavorare.
Se l’estensione del corpo civico non poteva più ormai essere sottoposta a restrizioni, il campo d’azione del ruolo di cittadino poteva ora essere rigidamente contenuto, anche a prescindere da limitazioni costituzionali.
Il contrasto tra lo statuto del lavoro nella democrazia antica e il capitalismo moderno suscita alcuni interrogativi di ampia portata: in un sistema nel quale il potere puramente economico ha sostituito il privilegio politico, quel è il senso della condizione di cittadino?
Di cosa avrebbe bisogno perché in un contesto molto differente venga ricuperato il rilievo preminente che nella democrazia antica avevano la condizione di cittadino e quella del lavoratore provvisto di diritti civici?
Pag. 635-36
Cap. 15. La trasmissione del sapere / Luciano Canfora
Cap. 16. L’ordine dorico come diapason dell’architettura moderna / Kurt W. Forster
Cap. 17. Il classico nella cultura postmoderna / Lambert Schneider
Cap. 18. La storia del pensiero / Maria Michela Sassi
Cap. 19. Il medico e la malattia / Jackie Pigeaud
Siamo giunti ad un punto molto interessante.
E’ una situazione nuova, quella della possibilità e della banalizzazione del trapianto di organi.
Non stupisce però molto lo storico, che tiene in giusto conto l’immaginario; si può scrivere la storia di ciò che potremmo chiamare “l’estetica del trapianto”, con le sue inibizioni, i suoi tabù, i suoi fantasmi, quelli stessi che si ritrovano già negli antichi.
All’epoca dei dibattiti sulla trasfusione sanguigna, nel 17. e 18. secolo, si fecero paragoni col trapianto, per poi concludere che non si tratta della stessa cosa.
Ma non è questa, a mio modo di vedere, la cosa più interessante.
Il medico contemporaneo, posto di fronte alle proprie responsabilità d’ordine pratico ed etico, come i sui predecessori, afferma la separazione della medicina da ciò che potremmo definire filosofia, costituendo così la specificità della medicina e i suoi limiti epistemologici; è indispensabile ridefinire il campo della medicina.
Non so se ciò possa essere d’aiuto per il medico moderno.
Ma lo storico non deve trascurare di sottolineare al tempo stesso la novità e la tradizione; a ciò corrisponde precisamente la sua funzione.
La storia deve essere capace di render conto dei luoghi comuni della medicina.
Un luogo comune non è un’idea generale.
I luoghi comuni, in retorica, sono le condizioni di possibilità accettate, legittimate, del discorso.
Si può, di volta in volta, renderne conto.
E’ impensabile, perlomeno per quanto riguarda la storia della medicina, separare ciò che costituirebbe una “storia della medicina” dalla filosofia, nella misura in cui, come ho cercato di dimostrare, la questione della rottura tra medicina e filosofia è una questione costitutiva del pensiero medico.
Pag. 814
Cap. 20. Il filosofo / Giuseppe Cambiano
In parallelo a queste tematiche, ma in un modo non sempre agevole da ricostruire, si è sviluppata la tesi secondo cui tutti gli uomini sono filosofi.
SI può ricordare che nella filosofia italiana del Novecento essa ricompare in Benedetto Croce, per il quale i tentativi moderni di rinnovare la figura “già sublime, del filosofo beato nell’Assoluto”, il quale si pone superiore agli altri o a se stesso quando non è ancora filosofo, si tingono inevitabilmente di comico e si manifestano come illusioni impossibili.
All’immagine del purus philosophus Croce oppone l’idea di una filosofia presente e operante in tutte le discipline che studiano l’uomo nella sua specificità storica.
Il filosofo storico, secondo Croce, “si sente ineluttabilmente preso nel corso della storia” e perciò è condotto ad accettare la vita qual è, un misto di gioie e dolori, di pensiero e azione.
La conclusione è che filosofo è ogni uomo e ogni filosofo è uomo.
Quest’idea crociana è ripresa da Gramsci, che assume però il termine “filosofia” nel significato che Croce attribuisce a “religione”, ossia come “una concezione del mondo che sia diventata norma di vita”, non libresca, ma attuata nella vita pratica.
Ritorna, dunque, in Gramsci la saldatura tra vita e dottrina, ma attraverso una generalizzazione della nozione di filosofo.
La differenza tra filosofia in questo significato ampio e filosofia in senso “professionale” diventa allora puramente quantitativa, non qualitativa: la filosofia professionale è data dai tentativi “per mutare, correggere, perfezionare le concezioni del mondo esistenti in ogni determinata epoca e per mutare quindi le relative misure di condotta, ossia per mutare la attività pratica nel suo complesso”.
E’ inutile sottolineare come ciò si differenzi dalle pretese dei filosofi antichi di stabilire uan differenza qualitativa radicale tra il loro modo di vita e quello dei più: la filosofia non è un tipo di vita che tutti siano per natura in grado di condurre, essa riguarda soltanto gli esemplari pienamente riusciti del genere umano, i quali sono inevitabilmente pochi.
In questo senso la vita filosofica non è universalizzabile di fatto e ne restano esclusi non soltanto gli schiavi, ma buona parte degli stessi cittadini liberi.
Pag. 841
Cap. 21. Poeta, saggio, sofista, filosofo: l’intellettuale nella Grecia antica / Carles Miralles
Attraverso testi verosimilmente fissati per iscritto più tardi, e spesso frammentari, senza sicurezza riguardo al pubblico né all’occasione cui erano destinati, noi possiamo dedurre che questa situazione del poeta, l’operatore culturale per antonomasia dell’epoca arcaica, preesisteva alla fissazione per iscritto, a meno che non ci fosse stata un’interruzione nelle diverse tradizioni poetiche.
Ma non abbiamo modo di calcolare con certezza né la possibilità né la portata di rotture innovatrici, di invenzioni e di cambiamenti importanti nelle origini.
Tutto sembra esserci arrivato molto consolidato.
Allora, o questo significa che le generazioni posteriori che ci hanno trasmesso i testi che ci rimangono vi erano intervenute in profondità, oppure deve essere indizio di continuità culturale.
Il poeta – i poeti – che troviamo all’inizio di ciò che noi chiamiamo “letteratura” greca è un professionista specializzato, che dispone, grazie al proprio sapere, di un luogo istituzionalizzato per intervenire nello scambio di doni e di onore che fanno il prestigio degli uomini dell’epoca.
Pag. 864
Toccato da un dono divino, il poeta è un uomo eccezionale, che non è mai esattamente come gli altri: come xeinos non è né forestiero, ad esempio, e nemmeno da morto sarà come gli altri.
L’immagine che i greci hanno costruito dei loro poeti più antichi ci permette di visualizzarli fra terra e cielo – foss’anche solo perché Platone ebbe più tardi la trovata di vederli come “un essere leggero, alato e sacro”.
Il senso, però, è del tutto diverso da quello dello scherzo di Voltaire sui lettrés: il poeta greco, anche se a volte sommamente indifeso fra gli uomini e persino ingiustamente maltrattato da loro, ha in compenso un dono divino.
E ha scoperto l’antidoto contro la mancanza di difesa nella necessità che di lui hanno queste comunità di greci che non lo considerano né uno di loro né un estraneo.
Da quando per noi ha inizio la cultura greca, il poeta ha convertito il dono degli dèi in mestiere umano; la poesia, se ancora conserverà per Platone la pericolosa caratteristica di cosa ispirata, incontrollabile e inquietante, arriverà ad essere, fra i greci, un’arte, una tecnica.
Il poeta greco non è, in epoca arcaica, un derelitto fra cielo e terra: ha colonizzato lo spazio fra gli dèi e gli uomini e ci vive sicuro, con il consenso degli dèi e mantenuto e onorato dagli uomini.
Pag. 865
Certo che ci fu poesia nell’epoca ellenistica, e molta.
Ma il poeta non era più l’operatore culturale per antonomasia.
Non si guadagnava da vivere facendo il poeta, ma doveva guadagnarselo facendo il maestro di scuola o il bibliotecario o l’animatore culturale al servizio di qualche potente – pochi, con più fortuna, persino nel palazzo di qualcuno dei monarchi dell’epoca.
Pag. 866
Cap. 22. L’utopia e i greci / Alfonso M. Iacono
Mumford evidenzia qui assai bene un aspetto importante dell’utopia: il suo riflettere e, nello stesso tempo, il suo annunciare uan dimensione della storia dove c’è posto per l’inattuabile e l’irrealizzabile.
E dove, soprattutto, l’inattuabile e l’irrealizzabile offrono, per contrasto, una luce critica per vedere l’attuale e il realizzato.
l’Utopia, parola inventata da Tommaso Moro, che significa letteralmente “non luogo”, è appunto il “non luogo” dell’osservatore che si simula dall’esterno per comparare il suo contesto storico-sociale, il mondo in cui egli vive, con possibilità altre, offerte dall’immaginario.
L’utopia paga assai spesso il prezzo di una sua eccessiva semplificazione, o, per meglio dire, come Mumford fa vedere assai bene nel comparare Venezia a Amaurote, paga il prezzo di una specularità che la rende, al contrario di quel che generalmente si pensa, troppo vicina al mondo storico reale e da questo troppo dipendente.
Come una sorta di mondo rovesciato.
Così, il sogno utopico di buone relazioni umane finisce col mostrarci una felicità in grigio.
L’abolizione del male, delle cattiverie, delle violenze, delle prevaricazioni, dello sfruttamento, della corruzione, si traduce allora nel conformismo, nella standardizzazione, nell’irreggimentazione delle istituzioni totali, nell’alveare di Bernard di Mandeville o nella fattoria degli animali di George Orwell.
Ma andando un po’ oltre la letteralità della parola utopia si può far corrispondere alla u il prefisso greco eu, “buono”, “bene” e leggere allora non più soltanto “non luogo”, ma “luogo buono”, “luogo ideale”.
Ma, se è così, c’è allora da chiedersi se non sia esattamente questo passaggio dal “non luogo” al “luogo ideale” a creare problema e a generare tutte le difficoltà inerenti alla definizione stessa di ciò che può dirsi o non dirsi utopia.
Il passaggio dal “non luogo” al “luogo ideale” sposta, forse impercettibilmente, il significato dell’utopia: alla critica dell’esistente per differenza e per contrasto viene a sovrapporsi il progetto immaginario.
Naturalmente, critica e progetto costituiscono entrambi elementi indispensabili all’utopia, ma è probabilmente nell’ambiguo rapporto tra questi due elementi che consiste la grande difficoltà nel definirne il concetto e nel decidere chi e cosa includere o escludere dal suo campo di significato.
Pag. 884
Cap. 23. Disegnare la terra / Christian Jacob
In Cina, la carta si presenta come uno strumento essenziale per la gestione e il controllo dell’impero, delle sue frontiere, delle sue risorse economiche, delle sue suddivisioni amministrative.
…………..
La cartografia è onnipresente nella gestione dello Stato come nell’esercizio e nel simbolismo del potere.
Pag. 911
Una componente della storia politica consiste “nella visita alle città, alle regioni, nella osservazione diretta delle caratteristiche dei fiumi, dei porti, della natura delle terre e dei mari, delle distanze fra le singole località”.
Lo storico deve dare un’idea delle caratteristiche salienti dei luoghi in cui si svolge l’azione e andare ben al di là della semplice enumerazione dei toponimi, al fine di offrire al lettore una carta mentale nella quale i tre continenti trovano collocazione in base ai quattro punti cardinali.
Lo storico deve inoltre mettere in condizione il proprio lettore di immaginare il quadro in cui si svolge uan spedizione o ha luogo uno scontro.
Nel libro trentaquattresimo della sua opera, Polibio mostra grande familiarità con la geografia alessandrina riprendendone anche i principali temi di discussione, dalla questione omerica, alle misure del mondo abitato, alle zone climatiche, ecc.
L’oggetto specifico delle Storie di Polibio contribuisce alla storicizzazione della geografia data la correlazione tra espansione romana e ampliamento dell’orizzonte del geografo e del viaggiatore; sollecita inoltre l’aggiornamento delle conoscenze.
Per quanto riguarda la conoscenza geografica dell’Occidente, le conquiste romane sono il corrispettivo della spedizione di Alessandro Magno in rapporto all’Oriente.
Pag. 931
Questo nesso tra geografia dalle aspirazioni universali e potere imperiale che rimodella le suddivisioni territoriali si ritroverà nel secolo di Napoleone.
Pag. 932
Il tema dell’interazione tra uomo e territorio pone il problema della definizione delle regioni e, di conseguenza, del determinismo.
Pag. 934
La carta e il testo: queste due forme di geo-grafia nascono in Grecia.
La prima risponde a un progetto di visualizzazione sinottica, di modellizzazione simbolica, che trasforma l’ecumene in spazio grafico, geometrizzato e quantificato; spazio di calcoli, di tracciati, di determinazione delle posizioni.
Il testo, al di là della differenza dei progetti discorsivi, fonda un modello di scrittura che costruisce lo spazio mediante la categorizzazione, la denominazione, l’analogia, la digressione, la descrizione.
Puramente e semplicemente descrittiva, oppure speculativa, maniaca del particolare o interessata alla ricerca del punto di vista panoramico della sintesi, in blanda forma narrativa o rigidamente strutturata in racconto, questa scrittura è “poetica” del mondo; nel caso di Strabone come in quello di Thévet, Elisée Reclus, Vidal de la Blache.
Pag. 937
La sopravvivenza di alcuni toponimi antichi va ben al di là del problema della loro localizzazione, per quanto controversa possa essere come nel caso di Tule.
Questi luoghi sono caratterizzati da una grande plasticità che consente a ideologie e nazionalismi di appropriarsene.
La geografia antica ha delimitato un orizzonte mentale e concettuale che s’impone all’erudito come al geografo, al viaggiatore come all’esploratore.
A Medioevo e Rinascimento, l’eredità della geografia antica regala la certezza rassicurante di un mondo già denominato, misurato, compiuto, la cui conoscenza si acquisisce tramite la biblioteca più che attraverso i tormenti della riscoperta.
Questa ecumene già descritta impone al geografo moderno la mediazione dei testi greci e latini: un vasto materiale di base, costituito da toponimi, da distanze e indicazioni topografiche, suscettibile di essere decontestualizzato, spersonalizzato e ricombinato all’infinito.
Ciò spiega la fortuna paradossale dei testi antichi, cui si attribuisce la capacità di fornire un “sapere quadro” del mondo, che lo rende intelligibile, memorizzabile, esprimibile.
Medioevo e Rinascimento imparano la geografia leggendo Plinio il Vecchio, Isidoro di Siviglia, Paolo Orosio, Pomponio Mela e persino Dionigi Periegeta.
Fanno così la conoscenza delle zone climatiche del globo terrestre, dell’insularità dell’ecumene delle zone climatiche del globo terrestre, dell’insularità dell’ecumene circondata dall’oceano, della sua suddivisione in tre continenti, del catalogo delle isole, delle ripartizioni etniche del mondo antico, della geografia delle regioni che hanno fatto la storia, come Grecia, Italia, Asia Minore.
In epoca moderna, il teso di Dionigi conserva la specificità che lo caratterizza dall’epoca di Adriano, ovvero l’efficacia immaginaria della carta mentale unitamente al potere mnemotecnico di un elenco di nomi di luoghi e di popoli che si dispiegano sulla scorta di un viaggio ideale attorno al mondo.
Sono queste le autorità cui, sino al 18. secolo, si rifà più o meno apertamente l’insegnamento di una geografia descrittiva, “politica urbana, morale…per dirla tutta, umana”.
Pag. 942
Non è possibile scrivere la storia della geografia sotto forma di narrazione lineare ed evoluzione semplice e teleologica.
Al pari della nostra, la geografia dei greci si compone d’un fascio di tradizioni che comportano metodi scientifici e generi di discorso spesso assai diversi.
Contraddizioni, controversie e difficoltà epistemologiche fanno parte di questa storia allo stesso titolo del lento progredire della conoscenza del globo e dell’affinamento successivo della sua immagine.
Sotto questo rispetto, la tradizione della geografia antica sembra indissolubilmente legata ai dibattiti, agli errori e diciamo pure alle divagazioni di una geografia europea alla ricerca di identità e degli strumenti più adatti alla realizzazione dei propri obiettivi, dovendo nel contempo fare i conti con un’eredità ambigua.
La trasmissione della geografia dei greci non può essere separata dalle operazioni di decostruzione, aggiustamento e traduzione che finiscono per instaurare uan nuova distanza concettuale e fare della scienza antica un oggetto storico privo di connessione con la scienza contemporanea.
Il legame tra geografi europei e loro predecessori greci e romani ci illumina sui mutamenti della disciplina, sul cambiamento delle sue frontiere, delle sue curiosità, delle sue domande di fondo.
L’evolversi del punto di vista del geografo sui testi antichi spiega gli spostamenti e le continuità che, più di vere e proprie fratture, caratterizzano la storia che abbiamo tentato di abbozzare: la geografia moderna nasce da uno scarto e da una presa di distanza, da uno sguardo critico che relativizza l’autorità degli antichi e colloca l’architettura della loro immagine del mondo in un corpus infinito di materiali topografici.
In quanto erede della tradizione neotolemaica, Mercatore non vede più alcuna utilità nel modernizzare le carte di Tolomeo.
Queste carte sono ormai dotate di un valore puramente storico e prive di incidenza su una geografia che deve sostenere ben altre sfide e soddisfare ben altre urgenze.
Nel 17. secolo, i Parallela Geographiae veteris et novae di padre Briet si servono del confronto tra antichi e moderni quale strumento d’una nuova pedagogia della geografia: due biblioteche vengono così metodicamente confrontate, paese per paese, per quanto riguarda il continente europeo, sulla scorta di una descrizione di tipo straboniano e di una tavola di nomenclatura ispirata alla tradizione tolemaica.
Ne deriva una geografia storica che tenta di ripensare la storia dei territori e dei paesi, la trasformazione delle loro condizioni naturali in seguito all’azione dell’uomo.
I generi di vita dei diversi popoli sono studiati tramite una griglia di elementi pertinenti che non si discosta da quella dell’etno-geografia antica (regime politico, organizzazione sociale, costumi, ecc.).
Osserviamo che questa geografia comparata non presta attenzione alla storicità del sapere geografico, alla possibile differenza di statuto, intenti e metodi tra antichi e moderni.
I greci hanno insegnato ai moderni che la geografia è intrinsecamente storicizzata, che è storica in quanto si applica a uno spazio vissuto, abitato, conquistato, perduto, attrezzato, coltivato da popolazioni del passato e del presente.
Elemento di intellegibilità per assistere al “teatro” della storia, per seguire l’andamento delle guerre contro i medi o l’avanzata delle truppe romane, la geografia diventerà naturalmente storica dacché si prefiggerà, in epoca rinascimentale e classica, di chiarire i testi degli autori greci e latini, sia storici sia poeti, ricollocando i loro toponimi in carte perlopiù moderne.
Nel 18. secolo, d’Anville sembra confermare questa netta separazione tra geografia antica e geografia moderna: “La geografia antica è racchiusa in ciò che gli scrittori dell’antichità, greci e romani, ci hanno lasciato in termini di conoscenza in materia”.
Ma in questo modo definisce la geografia antica in base a un corpus e non esclude l’esistenza di possibili legami con la geografia moderna.
Nei Rapports à l’Empereur sur le progrès des sciences, des lettres et des arts depuis 1789 l’articolo sulla geografia antica è affidato a Gosselin.
La geografia moderna rientra invece nel “rapporto” di Delambre sulle scienze matematiche.
Dopo aver ricordato le brillanti realizzazioni della geodesia francese nel 18. secolo (misura del grado di meridiano, calcoli della longitudine, nuova carta della Francia ecc.), Delambre afferma che la geografia “cammina a grandi passi verso la perfezione”.
Gosselin, nel suo articolo, s’adopra invece a dimostrare che la geografia antica costituisce ancora “uan parte essenziale e integrante della scienza geografica propriamente detta”, che non si riduce a “un’appendice della storia” e può collocarsi “al livello delle scienze esatte”.
Il confronto/scontro tra storico e astronomo-matematico può considerarsi un paradigma durevole.
Allo storico, la descrizione dello spazio fornisce il filo conduttore di un sapere enciclopedico del quale etnografia e storia costituiscono due dimensioni essenziali.
All’astronomo-matematico fornisce invece il forte interesse geodetico, il quadro cosmologico, il tracciato della cartografia generale e la paziente disciplina dei rilevamenti sul terreno, della triangolazione, delle carte con finalità pratica.
Strabone e Tolomeo hanno qui valore fondante, sono due punti di riferimento.
Esiste poi una posizione intermedia, quella degli eredi dei meteorologi greci che guardano alla geografia con l’occhio del naturalista: Descartes, Buffon, Buache, Humboldt.
Nella complessa dialettica tra greci e noi, l’eredità bifronte di una scienza a due teste – Tolomeo e Strabone – ispira e favorisce lo sviluppo della geografia moderna.
Almeno sino alla soglia del 19. secolo, greci e romani cooperano alla realizzazione del compito primario: l’inventario del mondo, la sua cartografia su piccola e media scala, la sua misurazione.
Palliativo alle lacune delle conoscenze moderne e all’impossibilità di fondare la carta su misurazioni esclusivamente astronomiche (la sindrome di Eratostene?), le fonti antiche non si limitano a venire incontro all’urgenza geodetica.
Quando la geografia moderna avrà assunto il definitivo controllo della sua cartografia, la disseminazione dei toponimi, delle distanze degli itinerari e dei frammenti si ricomporrà in testi organici, letti come altrettante lezioni da meditare sull’uomo, il tempo, lo spazio.
Pag. 950-53
Cap. 24. Scrivere gli eventi storici
Ci si domanda dunque di nuovo se, e in che senso, quel modello (nella misura in cui è lecito parlarne come di un modello unitario) possa ancora essere considerato, secondo la celebre espressione tucididea, un “possesso per sempre”.
Per tentare una risposta rievocheremo qui una serie di momenti e temi che appartengono alla storia di quella storiografia, o meglio delle riflessioni – prodotte non solo dagli storici, ma anche dai filosofi e retori antichi – che si sono nel tempo accompagnate alla vera e propria “scrittura degli eventi”: motivazioni dell’interesse storico, finalità proprie del tipo di discorso in cui si traduce e metodi da impiegare per conseguirle, sforzi di interpretazione del senso complessivo delle vicende umane.
Non un improbabile profilo, neppure sommario, di quella multiforme vicenda; semplicemente uan ricognizione, svolta peraltro in modo da evidenziare connessioni che implicano uan sequenza cronologica (una trattazione in forma prevalentemente sistematica è a mio parere poco convincente), di quei suoi aspetti che sembrano toccare più da vicino tematiche vive nel dibattito contemporaneo sulla storia, riconducibili al problema generale del suo valore conoscitivo, e delle condizioni della sua validità: un problema, del resto, centrale tanto nella riflessione storiografica greca quanto in quella moderna.
Pag. 957
Se si parte dalla premessa che tanto il mito quanto la storia rappresentano prima di tutto il modo per “ancorare il presente nel passato”, diventa più economico parlare di “frontiere aperte2 fra l’uno e l’altra e concepire senz’altro il passato come qualcosa che si può, o si deve, “inventare” per adeguarsi continuamente alle esigenze sempre mutevoli del presente.
Pag. 960
In conclusione sembra ragionevole pensare che la diffusione delle pratiche scrittorie abbia costituito un elemento importante per la nascita e i primi sviluppi della storiografia greca, ovvero che se ne debba considerare momento essenziale l’acquisizione di quel senso dell’alterità fra presente e passato che rappresentava il vero elemento di novità rispetto all’indistinzione temporale dell’epica.
Da questo stesso momento è anche segnata, con le parole di Ecateo, la responsabilità del “facitore di discorsi” rispetto al suo racconto, quale risulta dalla scelta razionale fra le diverse versioni di precedenti racconti, e dalla utilizzazione dei documenti che è riuscito a trovare; scelta e utilizzazione che, per tornare al discorso di partenza, non sono incompatibili con la funzione originaria di creazione d’identità che era propria del mito e della poesia epica che lo veicolava, ma la reinterpretano in termini di maggiore complessità.
Il nuovo tipo di discorso mantiene in effetti il principio che si debba vivere col ricordo delle grandi imprese, ma rivela una consapevolezza nuova della resistenza che i sedimenti del passato frappongono alla libera elaborazione del discorso memoriale.
L’acquisizione di questa consapevolezza appare a noi l’elemento essenziale, caratterizzante anche in seguito la scrittura storiografica greca, nella varietà delle forme nelle quali si articolerà.
Né è da vedervi contraddizione col fatto che già da Erodoto si manifesti la chiara tendenza a spostare verso il contemporaneo (o meglio verso il passato recente) l’asse dell’interesse storico.
L’umanizzazione del tempo, cioè la sua valutazione in termini di esperienza umana, può anzi esserne considerata un pacifico corollario; quello che conta è che anche per la costruzione della memoria del passato recente, o del presente, venga ormai sentita indispensabile la disponibilità di testimonianze, scritte od orali, che possano garantirne la validità.
Pag. 967
Se abbiamo sottolineato la dimensione scrittoria dell’opera di Ecateo è naturalmente perché la sua celebre dichiarazione d’apertura costituisce la fondamentale testimonianza di una nuova consapevolezza della necessità di rapportarsi in modo critico alle tradizioni del passato: un modo che resterà poi sempre un’importante componente del discorso storico, quale verrà organizzandosi a partire da Erodoto.
Con questo però non s’intende sottovalutare un’altra dimensione, non meno importante, della sua opera, che sarà poi anch’essa propria di Erodoto: l’interesse, che è facile ricondurre alle peculiari condizioni di vita delle comunità greche della costa anatolica, per l’indagine geografica, specialmente attraverso i viaggi di mare, e per la descrizione etnografica.
Esso rappresenta anzi, in quanto si richiama al principio dell’autopsia, un aspetto essenziale di quella dimensione empirica che, come vedremo, è propria della storiografia greca fin dalle sue origini.
E’ solo con Erodoto, in ogni caso, che il termine “storia” (istorie) entra a far parte del lessico intellettuale greco, dal quale poi, attraverso la mediazione latina (historia), passerà a quello dell’Occidente: almeno da questo punto di vista, dunque, la già ricordata definizione ciceroniana dello scrittore di Alicarnasso appare corretta.
Bisogna subito aggiungere, però, che il significato che tale termine ha nel celebre passo del proemio alle Storie erodotee non è esattamente quello che è per noi ovvio: un significato, quest’ultimo, che è stato acquisito alla lingua greca solo qualche decennio più tardi; esso vale piuttosto “indagine”, “ricerca”, se non, come vuole ora F. Hartog, “una procedura di linguaggio che… arriva a far vedere”.
Pag. 968
Il discorso pubblico fu, tanto nell’Atene del quinto secolo che nella Roma tardo-repubblicana, un momento essenziale della vita politica, ma anche la condizione principale della conoscibilità degli eventi.
Tucidide lo considerò certamente, in quanto strumento per la creazione del necessario consenso popolare, non meno diseducativo, e più pericoloso, della lettura pubblica che i logografi davano delle loro opere storiche: elementi diversi e convergenti di quell’azione di demagogica corruzione, alla quale la parola scritta aveva ben poche probabilità di opporsi efficacemente; il vero destinatario del messaggio storico di Tucidide restava il politico futuro, ed era per lui che Tucidide protestava il proprio integrale rispetto della verità.
In ogni caso non va sottovalutata l’importanza dell’insistenza dello scrittore su questo punto; anche se in seguito diventa quasi un luogo comune che tutti gli storici ripetono nei loro proemi, senza che ciò costituisca ovviamente una garanzia di affidabilità per i contenuti delle loro opere, essi resta pur sempre la regola fondamentale per questo tipo di scrittura.
Cicerone, parlando nel De oratore del lavoro dello storico, dichiara quasi con fastidio: “Queste norme le conosciamo tutti. Chi non sa che la prima legge della storia consiste nel non osare di dire il falso? E poi di non temere di dire tutta la verità? E che non vi sia nessun sospetto di favoritismo in ciò che si scrive? Nessun sospetto di malevolenza? Questi principi fondamentali sono noti a tutti” (2.62-63).
E’ sintomatico del carattere stereotipico di queste raccomandazioni il fatto che lo stesso Cicerone inviti in una lettera privata l’amico Lucceio a trascurare quella regola, nello stendere l’opera storica che gli chiede di comporre su se stesso: per Cicerone il valore esemplare delle sue gesta doveva avere la precedenza sul rispetto della verità.
E’ stato dunque per sua e nostra buona sorte che il grande oratore e intellettuale della fine della repubblica, pur convinto di potere meglio di chiunque altro innalzare la letteratura latina al livello di quella greca nel campo della storiografia, ha rinunciato a dare corso a questa minaccia.
Pag. 978
Il fatto che, dopo Tucidide, l’obbligo dello storico, indipendentemente dai suoi orientamenti e dai suoi interessi, di dire la verità, nei limiti in cui è onestamente in grado di accertarla, non sia stato seriamente contestato in linea di principio, non significa certo che sia venuta meno la discussione che diventa assai accesa a partire dal 4. secolo, e testimonia prima di tutto che la storiografia è ormai riconosciuta come uno specifico tipo di scrittura in prosa, del quale si tratta di definire le regole.
Le opere dei primi protagonisti di questa discussione non sono giunte fino a noi, e devono essere ricostruite sulla base di citazioni, spesso polemiche, di autori più tardi: specialmente Polibio, che scrive alla metà del secondo secolo, e ha un indirizzo storiografico che vuole rappresentare una riproposizione fedele, pur con qualche significativo ampliamento di prospettiva, del modello tucidideo.
In generale sembra comunque di poter dire che gli orientamenti principali che emergono, che si definiscono convenzionalmente “storiografia retorica” e “storiografia tragica”, rappresentino, da diversi o anche opposti angoli visuali, una ripresa, naturalmente in termini largamente rinnovati, di una prospettiva di tipo erodoteo: nel senso che tradiscono l’esigenza di recuperare quella immediatezza e quella estensione comunicativa, che Tucidide aveva ostentatamente ripudiato.
Ciò su cui si rileva un profondo contrasto è naturalmente il modo di realizzare questo obiettivo, che è la costruzione di un nuovo discorso storiografico: mentre da una parte si punta all’elaborazione di un testo che si presenti con i caratteri della semplicità e della chiarezza espressiva, dall’altra si ritiene di dover cercare effetti più propriamente poetici, anzi drammatici, suscettibili di sollecitare non tanto la riflessione quanto la partecipazione emotiva dei lettori.
Pag. 979
Le tecniche aventi per oggetto l’accertamento della verità, e in particolare delle reali cause dei fatti, sono analizzate e meticolosamente esposte da Polibio in più luoghi; lo storico vi si rivela sensibile e interprete e utilizzatore ai suoi fini storico-politici degli sviluppi più recenti della scienza ellenistica, sul piano sia della teoria che dell’applicazione pratica.
Non ci soffermeremmo su di esse, se non per rilevare l’importanza che ha in tale contesto la ricerca, la lettura e l’interpretazione dei documenti scritti, unitamente alla verifica della loro autenticità; elementi questi che costituiscono fra l’altro uno dei punti forti della polemica che Polibio sviluppa con lo storico siciliano Timeo nel corso del libro dodicesimo delle Storie (12.5-11, specialmente 9-11), e ci rassicurano sul fatto che il valore attribuito da Dionigi di Alicarnasso a questo tipo di documentazione nelle fasi iniziali della storiografia greca non possa essere considerato una pura fantasia.
Allo stesso modo ci limiteremo a menzionare l’importanza della discussione, sempre nel dodicesimo libro, relativa al modo di ricostruire e utilizzare i discorsi dei protagonisti dell’azione storica (12.25-26b).
Polemizzando ancora con Timeo, accusato di essersi praticamente inventato i discorsi – e presumibilmente di aver teorizzato la legittimità metodologica di un simile modo di fare – Polibio sostiene: “Il compito specifico della storia consiste anzitutto nel cercare di conoscere i discorsi realmente pronunciati e il loro vero senso; in secondo luogo, nel cercare di sapere per quale motivo ciò che è stato fatto o detto ha avuto o non ha avuto successo…
Chi passa sotto silenzio i discorsi veramente pronunziati e i loro motivi e vi sostituisce delle argomentazioni false o delle argomentazioni retoriche, toglie alla storia ciò che le è proprio” (12.25b).
Vale viceversa la pena di evidenziare un fatto che ha di per sé minore rilevanza metodologica, ma appartiene a quel mondo dell’ideologia che, come si è già sottolineato a proposito sia di Erodoto che di Tucidide, incide in modo sostanziale sulla confezione finale del prodotto storiografico, e ne determina il significato storico e la fortuna.
Nel caso specifico, è chiaro che l’idea interpretativa fondamentale che anima il racconto polibiano, quella secondo cui l’acquisizione da parte di Roma dell’egemonia sul mondo mediterraneo rappresenta il primo vero momento unificante della storia universale, rinnova in maniera radicale la prospettiva di Tucidide, che si poneva sì il problema di giustificare la scelta del tema, ma lo risolveva semplicemente assicurandosi che la “sua” guerra fosse la più importante fra quante se ne erano date fino al suo tempo; Polibio pretende invece di stabilire l’importanza del suo tema nell’economia generale del mondo storico, anche rispetto al futuro, nonostante che la conquista romana sia frutto di una tyke, la cui ratio non è invero sempre evidente.
I singoli eventi svoltisi su tutto l’arco dell’ecumene nel famoso cinquantennio dall’inizio della seconda guerra punica alla fine della guerra con Perseo si rivelano comunque a posteriori alla mente dello storico coordinati e finalizzati alla realizzazione di un piano complessivo; a questo punto la storia si fa veramente tragedia, ma non nel modo puerile in cui alcuni storici hanno ritenuto di poter aggirare l’obiezione aristotelica: bensì nel caso che l’artefice umano del racconto riesce a identificarsi con il senso più riposto degli avvenimenti.
Per noi è chiaro che questa concezione non è che la traduzione in termini storiografici dell’accettazione da parte di Polibio del dominio romano – propiziata anche dalle ben note vicende personali dell’ex dirigente della lega achea, trascinato a Roma come ostaggio all’indomani della guerra con Perseo, e lì per decenni blandito dalla potente famiglia degli Scipioni; un’accettazione che non poteva andare disgiunta dalla ricerca di una spiegazione del collasso politico del mondo ellenistico, e insieme dall’invenzione di una legittimazione del dominio romano.
Ma in ogni caso l’elaborazione ideologica e storiografica di Polibio, largamente condivisa – si deve presumere – anche se non condizionata, dagli ambienti più influenti della politica e della cultura romana, contribuì in maniera forse decisiva a determinare il formarsi della stessa concezione dei romani di una propria grandiosa missione imperiale, quale la troviamo formulata poi in Cicerone o in Virgilio; a parte, naturalmente, l’influenza che ebbe sull’elaborazione da parte delle dirigenze greche di quel modo di vedere il mondo romano che portò nel giro di qualche decennio a sceglierne la causa anche quando – come nel caso della guerra mitridatica – un’alternativa sarebbe stata possibile: un punto sul quale non è questa la sede per soffermarsi.
Quello che è qui da notare è invece che questo impianto storico-ideologico gettò le premesse di fondamentali sviluppi, anche storiografici, successivi; prima di tutto, l’idea di una koinè greco-romana nella gestione politica e culturale di un’ecumene unificata, e più tardi la creazione dell’idea della provvidenzialità dell’impero da parte della storiografia cristiana.
Pag. 984-86
Il progetto culturale di Plutarco, reso realistico anche da una secolare tendenza romana ad accogliere gradualmente le popolazioni vinte nel proprio sistema di governo, è allora quello di elaborare una piattaforma storica comune, nella quale entrambi i popoli possano riconoscersi, riconoscendo insieme anche quelle che sono le differenze, sia naturali che storiche, che esistono fra di loro: differenze che sono però tanto meno rilevanti, in quanto i romani siano disposti ad accettare, come di fatto sembrano aver accettato ormai da tempo, che il metro per la misurazione dei valori intellettuali è greco, e non romano.
Pag. 991
Sappiamo che proprio dalla scrittura di storie relative alla seconda di queste operazioni militari trae origine il testo che rappresenta l’unica riflessione sistematica sulla storiografia a noi conservata dal mondo antico: il Pos dei istorìan syngrafein (Come si deve scrivere la storia) di Luciano, sul quale ci soffermiamo conclusivamente anche perché è proprio qui che sembra formulato negli esatti termini del Ranke il principio (naturalmente già tucidideo e polibiano) che lo storico deve dire solo ”come effettivamente sono andate le cose” (39).
Questo testo, che si ricollega esplicitamente agli orientamenti critici formulati da Tucidide (42) e specialmente all’imperativo del rispetto della verità, ma li aggiorna sulla base delle discussioni successive, punta a distinguere con rigore la scrittura di storia da altri tipi di scrittura che con quella non devono avere nulla in comune: l’encomio prima di tutto, e più in generale la poesia, nella quale “la libertà è sfrenata, e unica norma è ciò che piace al poeta” (8).
Il punto è sempre quello che la mancanza di verità rende inutile la storia; il richiamo, che taluni fanno, alla necessità di abbellire il racconto per renderlo più gradevole alla lettura, sorvola sul fatto essenziale che i destinatari di quel racconto non sono la gente comune dell’oggi, am i pochi che sanno (10-11), e che potranno giovarsene specialmente in futuro (39; 61-63).
Il comandamento della verità, in particolare, deve far sì che lo storico somigli allo Zeus omerico, che è simbolo d’imparzialità fra i contendenti (49).
Lo storico dovrà inoltre essere provvisto di intelligenza politica (34), e possibilmente avere anche esperienza diretta tanto di politica quando di attività militare 837): ciò evidentemente perché non è possibile raccontare i fatti senza capirli; ma neppure la capacità espressiva è da sottovalutare (34), perché da essa dipende la chiarezza dell’esposizione, e in questo ambito ci si potrà anche sollevare, in particolari contesti, alle altezze del discorso poetico (43-46).
Infine, una considerazione di notevole originalità, in cui viene messa in evidenza la dimensione creativa dell’attività storiografica.
Pag. 992-93
La storiografia greca, nata dall’esigenza, comune a molti altri gruppi umani, di conservare il ricordo di eventi rilevanti per la vita della comunità, che assicura così la propria identità, si è caratterizzata specificamente per una volontà di accertamento critico della verità dei fatti e di spiegazione dei fatti stessi.
Essa ha mantenuto sempre acceso, come si è visto, il dibattito sui presupposti, i metodi, le finalità del discorso storico, ridiscutendone continuamente le modalità espressive, le funzioni memoriali, i valori conoscitivi, le responsabilità educative; in questo dibattito a partire dalla metà del secondo secolo sono sempre più autorevolmente intervenuti anche intellettuali romani, per i quali la cultura greca era diventata l’unica cultura possibile.
L’elaborazione polibiana dell’idea di uno sviluppo della storia dell’ecumene verso l’unificazione politica sotto il dominio di Roma vi ha poi introdotto un elemento del tutto nuovo, di grande importanza per il futuro: vi si sarebbe infatti innestata la concezione escatologica e finalistica della vicenda umana che fu caratteristica dell’universalismo cristiano.
La stessa idea avrebbe d’altro canto prodotto una radicalizzazione di preesistenti polemiche interne al dibattito storiografico: dalla saldatura con le rivendicazioni antiromane di varie tradizioni culturali vicino-orientali scaturì in effetti una sorta di ripudio del mondo greco di scrivere la storia, al quale furono contrapposte altre pratiche storiografiche, considerate più antiche e attendibili.
Pag. 1000
A guardare alle origini del contrasto fra Momigliano e Finley, si capisce dunque che il punto in discussione non è tanto se la storiografia greca rappresenti un riferimento indispensabile per il mondo moderno di pensare e fare storia, quanto di che tipo di riferimento si tratti; quel contrasto è quindi piuttosto una spia dell’incertezza odierna sulla natura della ricerca e della scrittura storica, nell’ambito di un dibattito culturale nel quale, come ha osservato lo stesso Momigliano, dopo il Creuzer e l’Ulrici la riflessione sulla storiografia greca è rimasta in realtà per molto tempo deplorevolmente marginale.
Il Momigliano si pone come erede di una tradizione di pensiero che vede quell’esperienza il prototipo di un approccio razionalistico alla ricostruzione delle vicende umane, che ne assume prima di tutto una realtà indipendente dall’attività dello storico, ne subordina la possibilità di analisi alla messa in opera di una specifica tecnica e alla disponibilità dei relativi materiali, i documenti; e infine sottopone la validità e l’attendibilità dei risultati ottenuti al giudizio pubblico.
Il Finley insiste viceversa sulla componente letteraria e artistica della storiografia greca, che egli vede radicata nella dimensione funzionale della memoria poetica originaria; e vi innesta suggestioni emergenti dalla riflessione storico-antropologica contemporanea, che, nella misura in cui esasperano il relativismo connesso a un approccio di tipo “primitivistico” al mondo greco, rischiano alla fine di distruggere qualunque piattaforma comune fra antico e moderno.
In questo modo le sue posizioni rafforzano obiettivamente quella concezione “retorica” della storia – oggi impersonata emblematicamente dallo studioso americano Hayden White, ma le cui fondamenta erano gettate da Roland Barthes - che non solo revoca alla storiografia qualunque statuto di scienza (sia pure “sui generis”), ma, cosa ben più seria, minaccia di togliere ogni fondamento reale alla storia stessa, in quanto serie di eventi prodotti e vissuti dall’uomo; ovvero, che del resto è lo stesso, di negarle conoscibilità, nella misura in cui delegittima la memoria, alla quale, anche se sostenuta da documenti scritti, rifiuta qualsiasi valore autenticamente testimoniale.
Appare chiaro che entrambe queste posizioni possono appoggiarsi a riflessioni e pratiche storiografiche del mondo greco (e romano); ciascuna di esse può dunque pretendere di interpretare correttamente l’”invenzione” greca della storiografia.
Tuttavia, come dovrebbe del resto risultare evidente da quanto si è detto fin qui, sembra a noi difficile negare che, almeno per quanto riguarda le premesse teoriche, la pretesa di cui si fa interprete il Momigliano sia meglio fondata dell’altra.
E’ vero che da Aristotele in poi i filosofi, abili a costruirsi in Grecia, al di là delle polemiche reciproche, uno statuto disciplinare di una solidità invidiabile, hanno fatto del loro meglio – ostentando (con la possibile ricordata eccezione del filosofo-storico Posidonio) sufficienza o disprezzo per una conoscenza accusata di restare prigioniera del particolare – per gettarla nelle braccia compiacenti della retorica; ma non per questo la storiografia antica, o almeno i suoi esponenti più significativi, hanno mai rinunciato a rivendicare la specificità di quel tipo di scrittura e la sua irriducibilità a moduli espressivi esclusivamente formali.
E d’altra parte la teoria retorica, pur fissando regole per il discorso storico, non ha mai preteso di entrare nel merito dei suoi contenuti: anzi, ne ha ad esempio distinto con cura le caratteristiche rispetto alla ben diversa narratio che costituisce parte integrante dell’oratoria giudiziaria.
Pag. 1009
Citazione da Johan Huizinga
La storia è sempre un dar forma al passato, e non può pretendere di essere qualcosa di più.
E’ sempre un cogliere un senso del passato, dandone un’interpretazione.
Anche il semplice raccontare è già comunicare un senso e l’assimilazione di questo senso può avere un carattere semiestetico.
Sarebbe errato pensare che queste considerazioni aprano la porta a uno scetticismo storico.
Ogni scetticismo storico, che svaluti una conoscenza acquisita in questo modo, non può che portare a uno scetticismo filosofico generale che non risparmia né la vita stessa né alcuna scienza, nemmeno la più esatta.
Se la storia, come attività intellettuale, è un “dar forma”, allora possiamo dire che, come prodotto, essa è uan forma – una forma intellettuale per comprendere il mondo, così come lo sono la filosofia, la letteratura, il diritto, la fisica.
Da queste altre forme intellettuali la storia si distingue in quanto si interessa del passato ed esclusivamente del passato.
Il suo obiettivo è di comprendere il mondo nel passato e attraverso il passato.
Pag. 1010
Conclusione: responsabilità della storiografia greca
La riproposizione del modello scientifico d’impianto tucidideo si accompagnava in Polibio, come si è detto, all’elaborazione di un’idea chiusa della storia del mondo, vista come un processo apparentemente diretto a una conclusione necessaria: che per lui era l’unificazione dell’ecumene sotto il dominio di Roma.
SI potrebbe insomma parlare già a proposito di Polibio di un embrione di quell’idea di “singolarizzazione” che ha finito per diventare, dal Settecento in poi, l’emblema di “una storia eurocentrica, al massimo atlantica – una storia (dice Christian Meier) concepita sulla base di una situazione in cui l’Europa poteva considerarsi centro del mondo, e in cui in ogni caso l’Europa moderna o, più precisamente, la civilizzazione che si è diffusa a partire da essa, poteva sembrare la meta della storia mondiale, [mentre] le altre storie sul globo terrestre parevano finire in ‘vicoli ciechi dell’evoluzione’”.
In effetti, come ricorda Giacomo Marramao, già il Löwith osservò che tra gli storici dell’antichità soltanto Polibio “sembra avvicinarsi alla nostra concezione della storia, in quanto rappresenta gli avvenimenti come se convergessero tutti verso un medesimo fine, la potenza mondiale di Roma.
In ogni caso è chiaro che la moderna “singolarizzazione” assumeva l’esperienza antica come parte integrante della propria identità, creando uan “sua” storia del mondo, o storia universale, che escludeva tutto ciò che non faceva parte dell’area antico-occidentale.
Sempre il Meier ha denunciato i limiti e i rischi di questa impostazione che a suo parere deve ormai lasciare il campo a una disponibilità a comprendere tutte le parti del mondo, che non possono essere ulteriormente private di un loro spazio in un contesto storico che aspiri a una dimensione realmente universale.
Del resto, siamo ora di fronte a un ribollire di fermenti antioccidentali – tanto all’interno quando all’esterno dell’”Occidente”, si potrebbe dire, se non fosse oramai evidente che “Occidente” non ha più senso né geografico né politico, ma solo ideologico – che mettono in discussione sia il ruolo egemone di quella cultura che negli ultimi cinque secoli ha avuto nei paesi europei il suo centro propulsivo, sia il suo supporto storico, cioè il radicamento che si è costruito nel passato.
In questa sede, ci incombe il riconoscimento del ruolo che la storiografia greca ha avuto nell’elaborazione dei presupposti di questo sistema di riferimenti: essa ha contribuito alla costruzione da una parte, con Erodoto, di uno schema oppositivo noi / gli altri, che ha implicita in sé l’affermazione della superiorità di “noi” su “gli altri”; dall’altra, e soprattutto, con Polibio, dei fondamenti di quel blocco storico-culturale, usualmente definito “mondo classico” (o simili), che la cultura europea a partire almeno dal Rinascimento ha considerato come proprio titolo di nobilitazione, a fondamento dei suoi valori.
Ci sono delle attenuanti a queste “responsabilità”.
Si può in effetti osservare, da una parte, che la contrapposizione polare greci / barbari ha avuto sì un momento forte nel quinto e quarto secolo, a causa dello scontro quasi costante in questo periodo con i persiani, ma è andata attenuandosi nell’età ellenistica e romana (né in ogni caso alla storiografia può essere attribuita una specifica funzione trainante nel diffonderla); dall’altra, che è pure esistita, come si è visto, una linea di “resistenza” storiografica all’accettazione polibiana del dominio romano: sia nella forma di una produzione storica greca propriamente antiromana, sia in quella, dai risvolti più radicali, di una affermazione (sempre in lingua greca!) della priorità-superiorità di altre esperienze storiografiche (egiziana, ebraica) rispetto a quella greca.
Ed è notevole che nel suo provocatorio Black Athena, una vivace denuncia dell’ispirazione “romantica e razzistica” della creazione, a partire dai primi decenni dell’Ottocento, del mito di una Grecia indoeuropea, senza commistioni col mondo afro-asiatico (“Aryan Model”), Martin Bernal ritenga di poterlo mettere in discussione proprio servendosi del ben diverso impianto ideologico che animerebbe i testimoni greci, storici e no, dei rapporti fra i diversi mondi culturali del Mediterraneo antico (“Ancient Model”).
Il problema sarebbe dunque anche qui quello dell’uso che i moderni hanno fatto della grecità, piuttosto che quello di un limite originario del modello storiografico greco; al quale non dovrebbero perciò essere imputate colpe di tipo “nazionalistico”.
Ma in ogni caso non sembra che il riconoscimento di questa responsabilità, qualunque essa sia, possa legittimare una messa in discussione del modello in quanto tale: la storiografia greca o moderna, non diventa per questo una “white methodology”; non da ultimo, per le capacità di autocorrezione che dimostra di possedere.
Meno che mai, come si è visto, può essere invocata a sostegno di una visione mitologizzante dell’approccio storico una pretesa inclinazione della riflessione antica a considerare la storiografia in termini esclusivamente retorici.
In realtà la cultura contemporanea, bianca e nera, non ha nulla da perdere, e molto da guadagnare, se, riconoscendo in questo come in tanti altri campi il suo debito nei confronti dell’esperienza greca, si sforza di riappropriarsi in modo costruttivo del valore che gliene appare più autentico.
Pag. 1011-13
Cap. 25. Per una storia delle storie greche
I greci avevano già narrato la loro “storia antica” a la loro “storia contemporanea” a partire del quinto secolo a. C.
Non si trattava però di un genere unitario: le varie opere erano diversissime per contenuto e per forma, la connotazione letteraria molto forte.
Contemporaneamente essi svilupparono tecniche d’indagine erudita e di ricostruzione del passato che furono applicate alle più svariate questioni storiche e antiquarie (sia nel campo della grande storiografia che nella storiografia locale).
Malgrado l’esistenza di modelli storiografici molto diversi, , gli autori migliori vennero a formare di fatto una serie quasi continua, una successione cronologica, perché molto spesso uno storico antico continuava l’opera di un suo predecessore o di ricollegava ad esso.
Giustamente si è parlato di “ciclo storico”, cioè della creazione di una specie di racconto ininterrotto della storia passata.
Sia le vicende di singole città e regioni, sia i grandi eventi che avevano coinvolto gran parte del mondo ellenico e popolazioni non greche (come le guerre persiane, la guerra del Peloponneso, le lotte per l’egemonia del quarto secolo a. C.) furono oggetto di indagine e di racconto.
I greci si avvicinarono inoltre a una sorta di “storia nazionale” (Ellenikà), determinata dalla connessione degli eventi più che dal senso di identità collettiva, dato che la consapevolezza di appartenere a un’unità etnica (tò ellenikòn) era disgiunta dall’idea di cittadinanza e subordinata ad essa nella prassi (l’unione di nazione e cittadinanza, com’è noto, è legata all’esperienza dei moderni stati nazionali).
Pag. 1015
“La vera questione – come ha indicato Momigliano – non è se i greci avessero coscienza storica, ma quali tipi di storia scrivevano e hanno trasmesso fino a noi”.
Quando poi essi dovettero far i conti con i romani e il loro rapido affermarsi come potenza egemone nel Mediterraneo, le vicende di questi ultimi furono inserite nella “storia universale”; storici greci come Polibio cercarono di comprendere le ragioni del loro successo e altri in seguito confronteranno personaggi e fatti greci e romani.
Ma ormai gli storici migliori formavano un “canone”, la storia greca anteriore era stata già scritta e formava un “ciclo”; la si poteva utilizzare come miniera di exempla, compendiare, inserire in un quadro più vasto e aggiornato, integrare con dettagli che illuminassero le personalità del passato, ma non si sentiva la necessità di riscriverla.
Solo la figura eccezionale di Alessandro, archetipo di regalità, continuerà per secoli ad avere una straordinaria fortuna letteraria e ad essere “riscritta”.
Pag. 1016
Nella seconda metà del 17. secolo e durante il 18. si svilupparono due visioni contrapposte del passato, che coinvolsero la storia in genere, e quindi anche la storia greca.
Difatti, a partire della filosofia cartesiana, innestandosi su critiche precedenti rivolte alla credibilità della storia, si diffuse un atteggiamento scettico verso la storiografia in genere e quella più antica in particolare (soprattutto riguardo alle origini).
Il tema è stato ampiamente studiato ed è inutile riprenderlo in dettaglio in questa sede.
Uan componente fondamentale, e anche un obiettivo di queste critiche distruttive, era la messa in discussione della Bibbia, e quindi della base stessa della “storia sacra” tradizionale.
L’applicazione dell’Antico Testamento di metodi di analisi storico-filologici e letterari (J. Astruc, J. G. Eichhorn, per citare due esempi famosi) tolse alla Bibbia la sua intoccabilità; la strada era già stata aperta da chi aveva ridotto il ruolo di Mosè nella composizione della Genesi, trasferendolo a scribi ispirati, che avrebbero però utilizzato documenti e racconti anteriori (vedi R. Simon e le critiche rivoltegli da J. Le Clerc).
La critica biblica divenne il campo fondamentale della discussione, com’è ovvio date le implicazioni religiose.
Intaccato il dogma dell’ispirazione, soprattutto nel mondo protestante ma anche in quello cattolico, l’analisi storico-razionale dovette divenire sempre più approfondita e raffinata, come anche la difesa della visione ortodossa.
Aver messo in discussione la storia sacra della Bibbia significò a maggior ragione dubitare – in modo ancora più radicale – della storia profana.
Anzi, poiché una libera critica biblica, specie in ambienti cattolici, sollevava problemi ed era a volte rischiosa, la discussione sul valore storico delle tradizioni “profane” poteva essere un modo inoffensivo e indiretto di discutere di tradizioni antiche.
La possibilità stessa di conoscere il passato veniva ormai messa in questione dal pirronismo storico.
Pierre Bayle fu la personalità di maggior fama, ma non certo l’unico (si pensi a La Mothe Le Vayer e al suo Discours du peu de certitude qu’il y a dans l’histoire del 1668); le posizioni dei “savants” erano molto variegate.
La cronologia, che univa insieme le diverse storie sacre e profane a partire dalla creazione confrontandone la ricostruzione temporale, era terreno di scontro tradizionale già dall’antichità, ma lo fu a maggior ragione dopo la Riforma e l’opera dello Scaligero.
A questo aveva risposto il dotto gesuita Petavius (Denys Petau) con il suo De doctrina temporum (1637) seguito dal Rationarium temporum, che ebbe un enorme successo.
La questione sarà poi rinnovata da Newton, che sconvolse anche la cronologia greco-romana; la sua opera suscitò uan famosa discussione europea (Frèret, Algarotti, ecc.).
Ma la critica non si limitò solo a questo settore.
Esisteva da tempo una sorta di gerarchia delle storie: la più importante era quella “sacra”, cui seguiva subito quella romana, mentre solo dopo veniva quella greca, cui tenevano dietro le altre.
Naturalmente la storia romana – più ricca d’implicazioni contemporanee perché finiva col coinvolgere origini e legittimità dell’impero e del papato – fu investita in pieno dal pirronismo; la tradizione sulle origini e i primi secoli di Roma fu messa seriamente in discussione in modo sistematico (nei “Mémoires de l’Académie” dal 1772 in poi; da L. de Beaufort nel 1738).
La storia greca venne coinvolta nelle discussioni sul valore delle fonti e della tradizione, ma in modo più episodico, come conseguenza della critica generale alla fides historica.
Qui si deve tener conto di un dato fondamentale.
Fino alla diffusione del pirronismo la storiografia romana era stata spesso giudicata più veritiera di quella ellenica, forse perché su quest’ultima gravava il giudizio negativo che ne aveva dato Giuseppe Flavio per i periodi più antichi.
Com’è noto fu Erodoto in particolare ad essere giudicato negativamente per la presenza delle “fables”, tanto vituperate nel 18. secolo, sviluppando quell’immagine piena di ombre oltre che di luci che troviamo ad esempio in Voltaire e che gli antichi avevano trasmesso.
Per un giudizio tipico si prenda il Nouveau dictionnaire historique portatif (Amsterdam 1766) che così ne parla: “Egli riferisce favole ridicole che invero dà per sentito dire, ma avrebbe fatto meglio a non riferire affatto. Agli occhi dei filosofi è tanto il padre della storia quanto il padre della menzogna”.
Comunque l’accusa di essere creduloni fu rivolta a molti storici greci, da Erodoto a Diodoro Siculo e ciò in linea con un diffuso scetticismo”.
Pag. 1027-28
I riferimenti di Voltaire sono più numerosi e frequenti a proposito della storia romana arcaica, allora così dibattuta; gli esempi relativi al mondo greco invece sono più limitati e poco felici.
Vico offrì invece un altro tipo di risposta al pirronismo: una storia filosofica unitaria che accettava insieme il ruolo della provvidenza divina nella storia universale e ammetteva che la storia antica era intessuta di favole e imposture che – riferendosi a Tucidide – “i greci fino al tempo di suo padre, ch’era quello di Erodoto, non seppero nulla dell’antichità loro propie”, ma individuava fasi comuni nello sviluppo delle nazioni, e vedeva l’età eroica della Grecia rappresentata dalla sapienza poetica di Omero.
In questo modo Vico attraverso la sua “nuova arte critica” recuperava uan dimensione storica e la conoscibilità del passato.
Ma la sua posizione, se prescindiamo dagli sviluppi del problema omerico, avrà seguito più per la storia di Roma che per la Grecia.
Prima di considerare i tentativi di riscrivere la storia dei greci come un insieme, occorre segnalare brevemente alcuni punti importanti relativi al 18. secolo, indispensabili per comprendere gli sviluppi successivi.
1. L’affinamento critico dei metodi filologici, che può essere esemplificato al meglio da Bentley e da Wolf, distanziati tra loro da un secolo.
2. L’inizio degli scavi di Ercolano (1738) e di Pompei (1748) e la riscoperta di Paestum, che danno una nuova e più diretta immagine dell’antichità in genere e che furono recepiti con entusiasmo dalle classi colte europee, soprattutto nella seconda metà del secolo.
3. La scoperta d’importanti documenti epigrafici, che ora vengono indagati e valorizzati con uno spirito nuovo: si pensi alle Tavole di Eraclea e alla pubblicazione esemplare che ne fu fatta dal Mazzocchi, sentite come una riscoperta della Magna Grecia.
4. I viaggiatori che già nel Seicento e poi ancor di più nel corso del Settecento e dell’Ottocento visitano la Grecia e il Levante, l’Italia meridionale e la Sicilia, descrivono le antichità e i paesaggi, creano col tempo una sensibilità nuova verso l’antico, informano sulle nuove scoperte, istituzionalizzano il Grand Tour come momenti della formazione delle élite europee.
5. L’opera di Winckelmann che interpreta l’arte greca come manifestazione della libertà civile e politica dei greci, affermando che “la libertà ha avuto la sua sede in Grecia, anche accanto al trono dei re”.
In questo modo Winckelmann “osava opporre allo stato settecentesco l’ideale delle virtuose repubbliche classiche”.
L’esaltazione che ne fece Goethe contribuì all’enorme successo che l’immagine ideale della grecità ebbe nella cultura tedesca, tanto che si è parlato di una “tirannia della Grecia sulla Germania”.
6. L’immagine di una “Atene borghese” e di un “modello spartano” hanno una grande diffusione soprattutto in rancia nel clima dell’illuminismo prerivoluzionario.
Esse trovano espressione in opere antichistiche d’alto livello, come quelle dell’abate Barthélemy, e negli scritti di un altro abate, il filospartano Mably; ancor più rilevante culturalmente il peso delle antiche repubbliche nella riflessione di Rousseau, che però nella nona delle sue Lettere scritte dalla montagna metteva in guardia i suoi ginevrini (“voi non siete né romani né spartiati; non siete neanche ateniesi… Voi siete mercanti, borghesi sempre occupati negli interessi privati…”).
Il Viaggio del giovane Anacarsi recava come introduzione una dotta storia ateniese dalla origini a Pericle, di tono moralistico.
7. Mentre la rivoluzione inglese del 1688 non si era generalmente rifatta a esempi classici da imitare (semmai biblici), la rivoluzione francese utilizzò i modelli repubblicani antichi quali li aveva rielaborati il 18. secolo.
“L’immagine incerta della nuova città terrena da fondare si delineava, per analogia o per contrasto, anche rivisitando la città antica” (Guerci).
Questo riferimento paradigmatico all’antico fu intenso soprattutto nei primi anni, per ridursi successivamente.
In seguito l’esperienza napoleonica diffuse in Europa alcuni paradigmi antichi, pur rilanciando il tema dell’impero e suscitando reazioni.
Ciò diede nuovo vigore allo studio dell’antichità ma nello stesso tempo la caricò di significati politici e sociali nuovi.
I difensori delle libertà “moderne”, coloro che temono per la proprietà privata o hanno paura di ogni rivoluzione, si sforzeranno da allora in poi di mettere a distanza l’antichità; sarà questa una condizione necessaria per uan visione più corretta della storia antica.
8. L’indipendenza delle colonie americane (1776) e le lotte per l’indipendenza greca (a partire dal 770, cioè dalla guerra russo-turca, fino al 1830 e oltre) avevano anch0esse avuto conseguenze sull’immagine dell’antica Grecia.
Veniva riproposta l’idea delle antiche repubbliche indipendenti da imperi e monarchie, si ridava attualità alla lotta contro il dispotismo, ci s’interrogava sull’instabilità delle repubbliche antiche e di Atene in particolare e sulle forme di governo miste.
Anche in questo caso il rapporto ideale con l’antichità era sostenuto con forza da alcuni, ma operando delle scelte (in favore di Sparta o di Roma ad esempio).
L’Iperione di Hölderlin canterà il risorgimento dell’antica Grecia, altri esalteranno la rigenerazione dell’Ellade, ma non mancarono gli oppositori.
Pag. 1031-34
Per trovare qualcosa di più avanzato nella storiografia scozzese occorre infatti rivolgersi piuttosto a Hume.
Il saggio sulla popolosità delle antiche nazioni (1752) va infatti molto al di là del semplice contributo erudito.
Esso infatti non si limita alla sola demografia e alla discussione delle cifre fornite dagli autori antichi, ma riguarda tutta l’economia antica, ivi compresa la schiavitù, e confronta lo sviluppo raggiunto dai moderni a quello degli antichi, negando a questi qualsiasi supremazia.
Vi troviamo in nuce una forma di “primitivismo” intelligente, ben prima che sorgessero le discussioni sul carattere dell’economia antica: “… vi sono molti altri elementi, per i quali le antiche nazioni sembrano inferiori a quelle moderne, sia per quanto riguarda la felicità che l’aumento della popolazione. Il commercio, le manifatture, la laboriosità, non furono mai in alcun luogo così prospere nelle epoche antiche come attualmente in Europa”.
E’ indicativo il fatto che il saggio di Hume avesse un’eco in Gibbon per il versante romano ma che, per quel che ho potuto vedere, non lo abbia avuto nelle prime storie greche in lingua inglese.
Ancora una volta, a proposito di un problema filologico-antiquario come quello della discussione sul numero degli abitanti (solo in apparenza minore), possiamo verificare l’esattezza della tesi di Momigliano su Gibbon, colui che unifica storia e antiquaria aprendo una nuova via.
Le storie greche in lingua inglese che si susseguirono per tutto il Settecento e i primi decenni dell’Ottocento mostrano bene quanto fosse cresciuto l’interesse per l’argomento e quanto si fosse consapevoli della necessità di riscrivere le vicende degli elleni; ma contemporaneamente rivelano quanto ancora ci si affidasse a intendimenti prevalentemente letterari e afilologici; da questo punto di vista occorre arrivare fino a Thirlwall e Grote, ben oltre Mitford e Gillies, per trovare uan nuova scrittura basata su un modo nuovo d’intendere le fonti.
Pag. 1036-37
La mancanza di una distinzione chiara tra storiografia e retorica, dall’antichità almeno fino alla fine del Settecento e agl’inizi dell’Ottocento, non significava necessariamente assenza di canoni critici; semplicemente questi potevano essere inglobati nel discorso storico, sottomessi alle necessità della narrazione, o talvolta limitati ai periodi più antichi.
Coloro che scrivevano di storia antica spesso da secoli occupavano presso le università cattedre di eloquenza o di retorica, talora di diritto, soprattutto dove non esistevano insegnamenti specifici di storia o di storie e lettere greche e latine (come nei Paesi Bassi nel secolo 16. e 17.)
Ma l’attività universitaria era solo uno dei mestieri possibili per gli autori di opere storiche; anzi personaggi di primo piano nel rinnovamento della storiografia del 19. secolo non provenivano affatto dalle universitates studiorum (anche se poi vi insegnarono: si pensi a Niebuhr, ambasciatore di Prussia, o a Grote, banchiere e parlamentare).
Fino all’Ottocento la trasmissione del sapere storico non è avvenuta solo in ambito universitario.
La professionalizzazione è più antica di quanto si creda, però non è mai stata totale.
Essa non è all’origine della storiografia moderna sull’antica Grecia; semmai ne costituisce un importante sviluppo successivo.
In paesi come la Germania e l’Olanda il processo era più avanzato che altrove, ma lo studio “moderno” della storia antica nasce fuori dall’università, anche se confluisce presto nei circuiti accademici che recepirono l’interesse crescente per l’antichità.
Perché nascesse una moderna storiografia sui greci erano necessarie alcune condizioni, ma tra esse non mi sembra rientri prioritariamente la professionalizzazione del mestiere di storico.
La prima condizione era che l’antichità non fosse più ritenuta superiore al mondo moderno neanche in campo letterario, che la querelle des anciens et des modernes fosse definitivamente conclusa con la sconfitta degli antichi; o meglio che si accettasse un fatto solo in apparenza banale: non era più possibile limitarsi a leggere o tradurre o riassumere gli autori antichi che avevano già scritto la storia greca, magari integrandoli o correggendoli.
Il primo tentativo di Emmius nel Seicento e altri come quello di Rollin nella prima metà del Settecento sono indicativi del fatto che fino ad allora persino chi voleva riscrivere la storia greca si rivolgeva totalmente agli storici antichi: o riassumeva i più autorevoli tra di essi, come nel caso del primo, o li rielaborava acriticamente in chiave edificante, come fece Rollin.
In sostanza ci fu uan fase (soprattutto in Gran Bretagna) in cui si “superò” la storiografia antica semplicemente riscrivendo la storia greca in modo letterariamente più aggiornato, ma solo successivamente si passerà a un ripensamento fondato sulla critica delle fonti, su nuove conoscenze e con nuovi e più “moderni” problemi.
La seconda condizione era che si guardasse agli elleni come a una nazione, una totalità, al di là del fatto che essi avevano formato un insieme di stati diversi, di “repubbliche” come si diceva allora.
La percezione dell’aspetto politico-statuale dell’antica Grecia era avvenuta presto e con ottimi risultati, da Sigonio a Emmius e al Meursius.
Ma non si era ancora unita a una chiara percezione dei greci come nazione, perché questo concetto si affermò nel corso del 18. e del 19. secolo.
La filosofia della storia e il pensiero dell’epoca romantica hanno avuto un peso notevole sulla storiografia, specialmente in Germania; poco – in qualche caso forse nulla – in altri paesi europei, dove semmai era stata la realtà di stati unitari ma composti di entità distinte (come nel Regno Unito) a facilitare la comprensione di quella molteplice esperienza antica.
Terza condizione, importante più per lo sviluppo successivo che per la nascita della storia greca, la sollecitazione a rivisitare in modo originale il passato che venne dalla scoperta o riscoperta di documenti, di siti archeologici eccezionali, di testimonianze artistiche o materiali in genere (basti pensare agli “Elgin’s Marbles” portati in Inghilterra negli anni 1803-12 e posti nel British Museum dal 1816).
Il recupero dell’antiquaria da un alto e della “filosofia” dall’altro da parte della storiografia avvenne con un certo ritardo nell’ambito della storiografia greca e in modo diseguale; sarà semmai l’epigrafia ad essere recuperata per prima nell’ambito di una filosofia senza confini che comprendeva studio dei documenti e storia.
Per quanto possa sorprendere, una figura come quella di A. Boeckh non è stata sempre definita come uno “storico”; gli storici autentici saranno semmai Niebuhr e K. O. Müller.
Per quel che riguarda gli antichi greci sarà il secolo della storia, l’Ottocento, a fare progressivamente tesoro dello studio dei documenti, e non il Settecento.
Forse la reazione al pirronismo in questo settore era stata la messa in discussione delle antiche certezze.
Ultima condizione, comune questa anche agli studi su Roma, la modernizzazione della percezione dell’antichità, prima nel campo della politica e poi dell’economia, e il suo rifiuto o la messa a distanza degli antichi.
Si è già detto dell’uso dell’antichità greco-romana come modello, un fenomeno nato certo con l’umanesimo, ma fortemente condizionato dalle realtà del Settecento prima, dalla Rivoluzione francese e dalle tensioni dell’Ottocento poi.
Nacque un vagheggiamento che costituiva una forma sia pure errata di conoscenza, ma soprattutto sorse per reazione un bisogno prepotente di mettere a distanza e di comprendere a fondo le differenze tra antico e moderno e tra esperienze antiche (opposizioni Atene / Sparta o Roma / Grecia) che fu importantissimo.
Si doveva mettere a distanza il modo d’intendere la libertà delle antiche repubbliche (B. Constant), il peso del popolo nella democrazia ateniese (ad esempio A. Boeckh per la critica alla retribuzione delle cariche pubbliche ateniesi e più in generale Mitford e Peyron), la natura onnicomprensiva delle società e degli Stati antichi (Fustel de Coulanges).
Così persino Wilhelm von Humboldt aveva scritto a Goethe nell’agosto del 1804: “sarebbe soltanto un inganno se noi desiderassimo di essere cittadini di Atene o di Roma antiche… l’Antichità deve apparirci come cosa distante, scevra di volgarità, quale mero passato”.
Nello stesso tempo le ricostruzioni delle antiche vicende scritte con occhi e sensibilità contemporanee resero viva e attuale la storia greca, anche se ad esempio trattare in questo modo la democrazia ateniese e i suoi esponenti politici portava a peccare di anacronismo (si pensi alle concezioni opposte di Mitford e Grote).
Necessità di mettere a distanza il mondo greco e sentimento di un legame forte con esso, visioni anticlassicistiche e classicismi si sono alternati e intrecciati e perdurano ancor’oggi: “La situazione degli studi è così disperatamente complessa perché nel considerare i greci con crediamo quasi sempre di aver a che fare con la nostra carne e con il nostro sangue, ma nella maggior parte dei casi, se ben si osserva, questo conto non torna… le nostre categorie si rivelano insoddisfacenti”.
La visione “laicizzata” della storia antica con il rifiuto di schemi teologici e l’applicazione di metodi critici e filologicamente agguerriti avranno però una conseguenza negativa; essi non potevano non saldarsi col tempo al dominio che gli Stati europei (“l’uomo bianco”) stavano estendendo sulle popolazioni d’Asia e d’Africa con la conseguente visione razziale (e talora apertamente razzista): la concezione provvidenziale aveva almeno creato uan catena di popoli e civiltà che metteva insieme, anche se non necessariamente sullo stesso piano, Oriente (in particolare gli ebrei), Grecia, Roma.
La laicizzazione e lo sviluppo dell’idea di nazione escludono gli altri, o almeno li pongono su un gradino più basso rispetto al mondo classico.
Ne risentono anche le maggiori storie universali (ad esempio quella che affiora dalle lezioni di Niebuhr e poi quella di E. Meyer), che pure valorizzano e non emarginano le altre culture e le ritengono giustamente parte integrante di un’antichità che non dev’essere solo greco-romana.
La critica alle tradizioni sull’età eroica comportava anche la negazione della presenza di colonie orientali in Grecia, così come del resto di tutto il patrimonio mitistorico, almeno fino a che le scoperte archeologiche non posero su basi nuove la conoscenza della Grecia del secondo millennio a. C.
Quello che è stato chiamato “il modello antico” venne incrinato e poi rifiutato da metodi e atteggiamenti critici che avevano origine più nella critica biblica che in presupposti razzisti; questi ultimi si sommarono ai metodi critici e all’ipercritica, ma non ne determinarono lo sviluppo; la visione eurocentrica della storia antica è anche il frutto della sua secolarizzazione.
Pag. 1037-40
In sintesi si può concludere che tra l’età della Rivoluzione francese e la metà circa dell’Ottocento si costituiscono alcuni tratti fondamentali delle tradizioni nazionali nel campo della storia greca.
Ciò avviene in Gran Bretagna, dove interesse per la storia dei greci e sensibilità politica comparvero prima che altrove, già alla fine del Settecento, per poi fondersi con la critica storico-filologica tedesca con Grote.
In Germania il movimento romantico e lo storicismo si innestarono sull’idealizzazione dei greci tipica dell’età di Winckelmann e di Goethe e sulla reazione al trauma dell’occupazione napoleonica, mentre la formidabile capacità di lavoro delle università tedesche (Gottinga in primo luogo, ma anche il nuovo grande ateneo berlinese promosso da Wilhelm von Humboldt), con la concorrenza interna tra professore e Privatdozent ed esterna tra università e università, moltiplicherà le ricerche filologiche ed erudite.
I frutti migliori si videro inizialmente nel campo della storia romana e solo successivamente in quello della storia greca.
Il movimento unitario e la rivoluzione del 1848 risvegliano anche negli Stati tedeschi quella sensibilità politica che fino ad allora era stata un fenomeno inglese e la storiografia di Grote suscita consensi od opposizioni.
Il criterio razziale si diffonde, e convergerà con i risultati raggiunti indipendentemente dalla linguistica indoeuropea (la Grammatica comparata di Bopp è degli anni 1833-49), mentre la critica storica delle tradizioni sulle origini si afferma e mina alla base la validità delle tradizioni mitiche, anche quelle su presenze orientali nell’Ellade.
La critica biblica tedesca, sia vetero che neotestamentaria, andava nella stessa direzione (si pensi a F. C. Baur e D. F. Strauss) e influisce direttamente sullo studio delle fasi più antiche della storia romana (A. Schwegler) e di quella antica in generale.
Mentre in Italia il tentativo di Denina resta isolato e l’interesse dei sotti va in direzione di altre fasi storiche, in consonanza con le discussioni e le lotte per l’unità nazionale, in Francia la storia greca per un cinquantennio vive di lavori particolari, perché la rivoluzione dopo il Termidoro (1794), l’Impero napoleonico e la restaurazione hanno allontanato i modelli ellenici dal mondo contemporaneo.
Solo poco prima della metà del secolo prende forma una storia dei greci che è in linea con le nuove sensibilità (Duruy).
Pag. 1064-65
Il decennio tra il 1860 e il 1970-71 vide cambiamenti radicali nella storiografia.
Si è parlato giustamente di un “mutamento ideologico” degli storici francesi tra 1865 e 1885, ma il fenomeno – con alcune differenze di cronologia – è più generale.
Esso è strettamente collegato da un lato al costituirsi della storia in disciplina “scientifica” affermatasi tra molte contraddizioni nei decenni precedenti (in Germania prima e poi in Gran Bretagna) e dall’altro ai mutamenti politici e sociali.
Il raggiungimento dell’unità nazionale in Italia (1861, Roma capitale dal 1870) e in Germania (1871), portano a un rafforzamento generale dell’idea di Stato nazionale rispetto a quella di piccolo Stato (Kleinstaaterei) e di (con)federazione.
Inevitabilmente ciò avrà, e continuerà ad avere a lungo fino al 20. secolo, conseguenze determinanti sull’interpretazione della storia greca in un senso sempre più unitario, “nazionale”, mettendo in valore gli Stati egemonici, siano essi Atene, Sparta, Tebe o soprattutto la Macedonia.
La diffusione della scienza dell’antichità tedesca e dei suoi metodi in altri paesi du accelerata non solo dal prestigio e dai successi germanici, ma anche da una precisa scelta compita da altri Stati europei.
Così in Italia ci fu l’importazione di docenti universitari tedeschi nelle università riorganizzate dopo l’unificazione (come Beloch a Roma e Holm a Palermo e Napoli); professori tedeschi già in passato avevano insegnato in Russia.
Il fenomeno parallelo di giovani studiosi di altri paesi europei che si recano a studiare o a perfezionarsi in Germania è più rilevante in altri settori, come la storia romana (E. Pais, C. Jullian) o la filologia classica in genere.
pag. 1065-66
La lettura della civiltà greca di Burckhardt va vista alla luce delle tre forze che egli vedeva all’opera nella storia: lo Stato, la religione e la cultura, come indicano le lezioni Sullo studio della storia (note anche col titolo Considerazioni sulla storia universale).
La forza della cultura greca era emersa anche grazie a quelle due altre potenze, ma esse avevano fatto sì che la città greca fosse stata “città dolente” (secondo l’espressione dantesca ripresa da Boeckh).
La visione pessimistica sia del presente che dell’esperienza greca, che pure vagheggiava con toni a volte classicistici, lo distinguono da altri storici contemporanei, anche dal Curtius, per il quale ebbe un moderato apprezzamento.
“Noi vediamo con gli occhi dei greci e parliamo con le loro espressioni”, affermava nell’Introduzione, ma il riconoscimento di un rapporto speciale tra gli antichi greci e moderni mi sembra resti su di un piano intellettuale senza avere risvolti razziali; anzi Burckhardt accostò più volte la polis e le città-stato fenicie.
Pag. 1072
Quindi la storia si rivela una successione di storie nazionali secondo una linea di sviluppo universale (che va da Egitto a Israele agli assiri, ai medi e persiani fino a greci, macedoni e romani).
Le civiltà però entrano in contatto e – come dice a proposito di Erodoto – “la storia non potrebbe fiorire entro l’ambito esclusivo del suolo nazionale; le nazioni diventano conscie di se stesse soltanto mediante i reciproci incontri”.
Questa di Ranke era una storia priva di ogni apparato erudito e fondata su documentazione superata.
Eduard Meyer per questo la giudicò un fallimento, ma essa resta indicativa della forza che la concezione universalistica manteneva in Germania in un’epoca di storie nazionali.
Pag. 1074
Numerose furono nei decenni finali dell’Ottocento e nei primi del Novecento le storie greche scritte da storici tedeschi, testimonianza non solo dell’interesse del pubblico colto e degli editori per il mondo greco ma anche dell’insoddisfazione per le storie di Curtius e di Grote.
La prima di questa sequela impressionante di opere fu dovuta ad Adolf Holm (1830-1900), che insegnava da tempo in Italia ed era noto per un’importante opera sulla Sicilia nell’antichità.
La sua storia, oggi dimenticata, fu rapidamente superata dalle altre, certo superiori o per erudizione o per senso critico o per originalità di vedute.
Non era però affatto priva di elementi positivi.
Molto chiara (talvolta persino banale), nella prima parte era caratterizzata da una critica temperata alle tradizioni mitistoriche; come scriverà lui stesso in un’aggiunta polemica verso Beloch, “la critica storica deve stare in guardia dal confondere due cose distinte: la dimostrazione che un fatto considerato storico non può essere ritenuto provato in quanto tale, e la dimostrazione che questo fatto è impossibile”.
Elementi di novità sono anche l’ampio spazio che egli assegnò alle vicende dell’Occidente greco e soprattutto alla storia ellenistica fino al 30 a. C. (un volume su quattro): per lui il vero soggetto della storia greca erano i greci e la loro civiltà da Massalia fino all’Oriente e per questo era necessario comprenderne le vicende a pieno titolo in una storia greca, senza fermarsi né al 4. secolo né alla conquista romana della Grecia propria.
Pag. 1076
Per una conclusione
Alcuni dei fili che abbiamo cercato di seguire arrivano fino ai nostri giorni e indicano delle continuità dall’antico a noi: recuperi consapevoli, lunghe durate per così dire sotterranee, profonde cesure compaiono nella storia della cultura con movimento alterno.
Scoperte di mondi ignoti o marginali grazie all’indagine archeologica fanno aggiungere pagine nuove e importanti al libro della storia greca, ma è indubbio che il posto eminente che conservano la democrazia ateniese e vicende come quelle della guerra del Peloponneso, per quanto integrate da nuovi documenti o esaminate con metodi e strumenti concettuali moderni, nascono in ultima analisi dalle pagine immortali di Tucidide.
Cosa fare di tutto ciò che è tra noi e i testi, i documenti e i monumenti antichi?
Ha senso fare, come spesso avviene o come si crede di fare, tabula rasa?
In un’epoca come la nostra in cui si è consapevoli della storicità dei modi di credere, dell’esistenza legittima di più modi d’intendere il passato (fino a dissolvere a volte il confine tra vero e falso) si ripropone il problema delle diverse verità della storiografia passata.
Non sarà inutile terminare riconsiderando le parole che uno storico eminente, Adolfo Omodeo, scrisse molti anni fa a proposito di Michelet: “E’ giusto considerar prescritti e decaduti gli storici che vanno lontanando nel tempo? Probabilmente tale prescrizione è ispirata da criteri di mal intesa filologia: dall’opinione che i nuovi studi, i nuovi documenti, abbian la forza di invalidare le ricerche anteriori.
Ma questa è uan concezione grossolana del superamento. L’acquisto di verità compiuto dai nostri predecessori, nel campo delle nostre ricerche, permane anche quando questa verità sia stata integrata da nuove scoperte.
Come già ai suoi tempi stabiliva Droysen, la verità è cosa ben diversa dalla precisione o esattezza”.
Pag. 1084